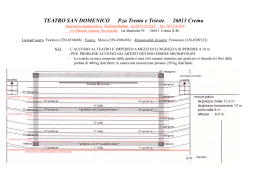Università di Roma “La Sapienza” Corso di Laurea in Arti e Scienze dello Spettacolo STORIA DEL TEATRO E DELLO SPETTACOLO a.a. 2013/2014 Prof.ssa Paola Quarenghi DISPENSA C (un centinaio di pp. a scelta) Ettore Petrolini Modestia a parte… Bologna, Licinio Cappelli 1932, pp. 135-150 DIECI ANNI DOPO1 Ecco: i dieci lunghi anni sono passati. E, in questo frattempo, ho studiato e consultato Tagore, l’orario delle ferrovie, la tavola pitagorica e l’annuario dei telefoni. Senza voler parlare delle leggi delle 12 tavole e del calendario gregoriano, mi permetto di dire che in fatto di opere di teatro difficilmente se ne potrà incontrare una che a prima vista non appaia noiosa. La materia di recitazione è nei libri di teatro quasi sempre immobile, se si eccettui qualcuna delle Opere scritte dagli scrittori-attori come Shakespeare, Molière e Goldoni; e cioè quelle commedie o drammi che, alla lettura, sembrano innocentemente melensi, oziosamente spiritosi di uno spirito piuttosto vecchiotto. Si discute molto di teatro teatrale o di teatro non teatrale. A tale proposito i critici, per fare impressione, ci accoppano di nomi: Gwynplaine, Gogol, Renard e Shaw, Pico della Mirandola, Landru, Girardengo, Marinetti e la Mandragola di Niccolò Machiavelli. Lasciamoli dire. La verità è che la maggior parte del teatro scritto dalla Commedia dell’Arte in poi è noioso e antiteatrale. Il fallimento dei teatri sperimentali non è colpa della incomprensione del pubblico; è originato soltanto dal fatto che, in questi tempietti, domina il più stomachevole e inutile rispetto dell’opera d’arte. Che cosa direste voi se, annunziandosi le nozze di un vostro amico con una bellissima donna, vi dicessero che lo sposo si è proposto di essere con lei rispettosissimo e di rimanere da essa a debita distanza? Nella stessa posizione sono coloro i quali professano per l’arte un rispetto che toglie loro qualsiasi iniziativa, qualsiasi libertà, anche quando è il maggior segno di stima profittarne e abusarne con violenza. L’opera d’arte va fecondata, giacché il fatto di essere conservata per iscritto è per essa una imbalsamazione, un artificio, un mezzo qualsiasi. Per renderla leggibile, occorre aggiungerle un carattere che non è il suo. L’opera teatrale scritta è soltanto lo scheletro della rappresentazione. Il Borghese Gentiluomo è l’opera molieriana che risente maggiormente della differenza fra teatro scritto e teatro recitato. In questa commedia, i mezzi teatrali non sono taciuti né sottintesi, ma chiaramente trascritti con tutti i preziosi trucchi comici del dialogo, con tutte le soluzioni in cui si evita qualsiasi conclusione, o catastrofe, o 1 In altre edizioni il titolo del brano è Discorso dell’attor comico. spiegazione. La commedia finisce in balletto e la satira finisce in canzonetta. È uno dei componimenti tipici di quello che nell’arte della recitazione voglio chiamare «lo spazio vuoto». L’attore che meriti questo nome, oltre al bagaglio d’immagini e di battute comiche prestabilite, deve avere una sensibilità dell’ambiente in cui lavora, un senso speciale che non è altro se non il talento dell’attore. Il pubblico del teatro è in continuo spostamento e oscillazione. Basta un nonnulla per orientarlo, basta poco per metterlo in sospetto e in allarme. In tale continuo movimento, il pubblico è come una materia compatta che, spostandosi da un punto all’altro, apre improvvisamente alcuni spazi e fenditure che minacciano tutta la compagine dello spettacolo. L’associazione delle idee, che nelle sere di spettacolo lavora rapidissima nella mente degli spettatori, le suggestioni che agiscono sul pubblico quasi all’unisono, sono altrettanti pericoli di catastrofi cui deve far fronte l’attore coi suoi mezzi. * * * Per colmare queste fenditure degli spazi vuoti nel pubblico, non basta l’opera recitata così com’è, come non bastano le vecchie risorse di trucchi teatrali predisposti e tradizionali: occorre avere un senso esatto di quello che domina il pubblico in quei momento e orientarlo improvvisamente, a tradimento, verso qualche idea nuova che lo colpisca all’improvviso e lo domini per qualche minuto. Un’allusione a fatti del giorno che formano il fondo dei pensieri d’ognuno, ma che nessuno s’aspetta di sentirsi ricordare a teatro. Una falsa intonazione. Un fischietto. Un versaccio. Una scernenza. Una malignità. E, in caso disperato, una cattiveria. Il pericolo maggiore è che il pubblico preveda tutto mentre si svolge la commedia, e che non si aspetti nulla di imprevisto e sia dominato da quel torpore di cattivo augurio che gli attori conoscono molto bene. Credo che i vecchi comici, che interpretavano commedie quasi sempre dello stesso soggetto, avessero appunto il senso dello spazio vuoto. Altrimenti, non si potrebbe spiegare la sopravvivenza di molti mezzi teatrali che hanno tutti lo stesso carattere, dalla recitazione dei comici dell’Arte a quella degli attori più colti. Osservando bene, si trova che hanno più resistenza di molte opere i mezzi buffoneschi più sfruttati; essi sopravvivono da Aristofane a noi, con una perenne attualità che molte opere teatrali non hanno. Lo spirito dell’attor comico non sarebbe mai mutato, come si può vedere in quello che nelle commedie scritte sopravvive dei mezzi della recitazione; non sarebbe mai mutato lo spirito del pubblico, che si è sempre lasciato accalappiare da tali mezzi; i quali, a leggerli a tavolino, sanno di scemenza; ma riportati alla ribalta hanno una meravigliosa freschezza e una vita segreta, che non si riesce a spiegare altrimenti che come un fenomeno della creazione più personale dell’attore. Come accade per gli effetti di tutte le arti, non ve ne sono di vecchi o di nuovi, a teatro come nelle parole o nei colori o nella musica, non esistono effetti sorpassati e inefficaci: sono tali soltanto quando sono usati a sproposito e fuori tempo. Essi diventano convenzionali se sono adoperati a colmare una insufficienza del creatore, poeta o attore che sia. Gli artisti sanno la straordinaria efficacia di un luogo comune, di una buffoneria risentita infinite volte: quando queste cose arrivano a tempo, riassumono una situazione, sono un mezzo d’espressione, dànno un calcio alla logica, al senso comune, all’opera stessa e formano la vera e propria soluzione teatrale. L’attore che dispone di questi mezzi, risolve da attore una situazione che nessun altro mezzo letterario avrebbe potuto risolvere con tanta efficacia; dà vigorosamente uno scappellotto alla storia e alla tragedia, piomba sugli spettatori e li prende nel pugno, tradisce la loro attenzione e li accaparra per qualche tempo: apre, nel dramma, lui stesso, quello «spazio vuoto»: ed egli stesso lo colma con un’insuperabile bravura, fino a quando non intervengano le risorse del letterato. Un caso particolarissimo e spesso interessante di quelle improvvisazioni con cui si riempie «lo spazio vuoto» è quello che io chiamo «slittamento» (l’uscire dalle dimensioni della finzione scenica passando per un momento in quelle della realtà). Per esempio, si può parlare col suggeritore, ammonire un rumoroso ritardatario: insomma, trarre profitto di tutto, dal rumore del seggiolino della poltrona lasciato cadere sbadatamente, all’immancabile pianto del bambino nelle rappresentazioni diurne. Naturalmente bisogna essere «tempisti», e cogliere il momento sia di uscire, sia di rientrare nello «spazio scenico». Lavorando su questo terreno per molti anni, mi sono accorto che non esiste commedia impossibile da recitare. Molti critici dicono, ed io lo riconosco senza difficoltà, che il mio repertorio è pieno di cose idiote che non sarebbero degne di stare accanto alle cose intelligenti che vi si trovano. Per me è lo stesso. La commedia, la considero come un buon pretesto e null’altro. Io ho recitato nella mia vita delle cose stupidissime che avevano soltanto il torto di non essere a quel punto di imbecillità che desideravo e che, alla fine, per ottenerlo, dovetti inventare da me. Nel periodo di musoneria italiana in cui un buon attore non era considerato tale se non si prestava alle parti lacrimose, io passai come un buffone distinto. Mi venivano a sentire per esclamare: «Quanto è scemo». Io, in quel tempo, inventai il mio motto: «più stupidi di così si muore»; creai due cose che amo soprattutto: «I salamini» e «Fortunello», che considero il principio di quel modo di recitare che perfezionai attraverso parecchi anni di lavoro. Molti critici mi proclamarono l’interprete della idiozia sublime, di quella idiozia che è la sola fuga possibile da questo mondo troppo logico, dove esistono troppe cose insolubili e troppe domande senza risposta; e dove esiste un’arte che la sola logica non può avviare alle soluzioni estreme. Basterà che ricordi come divenne grido trionfale e addirittura un formula il primo verso dei «Salamini» «Ho comprato i salamini e me ne vanto» e tutto il formulario delle risposte che risolvevano per me molti problemi: «Perché la terra gira? Perché sì. — Perché gli uomini sono fatti di carne e ossa anziché di acciaio? Perché sì». E via dicendo, con domande quasi angosciose miste ad altre soltanto pettegole, sino alla conclusione illogica ma riassuntiva: «ho comprato i salamini e me ne vanto». Lo stesso sistema ho adottato nelle commedie e nei drammi che recito. * * * L’attore, in momenti come questi, non fa più che dell’autobiografia. Io dò all’autobiografia in teatro una importanza pari a quella che essa ha nelle altre arti. Intendo una autobiografia superiore, un modo di insinuare nell’opera i propri sentimenti e punti di vista, la propria ironia o il proprio patetico come espressioni caratteristiche di uno stato d’animo individuale in cui tutti si riconoscono. Ho fatto nei primi anni della mia vita di tutto (vedi ciò che ho scritto su Piazza Guglielmo Pepe di Roma): nei teatri da quattro soldi i primi posti, e due soldi i secondi; dal camaleonte all’istrice, dal pappagallo sapiente alla scimmia imbalsamata: or piangendo lacrime di coccodrillo, ora ridendo il riso sesquipedale dell’ippopotamo. Fu una vita selvaggia, allegra e guitta, e un’educazione a tutti i trucchi e a tutti i funambolismi, davanti al pubblico, che magnava le fusaje (i lupini) e poi tirava le cocce (le buccie) sur parcoscenico al lume de certe lampene (lampade), che er fumo spanneva dapertutto un odore da bottega de friggitore. Di là sono salito ai caffè concerto di second’ordine con la consumazione obbligatoria, dalle ribalte di legno ai palcoscenici in muratura, dallo spettacolo da quattro soldi, con la grancassa e la parata all’entrata, al Varietà con lire una d’ingresso. Ho lasciato la Sirena del mare, le foche sapienti e la donna barbuta (che era un uomo travestito) per le attrazioni ginnastiche e le canzonettiste deliziosamente ignoranti. Ho imparato in questa mia esperienza a sondare la stupidaggine, ad anatomizzare la puerilità, a vivisezionare il grottesco e l’imbecillità del nostro prossimo, per arricchire il museo della cretineria. Il sentimentalismo odioso, la prosopopea, il tragicismo ad ogni costo, mi hanno attratto irresistibilmente; e la boria presuntuosa di qualche attore del teatro così detto serio, mi ha fornito molto materiale umoristico per il mio teatro. Alla fine, non profittavo più dello spazio vuoto del mio pubblico, ma lo creavo io stesso; e non per colmarlo, ma per tenere l’uditorio in quello stato di esaltazione in cui qualsiasi cosa si dica finisce per avere un senso o per non averne nessuno: più cretini di così si muore. Il mio ideale era ormai la creazione dell’imbecille di statura ciclopica. Devo dichiarare che non ho mai preso l’aria di estetizzante e di decadente, non mi sono mai entusiasmato alle metropoli, e da romano de Roma preferisco a tutti gli asfalti una strada serciata o un vicoletto co li panni stesi che interrompano l’uniformità del panorama: non mi sono mai chiamato con tre nomi, e non per modestia. Mi sono tenuto sempre lontano dalla modestia per paura di diventare... orgoglioso di essere modesto. Raffaele Viviani Dalla vita alle scene Guida, Napoli 1977 [1928], pp. 19-21, 25-26, 57-60, 78-81, 129-31, 53-56. II debutto Nacqui a Castellammare di Stabia, la notte del 10 gennaio 1888, all’una e venti, figlio di un cuor d’oro di donna e di un padre cappellaio, che più tardi divenne vestiarista teatrale. Un sequestro al suo magazzino, il giorno dopo la mia nascita, l’obbligò a tornare a Napoli, sua città nativa, e a darsi con maggior lena alle cose teatrali che egli, fin da giovanetto, prediligeva. Riprese le antiche amicizie e s’impiantò. Uomo ingegnosissimo ed onesto fino allo scrupolo, costruiva tutto con le sue mani; finì così per crearsi un vasto corredo di attrezzi teatrali e di indumenti, con i quali forniva alcuni teatrini dei quartieri più eccentrici. Tale industria lo aiutò a tirare innanzi la vita, ed a rimettere insieme quello che in gioventù aveva qua e là disperso per il suo temperamento generoso e vivace. Che Iddio lo abbia in gloria! Fu così che accompagnandolo mentre portava roba in uno di quei teatrini e precisamente in un teatro di marionette a porta S. Gennaro (tutt’ora esistente) incominciai a divertirmi alle vicende di Orlando e di Rinaldo. Cantava, tra i numeri che completavano lo spettacolo marionettistico, un certo Gennaro Trengi, tenore e comico, notissimo per i suoi vestiti multicolori. Io, che realmente me lo gustavo, ero riuscito ad imparare a memoria le sue «cose» che non assommavano a più di cinque o sei. Una sera il Trengi si ammalò. Lo spettacolo di varietà correva grave pericolo. Il pubblico avrebbe preteso certamente o Trengi, o... i soldi. Non c’era altro rimedio che levare porta (sospendere la rappresentazione). Aniello Scarpati, il proprietario dei «pupi» ebbe una idea. - Facciamo cantare ‘o figlio ‘e Rafele (mio padre). Accettai la proposta, con entusiasmo. Mi ero abituato ad imitare Trengi nei gesti e nella voce ed ero tutto preso già dall’ardente desiderio della scena. Fui vestito subito con l’abito di un «pupo», che mia madre raffazzonò alla meglio e mezz’ora dopo la musica, una tromba, un clarino ed un trombone attaccavano l’introduzione della «Ballerina». Mi presentai: non più alto di ottanta centimetri, compreso il tubino, con il bastoncino nelle mani, che facevo scorrere fra le dita. Udii un vociare confuso, una grande risata, e poi un silenzio di tomba. Ma non ebbi paura. Avevo quattro anni e mezzo e cantai... prima con voce tremula, rinfrancandomi a mano a mano, sino ad acquistare la più completa padronanza tanto che il pubblico (si pagava allora due soldi ai primi posti e un soldo ai secondi) mi compensò con prolungate acclamazioni. Il successo fu entusiastico. Trengi ristabilitosi chiedeva il suo posto, ma, come sempre accade nella vita, non l’ebbe più. Fu così l’inizio della mia carriera. Anche la stampa si occupò del caso unico, e la gente, dai quartieri più lontani accorreva ad assistere alle esibizioni del bambino-prodigio. Dopo qualche mese, mio padre, da uomo accorto, pensò che lo scherzo era già durato un po’ a lungo. Ebbi così anch’io la mia paga: due lire serali, ed ebbi anche tanti bei vestitini a colori, come usava il Trengi. L’uguaglianza della tinta si estese alla cravatta, alla camicia, al nastro che reggeva la caramella senza vetro, e perfino al bocchino che reggeva la sigaretta di cioccolata, sigaretta che divoravo regolarmente dopo ogni spettacolo: quattro serali ed otto le domeniche. *** Nel gennaio del 1900 mio padre morì e, per sotterrarlo, fummo costretti a vendere in blocco da un rigattiere gli ultimi panni e l’ultima attrezzeria che egli si era in vita amorevolmente e faticosamente costruita e che durante la sua lunga e penosa malattia giorno per giorno si era necessariamente assottigliata. Con lui si vuotò completamente la casa. Si era in carnevale e si usava allora dare nelle baracche, una specie di zarzuela carnevalesca chiamata: Zeza-Zeza, i cui personaggi erano: Pulcinella, Donna Rosa, sua moglie, Colombina, loro figlia e Don Nicola, padrone di casa. Gli attori che facevano Zeza-Zeza scendevano l’ultimo scalino dell’arte e per ingiuriare un comico si diceva: — Tu devi fare soltanto Zeza-Zeza... Mi presentai ad uno di questi baracconi di proprietà di Don Ciccio Scritto, famoso impresario di giostre, altalene, etc. e dissi di voler io fare la parte di Don Nicola nella Zeza. Grazie a Dio, per la temporanea assenza di Giovanni ’o pittore, che sosteneva la parte di Don Nicola, fui scritturato a cinquanta centesimi al giorno, per fare spettacoli continui dalle due pomeridiane fino alla mezzanotte, e in più la cosiddetta «parata», ossia su di una pedana esterna una specie di rappresentazione gratuita per radunare la folla: il che vuol dire, che dalle due a mezzanotte, fra l’esterno e l’interno, non c’era nemmeno il tempo di sputare. Tutto questo per 50 centesimi!.. Più di un mese feci questa vita, e i dieci soldi bastavano a dare un cucchiaio di pasta e un po’ d’acqua calda allo stomaco, prima di andare a letto. In casa Scritto ebbi la mia prima avventura amorosa. La figlia di Don Ciccio, Nicolina (personaggi che ora sono tutti fedelmente disegnati nel mio Circo Sgueglia) era tarchiata e piacente, e ben presto pel continuo amoreggiare tra Don Nicola e Colombina finimmo per dirci cose care di amore, tanto che oltre alla Zeza, montammo un numero di duetti napolitani, che intercalavamo allo spettacolo. Riuscii poi ad essere tanto simpatico alla famiglia Scritto, da acquistarmi la loro fiducia e mangiare con essi, prendendo parte attiva alle loro faccende. Il mio pensiero per Nicolina acquistava però sempre più consistenza ed evidenza, finché la cosa diede fastidio in famiglia ed un fratello maggiore di Nicolina, a nome Gaetano, una sera mi chiamò e mi fece intendere che avevo finito, perchè io ero uno spestato e non potevo ne dovevo più oltre continuare. Addio amore!... addio mezza lira!... *** Pensai che l’arte non era per me; m’impegnai come «ragazzo» in una bottega: vi resistetti per una settimana, dopodiché scappai via per scritturarmi in vari teatri quale canzonettista. Un bel giorno la Compagnia Bova e Carmerlingo scritturò [mia sorella] Luisella e me, con la paga di 12 lire serali, per una tournée in Alta Italia. Si viaggiava in tre (c’era anche mia madre) ed a Spezia la Compagnia non piacque. Passammo allora a Roma, per finire a Civitavecchia. Qui una colletta servì pel ritorno di tutti quanti, ma io, che vedevo a Napoli la miseria nera, non volli andarmene. Mi ingaggiai al concerto Eden, sostituendovi Ettore Petrolini, e debuttai come comico macchiettista. Allora l’Eden era in via della Scaletta, agiva col giro del piatto, ossia ogni artista, dopo lavorato, girava la sala col piattino e quello che faceva se lo pigliava. Io però che avevo la paga fissa rimasi assai male, quando dopo il debutto che andò assai bene, feci in una serata sola (di parte mia, in cinque giri) ben 13 lire e 40, soldi che dovetti consegnare all’impresa perchè scritturato a paga fissa. Fu così che dato il successo e dato il guadagno io divenni il «pupillo» del proprietario e la paga salì a 4 lire serali, e di più la sorella del proprietario, che faceva la lavandaia, mi lavava gratis quella poca roba che formava il mio corredo di biancheria. Passarono così tre mesi, quando il locale venne chiuso dalla Questura; le poche canzonettiste presero vie diverse ed io rimasi solo e disoccupato con sedici lire in tasca. Andai in Questura per farmi rimpatriare. Qui il funzionario mi disse che non si usava più dare il viaggio a meno che si trattasse di qualche delinquente; ma poiché nulla mi consigliava ad improvvisarmi delinquente, così dissi: - Se l’uso si è tolto, si rimetta per me; io mi trovo lontano da Napoli e non posso tornare a piedi in famiglia, soldi non ne ho, né posso rubare! Questo linguaggio fermo e persuasivo intenerì il funzionario di servizio il quale telefonò subito alla Questura di Napoli per chiedere informazioni sulla mia persona, e per sapere se la mia famiglia era o non in condizioni di potermi mandare i soldi per il viaggio. Così lo salutai e feci per andar via, ma fui preso alle spalle da una guardia e, alla mia sorpresa, il funzionario fece capire che io rimanevo sotto tutela della Questura... fino a che non arrivassero le informazioni da Napoli e poiché a Civitavecchia non vi erano camere di sicurezza, fui accompagnato al «Bagno Penale»! - Come, al Bagno Penale? - E non vorrai venire a casa mia! - mi rispose il funzionario; e montai su di un carro cellulare e mi avviai al Bagno! Discesi pallido e stordito: avevo tredici anni! Mi portarono prima per una piccola porticina di ferro nella camera di una guardia carceraria, mi tolsero i soldi, i lacci delle scarpe, le fibbie del gilet, le bretelle, mi diedero una pagnotta di pane bruno, e mi fecero passare per una porta più grande. Quando questa si chiuse dietro le mie spalle, provai un brivido di freddo che non ho mai più dimenticato. In un ampio cortile giù, lavoravano i condannati. Vi erano mobilieri, calzolai, sarti ecc... era una piccola città operosa, nella quale regnava il massimo silenzio. Tutti mi guardarono con curiosità, ed io guardavo loro con occhio vago e spaurito... chi sa che pensarono di me! Salimmo tre tese di scale e fui rinchiuso in una cella, solo! Ero troppo piccolo per essere messo con altri... si doveva salvaguardare la mia incolumità. Il pane non andava giù... passò un secondino con un cavalletto ed un grande registro sopra, che chiedeva cella per cella che cosa il detenuto voleva gli fosse comprato. Giunto a me, io dissi che coi miei soldi, lasciati alla porta, mi avessero comprato del pane buono e del salame. Ma ahimè, la roba ordinata si riceveva un giorno dopo e poiché era persuasione che la cattura durasse poche ore dissi di non voler niente. Pensavo: «Esco e me lo compero io...» Macché: venne la sera e la mia chiamata non veniva; ed io cominciai a piangere. Le ore mi sembravano eterne. La notte mi accoccolai sopra il pagliericcio e cercai di dormire, ma mille paurosi fantasmi mi tormentavano lo spirito e le carni. Di botto, un guardiano aprì la mia porta, spalancò la finestra e cominciò con una mazza di ferro a fare la visita alla cancellata, mentre il freddo denso maggiormente mi faceva aggrinzire. Dopo di aver battuto anche i muri, il guardiano con la lanterna in mano si allontanò senza chiudere però la finestra, ed io che tremavo di paura e di freddo mi buttai dal pagliericcio e con i piedi scalzi sul selciato gelido, andai a chiudere; ma dopo un paio d’ore da capo il guardiano, e così per tutta la notte. All’alba, quando stavo per chiudere gli occhi, rinfrancato dalla luce che mi veniva dall’alto, e vinto dalla stanchezza, fui chiamato dalla guardia carceraria: «Sveglia!». Erano le cinque! Dovetti arrotolare il pagliericcio per mettere il letto in ordine. Tre giorni, tre lunghi giorni, in quelle sofferenze. Veniva il secondino col registro, ed io ripetevo il solito errore: - Oramai, a momenti esco e me lo compro da me! Tre giorni nelle condizioni più tragiche, tre giorni di pianto, di sconforto; le lagrime mie intenerirono financo i miei colleghi, ma non riuscirono a commuovere una guardia carceraria che dirimpetto proprio alla mia cella mangiava certi maccheroni col ragù, che spandevano un odore svenevole, ed io dalla cella, affamato, guardavo, e quello mi vedeva e continuava a mangiare, non curandosi che a pochi passi un’anima soffriva, ed un piccolo stomaco languiva! Finalmente venne il fonogramma da Napoli, fui liberato ed ebbi 35 soldi, come piccole spese durante il viaggio. Mi portai poi anche un ricordo del bagno, un paio di scarpe che pagai 11,50 e che portai tre anni, tanto erano «forzate» anch’esse! Così si chiuse la mia prima tournée nell’Alta Italia. A Napoli i miei compagni mi domandavano vedendomi : - Da dove vieni? - Da Civitavecchia... - Hai fatto successo? - Eh... - Come è il locale? - Magnifico!... (…) Io, il varieté e la belva L’arte del varieté è un’arte specialissima. Chi ve la insegna? L’ambiente stesso, il pubblico, ed il pubblico è il più gran maestro. S’impara da sé, per propria esperienza. Pensate all’intelligenza condensata di un artista di varietà che ha pochi minuti per poter svolgere il suo «numero» e in quei pochi minuti deve convincere. Quando un comico del varieté dal solo modo di annunziare la prima «cosa» che fa, non riesce a suscitare una risata o a incatenare la generale attenzione, va incontro al quasi insuccesso. Dopo la prima strofa del suo tipo o della sua canzone, deve correre per la sala un mormorio di approvazione, una folata di consenso, mentre la musica ripete l’introduzione daccapo. Quando l’artista non ha ottenuto questo, ha perduto già terreno, ed il pubblico del varieté, addestrato all’immediatezza, rimanendo freddo dopo la prima parte, comincia ad essere disattento: e per interessarlo e scuoterlo, l’artista deve subito prodursi nel suo pezzo migliore di maggiore successo e spessissimo accade che, quando il pubblico non è preso subito, non si lascia prendere più. L’arte del varieté perciò è immediatezza e sintetismo; è il pugno nell’occhio bene assestato prima di dare al pubblico tempo di riflettere. Furono e saranno ben pochi gli artisti che nel varieté poterono far pensare. Molti noti strofaioli comici ebbero i loro grandi successi per la velocità della loro parlantina con la quale dicevano una infinità di cose banali; ma il pubblico, per la impossibilità stessa di poterle valutare, data la rapidità con la quale esse si succedevano, alla fine rimaneva più sorpreso che preso e, quell’attimo di disorientamento era sfruttato dal comico per piazzarvi il suo bis. Nondimeno comici di questo stampo raggiunsero larga notorietà e paghe vistose. Quindi arte specialissima quella del varieté, simultanea perché fatta di tante cose agglomerate, in cui accanto al mestiere, al mezzuccio, spesso affiora un guizzo d’arte pura, sintetica, perché a tratti, condotta con pochi tocchi sicuri e la firma... Quando io facevo il varieté, mi definirono soprattutto un futurista, perché facevo una commedia da solo; da solo rappresentavo una folla senza truccarmi, con i soli atteggiamenti e le diverse inflessioni di voce; è vero che io fui un artista singolare, ma pur vero che io ero un artista del varieté. E la mia arte è germogliata là; là si è plasmata, là ho imparato le infinite magagne del palcoscenico e a conoscere il pubblico, a capire, leggendo nell’aria, fiutando nell’atmosfera, se il pubblico era preso oppure no, se mi seguiva con interesse o no. All’attore del varieté non occorre molto tempo per capire se piacerà: gli bastano le prime «battute» per formarsi la convinzione del come passerà. Ecco perché dei grandi attori del varieté ce ne furono pochi e ce ne sono pochissimi, poiché le doti, che il varieté richiede, sono tante che è assai difficile poterle mettere insieme. Il comico del varieté non deve somigliare a nessun altro, né deve ricordare altri: deve avere una figura a sé, un genere a sé, un repertorio a sé; più riesce nuovo, più sorprende, più il suo successo è clamoroso. Deve avere una bella pronuncia e il dono di sapersi truccare con rapidità fulminea, deve essere un auto-direttore perché non è diretto da nessuno e spesso è costretto a improvvisarsi poeta e musicista per crearsi un repertorio nel quale sfruttare bene tutto quello che meglio sa fare, l’udito sensibile alla musica e il dono della comunicativa, per potere trasmettere alla folla quello che si propone di voler comunicare. Il pubblico in genere va prevenuto al teatro, ma al varieté va sfiduciato, specie in materia di uomini, a meno che non sappia di trovarsi davanti a qualche nome di valore indiscusso. Ma il comico giovane fa da costante domatore per domare la belva, — il pubblico — e fui anch’io un comico giovane, ed ebbi anch’io le mie terribili lotte. Al Trianon di Milano, in una matinée sono stato fischiato in un tipo di ubriaco: «La domenica del ciabattino». Dicevo, tra l’altro, nella prosa, mentre mi accendevo la pipa con un fiammifero di legno, per ben tre volte e con diverse inflessioni di voce: - «Ieri sera sono stato al S. Carlo». Ebbene: al Trianon di Milano, non riuscii a dirla la terza volta. Alla seconda volta che la dissi fu un coro di proteste e dovetti smettere. Immaginate se l’avessi detto anche la terza... C’era da farsi arrestare. E perché? Perché il pubblico era mal prevenuto contro il giovane, sapeva di trovarsi davanti a un novellino ed io ebbi il torto di non dare il cazzotto in un occhio, appena uscito, ossia quella qualche cosa che sarebbe valsa a formare l’ambiente. No. Ebbi il torto di presentarmi con un tipo truccato, posato, con sfumature e contrazioni della faccia. Volevo insomma, con un pubblico nuovo, filosofare e far pensare; ma la belva mi assalì di santa ragione e la quindicina terminò, come Dio volle. Tre anni senza tornare più a Milano, tre anni di attesa, nei quali mi ero portato grandemente avanti. Passavo di successo in successo al varieté di Genova, al Maffei di Torino, all’Eden di Napoli, alla Sala Umberto di Roma: guadagnavo dalle duecento alle trecento lire al giorno e Milano era per me la mia spina, e fu così che Bernardo Papa del San Martino nel Febbraio del 1908 mi fece scrivere da Giuseppe Raspantini, offrendomi per soli dieci giorni cento lire serali. Era un pessimo affare per me, ma io volevo la mia rivincita, la mia grande rivincita a Milano e dissi: «Anche gratis». E andai a Milano con mia moglie ed il mio Vittorio, che contava tre anni e mezzo. Grandi annunzi per le vie, enormi litografie, una réclame sbalorditiva. Dissi a [mia moglie] Maria: «Se non piaccio nemmeno adesso, potrò tornarci qui solamente da turista».. Le poltrone, Papa, le portò per quell’occasione, e a quell’epoca, pensate, a trentacinque lire e a quindici lire l’ingresso. Una montatura completa. Tutto il programma era buono, ma niente di notevole. Esso era completamente basato su me che facevo da solo l’intera seconda parte. E con che debuttai? con «La domenica del Ciabattino» (Ieri sono stato al S. Carlo... ). E fu un successo sbalorditivo! E perché? Perché il pubblico sapeva di trovarsi di fronte ad un artista compiuto. Lavorai, ricordo, oltre un’ora e un quarto. La mattina seguente, alle prove, gli habitués che avevano assistito al debutto, congratulandosi, mi chiedevano: - Ma è la prima volta che viene a Milano? - Nossignore: sono stato proprio dirimpetto al San Martino, al Trianon, tre anni fa. - Col medesimo nome? Viviani? - Viviani: - E col medesimo genere? - Col medesimo genere. - Questi tipi che fa adesso? - Quello che ho fatto ieri sera, l’ubriaco: «La domenica del Ciabattino», e al secondo «Ieri sera sono stato al S. Carlo.... » mi hanno zittito... - Com’è possibile? - Eppure, sono mancato tre anni da Milano per questo fatto. - É strano che allora non l’abbiamo capìto. - No, ero io che forse non mi spiegavo bene. Il pubblico è quello che è. È còmpito dell’attore portarlo dove lui crede e farlo applaudire quando a lui occorre. Ed io tutte queste cose non seppi ottenerle e rimasi sopraffatto dalla belva... - Da chi? - Dalla belva, il pubblico - spiegai. - Grazie. E sorridendo, tutti si congratularono. - Grazie per il complimento! E ritornando all’arte, nel varieté essa è maggiormente significativa, perché si esplica in un ambiente poco adatto ad ospitarla; ma quando il pubblico del varieté, che va per distrarsi, è invece preso da qualche cosa che, l’avvince e lo esalta e lo trascina all’applauso, chi ha ottenuto ciò con la forza viva delle sue qualità artistiche, è veramente un artista. La moglie e il mio teatro (…) Messo a posto l’uomo, pensai a migliorare anche l’artista, e in tre o quattro anni diventai uno «stellissimo», guadagnando dalle trecento alle quattrocento lire al giorno. Ma, raggiunta una certa agiatezza, cominciò nell’animo mio ad affacciarsi il bisogno di fare di più e di meglio. I figli, la famiglia, la mia sviluppata consapevolezza mi facevano sentire il disagio del Varieté. Mi urtava il vedermi ancora preceduto e seguito da donne libere; mi pareva di sciupare il mio ideale, e cominciai a pensare fortemente e con rinnovata passione di fare del vero teatro. Nel dicembre del 1918, allorché i giornali tutti facevano la campagna per fare chiudere i Varietés che offrivano uno spettacolo poco edificante ai reduci dal fronte, io colsi la palla al balzo e dissi a me: «Questo è il momento, togliti gli abiti da generale e vestiti da soldato». Mi accodai a tutti gli altri. Ero un ultimo arrivato, la recluta più giovane del grande esercito degli attori italiani. Pensai di creare all’artista quella rispettabilità che avevo saputo dare all’uomo, e condurre a termine tutto un programma di miglioramenti e debuttai al Teatro Umberto di Napoli, con un atto: «’O vico» (il vicolo) scritto da me, improvvisato tra i tipi del mio repertorio legati con un certo filo logico, affinché esso avesse una cotal parvenza di unità. Questo atto unico ebbe un successo insperato. Era il primo costruito con tenue trama, a base folcloristica, quasi un’impressione colorita, che più tardi doveva dare l’indirizzo a tutto un orientamento nuovo di teatro, ora conosciuto per «genere Viviani». Eravamo quattro in Compagnia, e, a forma di zarzuela, ed ogni notte impostavo atti nuovi, si provava due giorni di seguito ed ogni venerdì si rappresentava la produzione nuova a memoria. Così sono nati, settimanalmente, «Nterr’a Maculatella» (Scalo Marittimo) il «Caffè di notte e giorno», «A Cantina ‘e copp’o campo» (osteria di campagna) «Marina di Sorrento», «Porta Capuana», e tanti altri. Attività che segna forse il periodo più vivo e fertile e inventivo della mia carriera. Si capisce che io raccoglievo in pochi giorni la esperienza di anni ed anni di teatro di varietà, ossia quello dall’effetto sicuro e dalla parlata sintetica e spassosa. Ia stampa cominciò a parlare di me, registrando il successo. Il pubblico accorreva in massa al «mio teatro» dove si davano due spettacoli al giorno e tre alle feste, ed io chiusi il primo anno all’Umberto con un attivo di 18 atti scritti e 350 mila lire nette guadagnate, e così per tre anni di seguito. Naturalmente il «materiale macchietta» era finito; io avevo esaurito tutti i miei tipi più noti, li avevo disseminati in tutti questi «atti unici» che su questi tipi si imperniavano, cominciai quindi a lambiccarmi il cervello per scrivere cose di maggiore contenuto, ossia commedie a più ampio respiro. Si trattava, ora, di ricostruire di sana pianta e cominciai ad improvvisarmi commediografo con la medesima sicurezza di quando mi ero improvvisato compositore di macchiette e di quadri impressionistici. Vennero opere organiche, come «Circo Equestre Sgueglia», «Il fatto di cronaca», «Campagna napoletana», «Lo sposalizio», lavori di due o tre atti con figura centrale e con dipinture di ambienti. La mia tournée nell’Alta Italia trovò il pubblico indifferente. Non mi scoraggiai: vedevo che un po’ di terreno lo acquistavo. Alle serate di onore e di addio, recitavo davanti a teatri pieni. Purtroppo, il giorno dopo, ricominciava lo squallore e un lungo periodo di persuasione, fino a che l’ambiente era riscaldato... alla vigilia della mia partenza da ogni città. Anche questa epoca di alternative, grazie a Dio, passò. Fui sorretto dalla critica e scrissi: Pescatori, Don Giacinto, l’Operaio dell’arsenale, abbandonandomi unicamente al mio istinto, alla mia sensibilità. Avevo, come ho, innanzi tutto, il dono di non conoscere l’opera di nessuno, e pochi attori ho avuto occasione di sentire. Quindi vado avanti senza preoccupazioni, penso che tutto si può fare o rifare, mettendovi dentro una propria personalità; nessun pregiudizio quindi per quello che è stato già fatto. Io scrivo e metto in scena con una veduta unica, e sono sicuro che il mio pensiero originale non mi viene modificato passando per le mani del capocomico. La cosa che io rappresento è quella che ho immaginata, che ho elaborata nel cervello, e le sensazioni che riesco a dare sono quelle che pensavo di dover dare. So, prima di andare in scena, il successo che il lavoro otterrà. Non sono mai nervoso ad una mia «prima» poiché capisco che l’interprete non deve essere influenzato dalla responsabilità dell’autore. So scindere le due personalità, anzi le tre aggiungendovi il direttore, e devo a questo fatto se son riuscito a riscuotere intorno al mio nome prima una certa curiosità, mista di scetticismo, e poi il giudizio sereno e pacato della critica. Alcuni critici spesse volte mi hanno detto che Viviani attore deve rappresentare unicamente Viviani autore, se vuole dar cose di sicura riuscita: essi hanno detto una cosa esatta. Come mi trovo nel mio repertorio non mi trovo in quello scritto da altri, salvo rare eccezioni, poiché io scrivendo recito, mi investo della parte che mi assegno, e l’attore spesso è di grande ausilio allo scrittore e qualche volta l’autore offre all’attore di avvalersi di qualche finezza che all’attore sarebbe sfuggita e viceversa: insomma trovo modo di completarmi. Come questo sia venuto maturando nella mia attività, non so. Certo ho passato e passo anni di tormentosa ricerca della semplicità, quasi sempre rinunciando ad un effetto che mi guasti una linea, o mi alteri la freschezza del personaggio che io vivo. Voglio qui ricordare quanto ha scritto sulla mia arte l’illustre e ora compianto scrittore Ferdinando Russo e più precisamente sull’intima natura della mia arte, che molto ha sacrificato per mantenere intatta la propria linea. «Viviani è tutta una folla, una realistica folla plebea, di tipi riprodotti mirabilmente, incomparabilmente, perché studiati nella vita e fra la folla di quel popolo di piccoli eroi e di piccoli delinquenti, nel quale è lo scugnizzo, sia saponariello, sia lieto e spensierato rappresentante della rumorosa gaiezza di Piedigrotta. È un artista di una efficacia terribile, di una evidenza patetica; e non potrà aver seguaci ed imitatori». Se avessi voluto fare dell’arte commerciale avrei oggi certamente il triplo della mia fama e della mia fortuna, ma certamente sarei meno considerato da quelli, che grazie a Dio, formano con il loro severo giudizio la vera cifra di un artista. Se sono contento? No. Penso che vi è ancora molto da fare per la mia arte e per la mia fortuna. (…) Lottatore La lotta mi ha reso lottatore. Dicendo lotta intendo parlare, si capisce, non di quella greco romana che fa bene ai muscoli e stimola l’appetito, ma di quella sorda, quotidiana, spietata, implacabile che ogni giorno si è costretti a sostenere. E la mia vita fu tutta una lotta: lotta per il passato, lotta per il presente, lotta per l’avvenire. Con chi lotto? Non col pubblico, il quale anzi facilmente si fa mettere colle spalle sul tappeto, ma con i mille elementi che sono nell’anticamera, prima di giungere al pubblico. Parlo del repertorio, delle imprese, dei trusts, dei trusts sopratutto. Oggi, come ieri, l’uomo di teatro è in lotta continua coll’accaparramento dei teatri di tutta Italia, i quali sono tenuti e gestiti da pochissime mani, tutte strette tra di loro. Scrivere un’opera bella è cosa possibile, addestrare una Compagnia che reciti senza suggeritore, per poter dare esecuzioni fuse, colorite, è possibilissimo; ma quando si arriva alla scelta delle piazze e dei teatri, si è costretti ad arrestare la marcia e a piegare le braccia. Più che i Dieci di Venezia (parlo dei Dogi) i quattro, o cinque dei teatri (parlo dei managers) vi fanno il buono e il cattivo tempo di un’azienda, la luce o il buio pesto intorno ad un attore. Sicché non è più problema di migliorarsi artisticamente per arrivare alla meta; ma occorre potere scardinare questo blocco granitico, questo baluardo inespugnabile che ostruisce l’ingresso ai pochi teatri redditizi d’Italia. Questa via, io confesso di non averla saputa trovare. Milano, per citare un esempio, è diventata terra straniera per me ed io assisto da lontano, come un innamorato respinto, al succedersi delle Compagnie primarie (ed anche di quelle mediocri) per i teatri milanesi; senza poter portare nella metropoli lombarda il Viviani di oggi con il suo repertorio fresco. Se, di tanto in tanto, busso alla porta, mi si risponde con la medesima forma che per me ritengo sia stata racchiusa in un timbro a secco: «Non c’è posto». Mi accade nel campo del teatro quello che mi accadde nel varietà dopo il Trianon. Ma vivaddio, allora, dopo tre anni di assenza, venne il San Martino a ridarmi quel successo dovuto, ma in quest’altro campo la pausa anziché di tre, come per allora, già si è prolungata in sei anni ed il teatro che mi apre i battenti non si affaccia ancora. Altra lotta, dicevo, il repertorio, che mi costringe a vivere una vita di ricerche, di fatica assidua, per potermi rinnovare. Il pubblico è avido di novità e da me le esige pensate, sensate. Ed io giù, giorno e notte chiudo l’uomo nel camerino di un teatro o in un angolo di caffè o la notte nel mio studio, e gli impongo di scrivere e spesso l’uomo non ha voglia, ma il capo-comico glielo impone; lo scrittore si ribella, ponendo a sua giustificazione che già ha scritto cinquanta commedie e che intende ormai riscattare la sua libertà per vivere solo ed unicamente nei suoi affetti più puri — la moglie, i figli, la casa — ma il capocomico lo acciuffa, gli piega la testa verso il tavolo e grida: «Scrivi, perchè, se tu non scrivi, l’azienda non prospera; il tuo repertorio il pubblico lo sa a memoria. Da te si aspetta del nuovo e del bello; perchè se non scrivi cose belle, soldi non se ne fanno!». E l’uomo amareggiato e spesso stanco riprende a scrivere una sua opera amara; ecco perchè spesso, anche attraverso la facezia comica, vi è, in fondo alle mie scene, un substrato di amarezza: c’é sempre il popolo che parla il suo duro linguaggio della lotta. Poi s’è aggiunta la incomprensione della maggior parte delle platee d’Italia e il peggioramento del gusto artistico. Oggi, tranne poche eccezioni, gli spettacoli si allestiscono a base di frivolezze. Il cinematografo colla sua produzione nord-americana di assai discutibile buon gusto, ha finito per scombussolare i cervelli già per buona parte disorientati, ed allora la lotta tra l’artista ed il pubblico si rende ineguale. Dicendo il pubblico, non parlo di quello che va a teatro, che è il meno, ma della grande maggioranza che a teatro non viene. È irriducibile. Non vi abbatte, ma vi combatte col suo assenteismo, non accorgendosi di voi, per affollare le ampie sale degli innumerevoli iper-cinema ove spesso s’impara a diventar cretini. Di qui una catena di lotte; e non è possibile che siano tutte sostenute dai pochi paladini dell’arte. Essi, oggi o domani, saranno, purtroppo, sopraffatti e schiacciati dal peso stesso del loro sogno. Finiranno per cambiar mestiere o fare un’arte più spicciola, più commerciale, più da cinematografo, per la gioia o per la necessità di vedere, alfine, coronate le proprie fatiche dal necessario incoraggiamento materiale; ed incontrando l’arte genuina per la strada, poter esclamare alfine, a pieni polmoni, con sarcastica parola: «Ti saluto, bagascia!». (…) Come scrivo il mio teatro Non mi fisso sempre una trama, mi fisso l’ambiente; scelgo i personaggi più comuni a questo ambiente e li faccio vivere come in questo ambiente vivono, li faccio parlare come li ho sentiti parlare. Man mano che le figure acquistano corpo e la macchietta diventa tipo, porto la mia fantasia per la via più logica da seguire, a seconda dei loro caratteri, dell’atmosfera creata; le figure, che man mano balzano vive dall’insieme del quadro, pigliano forma di veri caratteri, le porto decisamente in avanti, in primo piano e le distacco dalle figure minori che mi servono poi unicamente per dare sfondo e colore e tra questi personaggi, già definiti in pochi tocchi, io vi creo la favola. Da questo momento il lavoro comincia ad elaborarsi nella mia mente e, portandolo avanti, cerco di far camminare di pari passo lo scrittore e l’uomo di teatro e spesso l’attore non è estraneo alla passeggiata, poiché viene a portare la sua acquisita esperienza nel procedimento di essa, e solo alla metà del primo atto comincio a pensare alla chiusa più logica per il taglio del primo finale. Ecco perché il più delle volte un mio primo atto potrebbe vivere anche da solo e per se stesso, e a ciò si deve se, dopo la prima calata di velario di un lavoro, come nel Fatto di cronaca per esempio, pubblico e critica si domandano: «E che viene adesso se il fatto è finito?» e seguono invece due atti di commento. Un lavoro che vuole essere anche e soprattutto un brano di vita, specie per un teatro dialettale, non può rimanere imprigionato nelle vecchie impalcature di teatro tipo: mentre là vigono e spesso pesano le regole, qui vige unicamente la vita, e il fatto nella vita non è narrato mai per filo e per segno, ma è colto da un occhio attento in mezzo a mille cose che gli vivono intorno, cose buffe, ora liete, ora tristi, ma sempre estranee al fatto. Per me la bellezza di un’opera risiede nei particolari minori, nella fedeltà del quadro, nella gradazione dei toni, nell’amalgama dei passaggi, nel sapore della parlata, nella umanità degli avvenimenti e come questi si snodano. Le creature vive e non letterarie, l’azione fluida e non ordita che prima dei palchi parli alla platea e tagliata al punto giusto. Quando non si ha più che dire, bisogna avere il coraggio di smettere: che importa che il lavoro venga di un atto e mezzo o due atti e tre quarti? Perchè diluirlo? Quando è finito, è finito, altrimenti si perde il contatto col pubblico. È questo il mio metodo, e così, con queste vedute, ho scritto fino ad oggi, in meno di dieci anni, circa cinquanta lavori di uno, di due, di tre atti. Sui due aspetti della mia attività artistica, Lucio d’Ambra ha scritto con felicissimo intuito: «Raffaele Viviana è autore ed attore nel medesimo tempo. Ma credo che Raffaele Viviani autore non scriverà le sue più complete commedie e Raffaele Viviani attore non ci darà le sue più complete interpretazioni se non quando questo autore e questo attore non lavoreranno più, come attualmente lavorano, uno per l’altro. Per ora nessuno dei due, infatti, compie quello sforzo supremo dal quale solamente escono le opere maestre e gli attori magistrali. Scrivendo per Raffaele Viviani attore, il Viviani autore sa di quale interprete di infinite risorse sceniche egli disponga e fida tranquillo in lui ove la commedia gli manchi. Da parte sua Raffaele Viviani attore recitando solo commedie del Viviani, continua a muoversi in un campo in cui già si è esperimentato e non è tratto a quei maggiori cimenti dove o ci si rompe il collo o si va avanti di colpo. In conclusione vorrei, per misurar compiutamente l’uno e l’altro di questi due singolari artisti, una commedia di Raffaele Viviani che fosse destinata ad un altro attore e vorrei che Raffele Viviani interpretasse una commedia che non fosse fatta apposta per lui, abito su misura e su misure ch’egli e noi conosciamo oramai da tempo. L’uno e l’altro hanno bisogno di cercare, in stato di libertà, in un campo diverso da quello in cui l’un l’altro si tengono, servendosi, reciprocamente prigionieri. Questi due gemelli scenici hanno insomma bisogno, per tagliato tra di loro il cordone ombelicale, se posso esprimermi così, della rispettiva adultabilità. «Viviani attore riempie la commedia e il palcoscenico da par suo, cioè da quel mirabile artista ch’egli è, così nell’insieme come nel particolare vivo, immediato, comunicativo, capace di passar di colpo dal riso al pianto e dal grottesco al tragico e nascondendo, l’uno nell’altro, umorista, insomma, di straordinaria efficacia. Certo questo attore, che sa da ogni cosa cavar la materia ed i segni della sua arte, dovrà salire un giorno, perchè così vuole il suo ingegno, dalla macchietta al tipo ed approfondirsi — cioè andare più a fondo — restringendo il suo campo e sostituendo alle risorse le necessità. Intanto egli ci appare ancora e sempre più attore stupendamente vivo da cui bisogna attendersi le maggiori affermazioni comiche e drammatiche. Della spontaneità di cui vivono tutte le interpretazioni del Viviani è fatta l’arte dei temperamenti autentici e degli artisti nati: Raffaele Viviani è di questi ed il suo generoso e nobile sforzo, come autore e come attore, per raggiungere a pieno l’arte e la verità merita sempre più da parte di tutti attenzione, incoraggiamento e rispetto». *** Insomma, io non sono un letterato, sono un sensibile, un istintivo; attingo la materia grezza dalla vita, poi la plasmo, la limo e ne faccio opere teatrali, soffermandomi su quanto mi è rimasto impresso, vivendo la mia infanzia a contatto della folla, della folla varia, spicciola, proteiforme, multanime, pittoresca della mia terra di sole. Il mio teatro è fatto di suoni, di voci, di canti, sempre gaio e nostalgico, festoso e melanconico, non di intrecci e di problemi centrali. Vivifico le mie vicende sceniche sempre con qualche cosa di puramente mio, di inconsciamente mio, se volete, e riuscendo a non rassomigliare a nessuno, penso che questo è il mio maggior merito. Le cose mie non possono rassomigliare a quelle degli altri, perchè fortunatamente le cose degli altri io le ignoro. Mai come in questo caso: Santa ignoranza! «E che faccio adesso, — dovrei chiedermi — se questo lo ha già fatto Tizio in modo stupendo, e quello lo ha già detto Caio in maniera superba?» Mentre io vedo tutto vergine davanti ai miei occhi, campi sterminati da mietere, entro in casa di coloro che conosco, cammino per le vie e pei vicoli da me già battuti, rifaccio la gente a me nota, esaltando il buono, correggendo il cattivo, facendo sistematicamente opera di propaganda e di persuasione per la mia Napoli, che voglio far apparire com’è, in Italia e fuori: culla di sogni d’incomparabile bellezza. Paola Quarenghi SCHEGGE DI NAPOLI1 Le strade di Napoli Il teatro di Viviani nasce dalla sua esperienza, precocissima,2 negli ambienti del varietà e in ogni genere di spettacolo popolare: dal teatro dei pupi, al circo, alle esibizioni a domicilio (le cosiddette “periodiche”), al café chantant. Negli anni dell’apprendistato, lavora in sale come il Teatro Petrella, situato nella zona portuale, un tempo «culla di grandi artisti»,3 ma all’epoca «frequentato unicamente da scaricatori di porto, marinai di velieri, soldati di dogana, popolino del rione e prostitute»,4 o come l’Arena Olimpia, un «baraccone di legno […] frequentato da tutta la malavita»5 del quartiere. Questi ambienti, o altri come il baraccone di Don Ciccio Scritto, che ispirerà la sua prima commedia in tre atti, Circo equestre Sgueglia (1922), non sono solo i luoghi della sua formazione artistica e la palestra dove si allena al rapporto con un pubblico vivacissimo e per niente benevolo che lui stesso definisce “la belva”, ma sono anche un osservatorio dal quale inizia la sua perlustrazione di Napoli, partendo da ambienti che le sue origini, non sottoproletarie ma piuttosto piccolo-borghesi, forse non gli avrebbero mai consentito di frequentare. Il mestiere del teatro, svolto a trecentosessanta gradi, permette a Viviani un’esperienza della vita e della città ricca e promiscua, un’esperienza che alimenterà non poco il suo teatro e la sua produzione d’autore. Non è un caso che egli intitoli le sue memorie Dalla vita alle scene e “Passaporto all’arte” uno dei capitoli che le compongono, facendo coincidere il suo vero battesimo artistico con un’esperienza traumatica patita a tredici anni: tre lunghi giorni di detenzione e digiuno nel bagno penale di Civitavecchia. Rimasto orfano appena dodicenne, Viviani è costretto a lavorare per mantenere se stesso e la famiglia. Analfabeta, impara a scrivere per necessità, per poter creare da sé, prima quelle macchiette e numeri di varietà che lo renderanno ben presto celebre, e poi quei lavori teatrali che prenderanno avvio proprio dal repertorio precedente. Già come artista di café chantant egli manifesta la vocazione per una comicità realistica, intrisa di sentimentalismo e umorismo, che porterà avanti anche nella sua produzione di drammaturgo, una vocazione che è il frutto di una straordinaria capacità di osservazione e di adesione alla vita degli ultimi. La macchietta dello scugnizzo rappresentò, nel 1904, il suo primo grande successo. Non era stata scritta da lui, ma da Giovanni Capurro6 e Francesco Buongiovanni (autori rispettivamente del testo e della musica) per Peppino Villani. Viviani però rinnovò completamente quella interpretazione, facendone un bozzetto di tale dinamismo e forza drammatica da convincere l’altro artista a rinunciarvi. I primi lavori in un atto risalgono al 1917, quando Viviani, approfittando della grave crisi che colpì il teatro di varietà in seguito alla sconfitta di Caporetto,7 decise di 1 Questo scritto è stato pubblicato, in una versione più ampia, nel volume Metropolis. Quaderni di Synapsis IX, Atti della Scuola Europea di Studi Comparati, Pontignano, 8-15 settembre 2008, a cura di Anna Masecchia, Le Monnier, Firenze 2010. 2 Figlio di un vestiarista teatrale, nell’autobiografia Dalla vita alle scene (Cappelli, Bologna 1928, poi Guida, Napoli 1977, da cui si cita), Viviani racconta di avere cominciato a recitare a quattro anni e mezzo, a Napoli, in un teatrino dei pupi di Porta San Gennaro, facendo l’imitazione in miniatura di un tenore comico. A vent’anni è già un affermato artista di varietà. 3 Raffaele Viviani, Dalla vita alle scene, cit., p. 31. 4 Ibidem. 5 Ivi, p. 36. 6 La sua composizione più nota è ’O sole mio, messa in musica da Eduardo Di Capua. 7 Sulle ragioni di questa crisi, cfr. Luciano Villevieille Bideri, Rappresentazioni cronologiche delle passare alla commedia.8 Questa prima produzione, nata, come si è detto, utilizzando e riconvertendo il suo repertorio precedente, costituisce un genere a sé. Viviani stesso non usa, per questi suoi lavori, l’appellativo di “commedia”, ma la perifrasi “Versi, prosa e musica”, che del resto spiega perfettamente la loro natura composita, fatta di dialogo, ma anche di «“numeri”, scenette, melologhi, “macchiette”, canzoni, parodie»,9 mescolati con materiali derivati da quelle che Pasquale Scialò chiama le «radici etnofoniche della Campania».10 È soprattutto in questo tipo di produzione in uno e due atti, che va dal 1917 al 1918,11 che Viviani crea, nel modo più vivido, un ritratto di Napoli e dei suoi abitanti. In lavori come ’O vico (Il vicolo, 1917), Tuledo ’e notte (Via Toledo di notte), ’Mmiez’ ’a Ferrovia (Piazza Ferrovia), ’O buvero ’e Sant’Antuono (Borgo Sant’Antonio), Scugnizzo-Via Partenope, ’N terr’ ’a ’Mmaculatella (Scalo Marittimo), Porta Capuana, ’A cantina ’e copp’ ’o campo (Osteria di campagna), Piazza Municipio, ’O cafè ’e notte e gghiuorno (Caffè di notte e di giorno), questi ultimi scritti tutti nel 1918, egli propone una vera e propria topografia teatrale della città. I lavori hanno per titolo i nomi di strade, piazze, vicoli, borghi. L’atto unico Tuledo ’e notte è addirittura costruito come uno stationendrama, le cui tappe sono rappresentate da luoghi e angoli precisi della celebre strada: l’incrocio col vicolo Berio, il ponte di Tappia, il palazzo della Banca Commerciale, la piazzetta della Trinità degli Spagnoli “sopra i Quartieri”, fino a Largo delle Baracche, luogo dove si praticava la prostituzione. In questi lavori sono rappresentati personaggi, mestieri, figure della Napoli popolare e sottoproletaria: venditori di biada, di fichi d’india, di carne cotta, di pizza, di limoni, di frittelle, di pesci, di castagne, di agli e cipolle, di frutti di mare, di pane e stoccafisso, acquafrescai, caffettieri ambulanti, spazzini, lustrascarpe, capére (pettinatrici a domicilio), ciarlatani, scugnizzi, mendicanti, zingari, straccivendoli, posteggiatori (cantanti di strada e d’occasione), tammurrari (suonatori di tammorra), pazzarielli (banditori), usuraie, strilloni, maschere di cinematografo, guardie, guardiani notturni, camerieri, vetturini, emigranti, marinai, portaceste, facchini del porto, ubriachi, guappi, prostitute. E l’elenco potrebbe continuare. In mezza a questa babele popolare e sottoproletaria si trovano anche, ma assai più rari, alcuni personaggi di borghesi o di aristocratici, costretti da quella singolare promiscuità delle classi che è una delle caratteristiche dei quartieri del centro storico di Napoli, a convivere, loro malgrado, con gli strati più bassi della popolazione.12 Sono piccoli borghesi, “signori scaduti” (che sono passati cioè dall’agiatezza alla miseria, pur dovendo mantenere ancora un certo decoro), aristocratici nottambuli, pieni di tic e di vizi, signori barbuti e signore elegantissime, tutti troppo presi dalle loro faccende di gioco, di denaro o di cuore, per accorgersi della realtà che li circonda. E se devono farci i conti, con questa sceneggiate di maggior successo, in Pasquale Scialò (a cura di), La sceneggiata. Rappresentazioni di un genere popolare, Guida, Napoli 2002, p. 193. 8 Il teatro di Viviani venne pubblicato in volume solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1950. Al 1957 risale l’edizione in due tomi della Ilte di Torino (trentaquattro commedie, a cura di Lucio Ridenti); nel 1987 è uscito invece il primo di sei volumi della pregevole edizione curata per l’editore Guida di Napoli da Guido Davico Bonino, Antonia Lezza, Pasquale Scialò. L’ultimo volume, con una introduzione di Goffredo Fofi, è uscito nel 1994. Questa edizione, oltre a contenere lavori inediti e notizie relative ai testi a cura di Antonia Lezza, propone anche le partiture musicali, con interessanti prefazioni e note di Pasquale Scialò. 9 Pasquale Scialò, La canzone è teatro, in La sceneggiata…, cit., p. 50. 10 Ibidem. 11 Il primo lavoro in due atti di Viviani è Piazza Municipio (Napoli, Teatro Umberto, 8 novembre 1918), il primo in tre atti Circo equestre Sgueglia (Napoli, Teatro Bellini, 29 novembre 1922). 12 Sulla composizione della popolazione di Napoli Renato Fucini scriveva nel 1878: «Sappi dunque che dicendoti tutto quello che ti dirò di questo popolo, intendo soltanto parlarti dell’ultima plebe. In un paese dove i quattro quinti della popolazione sono rappresentati da questo ceto, è naturale che un viaggiatore, il quale, come me, non se ne proponga uno scopo di studio, non veda altro che quello» (Renato Fucini, Napoli a occhio nudo, introduzione di Antonio Ghirelli, nota bio-bibliografica di Leonardo G. Sbrocchi, Einuadi, Torino 1976, p. 17). realtà, è di solito per subirla, come accade al signore scaduto di ’O vico, angariato dai poco discreti avventori del caffè dove si è fermato per una modesta consumazione; o al “signore del baule” di ’N terr’ ’a ’Mmaculatella, raggirato e derubato da furbissimi facchini del porto; o a Don Carlo, il “mezzo signore anziano” dell’atto unico ’O cafè ’e notte e gghiuorno, preso di mira da diversi avventori tra cui un ubriaco assai molesto. In questo atto unico compare anche uno scrittore, del tutto impermeabile al ricco spettacolo che lo circonda, preso com’è dal fuoco di un’ispirazione egotistica, ritratta con ironia implacabile da Viviani. Guappi e prostitute Uno spazio particolare hanno, in questi lavori, le categorie sottoproletarie dei guappi e delle prostitute. Come gli scugnizzi o gli zingari, che vivono “fore paese”,13 anche queste figure marginali non sono un argomento inedito nella letteratura napoletana. Si trovano nei romanzi di Mastriani, nelle opere della Serao, nelle poesie di Ferdinando Russo e Salvatore Di Giacomo.14 Ma in tutti questi autori, sia pure secondo modalità e misure diverse, anche quando l’osservazione è antropologicamente accurata, si avverte una sostanziale estraneità dello scrittore alle tematiche trattate, una partecipazione compassionevole, un’assimilazione di maniera, uno sguardo dall’alto che segna la distanza dai personaggi descritti. In Viviani questa distanza non si avverte.15 Il suo realismo, non convenzionale ma derivato da un’osservazione diretta, può a volte arrivare al sentimentalismo, in qualche caso addirittura al patetico, oppure essere illuminato, come avviene più spesso, da lampi di ironia o umorismo, ma coinvolge sempre anche l’autore (e quindi il lettore e lo spettatore). Nelle disavventure singolari o comuni dei suoi personaggi si riflette la paradossale, casuale, maldestra condizione di ogni essere umano. Secondo Vasco Pratolini, non c’è mai in Viviani quell’«arcadia, che […] piace e rapisce leggendo Di Giacomo», ma che spesso, nei poeti minori, «diventa provincialismo il più squallido»;16 Napoli e la sua gente non sono mai «un pretesto di poesia» (ibid.); nei suoi lavori non ci sono edulcorazioni romantiche, non c’è neppure quel «folclore documentario»17 che si trova nelle opere, pur filologicamente ed etnograficamente accurate, di Ferdinando Russo.18 Secondo Paolo Ricci, Viviani, discostandosi dal folclore documentario e dal verismo, ripudia tutti i luoghi comuni della retorica popolaresca, del colore e del pittoresco sorridente (e 13 Cfr. Zingari, dramma in tre atti del 1926. L’aria ’A caravana, da cui è tratta la citazione, fu ricavata dall’omonima poesia di Viviani. 14 Sull’argomento cfr. Paolo Ricci, Viviani nella poesia e nella vita napoletana, introduzione alle Poesie di Viviani, a cura di Vasco Pratolini e Paolo Ricci, Vallecchi, Firenze 1956, e gli studi di Antonio Palermo: Da Mastriani a Viviani. Per una storia della letteratura a Napoli fra Otto e Novecento, Liguori, Napoli 1972, e Il vero, il reale e l’ideale. Indagini napoletane fra Otto e Novecento, Liguori, Napoli 1995. 15 Paradossalmente, un maggiore distacco e un’ironia più sferzante Viviani li riserva ai personaggi del mondo del varietà (da poco abbandonato), che popolano i suoi primi lavori metateatrali, Eden teatro (1919) e La bohème dei comici (1920), nei quali lui stesso si fa personaggio col nome di Viviani o di Tatangelo. 16 Vasco Pratolini, Avvertenza a Raffaele Viviani, Poesie, op. cit., p. VII. 17 La definizione è di Paolo Ricci, Viviani nella poesia e nella vita napoletana, cit., p. XIX. 18 A Ferdinando Russo (1866-1927) (ma già prima di lui a Francesco Mastriani) si deve comunque il merito di avere allargato, secondo gli orientamenti del naturalismo francesce, il terreno della sua ricerca di scrittore-antropologo a figure e ambienti in buona parte fino ad allora ignorati dalla letteratura. Secondo Nicola De Blasi a lui si dovrebbe, fra l’altro, l’introduzione del termine “scugnizzo”, assente nella letteratura napoletana fino all’ultimo decennio dell’ottocento e poco o nulla utilizzato anche nel parlare comune. Cfr. Nicola De Blasi, Testimonianze per la storia di “scugnizzo”, probabile neologismo di fine Ottocento, «Lingua e stile», anno V, n. 2, dicembre 2006, pp. 229-54. lacrimoso). Egli era estraneo alla cultura positivistica da cui prendeva le mosse l’estetica verista. Era estraneo, nel contempo, al moralismo piccolo borghese, che caratterizzava anch’esso la produzione letteraria, poetica e teatrale del verismo nostrano, era infine estraneo all’intenerimento dei decadenti e dei crepuscolari. (Paolo Ricci, introduzione citata, p. XXXVIII) In lui non c’è alcuna nostalgia di un passato idealizzato, c’è invece attenzione ai dati storici e antropologici concreti, alla «vita attiva, appassionata, difficile e spesso eroica del popolo napoletano» (ivi, p. XXVI). E tutto questo è reso attraverso un linguaggio teatrale che, senza alcuna preoccupazione per i problemi dello “stile”, si serve, per esprimersi, di qualunque mezzo: dialoghi in prosa, versi, atletismi, voci di strada, canzoni popolari, canzonette d’importazione, musica colta; il tutto mescolato, a dar vita a un genere che è, insieme, tragico e comico, realistico e vaudevillesco, ironico e patetico, non letterario ma squisitamente teatrale. Per capire come Viviani tratta i suoi personaggi basterebbe analizzare i guappi e le prostitute del suo repertorio. I suoi camorristi19 non sono gli spavaldi eroi, pronti di mano e di coltello ma rispettosi di un loro codice d’onore, descritti in modo un po’ idealizzato da Ferdinando Russo.20 Sono “guappi di cartone”,21 povere creature segnate dalla vita, attaccate a un’immagine di sé che non corrisponde più a niente e che anzi, alla prova dei fatti, rivela tutta la sua natura di stereotipo “letterario”. Ferdinando ’o Cane ’e presa di ’O vico è un povero guappo che uscendo di galera scopre che la sua donna si è messa con un altro, più giovane e prestante di lui, e nonostante le minacce e il soprannome terribile,22 per sfogare la sua rabbia non riesce a far altro che divorare un biglietto vincente del lotto, un biglietto che avrebbe potuto finalmente togliere dalla miseria Mastu Rafele, portinaio-ciabattino, e sua moglie. Filiberto Esposito di Tuledo ’e notte è un guappetto tisico: si dà arie da “uomo di rispetto”, a parole minaccia, ma alla prova dei fatti cerca con ogni mezzo di sottrarsi allo scontro. Solo gli occhi innamorati della sua “protetta”, Ines, detta Bammenella, che si prostituisce «p’ ’o fa’ cumpare’» (per fargli fare bella figura), per comprargli le medicine e per salvarlo dalla galera, possono vederlo per quello che non è. È proprio 19 Il tema ha avuto grande fortuna nella letteratura, nel teatro, nel cinema, nella canzone. Sull’argomento Paolo Ricci scrive: «Nella letteratura popolare l’eroe guappesco ebbe il suo ruolo preminente, e spesso fu un ruolo positivo; del protettore dei deboli, del riparatore delle ingiustizie. Lo stesso Mastriani collocò spesso il “guappo” tra gli eroi positivi dei suoi romanzi; senza parlare poi di Federico Stella e del teatro San Ferdinando. Negli anni della formazione di Viviani la camorra era in via di dissoluzione e assumeva sempre più il carattere di pura e semplice associazione a delinquere» (Paolo Ricci, Viviani nella poesia e nella vita napoletana, cit., p. XLV). Viviani ha dedicato a questo tema, oltre a diversi lavori teatrali, anche la raccolta Canti della guapparia, in Raffaele Viviani, Poesie, cit. Molto di questa produzione poetica è poi stato trasferito, come si sa, nel suo teatro. 20 Al tema della camorra Russo ha dedicato diversi lavori: tra gli altri, la raccolta di sonetti Gente ’e malavita (Luigi Pierro, Napoli 1897), il romanzo Memorie di un ladro, uscito a puntate sul «Mattino» nel 1905, poi in volume da Treves nel 1907, i sonetti ’A camorra, pubblicati assieme all’inchiesta di Ernesto Serao, Origini, usi, costumi e riti dell’annorata suggietà, Bideri, Napoli 1907. Quest’ultimo lavoro, considerato un classico sull’argomento, è stato ripubblicato nel 2009 da Imagaenaria (Ischia). Una raccolta delle poesie di Russo, dal titolo Cronaca nera (’E scugnizze, Gente ’e malavita, La camorra, Poemetti napoletani) è comparsa nel 1962 da Bideri, con un saggio critico di Paolo Ricci, Ferdinando Russo, il verismo e la fedeltà al “documento umano”. 21 Il guappo di cartone è il titolo di un lavoro in tre atti di Viviani, andato in scena a Padova, al Teatro Garibaldi, il 12 gennaio 1932. In realtà, le figure alle quali si fa qui riferimento sono quelle della prima produzione di Viviani. Nelle opere successive, più legate a schemi drammaturgici regolari, questi personaggi acquisteranno una maggiore complessità: si pensi al Putiferio, guappo “scartellato” (gobbo) dell'omonima commedia del 1927, che vuole ritirarsi a vita privata per mettere su famiglia, o, appunto, al protagonista di Guappo di cartone, che, tornato dal confino, non riesce a trovare lavoro a causa del suo passato e cerca in tutti i modi di sottrarsi al ruolo di “uomo di rispetto” che la sua stessa comunità vorrebbe imporgli. 22 È il portinaio Rafele a spiegare il soprannome di Ferdinando: «’O chiammavano ’O cane ’e presa, pecché s’appiccecava senz’arme... ah! (fa l'azione di mordere) A morze!» [Lo chiamavano il cane da presa perché si batteva senz’armi... A morsi] (’O vico, in Raffaele Viviani, Teatro, cit., vol. I, p. 65). dal racconto-canzone di Bammenella, struggente e comico, che emerge la paradossale relazione fra i due: lei, che è molto più intelligente e generosa, in grado di trovare una soluzione per qualunque problema, accetta tutto da lui, botte comprese, per amore, certo, ma anche per coltivare l’illusione di avere accanto a sé un “uomo di rispetto”, che la protegge e la fa rispettare. Solo che invece di battersi per lei, Filiberto non sa fare di meglio che batterla.23 La situazione di Ines-Bammenella non è molto diversa da quella di Celeste, la prostituta di ’O cafè ’e notte e gghiuorno, che sa di non poter accettare le profferte di Luigino, un giovane che ha perso la testa per lei e sarebbe pronto a sposarla e a lasciare la brava ragazza con la quale è fidanzato. Celeste vive come un destino ineluttabile la sua relazione con Tore, «tipo di malvivente, distinto e gelido»,24 che la tratta come una schiava, non ricambia il suo amore e le rende «morze pe’ vvase»,25 morsi in cambio di baci. Cosa salva queste figure dal patetico stereotipo della donna di strada, di buon cuore, dal destino segnato? Qual è il legame che esse riescono a stabilire con lettori e spettatori sideralmente distanti dalla loro condizione materiale, ma che finiscono per identificarsi con loro? Per Celeste la spiegazione potrebbe consistere nella lucidità con cui riconosce la propria condizione, pur senza riuscire a cambiarla; o forse nel coraggio con cui rifiuta il salvagente offertole da un uomo che, per amor suo, butterebbe a mare un’altra creatura. Per Ines-Bammenella potrebbe essere la generosità, l’intelligenza, l’energia con cui affronta, per amore del suo uomo, tutte le situazioni, anche se non riesce a usare nemmeno una delle doti che possiede per salvarsi da lui. E per Margherita, la prostituta che canta uno «stornello triste»26 in Tuledo ’e notte? Cos’è che fa di questa figurina appena abbozzata, che pronuncia solo poche battute, un personaggio che si fissa nella nostra immaginazione, una creatura nella quale possiamo riconoscerci? In fondo, di lei non sappiamo nulla, se non che è «bruna, dai grandi occhi espressivi», che non sta bene di salute (Leopoldo il caffettiere le chiede come sta e lei risponde: «Nu poco meglio...»), che il suo uomo è in carcere. Sono forse il suo senso dell’umorismo, la sua capacità di non piangersi addosso nonostante tutto che ci avvicinano a lei, che ci fanno provare per lei un moto di simpatia? Certo Viviani è particolarmente abile nel creare un personaggio con poche battute, una didascalia, un gesto. Ma forse ciò che dà vera forza teatrale a queste figure è che l’autore ne fa, anche se solo per la durata di una scena, delle protagoniste. È soprattutto attraverso la voce che questi personaggi si fissano nella mente dello spettatore (o del lettore, che poi è uno spettatore dell’immaginario), una voce che non parla, ma canta.27 23 Cantato sulla musica della Valse brune: «E tutt’ ’e sserate, / chillo m’accide ’e mazzate! / Me vò nu bene sfrenato, / ma nun m’ ’o ddà a pare’!» [E tutte le sere / quello mi ammazza di botte. / Mi vuole un bene da morire, / ma non lo dimostra!] (Tuledo ’e notte, in Raffaele Viviani, Teatro, cit., vol. I, p. 108). 24 ’O cafè ’e notte e gghiuorno, in Raffaele Viviani, Teatro, cit., vol. II, p. 219. 25 Ivi, p. 205. 26 «Comme ’a fronna / ’a n’albero caduta / sta vita s’è perduta / dint’a ll’oscurità. / Volo e corro / cu ll’anema scuntenta / addo’ mme porta ’o viento, / sbattendo ’a ccà e ’a llà!» [Come la foglia / caduta da un albero / questa vita si è perduta / nell’oscurità. / Volo e corro / con l’anima scontenta / dove mi porta il vento, / sbattendo qua e là] (Tuledo ’e notte, in Raffaele Viviani, Teatro, cit., vol. I, p. 106). 27 Per trovare una figura analoga, che abbia la stessa forza drammatica, bisognerà guardare, dieci anni più tardi, alla Jenny dell’Opera da tre soldi di Brecht-Weill, anche in questo caso un personaggio che si esprime più col canto e col gesto che col dialogo. L’accostamento tra l’opera di Viviani, da un lato, e il teatro espressionista tedesco e brechtiano, dall’altro, è proposto da Paolo Ricci in un celebre saggio: Ritorno a Viviani, prefazione di Carlo Bernari, Editori Riuniti, Roma 1979 e, in modo più sfumato, da Vito Pandolfi: «Nei lavori di Viviani il canto ha la stessa funzione di acme, di crinale nel corso della parabola drammatica, che assumerà più tardi presso Brecht» (Vito Pandolfi, Raffaele Viviani, in Letteratura italiana, vol. III, I contemporanei, Marzorati, Milano 1969, p. 136). La relazione con l’espressionismo, basata secondo Ricci sul legame comune col teatro di varietà, è storicamente difficile da provare, e forse la ragione per cui Ricci la proponeva negli anni settanta (rivalutare e far uscire da una dimensione provincialistica l’opera di questo autore) è oggi in buona misura superata. Cristina Se si cercano figure analoghe a quelle di Viviani nel teatro italiano a cavallo fra otto e novecento, ci si imbatte in personaggi molto più legati alla tradizione ottocentesca del naturalismo o del verismo, movimenti la cui carica eversiva si spegnerà ben presto nel secolo nuovo. Un esempio può essere tratto dall’opera di Di Giacomo. La figura della prostituta Cristina, detta “la Capuana”, è al centro del suo primo dramma, ’O voto (1889), e della novella omonima da cui è tratto.28 Parlare di questo personaggio come della protagonista del dramma è in realtà improprio. Cristina è piuttosto oggetto delle scelte del protagonista maschile, Don Vito Amante, tintore malato di tisi, che, per ottenere la guarigione, fa il voto di redimere una prostituta sposandola.29 Ma il suo voto risulta subito imperfetto. Come gli fanno notare le donne che hanno assistito alla sua pubblica promessa, Don Vito dimentica di perfezionare il suo impegno portando i ceri di rito al Crocefisso del vicolo e trascura di fare l’elemosina alla mendicante cieca.30 Sono i primi segni di una volontà incostante, di una decisione maturata più per il terrore della malattia e della morte che per un atto di vera fede. Non passerà molto tempo, infatti, prima che, pressato dalla madre e dall’amante (Donn’Amalia, sposata a un altro uomo), egli dimentichi la sua promessa e abbandoni Cristina “la Capuana” al suo destino. Delle tre figure femminili del dramma, quella della prostituta risulta in realtà la meno incisiva.31 Coll’abilità letteraria che gli è consueta, Di Giacomo disegna nella novella, con pochi tratti sicuri, un ritratto di donna più riuscito di quello della versione teatrale, dove il personaggio ha ovviamente una possibilità di esprimersi attraverso il dialogo che non compensa però l’assenza delle icastiche descrizioni dell’autore. Di Cristina restano nella mente non tanto gli argomenti (piuttosto scontati e privi di ragioni storicamente determinate32), ma il carattere poco battagliero, 28 Il dramma (“scene popolari napoletane” in tre atti), il cui titolo originario era Malavita, venne scritto in collaborazione con Goffredo Cognetti, poi pubblicato col nuovo titolo nella raccolta del Teatro, R. Carabba, Lanciano 1910. La novella comparve nella raccolta Rosa Bellavita (Pierro, Napoli 1888). Al tema della prostituzione Di Giacomo dedicò il volume La prostituzione in Napoli nei secoli XV, XVI e XVII. Documenti inediti con cinquanta illustrazioni, R. Marghieri, Napoli 1899 (ripubblicato da Il Delfino, s.l. 1968 e La gazzetta di Napoli, Napoli 1994). Sulle figure femminili di Di Giacomo cfr. il saggio di Barbara de Miro d’Ajeta, I personaggi femminili nel teatro di Salvatore Di Giacomo, in Salvatore Di Giacomo settant’anni dopo, atti del Convegno di Studi 8-11 novembre 2005, a cura di Elena Candela e Angelo R. Pupino, Liguori, Napoli 2007. 29 Questo tipo di voto non è una singolare bizzarria del personaggio. Nel suo ancora attualissimo reportage La miseria in Napoli, pubblicato nel 1877, Jessy White Mario, riferendo un’informazione fornitale da un Ispettore dell’Ufficio Sanitario della città, scrive: «Egli mi disse un giorno: “Spesso, e in passato ancora più d’adesso, giovani del basso popolo innalzavano voti a San Gennaro per ottenere certi favori, cioè la guarigione di una malattia o certi guadagni, per isposare una trovatella o una prostituta”». E continua: «E ogni volta che ciò accade, e l’Ispettore osservò la condotta di parecchie di tali spose, gli venne provato che esse divengano [sic] mogli esemplari, e sono di una tale severità con le proprie figlie quale non si riscontra in altre madri del basso ceto» (Jessy White Mario, La miseria in Napoli, Le Monnier, Firenze 1877, p. 42). 30 Questo aspetto, in realtà, è più sottolineato nella novella che nel dramma. 31 Al personaggio della madre e soprattutto a quello dell’amante, entrambi appena abbozzati nella novella, sono riservate nell’opera teatrale scene di forte impatto drammatico. 32 Ellittico, rassegnato, e quasi onirico è il racconto che Cristina fa a Vito sul suo passato: «Che v’aggia di’?... V’aggia di’ ca io ’a nu mese mme trovo fora d’a casa mia, ca pò essere c’ ’a casa mia nn’ ’a veco cchiù, c’ a me tutto chello ca mm’è succieso me pare nu suonno? [...] Io so’ stata trattata malamente ... pur’ ’a patemo ... cu tutto c’ ’a notte ’o senteva ... chiagnere int’ ’o suonno... Basta! Chesta è ’a vita mia ... Simmo venute ’a Capua io e n’ata ... Chest’ata l’aggio sperza ... nun saccio addò sta cchiù pur’essa ...simmo arrivate ’e notte ... Uh, Giesù Giesù! A me mme pare nu suonno!... » (’O voto, in Salvatore Di Giacomo, Il teatro e le cronache, a cura di Francesco Flora e Mario Vinciguerra, Mondadori, Milano 1946, pp. 57-58). Il dramma, oltre che alla novella omonima, si ispira probabilmente anche al racconto l’atteggiamento sottomesso e la inevitabile rassegnazione che segue l’abbandono da parte del promesso sposo, una rassegnazione appena turbata dall’invettiva contro il Cristo del vicolo: [...] Leva le braccia e sbatte palma a palma, restando con le mani alte e congiunte. Giesù Cristo mio!... (dopo un breve silenzio) Tu ’o ssaie chello c’ aggio sufferto... Tu ’a saie sta vita mia, Cristo ncroce!... E ssi’ tu ca mme ce faie turnà!... Si’ tu!... (Col braccio destro levato e quasi minaccioso verso il Crocefisso) Io mme vulevo salvà! Io aggio fatto ’e tutto pe mme salvà!... Tu nun buo’?... Tu nun buo’?... [...] E accussì sia!...» (’O voto, in Salvatore Di Giacomo, Il teatro e le cronache, cit., p. 136) Cristina è una figura che non riesce a sbocciare teatralmente, a uscire dal bozzolo letterario, pur pregevole, in cui è involta. E del personaggio restano nella mente soprattutto alcune immagini più pittoriche che teatrali: una rosa lasciata cadere ai piedi di Don Vito Amante dalle persiane appena socchiuse della “casa”;33 l’ombra di lei sulla vetrata del basso in cui si svolge la scena madre del II atto fra Vito e Amalia; il gesto, troppo teatrale, delle mani alzate sbattute palma a palma, a metà tra la preghiera e l’invettiva, rivolto al Cristo del vicolo che non ha voluto salvarla; l’ineluttabile ritorno alla “casa” con cui si chiude il dramma: Corre alla porticella della mala casa e vi picchia col sasso due, tre volte, forte. Una donna s’affaccia di sotto alla persianella della casa. Uh! È Cristina! Crestinella!... Saglie! Saglie! La porta si spalanca. Cristina s’arretra, inorridita. Poi fa un passo verso la porta, si trascina quasi, cade quasi in ginocchio sui gradini che precedono la porticella. Si copre la faccia. S’ode il suo singhiozzo. Finalmente, a tentoni, ella entra. La porta si richiude, sbattendo. Marianna la cieca resta impiedi, tremante, muta, nel silenzio, sotto il Crocefisso. Nel lontano un romore di canti che a poco a poco muore. Cade lentamente la tela. (Ivi, p. 137) Filumena Filumena Marturano, protagonista dell’omonima commedia di Eduardo (1946), non cede alla rassegnazione come Cristina “la Capuana”, non si esprime col canto come le prostitute di Viviani, ma conosce alla perfezione l’equilibrio fra parola e silenzio. Stavolta è lei la protagonista assoluta del dramma, non solo perché questo porta il suo nome, ma perché sono le sue azioni, i suoi stratagemmi (come la finta agonia, architettata per strappare un matrimonio in extremis), le sue rivelazioni sconvolgenti e i segreti mantenuti ad ogni costo, che mandano avanti, un colpo di scena dopo l’altro, la commedia. Se di Cristina non sappiamo quasi nulla se non che ha lasciato Capua per Napoli («Accussì nun ce fosse venuta!»34), se delle prostitute di Viviani possiamo immaginare, ma non conosciamo la storia e le ragioni che le hanno portate sulla L’ignoto, comparso nell’omonima raccolta pubblicata da Carrabba, Lanciano 1920. Vi è descritta la vicenda di una giovane capuana, Letizia, che, sedotta e abbandonata, una sera, con l’aiuto di un mezzano, fugge da Capua per cercare fortuna a Napoli. Nel suo viaggio Letizia non è sola, ma è in compagnia di un’altra giovane, Marta, sedotta e abbandonata, dopo di lei, dallo stesso uomo. Unite dalla sventura, le due ragazze cercano conforto l’una nell’altra e si promettono solidarietà reciproca, ma una volta arrivate a Napoli, verranno separate dalla folla e Letizia si troverà sola ad affrontare “l’ignoto”. Il racconto, molto suggestivo, può essere letto come un antefatto di cui, nel dramma, non restano che pallide tracce. 33 La lettura di questo lavoro di Di Giacomo evoca le opere pittoriche di Antonio Mancini, Vincenzo Irolli, Luca Postiglione, ma sopratutto di Gaetano Esposito e Vincenzo Migliaro. Sull’argomento si vedano i bei volumi curati da Franco Carmelo Greco La pittura napoletana dell’Ottocento di Franco Carmelo Greco, Mariantonietta Picone Petrusa e Isabella Valente, Pironti, Napoli 1993 e La scena illustrata: teatro, pittura e città a Napoli nell'Ottocento, Pironti, Napoli [1995]. 34 ’O voto, in Salvatore Di Giacomo, Il teatro e le cronache, cit., p. 131. strada,35 di Filumena sappiamo come quando e perché è finita in quella casa dove il ricco Domenico Soriano l’ha trovata e da cui l’ha tolta, venticinque anni prima, per farne la sua mantenuta. È la stessa Filumena a raccontare, in un drammatico monologo, come quella scelta sia stata dettata dalla miseria e dalla mancanza di alternative. Certo la sua condizione ora è migliore di quella della Cristina di Di Giacomo o delle prostitute di Viviani, ma è sempre soggetta all’arbitrio di un uomo, che infatti ha deciso di “liquidarla” per sposare una donna più giovane e, almeno in apparenza, più rispettabile di lei. Ma ciò che Filumena vuole da Domenico Soriano non è solo la propria sicurezza, è molto di più: vuole un cognome da dare ai tre figli che ha avuto in segreto da tre uomini diversi quando ancora stava nella “casa”. Uno di quei tre giovani, e Filumena non dirà mai quale, è figlio di Domenico Soriano. Dopo una battaglia combattuta senza esclusione di colpi, alla fine riuscirà a raggiungere il suo scopo, a cancellare dai documenti dei tre ragazzi l’infamia di quel segno, NN (nomen nescio) e a fare di Domenico non solo un padre, ma un uomo. La commedia ebbe un grande successo, ma gli inganni, i segreti, i sotterfugi di Filumena scandalizzarono la parte più benpensante del pubblico e della critica, che vide in essi l’esercizio di una discutibilissima “arte di arrangiarsi”. Questo il commento di Francesco Bernardelli, all’indomani del debutto a Torino: Quella donna di malaffare, quell’ospite di bordello, quella truffaldina che organizza il colpo della finta morte per carpire il matrimonio a un tale che non sarà galantuomo, ma che l’ha sottratta alla vita infamante e la mantiene da venticinque anni, quella donna che, ingrata e briccona, non solo tenta di appioppare al poveraccio tre figli che le fecero, in una sosta di cinque minuti, chi sa quali clienti fuggitivi, ma ci riesce con un ricatto perfido, mettendogli in cuore un’ansietà senza scampo, un dolore sottile, «uno è figlio tuo ma non ti dico qual è», questa donna sarebbe la “madre” in una nuova rettorica? Questa sarebbe la scoperta di Eduardo? (Franceso Bernardelli, «La Stampa», 3 aprile 1947) Anche un critico fino ad allora vicino all’autore come il veneto Eugenio Ferdinando Palmieri, mascherando dietro il giudizio estetico un evidente disgusto morale, poteva scrivere: Questa Filumena Marturano è una commedia, in senso estetico, ripugnante. La famosa abilità dell’autore non riesce a nascondere il trucco: e noi assistiamo irritati a una squinternata progressione di episodi bassamente astuti. [...] Filumena Marturano è un inganno maldestro e irritante, un imbroglio, appunto, disgustoso. Elevato a norma l’arbitrio, l’autore tenta di gabellare per umana una vicenda che è tutta, dall’avvio assurdamente pulcinellesco al finale violentemente costretto, una successione di pretesti palesi, di gherminelle scoperte. [...] Commedia insopportabile. (E.F.P. [Eugenio Ferdinando Palmieri], «Il Tempo», edizione di Milano, 15 aprile 1947) Col personaggio di Filumena, però, Eduardo mostra non solo le ragioni sociali che sono alla base della cosiddetta “arte di arrangiarsi”, ma ne rovescia il senso, va oltre la superficie pulcinellesca e rivela quanto questi comportamenti, esercitati in gran parte per fini altruistici e non egoistici, siano ben altro che una comoda scappatoia al faticoso mestiere di vivere, ma rappresentino piuttosto il massimo del sacrificio (un sacrificio non condiviso), impongano una tensione continua superiore a qualunque fatica. È lo stesso Domenico Soriano a descrivere, senza comprenderne il senso, la situazione di Filumena: Un’anima in pena, senza pace, maie. Una donna che non piange, non mangia, non dorme. T’avesse visto maie ’e durmì. N’ànema dannata, chesto si’. (Filumena Marturano, I atto, in Eduardo De DOMENICO 35 Quella di cui sappiamo qualcosa di più è Nannina, la prostituta di ’Mmiez’ ’a Ferrovia, che con il suo Avvertimento cantato cerca di convincere la giovane Concettina a non cadere nella trappola in cui lei stessa è caduta lasciandosi sedurre da Alberto, un giovane senza scrupoli che l’ha rovinata: «Io ero comm’a vuie n’angelo ’e figlia / e stevo sott’ ’o sciato ’e mamma mia. / P’ Alberto me ne jette d’ ’a famiglia / e so’ fernuta ’mmiez’ ’a Ferrovia [...]» (’Mmiez’ ’a Ferrovia, in Raffaele Viviani, Teatro, vol. I, pp. 151-52). Filippo, Teatro, edizione critica e commentata a cura di Nicola De Blasi e Paola Quarenghi, vol. II, Cantata dei giorni dispari, tomo I, Mondadori, Milano 2005, p. 539) Ecco perché, alla fine del dramma, il pianto di Filumena, la sua scoperta delle lacrime risultano così sorprendenti e commoventi. Perché rappresentano non solo l’espressione dell’emozione, della gioia per un obiettivo raggiunto, ma rivelano l’allentamento di una tensione che non si è mai potuta permettere il lusso di un cedimento, segnalano la fine di un’improba, solitaria fatica, che ora, forse, potrà essere finalmente alleviata e condivisa.36 L’idea della commedia, racconta Eduardo, gli venne da un episodio di cronaca, da ricordi d’infanzia, forse anche da esperienze autobiografiche, ma tutto questo non sarebbe stato sufficiente a fare di Filumena Marturano quella grande commedia che è se egli non avesse saputo constatare con i propri occhi, apprendere dalla cronaca e dalla storia del suo tempo, non solo la miseria ordinaria di Napoli, ma come l’esperienza tragica della guerra avesse potuto portare quasi un terzo delle donne nubili della sua città a esercitare stabilmente o occasionalmente la prostituzione per poter vivere e far sopravvivere.37 Il fatto che nella commedia, scritta un anno dopo la fine del conflitto, non si faccia mai, neppure una volta, riferimento alla guerra,38 non cambia il senso di questa osservazione. Del resto è lo stesso Eduardo a dichiarare che Filumena Marturano È una commedia sociale, vuol essere la riabilitazione di una categoria di donne, vuol essere un grido di ribellione in questo mondo sconvolto e turbinoso che ci ha lasciato la guerra. Una volta tanto Filumena non è un solo personaggio che io faccio rivivere, ma una serie di creature vive di cui ella è 39 l’esemplificazione e l’interprete. La commedia ebbe un grande risalto, anche al di fuori dell’ambito strettamente teatrale; diede un contributo non indifferente al dibattito della Costituente sulla definizione del diritto di famiglia; e non mancò di suscitare interpretazioni tendenziose e di parte sia negli ambienti cattolici che di sinistra. Anche il suo successo mondiale ha confermato come un’opera profondamente legata a un luogo e a una cultura, possa essere, allo stesso tempo, assolutamente universale. 36 Una lettura altrettanto originale della napoletana “arte di arrangiarsi” Eduardo la propone anche nella commedia Napoli milionaria! (1945). Al I atto, utilizzando un espediente spesso sfruttato dal teatro comico, impone al suo protagonista Gennaro Jovine di fingersi morto per evitare una perquisizione che porterebbe alla scoperta della merce di contrabbando nascosta sotto il letto in cui giace. Ma la rozza messinscena di Gennaro si trasforma in atto eroico nel momento in cui “il morto” si trova a dover sfidare le bombe e il pericolo della morte per mantenere fede al grottesco impegno che si è assunto. Il suo coraggio è riconosciuto anche dal brigadiere Ciappa, il quale, pur avendo fiutato l’inganno, rinuncia alla perquisizione e all’arresto, perché «È sacrilegio a tuccà nu muorto, ma è cchiú sacrilegio a mettere ’e mmane ncuollo a uno vivo comme a te» (Napoli milionaria!, in Eduardo De Filippo, Teatro, op. cit., p. 84). 37 Così scrive Norman Lewis nel diario di guerra Napoli ’44: «Nell’ultimo bollettino del Bureau of Psychological Warfare si dice che a Napoli quarantaduemila donne esercitano, occasionalmente o con regolarità, la prostituzione. Questo su una popolazione femminile nubile che si aggira intorno a centocinquantamila» (N. Lewis, Napoli ’44 [1978], Adelphi, Milano 1993, pp, 136-37). 38 Un’ambientazione bellica venne invece scelta da De Sica per il primo incontro fra Domenico e una giovanissima Filumena: l’incontro avviene nella “casa”, in una notte di bombardamenti, durante l’ultima guerra mondiale. 39 La dichiarazione di Eduardo è riportata nella recensione di R.S., «Tempo Sera», 9 gennaio 1947. Eduardo De Filippo, Nota autobiografica, in Eduardo De Filippo. Vita e opere, Mondadori, Milano 1986, pp. 58-59. Sono nato a Napoli il 24 maggio 1900, dall’unione del più grande attore-autore-regista e capocomico napoletano di quell’epoca, Eduardo Scarpetta, con Luisa De Filippo, nubile. Mi ci volle del tempo per capire le circostanze della mia nascita perché a quei tempi i bambini non avevano la sveltezza e la strafottenza di quelli d’oggi e quando a undici anni seppi che ero “figlio di padre ignoto” per me fu un grosso choc. La curiosità morbosa della gente intorno a me non mi aiutò certo a raggiungere un equilibrio emotivo e mentale. Così, se da una parte ero orgoglioso di mio padre, della cui compagnia ero entrato a far parte, sia pure saltuariamente, come comparsa e poi come attore, fin dall’età di quattro anni, quando debuttai nei panni di un giapponesino nella parodia dell’operetta Geisha, d’altra parte la fitta rete di pettegolezzi, chiacchiere e malignità mi opprimeva dolorosamente. Mi sentivo respinto, oppure tollerato, e messo in ridicolo solo perché “diverso”. Da molto tempo, ormai, ho capito che il talento si fa strada comunque e niente lo può fermare, ma è anche vero che esso cresce e si sviluppa più rigoglioso quando la persona che lo possiede viene considerata “diversa” dalla società. Infatti, la persona finisce per desiderare di esserlo davvero diverso, e le sue forze si moltiplicano, il suo pensiero è in continua ebollizione, il fisico non conosce più stanchezza pur di raggiungere la meta che si è prefissa. Tutto questo però allora non lo sapevo e la mia “diversità” mi pesava a tal punto che finii per lasciare la casa materna e la scuola e me ne andai in giro per il mondo da solo, con pochissimi soldi in tasca ma col fermo proposito di trovare la mia strada. Dovrei dire: di trovare la mia strada nella strada che avevo già scelto da sempre, il teatro, che è stato ed è tutto per me. Inutile parlare delle difficoltà, degli stenti, della fame: chi, da indipendente, vuole perseguire un ideale va sempre incontro a periodi travagliati, ma se l’ideale ce l’hai e sai di poterlo servire degnamente, sopporti ogni cosa. Per anni e anni feci di tutto: comparsa anche in cinema, attrezzista, direttore di scena, caratterista. Poco a poco mi feci un nome come attore e scrittore e regista. La prima commedia vera e propria, un atto unico intitolato Farmacia di turno, la scrissi nel 1920, la prima regia ufficiale fu la messa in scena di una commedia musicale di Enzo Lucio Murolo, Surriento gentile, nel 1922; ma quante scene avevo scritto e quante regie avevo già fatto senza poterle firmare. Fui in Compagnie di rivista, d’avanspettacolo, di prosa; nel 1931 formai la Compagnia Teatro Umoristico I De Filippo, con Titina e Peppino. Debuttammo trionfalmente con Natale in casa Cupiello e per anni passammo da un successo all’altro in tutta Italia. Nel 1944 Peppino lasciò la Compagnia. Intanto stava per finire la guerra, e con essa il ventennio fascista. Finalmente avrei potuto cambiare il mio modo di scrivere; mentre durante il fascismo avevo dovuto nascondere le verità sociali sotto il grottesco e l’assurdo per non essere censurato, adesso potevo parlar chiaro e cimentarmi nella forma teatrale alla quale da sempre avevo aspirato, che è poi la più antica: corrispondenza ideale tra vita e spettacolo, fusione ora armoniosa ora stridente tra riso e pianto, grottesco e sublime, dramma e commedia, abbandonando quell’artificio scenico che è la netta divisione tra farsa e tragedia. Mi domandavo: «Ma perché per oltre due ore il pubblico deve o solo ridere o solo piangere? E perché gli spettatori, mettiamo, di Molière, accettavano le sue commedie tragiche — o tragedie comiche — e quelli di oggi non ci riescono?» La risposta che mi diedi fu una sola: «Non c’è ragione valida, c’è solo l’uso, divenuto tradizione, di tale artificiale divisione». Scrissi allora Napoli milionaria!, fondai una nuova compagnia, Il Teatro di Eduardo, e, confortato dal grande successo ottenuto dal nuovo genere teatrale, ho continuato per trent’anni a scrivere e recitare una ventina di commedie, oggi conosciute e recitate in tutto il mondo. Riassumere una vita artistica tanto lunga e tanto piena di avvenimenti (mi sono occupato di cinema, televisione, radio, regie liriche; ho costruito un teatro a Napoli, ho formato la Compagnia La Scarpettiana che ho diretto per molti anni; ho scritto poesie, saggi articoli, eccetera) non è cosa facile: tutto sembra importante eppure niente pare indispensabile, nel proprio passato, tanto che a un certo punto non si riesce a capire se si è detto troppo o troppo poco. Forse è perché l’unica cosa che conta veramente nella vita di un artista è il futuro, e il passato, a insistervi a lungo, limita la creatività e la voglia di essere creativi. Paola Quarenghi VICOLI STRETTI E LIBERTÀ DELL’ARTE1 Eduardo De Filippo, eminente uomo di teatro, riassume nella sua personalità tre figure rimaste, nella pratica odierna del palcoscenico, isolate e divise, ma che, dal Ruzante a Molière, ai nostri comici dell’arte, costituirono gli elementi essenziali della drammaturgia: l’autore, l’attore e il regista. Con queste parole si apre la relazione di Giovanni Macchia2 per il conferimento a Eduardo del premio Feltrinelli per il teatro 1972. Ad assegnare il premio, non senza qualche contrasto interno,3 è l’Accademia Nazionale dei Lincei, la più autorevole istituzione culturale italiana. Nella sua relazione Macchia sottolinea non solo i meriti del lavoro teatrale complessivo di Eduardo, ma in modo specifico i suoi meriti di drammaturgo, ricordando che i suoi testi «vivono al di là dell’efficace interpretazione data dal loro autore»; e proprio come scrittore di teatro lo ricollega a quella grande tradizione che va «dal Ruzante, a Molière, ai nostri comici dell’arte». Il premio Feltrinelli e le due lauree in lettere honoris causa conferitegli, prima dall’Università di Birmingham (nel 1977), poi dall’Università di Roma «La Sapienza» (nel 1980), sono il giusto riconoscimento a un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al teatro, raccogliendo, allo stesso tempo, successi e incomprensioni, soddisfazioni e amarezze, osanna generici, o strumentalmente parziali e legittimi riconoscimenti. L’importanza della sua attività, che non ha trascurato nessuno dei mestieri del teatro (attore, autore, regista, capocomico, impresario) e nessun settore dello spettacolo (varietà, rivista, teatro di prosa e lirico, cinema, televisione), è universalmente riconosciuta, ma la sua figura non ha ancora trovato una piena e legittima collocazione nelle “storie” e nelle “antologie”, sia di letteratura che di teatro. Il fatto è che per molti versi Eduardo resta, nel panorama teatrale italiano del Novecento, un personaggio anomalo e come tale sfugge alle categorie ordinarie. Nel secolo dei corporativismi e delle specializzazioni un artista come lui, eclettico e non inquadrato, fatica a trovare posto. Sono pochi nel nostro secolo gli uomini di teatro che abbiano praticato il suo stesso percorso: fra questi Raffaele Viviani, altrettanto grande, ma meno fortunato e meno abile dal punto di vista imprenditoriale; Dario Fo, che più di altri gli si avvicina per l’ampiezza e la compiutezza del suo progetto artistico; e, ai nostri giorni, gli attoriautori-registi delle ultime generazioni, che non a caso provengono dagli stessi bacini culturali e linguistici, napoletano e padano, e che a quella tradizione, sia pure indirettamente, si riferiscono. Il suo impegno Eduardo lo ha sostenuto con un progetto graduale, coerente e organico, teso non tanto alla valorizzazione delle singole componenti dell’attività teatrale, ma alla realizzazione di un’idea di teatro che va oltre l’ambito strettamente artistico per comprendere in un’unica prospettiva valori etici ed estetici. E' stata proprio la complessità di un simile progetto a far sì che Eduardo non venisse pienamente accettato dalle varie categorie dello spettacolo e fosse guardato con qualche diffidenza da tutte. Tra gli scrittori di teatro e i letterati c’è chi lo ha considerato e 1 Introduzione al volume œEduardo De Filippo, Teatro, vol. I, Cantata dei giorni pari, edizione critica a cura di Nicola De Blasi e Paola Quarenghi, Mondadori, Milano 2000, pp. IX-XLIX. 2 Adunanze straordinarie per il conferimento dei premi A. Feltrinelli, vol. I, fasc. 10, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1973, pp. 208-9. 3 E' lo stesso Macchia a ricordare le dure resistenze di alcuni colleghi dell’Accademia di fronte alla proposta di conferire il premio a Eduardo e il commento di un «austero collega» al momento dell’assegnazione: «Abbiamo dato il Premio Feltrinelli a un guitto» (Giovanni Macchia, Gli anni dell’attesa, Adelphi, Milano 1987, p. 40). continua a considerarlo non un vero autore, ma piuttosto un attore che ha scritto commedie per sé e per la propria compagnia, e non gli perdona le origini culturalmente plebee, legate al comico4 e al dialetto. Molti attori, vedendo in lui non l’attore, ma il capocomico, lo hanno definito tirannico, poco solidale, avaro, «cattivo».5 Certo non lo hanno considerato come uno di loro i capocomici, invidiosi di una fortuna e di una autonomia niente affatto comuni; né gli impresari, ai quali è sempre riuscito a strappare percentuali superiori a quelle degli altri direttori di compagnie; né i registi, che nella essenzialità dei suoi allestimenti hanno visto non la conquista di una raffinata semplicità, ma un segnale di scarsa fantasia o di pericolosa parsimonia, e forse non gli hanno perdonato affermazioni come questa: «A costo di sembrare un reazionario, confesso che preferisco un teatro dominato dal grande attore a quello dominato dal grande regista. Se non altro costa meno».6 Forse il peccato che, inconsciamente, la cultura italiana gli ha fatto scontare è quello di aver rotto schemi di comportamento, scavalcato barriere professionali e di categoria, superato confini culturali, procedendo in modo del tutto personale e libero, senza però assumere quel piglio rivoluzionario o quegli atteggiamenti da maître à penser che hanno conquistato ad altre figure del teatro del Novecento stuoli di seguaci. Il grande successo di pubblico, che in qualunque altro paese sarebbe stato considerato un titolo di merito per un uomo di teatro, in Italia è stato guardato dai settori più snobistici della cultura con diffidenza, come il segnale di un’arte troppo disponibile, troppo facile, troppo popolare.7 Né è stata riconosciuta come una prova di intelligenza teatrale l’abilità imprenditoriale di Eduardo, che se da un lato gli ha consentito di ricavare dal teatro cospicui guadagni, dall’altro gli ha permesso di lavorare con margini di autonomia sconosciuti alla maggior parte dei suoi colleghi artisti. Del resto, una simile incomprensione non stupisce da parte di una cultura come quella del nostro Novecento, malata, allo stesso tempo, di romanticismo e di idealismo, affezionata allo stereotipo dell’artista incompreso, dissipatore del proprio genio e delle proprie sostanze (più spesso, di quelle altrui); e pronta a considerare la capacità di ricavare ricchezza dall’attività artistica come una qualità sospetta o decisamente sconveniente. Un’altra conseguenza della relativa incomprensione della personalità di Eduardo è stata la creazione di un mito a lui dedicato, un ingombrante monumento, che se da un lato va visto come un tributo alla sua grande popolarità, dall’altro si è rivelato ben poco utile, se non addirittura dannoso, a una conoscenza approfondita della sua opera. Questo mito popolare infastidisce gli intellettuali più snob, che non amano condividere alcunché con la gente comune; genera qualche sospetto in quelli più seri, giustamente diffidenti verso ogni genere di mitologia; favorisce la produzione di una pubblicistica di qualità scientifica modesta o nulla, i cui dati sono spesso di terza o quarta mano, l’aneddotica la fa da padrona e le inesattezze si trasmettono in una specie di “telefono senza fili” che ostacola, invece di aiutare, il lavoro degli studiosi seri. Siccome poi non è fatto con i materiali più raffinati, ma con quelli più grossolani, questo monumento offre il 4 «La cultura ufficiale disprezza il riso», ricorda ancora Macchia (ibidem, p. 40). Questa categoria, così poco pertinente sul piano estetico, ha finito con l’entrare anche nel titolo di una recente monografia: Il cattivo Eduardo. Un artista troppo amato e troppo odiato, a cura di Italo Moscati, Marsilio, Venezia 1998. 6 Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, a cura di Isabella Quarantotti De Filippo, Bompiani, Milano 1985, p. 164. 7 Si veda, a questo proposito, il bell’articolo di Elena Croce, Snobismo e provincia, «La Voce Repubblicana», 15 gennaio 1959. 5 destro a frettolose demolizioni; il che è normale in un paese simpaticamente dissacratore come il nostro, dove non c’è statua o busto marmoreo che non abbia il naso rotto. Del resto non c’è niente di meno congeniale a Eduardo della immobilità di un monumento, se si considerano l’anticonformismo e la voglia di sperimentare che non lo hanno mai abbandonato, nemmeno negli ultimi anni della sua vita. Al centro del progetto eduardiano non c’è l’attore, non c’è l’autore, non c’è il regista, non ci sono il capocomico né l’impresario: c’è il teatro. Non semplicemente lo spettacolo, a cui pure tutte queste componenti devono collaborare in funzione di un risultato unitario, ma proprio il teatro: quel «mistero» — come lo definisce Eduardo — che è nato con l’uomo e che in duemilacinquecento anni ha conosciuto splendori e miserie, ma ha continuato a sopravvivere a ogni crisi e continuerà a farlo, nonostante la scoperta di mezzi espressivi e di comunicazione artistica più moderni e potenti. Su questo Eduardo non ha dubbi: «Fino a che ci sarà un filo d’erba sulla terra, ci sarà un filo d’erba finta in palcoscenico»;8 perché il teatro non è solo un intrattenimento superfluo, ma è qualcosa di indispensabile all’uomo, il quale, «per fare diventare reale la propria vita, la deve fingere sul palcoscenico».9 E non stupisce tanta fiducia in un autore, che al protagonista di una sua commedia ha fatto dire: «Quando in un dramma teatrale c’è uno che muore per finzione scenica, significa che un morto vero in qualche parte del mondo o c’è già stato o ci sarà».10 Il suo è dunque un teatro che guarda alla realtà e la ripropone in scena filtrata attraverso il procedimento artistico della finzione; una finzione resa più attraente dalla presenza di motivi comici, ma certo non sterilizzata, non innocua. La lunga vita di teatrante di Eduardo non è stata facile; e non solo al tempo della sua formazione e del lungo e paziente apprendistato artistico, che fu poi il tempo del fascismo e di due guerre mondiali; ma anche nel dopoguerra, in quegli anni che Eduardo chiama “dispari”, cioè difficili, nonostante i riconoscimenti e i consensi ormai consolidati. E che le difficoltà e le verifiche non siano mai finite per lui, nemmeno dopo la sua morte, è la prova lampante di un impegno sperimentale che non lo ha mai abbandonato e che lo ha condotto a seguire non le rotte tracciate dai successi ottenuti ma le vie più strette e impervie, perché — come ricordava lui stesso all’amico Maurizio Valenzi, all’epoca sindaco di Napoli — «il cavallo corre meglio quando la via è diretta e libera ma [...] a guidare nel vico stretto “c’è più sfizio”».11 La tradizione Figlio d’arte, Eduardo inizia la sua attività teatrale nell’alveo di una tradizione antica, che, attraverso le maschere del Teatro San Carlino, si ricollega alla Commedia dell’Arte. Di quella tradizione suo padre, Eduardo Scarpetta, cresciuto alla scuola del grande Pulcinella Antonio 8 Risposte di Eduardo al questionario Centouno domande sul teatro, inviatogli dai bambini della scuola elementare romana Quarto Miglio, citate nell’intervento di Isabella Quarantotti De Filippo al convegno «L’arte della commedia» (Roma, Teatro Ateneo, 21 settembre 1988); atti a cura di Antonella Ottai e Paola Quarenghi, Bulzoni, Roma 1990, pp. 11-2. 9 Ivi, p. 11. 10 L’arte della commedia, in Cantata dei giorni dispari, vol. III, Einaudi, Torino 1979, p. 256. 11 A Valenzi, per confortarlo delle sue fatiche di amministratore, Eduardo dedicò una poesia, intitolata appunto ’O vico stritto. Cfr. Maurizio Valenzi, Uno sguardo, una voce, la storia di una gente, «L’Unità» (Roma), 15 maggio 1980. Petito, è un erede, ma — secondo alcuni — anche un pericoloso avversario, sia per aver “inquinato” il repertorio più antico e originale del teatro napoletano con pochades e vaudevilles di importazione francese, sia per aver contribuito, con l’affermazione della maschera borghese di Felice Sciosciammocca, al declino di Pulcinella, la maschera che di quella tradizione è il simbolo. Oltre che attore e autore di successo, Scarpetta è anche un abilissimo capocomico e la sua compagnia, pur proponendo un repertorio dialettale, recita nei teatri maggiori. Con lui Eduardo inizia, fin da piccolissimo, il proprio apprendistato, venendo a contatto, giorno dopo giorno, con il mondo del teatro e la sua gente. Agli attori dialettali riconoscerà doti di «naturalezza, ritmo, creatività», capacità di improvvisare, «cosa quasi impossibile per un attore in lingua», e la padronanza di quel «bagaglio tradizionale di sotterfugi, malizie, lazzi, convenzioni sceniche che è utile qualora ad esso si unisca senso della misura, intelligenza, sensibilità»;12 ma ne riconoscerà anche i difetti: primo fra tutti l’ignoranza, inaccettabile per un artista che non voglia restare chiuso negli angusti confini del proprio mondo. Prendendo parte agli spettacoli in piccoli ruoli e osservando gli attori più esperti, Eduardo impara l’arte della recitazione; copiando commedie, si familiarizza con la scrittura teatrale. Attraverso queste pratiche apprende, in modo naturale, gli elementi base di quella drammaturgia (tagli delle scene, caratteri dei personaggi, strategie di sviluppo degli intrecci) che gli verranno utili nella sua futura esperienza di autore, sia quando dovrà riproporli imitandone i modelli, sia quando deciderà di modificarli in modo originale. Negli anni dell’apprendistato, pur recitando prevalentemente i lavori di Scarpetta, «privi di profondità, ma rielaborati con un gusto dello spettacolo, un’abilità nel taglio delle scene, un senso del ritmo davvero eccezionali»,13 si interessa anche ad altri generi e ad altri autori, come quegli esponenti del Teatro Dialettale d’Arte che furono fieri avversari artistici di suo padre, e che sostennero, contro il suo teatro, che oggi chiameremmo commerciale, un repertorio di matrice letteraria e di ambientazione naturalistica, più attento alle tematiche sociali. Dall’aspirazione a creare un «teatro di contenuto che fosse anche spettacolo»14 nasceranno le opere migliori della sua drammaturgia, nella quale egli continuerà sempre a servirsi del comico, superando, in una chiave molto originale, i confini dei generi classici. Dalla drammaturgia tradizionale impara a mescolare liberamente materiali derivanti dal repertorio popolare con altri ricavati dalla letteratura e dal teatro colti. Anche questa pratica, di cui si ha un esempio nel genere della parodia, e che sarà poi ampiamente utilizzata nel teatro di varietà, nella rivista e nell’avanspettacolo, lo familiarizza con l’idea di un uso libero del materiale drammaturgico, fondato non sul principio dell’omogeneità stilistica e dell’assoluta originalità artistica, ma piuttosto sul reimpasto di spunti provenienti da fonti e generi diversi. La pratica dell’improvvisazione — pur molto ridimensionata da Scarpetta rispetto alla tradizione precedente — lo avvicina a un metodo di creazione collettivo, non legato al principio della centralità del testo, né dell’autore unico; un metodo che Eduardo metterà in pratica soprattutto nel teatro di rivista e nei primi anni della compagnia del Teatro Umoristico, quando, utilizzando un copione abbastanza scarno e sintetico, magari scritto a quattro mani, lo arricchirà assieme ai suoi 12 Risposte ad alcune domande sulla recitazione pubblicate in inglese in Actors on Acting, a cura di Toby Cole e Helen K. Chinoy, Crown Publishers, New York 1970, pp. 470-2; e, in italiano, in Eduardo nel mondo, «Quaderni del Teatro Tenda», n. 4, Bulzoni, Roma 1978, pp. 79-81; poi, con qualche variante, in Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, da cui si cita (p. 172). 13 Risposte al questionario di Sergio Corbi, allegate a una lettera del 9 maggio 1970, GV, p. 1. 14 Ibidem. compagni di battute a soggetto, create direttamente in scena durante le prove e, assai più raramente, durante gli spettacoli. A un progetto di drammaturgia collettiva tornerà a ispirarsi anche negli ultimi anni della sua vita, quando cercherà di ricreare, con gli studenti dei suoi corsi di scrittura teatrale di Firenze e Roma quella che chiamerà «la bottega del teatro». Anche se i risultati di quel lavoro saranno in realtà più individuali che collettivi — né ci sarebbero stati del resto i presupposti perché fosse diversamente — l’esperimento testimonia l’interesse di Eduardo per il recupero di metodi che nelle sue intenzioni avrebbero dovuto richiamarsi alle tecniche drammaturgiche della Commedia dell’Arte: «Questa è una tecnica antica, molto antica, [...] era la tecnica di ogni gruppo di compagnia, quando non c’era la Società degli Autori, quando [...] appena si scriveva una commedia, una novità, era già di dominio pubblico».15 Nel secolo delle avanguardie, mentre la cultura letteraria più avanzata va negando in modo via via più deciso il valore della tradizione, Eduardo continua a difenderne la lezione, sia servendosene per il suo lavoro di autore e attore, sia adoperandosi perché quel patrimonio culturale non vada disperso. Già alla fine degli anni Trenta — in un periodo non favorevole a certi recuperi — ribadiva la necessità di pubblicare testi del repertorio teatrale napoletano e pensava già che si potesse usare il cinema come strumento per conservare la memoria degli attori di tradizione, dei quali presentiva la scomparsa. Quello stesso repertorio lo ripropose sia mettendolo in scena, particolarmente negli anni del dopoguerra, sia creando un teatro, il San Ferdinando, e una compagnia, la Scarpettiana, destinati a rappresentarlo. A metà degli anni Cinquanta propose a Einaudi di pubblicarne i testi e negli anni Settanta progettò addirittura una “storia televisiva” del teatro napoletano, che realizzò poi solo in forma ridotta mettendo in scena per il piccolo schermo un ciclo di commedie di Eduardo e Vincenzo Scarpetta, che uscirono anche in edizione a stampa. Come già aveva iniziato a fare suo padre, per tutta la vita andò raccogliendo copioni del repertorio napoletano,16 un patrimonio importante per chi voglia conoscere meglio il retroterra culturale da cui prese le mosse il suo teatro. Fu lui stesso a indicare agli studiosi la strada per una ricerca sulle relazioni fra la propria drammaturgia e quella tradizionale, rivelando debiti insospettati con quest’ultima anche in lavori apprezzati proprio per le soluzioni particolarmente innovative. Per esempio raccontò17 di aver creato il personaggio del Professor Santanna, quell’«anima utile che non compare mai» che è l’invenzione più originale della commedia Questi fantasmi!, partendo dalla tecnica tradizionale dell’“a parte”.18 Per il secondo atto deL’arte della commedia, manifesto della sua poetica teatrale, raccontò19 di aver preso lo spunto dall’atto unico I comici e l’avvocato di Giacomo Marulli, un autore napoletano della prima metà dell’Ottocento. E anche per il linguaggio del suo ultimo lavoro, la traduzione in 15 Lezione all'Università di Roma «La Sapienza», Teatro Ateneo, 24 novembre 1981. Trascrizione da registrazione video. 16 Questi copioni, circa millecinquecento fra commedie di Eduardo e di altri autori, sono attualmente ospitati presso la Società Napoletana di Storia Patria. L’Associazione Voluptaria di Napoli ne ha pubblicato il catalogo, a cura di Ernesto Cilento (catalogazione di Claudio Novelli, con la collaborazione di Anna Ritta Abbate e Fabio Pacelli), stampa LEGMA, Napoli 1998. 17 Nell’estate del 1983, nel corso di una conferenza-spettacolo tenuta a Montalcino nell’ambito dello Studio Internazionale dello Spettacolo diretto da Ferruccio Marotti. Il testo della conferenza è stato pubblicato, col titolo I fantasmi siamo noi!, in «Piccolo Teatro di Milano», n. 3, 1985, pp. 16-9. 18 L’“a parte” è quella convenzione scenica per cui l’attore, nei panni del personaggio, fingendo di parlare tra sé, si rivolge direttamente al pubblico. 19 Cfr. Carlo Muscetta, Da «Napoli milionaria!» a «L’arte della commedia», in Realismo, neorealismo, controrealismo, Garzanti, Milano 1976, p. 301. napoletano della Tempesta di Shakespeare, scrisse di essersi ispirato a «un genere teatrale antichissimo, la Féerie seicentesca che fino a circa metà dell’Ottocento fece parte del repertorio di molte Compagnie».20 Fino alla fine Eduardo continuò a rivendicare il valore della tradizione: «quella linea ideale, con la quale uniamo ciò che è stato a ciò che sarà».21 Si dice che nella vita di un uomo c’è un punto di partenza ed un punto di arrivo, di solito riferiti all’inizio e alla fine di una carriera. Io, invece sono convinto del contrario: il punto di arrivo dell’uomo è il suo arrivo nel mondo, la sua nascita, mentre il punto di partenza è la morte che, oltre a rappresentare la sua partenza dal mondo, va a costituire un punto di partenza per i giovani. Perciò a me la morte m’incuriosisce, mi sgomenta, ma non mi fa paura, perché la considero la fine di un ciclo — il mio ciclo — che però darà vita ad altri cicli legati al mio. Soltanto così, anche se non crediamo in un dio al di fuori di noi, possiamo sperare nell’immortalità. […] Una immortalità umana, quindi limitata, ma all’uomo è stato concesso il 22 dono di sognare, che non è poi piccola cosa... In questa prospettiva non statica ma dinamica, non conservatrice ma progressiva, l’esperienza del passato è vista come un «trampolino» per saltare più in alto; e la stessa vita umana è collocata in una dimensione assai più ampia di quella delle piccole esistenze individuali. Nella «inarrestabile evoluzione» di questi cicli, «i milioni, miliardi di punti di partenza che milioni, miliardi di esseri umani lasciano nel morire, sono la vita che continua, la vita che continua è la tradizione».23 La lingua del teatro L’attività di autore di Eduardo comincia quasi contemporaneamente a quella di attore. L’italiano non è la sua lingua e non sarà mai la sua lingua teatrale. Istintivamente cercavo le mie radici nei teatri dialettali, anche perché le compagnie “in lingua”, sebbene vantassero grandi attori, non avevano un repertorio che rappresentasse la situazione italiana o situazioni regionali, e la maggior parte degli attori di contorno recitava in modo artificioso e manierato. [...] pur conoscendo e amando autori grandi, come Shakespeare, Molière, Cechov e altri sommi, la mia attenzione fu soprattutto rivolta ai teatri dialettali, giacché intuivo che un vero teatro nazionale italiano poteva formarsi solo se affondava le sue radici nelle varie tradizioni 24 popolari e se traeva da quelle il succo necessario per crescere e svilupparsi. In due sole occasioni fece parte di compagnie in lingua. Nel 1927, quando, lasciato il fratello Vincenzo, si unì alla Carini-Gleck-Falconi-Pilotto; e poi nel 1936, quando venne scritturato da Guido Salvini per una messa in scena straordinaria di Questa sera si recita a soggetto di Pirandello, a un congresso internazionale di teatro a Vienna. Nella prima compagnia, che si sciolse dopo pochi mesi di recite, non ebbe certamente ruoli di primo piano, vista la presenza di 20 Nota del traduttore a «La tempesta» di William Shakespeare nella traduzione in napoletano di Eduardo De Filippo, Einaudi, Torino 1984, p. 185. Riferimenti al sistema dei ruoli e alle maschere della commedia dell’arte si trovano anche nell’interpretazione che Eduardo diede del testo, realizzandone, nel 1984, una registrazione sonora in cui copriva da solo tutti i ruoli maschili. 21 [Cercare autore e titolo], «Il Giornale d’Italia», 19 maggio 1981. 22 Conferenza di Montalcino, luglio 1983, ora in Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., pp. 181-2. 23 Conferenza di Montalcino, in Eduardo. Polemiche..., cit., p. 182. 24 Risposte al questionario di Sergio Corbi, cit., pp. 1-2. tanti primi attori più anziani di lui. Nella seconda ebbe invece una parte da protagonista, quella di Verri; ma, nonostante il successo riscosso dallo spettacolo, nemmeno questa esperienza fu particolarmente significativa per lui. Della sua prestazione, parecchi anni più tardi, Anton Giulio Bragaglia avrebbe dato un giudizio non lusinghiero: Quando recita in lingua egli si cancella come una scritta in gesso sulla lavagna: non è nemmeno più lo spettro di se stesso. [...] Eduardo in italiano non somiglia più a De Filippo. Non ha niente a che vedere con lui. Ricordo, ancora con senso di disagio che mi accappona la pelle finoggi, la sua recita in Pirandello allo Joseph-Stader [? non Josephstadt?] Theater a Vienna circa vent’anni fa. Eduardo sembrava un filodrammatico in lingua italiana e aveva smarrito perfino la mimica. Privo dei suoi mezzi di espressione, questo eccezionale, grandissimo commediante 25 diventava bambino. Il giudizio di Bragaglia — forse non del tutto equanime a causa di una polemica sorta nel frattempo con Eduardo, ma confermato anche da altre testimonianze — mette l’accento su una questione di cui lo stesso Eduardo si rese conto ben presto. Il napoletano era la sua lingua madre. Su quella lingua egli aveva modellato la sua gestualità di attore, i meccanismi della sua comicità. Grazie a essa aveva potuto evitare le trappole di quell’“italiese” che «non si parla nella vita e neppure nei romanzi»26 e che dà a tutte le commedie l’aria di essere state tradotte dall’inglese o dall’americano; o a quell’“antilingua teatrale” — come la definisce Claudio Meldolesi mutuando il termine da Calvino — che «si colloca prima delle parole e delle cose», e che rappresenta una delle più meschine invenzioni del teatro italiano del Novecento. Il suo portavoce, l’attore, l’“attore di voce” che tutti conosciamo, agisce aggiornando istintivamente un compromesso stretto in tempi lontani fra la lingua media scritta e le convenzioni sceniche borghesi, assunte come eterne. Due 27 atteggiamenti contagiosi contraddistinguono questa antilingua: il fare pensoso e la disinvoltura. Per Eduardo il testo teatrale è un vestito che l’attore deve aggiustarsi addosso per sentircisi comodo. Egli non arriva certo a sostenere, come faceva Angelo Musco in polemica con Pirandello, che il testo altro non sia che una semplice pezza di stoffa, con cui l’attore deve confezionarsi da sé il proprio vestito, ma sa che l’attore, per avere piena padronanza dei suoi mezzi espressivi, deve in un certo senso reinventare quell’intreccio di convenzioni che costituiscono il testo — primo fra tutti la lingua — per poterlo far proprio completamente. Solo così potrà recitare con la naturalezza che si richiede a un buon interprete. Riprendendo la pratica degli attori venuti prima di lui, Eduardo comincia quindi a forgiarsi quello strumento fondamentale per il suo lavoro di attore che è il testo: e inizia a scrivere, in modo funzionale al ruolo che deve interpretare, alla compagnia di cui fa parte, al genere che pratica; prima adeguandosi a modelli preesistenti, poi superandoli. Scrivendo nella propria lingua, fa nascere insieme la parola e il gesto, e non fa semplicemente della gestualità un accompagnamento al contenuto verbale del testo. Anche mentre scrive, la sua esperienza d’attore lo guida nella scelta delle espressioni più recitabili, più efficaci, o più adatte al comportamento di personaggi che, 25 P.R. [Anton Giulio Bragaglia], Eduardo senza Eduardo non è più Eduardo, «Film d’Oggi», 21 maggio 1952 [verificare che sia questo l’articolo]. 26 Dalle risposte di Gabriele Baldini all’inchiesta Gli scrittori e il teatro, «Sipario», anno XX, n. 229, maggio 1965, p. 2. 27 Claudio Meldolesi, Gesti, parole e cose dialettali. Eduardo, Cecchi e il teatro della differenza, «Quaderni di teatro», anno III, n. 12, maggio 1981, p. 132. mentre nascono, cominciano già a muoversi nel suo corpo di attore. Del resto, all’inizio e per una lunga fase della sua esperienza artistica, il suo è un teatro comico e non c’è modo di far ridere in una lingua che non sia la propria. L’abitudine a questo lavoro di adattamento Eduardo non la abbandonerà mai, nemmeno quando reciterà i lavori di altri autori che non interpreterà mai senza tradurli, non tanto in un vero dialetto napoletano, quanto in un italiano napoletanizzato. E quella stessa pratica la adotterà istintivamente anche recitando i propri testi. Fra la battuta scritta e quella detta lascerà sempre una certa distanza, modificherà sempre, almeno un poco, le parole o la struttura della frase, pur senza cambiare il concetto e senza variare la parte finale della battuta, per non disorientare il compagno di scena che aspetta un attacco preciso per cominciare a parlare. Era questo uno degli elementi che davano alla sua recitazione quel carattere di straordinaria naturalezza che i più ingenui consideravano spontaneità e istinto naturale, ma che era invece il risultato di una tecnica talmente assimilata e decantata da diventare invisibile. Del resto, la lingua dei suoi testi, napoletano stretto o italiano napoletanizzato che fosse, per Eduardo era semplicemente un mezzo, non un fine. Non si poneva certo, rispetto a essa, con l’atteggiamento del purista; non si faceva condizionare dall’obbligo di aderire al linguaggio di una determinata epoca, o di una determinata classe sociale. Scriveva nella lingua che gli serviva per rappresentare la realtà che, in un determinato momento, sentiva di voler rappresentare. E durante la sua vita di attore e autore questa lingua avrebbe continuato a modificarla, ad adattarla alle proprie esigenze espressive e a quelle della comunicazione con il pubblico. Del fatto che il dialetto in Eduardo non sia una prigione angusta, un rifugio regionalistico, si accorgono i critici più attenti: per Pandolfi il suo non è «il teatro per Napoli, ma il teatro di Napoli»;28 per Corrado Alvaro,29 nelle opere del dopoguerra (particolarmente a partire da Questi fantasmi!) la cadenza napoletana di Eduardo non è che una delle tante convenzioni teatrali, uno strumento più adatto di altri, perché più aderente alla realtà che egli come autore vuole rappresentare. Nell’atteggiamento di Eduardo nei confronti del dialetto, del resto, non c’è mai stato il senso di inferiorità di chi sa di usare una lingua marginale e ghettizzata, ma piuttosto l’orgoglio di chi sente di ricollegarsi, attraverso quella lingua, a una grande tradizione culturale, meno angusta in realtà di quella che gli stessi modelli nazionali propongono. Bisogna intendersi sul significato di “teatro dialettale”; se si allude al contenuto del mio teatro, non mi sembra che i temi trattati siano limitati a una regione, a una città. Nello scrivere io ho in mente una realtà italiana, anche se l’ambientazione è napoletana. Se invece per teatro dialettale si intende parlar di “lingua”, vi posso rispondere che la lingua pura la parlano solo al Terzo Programma della radio e in alcune trasmissioni TV, e neanche in questi due casi si può essere proprio certi che si tratti di lingua pura. L’Italia parla un dialetto che io cerco di ricreare nella mie commedie; dato che sono napoletano, le cadenze dialettali che uso sono napoletane. [...] E poi, se vogliamo, il nostro aggancio all’Europa, al mondo, non è certo l’Italietta di Giolitti o l’Italietta di Mussolini, bensì le varie Italie connesse e influenzate da grandi ed evolute nazioni quali l’Austria, la Spagna, la Francia, Venezia, ecc. Con ciò non 30 intendo denigrare l’unità d’Italia, ma voglio dire che nazione non si nasce, si diventa. [Se l’ha già usata Nicola toglierla, altrimenti lasciarla] Attori orfani e comici imprenditori 28 Vito Pandolfi, Teatro italiano contemporaneo (1945-1959), Laterza, Bari 1976, p. 125). Eduardo, «Sipario», anno XI, n. 119, marzo 1956. 30 Risposte al questionario di Sergio Corbi, cit., pp. 3-4. 29 In virtù di un impegno teatrale non di settore ma globale, Eduardo è tra i pochi ad avere opposto resistenza a quel processo di demolizione sistematica della cultura d’attore che si è prodotto in Italia nel corso del nostro secolo.31 La trasformazione più evidente prodotta da questa “rivoluzione industriale” è costituita dalla scomparsa progressiva e quasi totale del teatro concepito come piccola impresa autonoma, solitamente a gestione familiare, e la sua sostituzione con un sistema finanziato da grandi società monopolistiche a gestione privata, alle quali sarebbe subentrato, soprattutto nel secondo dopoguerra, lo stato. Nel nuovo sistema, l’attore — e con lui l’autore, un tempo legato anch’egli, in modo molto più organico, alle compagnie — diventa, per così dire, un libero professionista, a disposizione di un mercato che abbia bisogno di lui. Più di quello di tradizione, il nuovo attore è in balia del caso, dei gusti del pubblico, della disponibilità degli impresari, del gradimento dei registi. Legato da contratti a scadenze sempre più ravvicinate, stagione per stagione o addirittura spettacolo per spettacolo, ha perso quella pur fragile protezione rappresentata un tempo dalle compagnie, a cui lo legavano di solito contratti triennali, e molte delle garanzie del vecchio mestiere: sistemi di formazione tradizionali, progressione della carriera legata ai ruoli, specializzazione in un determinato repertorio. In questo processo di trasformazione — per molti versi ineluttabile, per altri miope e velleitaristico — l’attore è diventato un orfano senza altre risorse che il proprio talento; un talento, verrebbe da dire, senza radici. Formatosi all’interno di una compagnia tradizionale, ma fatte anche altre esperienze, Eduardo avverte da un lato l’angustia del vecchio sistema, dall’altro i pericoli del nuovo. Così, pur sottoponendosi alle regole della carriera tradizionale, ne brucia rapidamente le tappe. Ad esempio, fin da giovanissimo, oltre a interpretare quelle parti di “secondo brillante” che per età e caratteristiche gli si addicono di più, si cimenta anche nei ruoli in parrucca, o di “mezzo carattere”, solitamente riservati agli attori più anziani. In occasione di qualche serata d’onore veste i panni di Felice Sciosciammocca, abitualmente interpretato dal primo attore della compagnia, Vincenzo Scarpetta. A diciannove, vent’anni comincia a sostituire quest’ultimo nella direzione delle prove, scontrandosi con la diffidenza e il senso di superiorità degli attori più vecchi e di maggiore esperienza (quelli che Viviani chiamava i “passoloni”) e a soli ventun anni firma la sua prima regia. Confortato anche dall’esperienza del padre e del fratello e spinto dal bisogno economico (le paghe di Vincenzo Scarpetta non sono certo laute e i periodi di riposo non sono coperti dal contratto), comincia fin da giovanissimo a pensare a una propria compagnia e ci vorranno dieci anni di esperimenti e tentativi prima che possa far partire, senza nessuna reale garanzia se non un contratto di pochi giorni, quella che diventerà una delle formazioni di maggior successo degli anni Trenta e Quaranta: il Teatro Umoristico I De Filippo. L’esperienza di palcoscenico influì non poco sul suo lavoro di autore teatrale. Ad esempio, il fatto che la compagnia Scarpetta fosse basata su ruoli rigidamente e gerarchicamente definiti impose limiti precisi nella strutturazione dei suoi primi lavori e nella definizione dei caratteri; e lo stesso si può dire per il genere, comico-brillante, praticato da quella formazione, al quale come 31 Scrive Gramsci alla fine degli anni Dieci: «Il teatro, come organizzazione pratica di uomini e di strumenti di lavoro, non è sfuggito dalle spire del maelström capitalistico. Ma l’organizzazione pratica del teatro è nel suo insieme un mezzo di espressione artistica: non si può turbarla senza turbare e rovinare il processo espressivo, senza sterilire l’organo “linguistico” della rappresentazione teatrale. [...] L’origine di questi fenomeni vistosi è da ricercare unicamente nel mutarsi dei rapporti economici tra l’impresario del teatro, divenuto industriale associato in un trust, il capocomico, divenuto mediatore e i comici soggiogati alla schiavitù del salario» (Antonio Gramsci, Emma Gramatica [1 luglio 1919], in Letteratura e vita nazionale, Editori Riuniti, Roma 1987, pp. 449-50). autore si doveva conformare. Quando poi diventò lui stesso capocomico e poté scegliere con più libertà che tipo di teatro praticare, continuò comunque a essere condizionato dalle caratteristiche della propria compagnia. Il Teatro Umoristico era infatti una formazione di tipo particolare, al cui vertice non c’era, come di solito, un attore principale, ma tre primi attori, tre personalità distinte e complementari, le cui capacità artistiche non andavano sacrificate ma valorizzate da un repertorio confezionato su misura. Questa compagnia continuò a recitare per tredici anni con grande successo; ma proprio questo successo, se da un lato giovò alla fortuna economica e alla fama d’attore di Eduardo, dall’altro ritardò forse quello sviluppo creativo che, come scrittore di teatro, egli sentiva già maturo, ma che non poteva ancora esprimere compiutamente perché frenato dal tipo di repertorio praticato dalla compagnia e dalle presenza del fratello Peppino, il quale, per le sue straordinarie doti comiche era apprezzato dal pubblico come e forse più di lui. Inoltre, come autore Eduardo doveva porsi nella prospettiva del capocomico e contemperare le proprie esigenze espressive con quelle dei suoi attori, i quali non venivano scritturati stagione per stagione, in base alle esigenze dello spettacolo da mettere in scena, come avviene oggi, ma facevano parte della compagnia per anni, a volte anche per decenni. Con loro doveva amministrare la scrittura «come il padre di una famiglia numerosa amministra il suo patrimonio: “Quest’anno il maggiore ha bisogno di un paio di scarpe, l’anno prossimo si penserà al cappotto della più piccola”».32 Tutto questo non deve far pensare a una condizione semplicemente servile del suo lavoro di autore. Anzi, proprio da un rapporto così stretto con la realtà della compagnia potevano derivargli importanti vantaggi: prima di tutto quello della verifica immediata della validità scenica delle sue commedie; poi spunti per impostare il carattere di qualche personaggio o suggerimenti per modificarlo, una volta creato, perché, come dice lui stesso, «l’autore può avere sorprese dal suo personaggio vedendolo interpretato dall’attore, giacché il personaggio si confessa più a questo che a quello».33 E spiega: «L’autore si esprime principalmente attraverso le parole, l’attore ha a sua disposizione gesti, sguardi, modi di camminare, di muoversi che rivelano la personalità più dettagliatamente e a volte più profondamente delle parole».34 I testi teatrali che scrive, dai più elementari ai più complessi, non hanno per lui solo un valore artistico, ma costituiscono, assieme al talento d’attore suo e dei suoi compagni, il primo capitale dell’impresa di cui è a capo. La gestione di un patrimonio teatrale fatto di commedie che non vengono messe da parte dopo una stagione, ma vengono riproposte e mantenute — come si diceva un tempo con un’espressione oggi caduta in disuso — “in repertorio”, rende possibile all’autore-capocomico-regista-interprete tutto un lavoro di bulino e, a volte, di vera e propria riscrittura, che finisce per trasferire nel testo quella vita che è poi la vita stessa del teatro; permette cioè all’attore-interprete-regista di proseguire quella ricerca sul personaggio che non termina certo al momento dell’andata in scena, ma continua fino a che lo si recita e, se il testo è valido, non finisce mai. La compresenza, in un’unica persona, di ruoli artistici diversi e complementari, se da un lato pone qualche limitazione a ogni singolo ruolo, dall’altro li potenzia tutti e rende il valore complessivo dell’esperienza assai più ricco che una semplice sommatoria. Al progetto eduardiano non mancò nemmeno l’impegno di impresario di teatro: l’ultimo anello che lo portò al completo controllo della catena di produzione e consumo della macchina teatrale. 32 Testimonianza di Isabella Quarantotti De Filippo, in Eduardo. Teatro TV Vita, a cura di Ferruccio Marotti, Videoelectronics Club, Roma 1989, p. 43. 33 Risposte al questionario di Toby Cole, Eduardo nel mondo, cit., p. 80. 34 Ibidem. Nel secondo dopoguerra acquistò, in macerie, il Teatro San Ferdinando di Napoli e lo ricostruì, inaugurandolo nel 1954. Alla base di questa impresa ci furono probabilmente diversi obiettivi e forse, prima di tutto, il completamento di quel sogno di indipendenza che gli avrebbe permesso di lavorare in completa autonomia, senza vincoli parassitari. E poi il sogno di restituire alla città di Napoli un edificio teatrale di grande tradizione, facendone la sede stabile di una compagnia che potesse rappresentare, con pari dignità, sia il repertorio italiano e internazionale, sia quello napoletano, a cui Eduardo voleva fosse riconosciuto il «valore di teatro nazionale».35 Tra tutte le sue imprese, quella del San Ferdinando fu la più dispendiosa e frustrante: gli procurò infatti più critiche che elogi, più perdite che guadagni. E fu anche quella che generò il maggior numero di malintesi. Ma in questa impresa, che non era riuscita a nessun attore italiano prima di lui, né sarebbe riuscita, almeno in modo durevole, dopo di lui, si trovò ben presto isolato; non solo economicamente, ma anche culturalmente. Le autorità napoletane guardarono con indifferenza o diffidenza al suo progetto;36 qualcuno lo interpretò come un atto di megalomania, come il segno di ambizioni artistiche ed economiche smodate (Emilio Barbetti lo definisce con scherno un sogno di «bayreuthiana memoria»37). Ben pochi sottolinearono il coraggio e la tenacia dimostrati da Eduardo nel portare avanti un simile impegno, che metteva a repentaglio non il denaro altrui (per esempio quello dello stato), ma il proprio. Negli anni in cui il teatro, in Italia, si avviava a diventare in blocco un’attività pubblica o sovvenzionata e l’industria dello spettacolo stava per approdare a quel Paese di Bengodi in cui i rischi d’impresa sono a carico dello stato e i guadagni appannaggio degli impresari, il programma eduardiano era troppo anacronistico per essere capito e apprezzato. Ma il fatto che esso sia, almeno in parte, fallito — per esempio nell’aspirazione, troppo anticipatrice, di fare del San Ferdinando uno “stabile” privato che collaborasse alla pari con i teatri pubblici — non toglie nulla ai meriti dell’impresa. Che il San Ferdinando non potesse diventare per Eduardo e per i suoi attori una sede stabile, una “casa”, fu chiaro da subito. Tutt’al più sarebbe stato un luogo di passaggio, l’approdo delle stagioni napoletane. Non poteva essere diversamente per una compagnia non sovvenzionata. D’altra parte quel nomadismo, che era stato considerato nei decenni precedenti come uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un buon livello artistico delle compagnie e che avrebbe portato in quegli anni alla realizzazione in Italia di diverse realtà teatrali stabili, fu per Eduardo soprattutto l’incentivo a una popolarità sempre più vasta e una risorsa per la sua attività di autore e attore. I padroni del teatro The theatre’s laws The theatre’s patrons give And we, that live to please, 35 Dal programma di sala dello spettacolo Pulcinella in cerca della sua fortuna per Napoli, di Pasquale Altavilla, andato in scena al Piccolo Teatro di Milano nel 1958, poi in Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 80. 36 Sul difficile rapporto di Eduardo con gli amministratori napoletani, si veda la questione del Teatro Stabile a Napoli, alla cui direzione Eduardo fu chiamato, prima nel 1958, poi nel 1963, senza che le autorità si decidessero a dare attuazione pratica ai progetti da lui presentati. Sulla vicenda si veda la ricostruzione fatta da Isabella Quarantotti in Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, pp. 78 sgg. 37 Emilio Barbetti, Il caso De Filippo, «Il Ponte», anno X, n. 2, febbraio 1954, p. 273. Must please to live. 38 Questo motto, attribuito a Shakespeare, si attaglia perfettamente alla pratica artistica di Eduardo e alla sua concezione del teatro. Come per gli elisabettiani, anche per lui i padroni del teatro sono gli spettatori. In uno scritto scherzoso preparato per l’inaugurazione del San Ferdinando lo dice esplicitamente: Comme me venette ncapa ’e fravecà stu teatro nun v’ ’o saccio dicere, ’o cert’è ca miezo Pontenuovo ’o San Ferdinando ce sta n’ata vota. E' ’o mio? A me nun me vo’ trasì ncapa ca songo ’o patrone, pecché, scusate: vuie quanno v’avite accattato nu palco o na pultrona, pe’ chelli ddoie ore ca dura ’o spettacolo, site patrune vuie [...] songo patrune tutte chille ca s’accattano ’o biglietto e traseno, e tutte chille ca traserranno quanno nuie simmo 39 muorte tutte quante. Per ogni impresa di spettacolo che non sia finanziata dal denaro dello stato il pubblico è colui che decide le sorti dei teatranti e delle compagnie. Il teatro del Novecento ha cercato in ogni modo di emanciparsi dalla sua dipendenza, vista come un laccio alla libertà dell’artista. L’esperienza di Eduardo è, anche in questo caso, inusuale. Da quando, giovanissimo, ha iniziato la sua carriera teatrale, egli ha imparato a considerare il pubblico come il primo riferimento e a intessere con lui un dialogo che non si è più interrotto. Nei suoi confronti ha elaborato strategie prudenti, ma non pedisseque. Ha imparato ben presto, dai successi e più ancora dagli insuccessi, a non deluderlo troppo nelle sue aspettative, ma allo stesso tempo a portarlo, quasi senza che se ne accorgesse, verso direzioni nuove. In questa strategia rientra l’uso che egli fa del comico. Comprando un biglietto per i suoi spettacoli, il pubblico si aspetta di divertirsi, ma nella materia delle sue commedie Eduardo ha impastato ingredienti non innocui: primo fra tutti, un’osservazione lucida, anche se non impietosa, delle eterne contraddizioni che travagliano la vita di ogni uomo. Così, alle sue performance lo spettatore ride, ma ride “verde”, avvertendo inconsciamente che il vero bersaglio della risata non è il personaggio in scena, ma lui stesso.40 Ma può capitare anche che non si accorga di aver riso di se stesso e allora «dà del buffone all’attore che è riuscito a farlo ridere».41 Sulle reazioni del pubblico Eduardo ha messo a punto le proprie commedie, nei casi più estremi ha addirittura cercato soluzioni alternative per non scontentarlo, come è avvenuto con Uno coi capelli bianchi, per la quale scrisse un finale “di ricambio” e lo recitò di seguito al primo, 38 [Le leggi del teatro / Le dettano i padroni del teatro / E noi, che viviamo per piacere, / Dobbiamo piacere per vivere.] Judith Malina attribuisce questo motto a Shakespeare (senza però indicarne la fonte) nel libro-intervista di Cristina Valenti, Conversazioni con Judith Malina. L’arte, l’anarchia, il Living Theatre, Elèuthera, Milano 1995, pp. 293-4. Al rapporto fra Eduardo e Shakespeare è dedicato il bell’intervento di Agostino Lombardo al convegno «L’arte della commedia», atti citt., pp. 141-54. 39 [Come mi venne in mente di costruire ’sto teatro non ve lo so dire, quel che è certo è che in mezzo a Pontenuovo [?] il San Ferdinando c’è un’altra volta. E' mio? Non vuole entrarmi in testa che sono io il padrone, perché, scusate: voi quando vi siete comprati un palco o una poltrona, per quelle due ore che dura lo spettacolo, i padroni siete voi [...] sono padroni tutti quelli che si comprano il biglietto ed entrano, e tutti quelli che entreranno quando noi saremo morti tutti quanti.] Eduardo De Filippo e il Teatro San Ferdinando, Edizioni del Teatro San Ferdinando, Napoli 1954, s.p., poi in Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 70. 40 Sul ridere “verde”, cfr. Eduardo De Filippo, Lezioni di teatro all’Università di Roma «La Sapienza», a cura di Paola Quarenghi, con una prefazione di Ferruccio Marotti, Einaudi, Torino 1986, pp. 68-9. 41 Riflessioni sul teatro, in Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 148. lasciando, per così dire, al singolo spettatore la possibilità di decidere la sorte del protagonista e il senso del lavoro. Ha conosciuto i tipi di pubblico più disparati: quello borghese e aristocratico, che andava a teatro per divertirsi alle vicende inverosimili delle pochades francesi, abilmente adattate da Scarpetta padre e figlio; e quello popolare dei drammi e delle sceneggiate, che era capace di aspettare l’attore che interpretava il cattivo, ’o malamente, fuori dal teatro per punirlo a dovere; o ancora quel pubblico del varietà, esigente e impaziente (Viviani lo chiamava «la belva»), che poteva portare al trionfo l’artista in grado di conquistarlo, ma poteva anche costringerlo alla fuga se questi non aveva l’orecchio e la sensibilità per prevedere le sue reazioni, per domarlo in tempo. La sua lunga esperienza di attore gli insegna a riconoscere, anche a sipario chiuso, la qualità del pubblico e a scegliere il tipo di recitazione più adatto: [...] dal rumore, dal parlottio che sento in sala prima del segnale del buio, prima di mandare su il sipario, posso dire l’incasso. Dalle prime risate o dal primo mormorio di approvazione o disapprovazione capisco la qualità del 42 pubblico, capisco come si deve recitare quella sera, quale deve essere la tattica da usare [...]. L’uso del termine “tattica” fa pensare a un atteggiamento guardingo. Ed effettivamente il rapporto col pubblico, così appagante per un attore, è anche una sfida che ha bisogno di strategie accorte, fatte di gesti generosi e di ritrosie, di dichiarazioni aperte e insieme di mistero, di forzature e di pazienza. Nella prefazione alla biografia di Eduardo Scarpetta scritta da Mario Mangini, Eduardo parla di «quel procedere prudente, accorto e abile»43 che salvaguardò il rapporto di Scarpetta col suo pubblico, e che mancò invece ad altri autori, suoi avversari artistici, i quali, «ansiosi di realizzare il teatro dei loro sogni», troppo impetuosamente misero da parte ogni tattica e furono abbandonati dagli spettatori. Da quando, ancora bambino, si è presentato per la prima volta di fronte a una platea, abbagliato dalla luce dei riflettori, e ha sentito nascere da quel buio il primo applauso, ha cominciato a capire l’ambivalenza del rapporto col pubblico: confortante, esaltante addirittura per l’attore, ma anche infido: come il mare, che descrive in una sua poesia, quando di notte «vatte ’a scugliera / e caccia ’e mmane... / migliara ’e mane / e braccia / e gamme / e spalle...» e «arraggiuso cumm’è / nun se ne mporta / ca ce straccia ’a scugliera».44 E proprio la parte del mare Eduardo farà “interpretare” al pubblico in una sua commedia, La grande magia, il cui primo atto è ambientato sulla terrazza panoramica di un albergo che si affaccia sul “mare” della platea. Ma come la violenza del mare fa parte delle leggi della natura, così le reazioni negative del pubblico fanno parte delle leggi del teatro. E come del mare che «sta facenno ’o mare», così di quel pubblico che fa il suo mestiere di pubblico non c’è da avere paura, ma neppure si deve sottovalutarne l’autorità o peggio disprezzarla. In un secolo in cui le avanguardie teorizzano la “voluttà di essere fischiati”, l’orrore dei battimani; o sminuiscono l’importanza del pubblico, mettendo nei loro manifesti e proclami l’accento sull’atto della creazione più che su quello della fruizione dell’opera, Eduardo rispetterà sempre l’autorità degli spettatori. Del resto, nel corso della sua carriera, non solo il pubblico non lo abbandonerà mai, ma sarà, nei momenti difficili, un’àncora, un solido punto di riferimento. Se il successo non avesse arriso a lui e ai fratelli, negli anni in cui il fascismo proclamava la lotta contro i 42 Lezioni di teatro, cit., p. 134. Mario Mangini, Eduardo Scarpetta e il suo tempo, Montanini, Napoli 1962, p. 12. 44 Le poesie di Eduardo, Einaudi, Torino 1975, p. 18. 43 regionalismi, forse anche la sua carriera teatrale di attore-autore dialettale sarebbe finita, come quella di tanti altri attori, spazzata via da riforme, decreti, divieti. I riconoscimenti del pubblico invece gli diedero autorità, sia nei confronti del potere, che non poteva mettere al bando una compagnia dialettale così amata e seguita come quella del Teatro Umoristico, sia nei confronti degli altri autori, anche molto illustri, che lo blandivano e arrivavano addirittura alle pressioni politiche per far mettere in scena i loro testi dai De Filippo. Il pubblico gli ha dato sostegno nei momenti difficili, quando la critica e gli intellettuali guardavano con sufficienza o disprezzo al suo teatro; gli ha dato infine la possibilità materiale di continuare il proprio lavoro, senza sottostare ad altre forme di dipendenza, forse più pericolose per un autore, prima fra tutte la dipendenza dal potere. La sua popolarità non è stata un fenomeno effimero, imposto da un’élite o dalla moda di un momento: ha riguardato gente di ogni età, cultura ed estrazione sociale, e dura ancora oggi che lui non c’è più. Io scrivo per tutti: ricchi, poveri, operai, professionisti... tutti, tutti! belli, brutti, cattivi, buoni, egoisti... Quando il 45 sipario si apre sul primo atto d’una mia commedia, ogni spettatore deve potervi trovare una cosa che gli interessa. Il desiderio di farsi capire da spettatori così diversi tra loro ha costretto Eduardo a uno sforzo creativo particolare. Questo sforzo, sottovalutato di solito da chi pensa che l’autore abbia l’obbligo prima di tutto di rispondere alle proprie esigenze creative, comporta invece uno straordinario esercizio di osservazione prima e di comunicazione poi, da cui l’opera teatrale non può che essere arricchita. Prima di qualunque altra cosa, dell’organicità dello stile, della ricerca di forme e linguaggi nuovi, Eduardo ha messo la comunicazione col pubblico. Qualche volta questo sforzo comunicativo ha assunto forme troppo dirette e l’autore non è riuscito a trovare un correlativo oggettivo sufficientemente forte da reggere all’urgenza del suo messaggio. Ma molto più spesso, proprio da questa ricerca di dialogo, di contatto, sono nate le invenzioni più geniali del suo teatro, che hanno portato all’inserimento di intere platee di spettatori all’interno della sua drammaturgia: in veste di pubblico, come nell’atto unico Sik-Sik, l’artefice magico; o di scenografia (come “mare” nella Grande magia); o di personaggio (quel Professor Santanna che è una sorta di “spalla” muta del protagonista). Oppure la comunicazione con gli spettatori ha suggerito la struttura stessa della commedia, come nel suo ultimo lavoro, Gli esami non finiscono mai, in cui Eduardo rinuncia come attore all’identificazione con il proprio personaggio per “mostrarlo” e “mostrarsi” direttamente nella veste di attore e autore. Dalla protesta, dalla rinuncia alla comunicazione con un mondo “sordo”, che non vuol sentirsi dire verità sgradevoli, è nato invece il personaggio “muto” di Zi’ Nicola (Le voci di dentro), che si esprime, solo per chi lo sa capire, con botti e fuochi d’artificio. Il dialogo di Eduardo col suo pubblico non è passato soltanto attraverso la finzione scenica, ma si è fatto anche dialogo diretto con gli spettatori, fra un atto e l’altro o alla fine degli spettacoli, in camerino, o in forma epistolare. Al 1977 risale il progetto, accettato da Einaudi ma poi non realizzato, di pubblicare una raccolta di lettere di spettatori, con le relative risposte di Eduardo; uno scambio che avrebbe dovuto investire «non soltanto il discorso teatrale, ma anche e 45 Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 142. soprattutto i contenuti etici e politici delle commedie».46 Questa comunicazione non si è interrotta neanche quando egli si è ritirato dalle scene, dal momento che ha continuato fino all’ultimo a cercare il contatto con i giovani (nei suoi corsi di drammaturgia) e con la gente, tenendo recital di poesie negli stadi, nelle fabbriche, nelle piazze, accolto sempre con un calore straordinario. Quasi mai, invece, Eduardo si è lasciato adescare dalle malie della comunicazione televisiva. Nonostante sia stato, fra gli uomini di teatro italiani, uno dei primi a lavorare in televisione, intuendone subito le enormi possibilità, ha sempre continuato a usarla come un mezzo per la diffusione e la documentazione del suo teatro. Il suo interesse per la tecnologia televisiva, che lo ha portato a sperimentazioni avanzate (per esempio sull’uso del colore, di cui è stato un pioniere), non è mai stato finalizzato alla ricerca di quello che si chiamava un tempo lo “specifico televisivo”, ma è sempre stato messo al servizio di una sorta di comunicazione teatrale allargata. Mentre è massiccia la presenza di Eduardo sul piccolo schermo come interprete delle proprie commedie, sono rarissime le sue partecipazioni a programmi di intrattenimento, o culturali: spettacoli, talk-show, varietà televisivi. Ad Alessandro Blasetti, che nel 1973 gli scrive per invitarlo a prendere parte alla sua trasmissione L’arte di far ridere, Eduardo risponde di non avere più voglia di “parole”: «se non parlo è perché ho perso fiducia nel “dire”, che ci rende tutti uguali, e preferisco “fare”, che, per lo meno, ci divide in professionisti e dilettanti». E scusandosi con Blasetti per il rifiuto chiude la sua lettera affermando che «quando si arriva a una conclusione pessimistica, che è costata una vita di fatiche e dubbi, non la si può ignorare, sia pure per fare cosa gradita a un amico».47 Due anni più tardi rifiuta anche la proposta di Corrado Augias: Augias gli ha chiesto di presentare in televisione il suo programma sull’Attore, e lui gli ha spiegato come i giornalisti, a poco a poco, stiano distraendo gli attori dal discreto “ritiro” che dovrebbero invece tenersi caro. Infatti, se a un attore gli togli il mistero, che gli resta? [...] Il pubblico non deve identificare i personaggi delle commedie con la vita privata dell'attore che le interpreta. L’attore è un uomo, certo, ma per professionalità deve far finta di non 48 esserlo. Queste dichiarazioni, ben lungi dal contraddire quanto si è detto fin qui sulla volontà di comunicare di Eduardo, sono invece la prova della perfetta coerenza del suo progetto. La sfiducia che egli ha maturato nel “dire” non riguarda infatti la comunicazione teatrale, ma quella finta comunicazione che consiste nell’immolarsi sull’altare dei mass media, davanti a milioni di spettatori, senza quella mediazione artistica che protegge l'intimità dell’uomo di spettacolo e ne mantiene intatto il prezioso segreto. Anche il cinema sarà per Eduardo una esperienza importante, ma nel complesso non sostanziale. Nel girare i suoi film raramente riuscirà a dimenticare il teatro. Quasi tutti, del resto, sono tratti da opere teatrali, sue o di altri autori, e rarissimi sono i soggetti originali. La sua vera comunicazione col mondo è passata attraverso la relazione diretta col pubblico. E questo fin da giovanissimo, da quando ha deciso che il palcoscenico sarebbe stato il suo posto, la sua casa («là so esattamente come muovermi, cosa fare: nella vita sono uno sfollato»).49 Da quella postazione, luogo di osservazione del mondo e luogo di comunicazione col mondo, ha sempre lavorato e 46 Appunto di Elena De Angeli, preparato forse per Giulio Einaudi, [s.d., ma maggio 1977], archivio Einaudi. Eduardo ad Alessandro Blasetti, Roma, 28 settembre 1973, GV. La prima puntata della trasmissione è andata in onda il 25 dicembre 1973. 48 Diario di Isabella, inedito, quaderno II, p. 60. 49 Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit. p. 148. 47 scritto; e ha cercato di salvaguardarla a tutti i costi da qualunque tipo di ingerenza esterna, proteggendo l’autonomia del proprio lavoro e consentendo che entrasse in quello spazio, lo spazio del teatro, solo ciò che al teatro è davvero indispensabile: la realtà, filtrata attraverso la fantasia di un autore, gli attori, il pubblico. Ha lasciato fuori invece tutto ciò che è inutile o dannoso: le speculazioni degli affaristi, gli sperperi, la politica di palazzo, gli interessi corporativi, le raccomandazioni, il pressapochismo e l’imbroglio. In questo modo, senza lanciare proclami ideologici attraverso le sue commedie, ma dando un concreto esempio di moralità attraverso il suo lavoro, ha insegnato non solo alla gente di teatro, ma a tutti, la profonda serietà di un’arte dove non si finge di far sul serio, ma si pratica, con onestà, pazienza e umiltà una finzione necessaria. Il rapporto con la cultura Per usare una definizione coniata da Ferdinando Taviani, si può dire che Eduardo appartenga alla categoria degli “uomini di scena”, e non a quella degli “uomini di libro”.50 Cresciuto in un ambiente in cui l’artista, nel suo fare, non ha come referente diretto il mondo della cultura alta e i suoi esponenti, ma prima di tutto il pubblico e le sue reazioni, egli si accosta alle cose dell’arte con l’atteggiamento libero dell’artigiano, che non pensa a “far grande”, ma a servirsi delle tecniche apprese e a inventarne di nuove, per creare nuovi oggetti d’uso. Tra questi oggetti d’uso è il copione, non ancora diventato testo. Il salto dall’artigianato all’arte verrà dopo, ma Eduardo conserverà sempre l’attitudine di chi non si fa troppo intimorire dai problemi estetici, dai confronti artistici, dai giudizi degli intellettuali. Questo non significa naturalmente che disprezzasse la cultura o i letterati, né che fosse indifferente al loro giudizio; tutt’altro. Ma non erano loro il suo primo referente, e non era il loro ambiente quello nel quale aveva preso le mosse la sua attività di autore, un’attività cominciata a partire da una condizione culturalmente modesta, alla fine di un corso di studi breve e piuttosto irregolare, che aveva lasciato lacune che solo la pratica, la forza di volontà, l’intelligenza creativa avrebbero reso irrilevanti, prima ancora di cancellarle del tutto; ma che il mondo della cultura alta non gli avrebbe mai perdonato completamente. Più che i critici o gli studiosi furono soprattutto gli artisti e gli scrittori (magari nella veste di critici d’occasione) a capire meglio i meriti della sua drammaturgia, perché seppero osservarla non con l’occhiale cieco dei pedanti, con il bilancino dei “grammatici”, ma con la lucidità dei visionari. Tra questi personaggi figurano i nomi degli artisti e degli scrittori più antiaccademici del nostro secolo: Alberto Savinio, Ennio Flaiano, Corrado Alvaro, Salvatore Quasimodo, Ruggero Jacobbi, fino a Dario Fo. Se da un lato la critica teatrale arriverà in ritardo a scoprire le qualità di autore di Eduardo, la critica letteraria (salvo poche eccezioni)51 continuerà, anche dopo questa scoperta, a trattare “il 50 Ferdinando Taviani, Uomini di scena, uomini di libro, Il Mulino, Bologna 1995. Assieme a Ferruccio Marotti e Claudio Meldolesi, Taviani ha prodotto le riflessioni più interessanti sul teatro di Eduardo, collocandole nell’ambito delle ricerche sulla cultura dell’attore a cui questi studiosi, tutti e tre allievi di Giovanni Macchia [?], si dedicano da anni. 51 Tra queste eccezioni si devono ricordare almeno Carlo Muscetta (al quale va riconosciuto il merito di aver patrocinato e curato, per Einaudi, la prima edizione dell’opera teatrale di Eduardo), e Franca Angelini, che, da molti anni si adopera per infrangere le barriere fra le discipline storico-letterarie e quelle storico-teatrali, e ha dedicato caso De Filippo”52 con un certo imbarazzo, relegandolo di solito sbrigativamente nel capitolo dei “dialettali”, guardandolo come un oggetto misterioso, o affrontandolo con strumenti critici poco impegnativi (come l’analisi tematica), senza sforzarsi di collocarlo in quel contesto teatrale che certo avrebbe aiutato a comprenderne meglio i meriti. Per altro, anche come autore dialettale egli viene studiato in modo distratto, senza nemmeno preoccuparsi di analizzare, con strumenti degni di questo nome, la lingua dei suoi testi. Negli anni della compagnia del Teatro Umoristico, quando ancora Eduardo si identificava con quella “società a nome collettivo” che erano i De Filippo, la critica (salvo poche eccezioni, tra cui Renato Simoni ed Eugenio Ferdinando Palmieri) aveva eluso il problema della sua drammaturgia mettendo in risalto soprattutto le sue doti di attore e lasciando in ombra, o negando del tutto, i suoi meriti di autore. Nel dopoguerra però, gli straordinari successi di commedie come Napoli milionaria!, Questi fantasmi!, Filumena Marturano — successi che erano andati oltre la misura ordinaria del fenomeno teatrale — costrinsero i critici a una presa di posizione più netta. Alcuni di loro riconobbero da subito a Eduardo indiscutibili qualità come scrittore di teatro, e continuarono poi a riconoscergliele anche negli anni di minor fortuna. Vito Pandolfi, uno dei suoi maggiori sostenitori, nel 1946 definisce Questi fantasmi! (assieme al film Sciuscià di De Sica) l’espressione più autentica di quell’immediato dopoguerra [citare direttamente Pandolfi].53 E Alvaro, nel 1956, scrive: «Se dovessimo indicare a stranieri un teatro che desse l’essenza della vita italiana dopo la guerra, nella finzione teatrale, indicheremmo Eduardo».54 Ad apprezzamenti di questo tipo si aggiunsero importanti dichiarazioni di stima da parte di uomini di cultura di altri paesi: Eric Bentley, regista e studioso di teatro anglo-statunitense che, fin dai primi anni Cinquanta, avrebbe cercato di far conoscere il teatro di Eduardo nei paesi di lingua inglese;55 e prima ancora Orson Welles, il quale, intervistato a Venezia nel settembre del 1948, dice di ritenere Eduardo l’uomo di teatro «più importante, oggi, in Europa [...]. E non soltanto come attore».56 Ma un’altra parte della critica continuò ancora a considerare le sue commedie come l’espressione di un teatro minore. Un certo atteggiamento di sufficienza venne mantenuto a lungo da Silvio d’Amico, forse il più importante e influente fra gli studiosi e i critici di teatro del importanti ricerche al teatro degli attori (cfr. fra gli altri il volume Il teatro del Novecento da Pirandello a Fo, Laterza, Bari 1976). Nell’ambito delle ricerche specifiche si possono ricordare gli utili repertori di Fiorenza Di Franco (tra gli altri, la teatrografia Eduardo, Gremese, Roma 1978); le analisi critiche di Anna Barsotti (Eduardo drammaturgo (fra mondo del teatro e teatro del mondo), Bulzoni, Roma 1988), che ha curato anche la prima edizione con note introduttive ai testi, cronologia e bibliografia del Teatro di Eduardo; e la documentata biografia di Maurizio Giammusso, Vita di Eduardo, Mondadori, Milano 1993. Interessanti sono anche le prospettive metodologiche di Antonella Ottai, illustrate in vari saggi, che hanno portato alla realizzazione del primo compact disk interattivo dedicato a Eduardo, di prossima pubblicazione per la ERI. [Se non diciamo altrove della Bibliografia diciamolo qui] 52 Questo è il polemico titolo dell’articolo di Emilio Barbetti (cit.), che risale ad anni in cui Eduardo, come autore, aveva già scritto alcuni dei suoi lavori più importanti. 53 Vito Pandolfi, 1946: verità del dialetto, «Il Politecnico», anno II, n. 30, giugno 1946, p. 34. 54 Corrado Alvaro, Eduardo, art. cit. 55 Eric Bentley, Eduardo De Filippo and the Neapolitan Theatre, «The Kenyon Review», vol. XIII, n. 1, winter 1951, e In Search of Theatre, Alfred A. Knopf, New York 1953 [controllare bene i dati bibliografici]. 56 Giulio Cesare Castello, A Orson Welles piacciono Eduardo De Filippo e De Sica, «Il Mattino del Popolo» [Controllare la dizione della testata], Venezia, 4 settembre 1948. Castello aggiunge ancora: «Welles ha molta simpatia per Napoli milionaria e considera l’arte interpretativa di Eduardo come un fatto non soltanto di istinto e di tradizione, ma sopra tutto come un fatto di meditata e studiosissima elaborazione. Egli trova, mi pare, in Eduardo, quella consapevole norma, quella disciplina di cui il resto del nostro teatro è privo». Novecento in Italia, la cui recensione a Questi fantasmi!, pur positiva, denuncia una posizione decisamente “classista”. D’Amico sembra stupirsi e forse anche un poco dolersi che, in anni di crisi grave della drammaturgia italiana, proprio dalla scena dialettale sia venuta una novità che non mostra segni di crisi e anzi concilia pubblico e critica in un consenso pressoché unanime. E quasi a difesa delle proprie posizioni passate, sempre molto liquidatorie nei confronti del repertorio dialettale in generale e di quello di Eduardo e dei suoi fratelli in particolare, precisa: «Noi veramente diremmo che senza la preesistenza di tanto teatro di alta classe assaporato in questi ultimi decenni, nemmeno a dirlo con Pirandello in testa, la bella commedia di Eduardo non sarebbe venuta al mondo».57 In seguito d’Amico avrebbe reso meno tiepidi i propri giudizi (pur conservando sempre un certo aristocratico distacco); ma da questo momento il riferimento alla drammaturgia di Pirandello sarebbe diventato uno degli strumenti di attacco più aggressivi contro il teatro di Eduardo. Vi si fece ricorso soprattutto negli anni Cinquanta, quando la sua fortuna teatrale conobbe una battuta d’arresto, a partire dal “fiasco” della commedia La grande magia (1948) e poi con altri lavori che non avrebbero certo replicato (almeno fino a Sabato, domenica e lunedì, del 1959) i successi delle sue commedie più fortunate. Inoltre, è proprio all’inizio degli anni Cinquanta che comincia la pubblicazione del suo teatro presso un editore importante come Einaudi. Fintanto che le sue commedie venivano rappresentate a teatro e tutt’al più pubblicate sui periodici di spettacolo, il confronto aveva riguardato soprattutto i critici teatrali. Ma nel momento in cui le sue opere entrano, per così dire, nell’Olimpo delle Belle Lettere, e vengono immortalate, come ricorda Luigi Silori, «sub specie aeternitatis»,58 anche la critica letteraria deve cominciare a occuparsi di lui e i giudizi si fanno tanto più severi quanto più cresce la sua popolarità, alimentata dal cinema prima e dalla televisione poi. Tranne alcune importanti eccezioni, i critici letterari o ignorano il teatro di Eduardo o lo trattano con una sufficienza che li porta ora ad atteggiamenti paternalistici, ora a sospensioni di giudizio, ora a stroncature senza appello. Le sue origini di attore comico e dialettale vengono considerate una garanzia non sufficiente per la sua attività di scrittore di teatro. Del resto, dal momento che la drammaturgia è vista come un sottogenere della letteratura, è ovvio che quegli autori che non siano già dei letterati, ma “semplicemente” degli uomini di teatro, debbano essere guardati come intrusi o parvenus, invece che come legittimi abitatori di quel mondo. Bonariamente paternalistico è l’articolo citato di Luigi Silori; del tutto stroncatorio quello di Emilio Barbetti, il quale definisce Eduardo «un “caso” teatrale dei più caratteristici e bizzarri»,59 «un commediografo istintivo, che, traviato da miraggi intellettualistici» (quelli del teatro di Pirandello), ha abbandonato la strada di «un’arte limitata ma genuina» per «penetrare in territori ad esplorare i quali gli mancano, oltre tutto, la preparazione sociale e culturale».60 Nello Ajello poi parla di «confusionaria ed eclettica e mal digerita cultura teatrale».61 E' un debole scudo ad attacchi di questo tipo la dichiarazione di Eduardo a Vito Pandolfi62 che «il teatro non è un libro, non è un’opera letteraria», che è «una linea di mezzo», nel seguire la quale non bisogna dimenticarsi dello «spettatore grosso». Questo vale fino a quando il teatro si fa in scena. Quando è stampato, diventando “libro”, diventa automaticamente anche letteratura. Su questo argomento, certamente il più controverso della sua complessa attività 57 «Il Tempo», 12 gennaio 1946. Luigi Silori, Eduardo De Filippo, «Belfagor», anno V, n. 6, 30 novembre 1950, p. 676. 59 Emilio Barbetti, Il caso De Filippo, cit., p. 268. 60 Ivi, p. 273. 61 Storia e antologia della Napoli proletaria, «Nord e Sud», [trovare annata e numero] luglio 1955, p. 87. 62 Intervista a quattr’occhi con Eduardo De Filippo, «Sipario», anno XI, n. 119, marzo 1956, [pp. ?]. 58 di uomo di teatro, si genereranno i maggiori equivoci. Proprio le sue doti di attore, unanimemente riconosciute e apprezzate, finiranno per essere usate come arma contro i suoi meriti di scrittore di teatro. Le sue commedie — si dice — non avrebbero avuto lo stesso successo se non fossero state interpretate da lui. E anche dopo la sua morte il dibattito è tornato ad accendersi, più o meno con le solite argomentazioni e i soliti interrogativi. Né sembra sia stato preso granché in considerazione il fatto che all’estero il suo teatro sia stato tradotto e rappresentato in tutto il mondo, da compagnie grandi e piccole, e da attori di primo piano come Valentine Tessier, Jacques Mauclair, Käthe Dorsch, Laurence Olivier, Joan Plowright, Ian McKellen, Ralph Richardson, Judy Dench. Ancora una volta è la grandezza d’attore di Eduardo l’argomento più usato come arma di attacco alla sua drammaturgia; ed è piuttosto curioso che non ci si chieda mai se quell’arte avrebbe potuto raggiungere gli stessi livelli senza le sue commedie. Il più appassionato e brillante nel sostenere posizioni di questo tipo è Carmelo Bene, il quale, in occasione degli ottant’anni di Eduardo, lancia un vero e proprio appello per “liberarlo” dalla prigionia dei suoi testi, dalla fissità mortale a cui lo hanno consegnato le edizioni di Einaudi, “l’editore dei morti”, come lo chiama Bene. Eduardo ha paura della morte, è come un bambino. Teme di scomparire per sempre, che mai più nulla si saprà di lui, dopo settant’anni di palcoscenico [...] e allora si affida ai Millenni dell’Einaudi, all’immortalità del testo scritto. Ma Eduardo non c’entra nulla con i suoi testi. [...] Eduardo vive solo nella rappresentazione. E cioè nel solo luogo dove vive il grandissimo attore. Eduardo scrive sulla scena. [...] è grande autore dove è grande attore. E se per gli ottant’anni vogliamo fargli un augurio, propongo: liberiamolo da Einaudi; liberiamolo dai Millenni. Perché se fra mille anni qualcuno lo leggerà rimarrà deluso, getterà via il testo, sconsolato. Non capirà mai la sua unica, 63 inestimabile, irripetibile grandezza. Sulle previsioni di qui a mille anni è certo inutile fare pronostici, ma l’appello di Bene — che per altro si inserisce con coerenza nella sua personale concezione del teatro, della drammaturgia, dell’attore — pone l’accento su una questione fondamentale. Che cosa dovrebbe fare un uomo di teatro che non sia solo un attore-interprete per lasciare memoria di sé e della propria arte? Per non spezzare il filo della tradizione, la trasmissione di un’esperienza che — come dice Eduardo — è un valore indiscutibile, qualunque uso se ne voglia fare? Come attore, anche lui sembra aspirare a una sorta di cupio dissolvi quando contrappone la fissità mortale dell’immagine cinematografica alla possibilità di cambiare che offre invece il teatro («L’attore quando muore deve morire. Basta! Deve sparire! Non deve lasciare quest’ombra, questa falsa vita»).64 Ma anche se come attore nega il valore di quelle “ombre” che continueranno a muoversi sugli schermi dopo la sua morte, come autore non nega affatto il valore storico e artistico che in quei film o in quelle registrazioni televisive è condensato. Non a caso egli è stato tra gli uomini di teatro uno dei più attenti a lasciare una documentazione cospicua e varia della propria attività di attore, regista, autore. Da questo punto di vista poco importa se domani la sua esperienza sarà superata. Allo stesso modo, del resto, anche un uomo di teatro come Carmelo Bene che teorizza la “scrittura di scena” è molto attento a lasciare qualcosa dietro di sé (film, registrazioni televisive, scritti), a produrre una teoria della propria arte, a creare, anche con l’aiuto di critici e studiosi, un’esegesi che gli sopravviva. E lo stesso si può dire di tanti altri uomini di teatro contemporanei. Eduardo non ha mai scritto nulla sul proprio lavoro. Come attore non credeva ai “sistemi”, o alle teorie, convinto 63 64 Carmelo Bene, Liberiamo Eduardo!, «L’Unità», 18 maggio 1980 [controllare il testo]. Lezioni di teatro, cit., p. 138. com’era che il teatro si evolva continuamente assieme alla vita e che non sia possibile congelarlo in un metodo. Sosteneva che l’attore cerca per tutta la vita la perfezione scenica, certo di non poterla mai raggiungere.65 Sono stati questa consapevolezza e insieme l’idea che «il teatro si fa, non si discute» a impedirgli di scrivere sul proprio lavoro e non l’incapacità alla riflessione critica, come da parte di alcuni si è sostenuto. Invece di lasciare condensata in norme e consigli un’esperienza, non solo non verbalizzabile, ma segreta e personale; invece di lasciare ai posteri interpretazioni del suo teatro; invece di erigersi da sé un proprio personale monumento in vita attraverso autobiografie o libri di memorie, Eduardo ha preferito lasciare, a chi sarebbe venuto dopo di lui, semplicemente le sue opere: e prima di tutto le commedie, quel concentrato di sapere teatrale e di osservazione della vita attraverso il teatro che altri, in futuro, avranno la possibilità di giudicare e usare, apprezzare o rifiutare. Sulla validità nel tempo della sua opera d’autore Eduardo non fa pronostici: «Non so quando le mie commedie moriranno e non mi interessa: l’importante è che siano nate vive».66 Se nascere vivo per un testo di teatro significa aderire al proprio tempo, esserne il riflesso e insieme la coscienza critica, produrre nello spettatore un effetto di evidenza che lo porti a riconoscersi nelle vicende di personaggi apparentemente lontani da lui, allora si può dire che molte delle commedie di Eduardo sono nate vive. E se si considera il testo non come un’opera letteraria, ma come il prima e il dopo del teatro, la premessa e l’estratto di quell’esperienza, non si può essere d’accordo con la visione, quella sì profondamente letteraria, di Carmelo Bene. Nel testo, in qualunque testo — anche in Shakespeare, anche in Molière — il teatro non c’è più: c’è stato; dorme, disseminato fra le pagine dalla maestria di un autore e dall’esperienza scenica accumulata dopo la sua creazione. Quel teatro, per manifestarsi di nuovo in atto, deve essere risvegliato da nuovi attori, nuovi registi, che siano in grado di ricollegarsi a quell’esperienza del passato e immettervi una vita nuova, nuove esperienze. Senza questo, neppure il più grande capolavoro di teatro potrà più dire quel che ha da dire. Solo la capacità di parlare in epoche e a culture diverse può dare la prova del valore di un testo. Tra le commedie di Eduardo alcune hanno già superato entrambe queste prove. Molte hanno avuto una vita scenica lunga e fortunata; alcune hanno accompagnato il loro autore-interprete nel corso di tutta la sua carriera e il “sera per sera” del teatro ha depositato in questi testi un valore aggiunto, un ingrediente particolarmente prezioso: il tempo; quel tempo al quale Eduardo autore ha affidato idee e spunti per le sue trame, lasciandoli sedimentare a lungo, a volte per anni, in attesa che gli si imponessero con una tale evidenza da guidargli la mano in una scrittura quasi automatica; il tempo degli innumerevoli confronti col pubblico, dei successi e degli insuccessi, delle incertezze, degli errori e di nuove conferme; il tempo di quella routine quotidiana del teatro, che smussa le asperità, calibra i ritmi, aggiusta le proporzioni; il tempo della storia, che è entrato fra le pagine a modificare generi, intrecci, personaggi; il tempo della vita, che ha cambiato l’uomo (e con lui l’attore e l’autore) eliminando dalle sue creazioni la piccola cifra dello stile personale, l’ingombro dell’egotismo, quel sentore di troppo nuovo che hanno i vestiti appena usciti dal negozio; quel tempo dell’esperienza umana e teatrale che, condensato e trasformato in commedie, ha fatto scrivere a Ennio Flaiano, a proposito di Natale in casa Cupiello, che il teatro 65 «L’attore muore senza poter dire d’aver raggiunto la perfezione. Egli dà al pubblico il risultato della sua continua esperienza artistica, ma tale esperienza, nel momento stesso in cui si raggiunge, diventa un fatto superato» (Eduardo De Filippo, ’O canisto, Edizioni Teatro San Ferdinando, Napoli 1971, p. 71; poi in Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 159). 66 Questa riflessione, che risale al 1970, è pubblicata nel volume Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., p. 142. forse non è «un genere letterario ma un genere di vita, un modo di arrivare alla verità per tentativi che coinvolgono l’esistenza».67 67 Ennio Flaiano, Un teatro per sopravvivere, «L’Europeo», 1 settembre 1966. Paola Quarenghi IL TEATRO NEL TEMPO. STORIA DELL’EDIZIONE CRITICA DELLE “CANTATE” DI EDUARDO1 Il mio intervento, “Il teatro nel tempo”, dovrebbe far riferimento al lavoro realizzato assieme a Nicola De Blasi per l’edizione critica del Teatro di Eduardo nei “Meridiani” di Mondadori, tre volumi usciti rispettivamente nel 2000, 2005 e 2007. Avendo impiegato più o meno vent’anni in questa impresa, ho pensato che non fosse il caso di tenervi qui una ventina di ore a parlarne, quindi ridimensionerò l’intervento e spero di stare nei venti minuti richiesti. Non racconterò quindi la storia dell’edizione critica, ma proporrò alcune riflessioni nate in margine a questo lavoro, e resterò fedele all’idea del titolo originario, che potrebbe quindi essere corretto così: Il teatro nel tempo. Storie dall’edizione critica delle “Cantate” di Eduardo. In questa nostra epoca il tempo sembra essere considerato non un valore o una risorsa, ma piuttosto una merce. Lo consumiamo in fretta, lo usiamo e lo gettiamo. In questa breve comunicazione vorrei parlare di come funziona il tempo nella drammaturgia di Eduardo, e di come, nel corso della sua attività artistica, lo stesso Eduardo lo ha trattato. Naturalmente non pretendo di elaborare una teoria in materia, ma solo di descrivere alcune situazioni o raccontare episodi e testimonianze che mi sembrano in questo senso interessanti e che rivelano un uso del tempo felicemente anacronistico, non solo se confrontato con il nostro modo di considerarlo oggi, ma anche, in buona misura, con quello della sua epoca. Eduardo ha avuto una vita lunga e operosa: è nato nel 1900, ha cominciato a recitare all’età di sei anni, si è ritirato dalle scene nel 1981, e ha continuato a lavorare fino al momento della sua morte, avvenuta il 31 ottobre 1984. Ha avuto dunque a disposizione parecchio tempo e lo ha usato bene. Il tempo della formazione Con quali tempi, con quali modalità è avvenuta la sua formazione artistica? Eduardo è — come si dice in gergo — un figlio d’arte. Ha lasciato la scuola molto presto. Lui stesso si definiva uno «scrittore di teatro “illetterato”», che ha imparato il mestiere «con cocciutaggine ed entusiasmo, sbagliando, cadendo, rialzandosi e finalmente realizzandosi attraverso il suo lavoro».2 Così racconta degli inizi del suo apprendistato: Avevo sei, sette anni e passavo giornate intere a teatro. Essendo figlio d'arte mi riusciva facile farlo. Una commedia, o dalle quinte, o da un angolo di platea, o con la testa infilata tra le sbarre della ringhiera del loggione, o da un palco me la vedevo chissà quante volte. Ricordo con chiarezza che perfino gli attori che più ammiravo e che più mi entusiasmavano […] suscitavano in me pensieri critici. “Quando farò l'attore io, non parlerò così in fretta”, oppure: “Qui si dovrebbe abbassare la voce”, oppure: “Prima di quello strillo ci farei una pausa lunga almeno tre fiati”. Ma allora, perché restavo là inchiodato ad ascoltare, dimenticando ogni altra cosa? Perché, forse senza saperlo, io che ero appena arrivato nel mondo del teatro, stavo servendomi del punto di partenza fornitomi da quegli artisti, per muovere i miei primi passi, per cercare me stesso, il mio stile. (E.D.F., lezione-spettacolo tenuta a Montalcino nel 1983, in «Piccolo Teatro di Milano» 1985, pp. 16-17) 1 Questo scritto è il testo di un intervento proposto nell'ambito del seminario “La commedia umana di Eduardo”, tenutosi all’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria il 28 maggio 2009. 2 Ringraziamento per il conferimento della laurea, in Allocuzioni pronunciate durante la cerimonia di consegna di lauree honoris causa, Aula Magna, 18 novembre 1980, tip. D’Amato, Roma s.d., pp. 17 sg.; poi in «Biblioteca Teatrale», [n.s.], nn. 57-58, gennaio-giugno 2001, p. 244. È proprio in questa situazione di apprendistato silenzioso e discreto, non prescrittivo, senza regole né orari, che il piccolo Eduardo comincia a educare la sua capacità di osservazione, ad affinare i suoi strumenti critici. E ancora: Stando in teatro tutto il giorno, ho imparato, con la pratica e con l'insegnamento di grandi maestri di quell'epoca, tutto ciò che c'è da imparare in palcoscenico. Facendo teatro, si viene a contatto non soltanto con le arti propriamente teatrali: la recitazione, la drammaturgia, la regia, ma anche con la pittura, il disegno, la scultura, la musica, il canto, la danza e s'impara di necessità un poco di tutto. [...]. In palcoscenico si impara a conoscere anche l'artigianato, meno appariscente delle cose di cui v'ho parlato ma d'importanza altrettanto vitale per mettere su uno spettacolo. [...] Ricordo che mio padre, Eduardo Scarpetta, mi regalò una scrivania per invogliarmi a ricopiare testi teatrali, a dieci pagine al giorno. Così fu che copiando commedie, farse e tragedie, a poco a poco, copia oggi e copia domani, finii per capire il taglio d'una scena, il ritmo dei dialoghi, la durata giusta per un atto unico, per due, per tre atti. (Ringraziamento per il conferimento della laurea honoris causa, cit., p. 18) I passi appena letti, da un lato comunicano l’idea di un apprendimento globale, non prescrittivo e programmatico, ma libero, un apprendimento che sceglie da sé tempi e modi; dall'altro fanno riferimento a un sistema e a una tradizione già esistenti da cui partire, da cui ricavare ciò che può servire e scartare ciò che non piace, non interessa più o non è più adeguato. Ed è un apprendimento basato non sulla trasmissione di nozioni, ma sull’osservazione del lavoro altrui. Inoltre, nei passi citati, Eduardo sottolinea l'importanza di un apprendistato non settoriale, ma globale: non sono solo le competenze artistiche che gli interessano, ma anche quelle tecniche e artigianali, così importanti in quell'arte materiale che è il teatro. L’apprendimento, inoltre, si allarga fino a comprendere la vita del teatro nel suo insieme, con le sue pratiche, i suoi pregi e difetti, i suoi valori, e anche le sue esigenze, come quella di provvedere, in un’epoca in cui i sistemi di riproduzione non sono ancora meccanizzati e serializzati, ma manuali, alla trascrizione dei copioni, o anche solo delle “parti” da fornire agli attori della compagnia. Un lavoro che noi considereremmo noioso e poco gratificante, ma che permette al giovane Eduardo di assimilare, non per via razionale, ma fisica, le strutture e i tempi di un tipo di drammaturgia che poi potrà modificare o anche rivoluzionare, ma che intanto apprende. È noto, fra parentesi, come un attore di tradizione e formazione ben diversa da Eduardo come Gian Maria Volonté si appropriasse della parte proprio scrivendo e riscrivendo le battute del personaggio, incorporando concetti, pensieri e parole attraverso il movimento fisico della mano che scrive, e collegando così corpo e mente. Il tempo della gestazione artistica Quando si approfondisce la storia del teatro di Eduardo, e si cerca di risolvere quel problema delle origini che è un po' l'ossessione degli storici, ci si sorprende nello scoprire che in parecchi casi i suoi soggetti teatrali sono nati molto prima di venire utilizzati e hanno aspettato anni, o addirittura decenni prima di diventare commedie. Questa pratica appare particolarmente singolare se pensiamo al valore che hanno oggi le idee e alla fretta con cui le consumiamo. Questi fantasmi! (1946), una delle commedie più fortunate di Eduardo, che è fra l'altro così legata, se non nell'intreccio, negli umori, al clima di incertezza del dopoguerra, venne ideata negli anni trenta. Del soggetto dell’Arte della commedia, scritta nel 1964, l'autore racconta la trama quasi in dettaglio già in un’intervista del 1952. Il figlio di Pulcinella, pubblicata nel 1960 e messa in scena nel 1962, aveva già un intreccio ben elaborato nel 1955. E l’ultimo dei lavori di Eduardo, Gli esami non finiscono mai, scritto nel 1973, così innovativo nella struttura e difforme rispetto alle grandi commedie del dopoguerra, era stato pensato proprio in quell’epoca, per sostituire eventualmente Filumena Marturano, che è del 1946, nel caso che quest’ultimo lavoro non avesse successo. È Eduardo stesso a teorizzare, durante una lezione all’Università «La Sapienza» di Roma, la necessità di coltivare le idee, di lasciarle maturare fino a che non si impongono alla mente del loro autore e chiedono con urgenza di essere portate alla realizzazione. Allora può capitare, come è capitato a lui più di una volta, che la stesura di un testo sia poi rapidissima e che avvenga in modo quasi automatico. Quell’automatismo però non significa approssimazione o casualità. Al contrario, la rapidità della redazione è il frutto di una solida conoscenza delle tecniche di costruzione drammaturgica, ma anche di un’elaborazione interiore molto accurata, grazie alla quale la scrittura non è che l’ultima fase, quella concreta e materiale, della creazione. Quei soggetti, quegli intrecci sviluppati in tempi a volte rapidissimi — Le voci di dentro venne scritta in una settimana, Filumena Marturano in dodici giorni — hanno avuto a volte una sedimentazione lunghissima e il loro autore non ha avuto fretta di portarli alla vita della scena, ma ha aspettato il momento, la congiuntura più opportuna, o anche solo l’occasione. Il tempo della maturazione (la costruzione del mestiere) Il 3 dicembre 1938 compare sulla rivista “Film” un articolo di Gherardo Gherardi, che era un autore teatrale abbastanza apprezzato all’epoca, il quale trova da ridire sui metodi, a suo dire sbrigativi, impiegati dalle compagnie dialettali nella preparazione dei loro spettacoli. Siamo negli anni della battaglia condotta dal governo fascista contro quelli che venivamo chiamati “i regionalismi”, per cui si cercava di opporsi all’uso del dialetto a teatro (e più ancora al cinema). Questa battaglia, oltre che con precise direttive ai direttori dei giornali affinché pubblicassero (o non pubblicassero) questo o quell’articolo (le cosiddette “veline”), era sostenuta da una ben congegnata campagna di stampa, che vedeva impegnati anche intellettuali, letterati, scrittori, più o meno disinteressati e in buona fede, solidali con gli orientamenti del regime. Nel suo intervento, Gherardi, dichiarandosi contrario al nomadismo teatrale, attacca apertamente le compagnie dialettali, che all’epoca avevano molto successo, chiamando in causa in modo esplicito i De Filippo: Assistiamo — scrive — al fenomeno delle compagnie dialettali che, sole, possono resistere all'attuale organizzazione. Perché effettivamente esse e il loro repertorio e il modo di intendere l'arte del teatro possono trovarsi a miglior agio in un mondo stranamente arretrato come quello del teatro. Ed ecco che nella metropoli, dopo aver avuto tre compagnie di riviste contemporaneamente, abbiamo ora tre compagnie dialettali (napoletana, genovese, veneziana) in due delle quali il metodo artistico ritorna con violenza incomprensibile alle antiche forme del teatro dell'arte. Due grandi attori come i De Filippo riprendono con sempre maggior frequenza il sistema di pensare una commedia alla notte, di provarla la mattina dopo per rappresentarla in settimana. Grande successo, certo: i De Filippo sono i De Filippo e hanno spesso ragione. Ma il sistema è quello che è: tutto meno che moderno, tutto meno che attuale, anche da un punto di vista schiettamente artistico. Sarebbe ora eccessivo far risalire all'organizzazione attuale del teatro la responsabilità di questi metodi d'arte arretrati, ma è un fatto che questi parallelismi tra arcaicità dell'organizzazione e arcaicità del metodo artistico non possono non indurre a riflessioni paurose. (Gherardo Gherardi, Il progetto De Stefani sarà realizzato?, “Film”, 3 dicembre 1938) Chiamato in causa, Eduardo, che era amico di Luigi Antonelli, critico teatrale del “Giornale d’Italia”, scrive una lettera aperta al direttore di quella testata, replicando in modo molto preciso a Gherardi: Se il pubblico viene a noi con pieno consenso, a Tripoli come oggi a Trieste, a Napoli come a Milano, [...] una ragione ci deve essere! Questo periodo di voga e di comprensione, noi lo abbiamo atteso per lunghissimi anni, diciamo almeno venti, recitando nelle compagnie di ordine e in quelle a scartamento ridotto; nei grandi teatri e nei baracconi; nelle metropoli e nei paesetti di provincia [...]. Dovemmo lottare con le unghie e con i denti; dovemmo comporre le nostre commedie, battuta per battuta [...] fra gli assillanti problemi del lunario e dell’incerto domani. Quelle commedie [...] costarono anni di lavoro sconosciuto; e alcune dormirono a lungo nel cassetto, senza che nessun capocomico volesse rappresentarle; senza che nessun uomo e maneggione di teatro ci volesse accordare tanto di fiducia da comporre per noi una modesta compagnia ed allestire una decorosa messa in scena. («Il Giornale d’Italia», 15 dicembre 1938) Quella estemporaneità apparente, che Gherardi scambia per approssimazione, è in realtà il frutto di un lavoro silenzioso durato anni, un lavoro a lungo misconosciuto. Ma l'idea espressa nell'articolo, che Eduardo propone come rivendicazione forte, ha anche un suo aspetto positivo che secondo me è molto importante da recuperare soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui i talenti tendono a bruciarsi troppo rapidamente: un artista giovane ha un successo clamoroso e quel successo gli pesa come qualcosa di difficile da elaborare, con conseguenze pesanti sul futuro della sua carriera (oltre che della sua salute psichica). L’iniziale difficoltà ad affermarsi, nella concezione di Eduardo, può diventare un valore: la condizione ideale perché la creatività abbia modo di esercitarsi secondo ritmi propri e senza aspettative paralizzanti o condizionamenti esterni. Di questo argomento, in rapporto ai processi di creazione del suo teatro, Eduardo tornerà a parlare molti anni più tardi, in un’intervista rilasciata alla studiosa americana Mimi d’Aponte, in cui il tempo della creazione solitaria è indicato, in modo ancora più esplicito, come una risorsa: [Il mio teatro] crebbe perché fu lasciato solo. Per trent’anni nessuno lo disturbò. («Oh, è una cosa dialettale — passerà»). E così, col tempo e la possibilità di crescere naturalmente, si è sviluppato un teatro. Non si può imparare a recitare in un anno, o costruire un teatro in un anno. (Mimi d’Aponte, Encounters with Eduardo De Filippo, «Modern Drama», anno XVI, n. 3-4, dicembre 1973, p. 350) Quindi il tempo della lunga gestazione e della faticosa preparazione, il tempo difficile dei rifiuti, delle difficoltà, non rappresenta solo un ostacolo alla creazione artistica, ma anche una preziosa protezione per un’attività che deve maturare con i suoi ritmi, con i suoi tempi, per l’appunto. Il teatro come specchio del suo tempo Ma il tempo è anche oggetto dell’osservazione di Eduardo scrittore di teatro e attore. Le sue commedie, a volte accusate di essere un po’ appiattite su una visione naturalistica e piccolo-borghese della realtà, sono invece il frutto di un’analisi disincantata e a volte profetica di un microcosmo che riflette una realtà ben più vasta. La sua analisi è spesso severa e per nulla accomodante, benché faccia reiferimento, di solito, a situazioni trattate in chiave comica o umoristica. Come scrive in una sua testimonianza Fellini, spettatore negli anni trenta di un'edizione di Natale in casa Cupiello, la visione di quegli interni domestici modesti, di quei personaggi ignari e infelici eppure determinati a vivere, negli anni in cui la commedia venne scritta e rappresentata costituivano un eccellente antiveleno contro le mitologie false e roboanti messe in giro dal regime fascista a scopo di propaganda e rappresentavano un salutare «viaggio attraverso l’italianità» (questo il titolo dell’articolo di Fellini), una forma di resistenza contro la falsificazione della realtà messa in atto dal regime. E non è un caso che la critica più conformista attaccasse le scelte di repertorio di quegli attori e li invitasse a presentare «ambienti più decorosi», a liberarsi di quella «straccioneria morale e materiale» che, a suo dire, avrebbe caratterizzato i loro spettacoli.3 Gli interni realisticamente piccolo-borghesi che la commedia di Eduardo proponeva al pubblico non rappresentavano un ripiegamento nostalgico verso una realtà particolaristica e provinciale, ma secondo Fellini mostravano, in quel tempo di cortei, bandiere, camicie nere, fanfare, e di «tutta la manifestazione roboante del mito guerriero romano e italiano», «una visione delirante, addirittura conturbante, cui si giungeva però attraverso i modi della risata e della farsa»4. Una commedia come Napoli milionaria!, scritta nel 1945, ha tutta la forza che nasce dall’«urgenza di dire la verità» (questa è la definizione che dà del neorealismo Sergio Amidei, sceneggiatore di un grande film di quegli anni, Roma città aperta, che di quell’epoca è diventato un simbolo); una verità che non è più possibile contenere, nel momento in cui il bavaglio della repressione è stato tolto; ma una verità che non sono in molti ad aver fretta di raccontare e che non rappresenta la voce di chi si accoda trionfalisticamente ai nuovi vincitori, ma li mette in guardia dai pericoli che si annidano dietro la vittoria. L'immagine che Eduardo presenta di quella vittoria è così poco trionfalistica che non ci si stupisce che, nonostante i reiterati progetti di messa in scena negli Stati Uniti, risalenti già ai primi anni del dopoguerra, Napoli milionaria! non sia mai stata rappresentata in quel paese. Un altro esempio può riguardare Questi fantasmi!, una commedia apparentemente assai meno legata all’oservazione della realtà del tempo, ma che mostra il disagio di quegli anni in forma allusiva, comica, umoristica. Il successo fu clamoroso e Questi fantasmi!, non a caso, venne indicata da Vito Pandolfi, in un articolo comparso nel giugno 1946 sulla rivista di Vittorini «Il Politecnico», come l’opera che, assieme al film Sciuscià di De Sica, sarebbe stata in grado un giorno di «risuscitare nella nostra memoria il senso e l’affanno di questi anni», perché entrambi questi lavori «esercitano un’adesione diretta alla cronaca e alla storia» e sono attualmente i soli che «diano una appropriata rappresentazione del nostro stato d’animo». Ai suoi studenti della scuola di drammaturgia tenuta alla «Sapienza» di Roma dal 1981 all’83, Eduardo raccomadava di non limitarsi a quell’autoauscultazione a quell’autoconfessione che sembrano piacere tanto a sceneggiatori e autori di poco talento, ma di osservare la realtà, la gente, appuntando lo sguardo in ambienti disparati, cercando di cogliere quei gesti, quei modi di parlare che riflettono e caratterizzano il loro tempo. Ma raccomandava loro anche di non soffermarsi sulla riproduzione pedissequa di questa realtà, bensì di vivificarla con la fantasia, perché la realtà nuda e cruda in teatro è noiosa. Dava loro, insomma, quello stesso consiglio che Amleto dava agli attori venuti a recitare a Elsinore, perché il fine del teatro «dalle origini a ora, è stato di tenere, per così dire, lo specchio alla natura, di mostrare alla virtù i suoi lineamenti, al vizio la sua immagine, e all’età e al corpo del tempo la loro fama e impronta» (Amleto, III.ii.22-24; il corsivo è mio). Il tempo della cristallizzazione E poi c’è il tempo di vita del suo teatro. Non dimentichiamo che le commedie di maggior successo Eduardo ha continuato a recitarle per decenni, per una vita. Pensiamo per esempio a Natale in casa Cupiello, scritta nel 1931 come atto unico per l’avanspettacolo, poi diventata commedia in due e infine in tre atti. Questo lavoro Eduardo lo ha recitato per quasi cinquant'anni, fino all'ultima edizione, quella 3 Ermanno Contini, rec. a Natale in casa Cupiello e Cupido scherza e spazza (quest’ultima di Peppino), «Il Messaggero», 4 novembre 1933. 4 Federico Fellini, Un viaggio attraverso l’italianità, in «Piccolo Teatro di Milano», quaderno n. 3, 1985, p. 41. televisiva del 1977. In un arco di tempo così lungo, la commedia si trasforma e queste trasformazioni sono rese più facili dal fatto che Eduardo assomma nella sua persona le funzioni di autore, attore, capocomico, regista. Come autore può così accogliere nel testo, senza mediazioni, quei cambiamenti o quegli arricchimenti che come attore, regista o capocomico sente necessari o importanti, non solo per rispondere alle esigenze della compagnia, di volta in volta diverse, o all'evoluzione del proprio ruolo di interprete-regista, ma anche ai cambiamenti di gusto del pubblico. Inoltre, un lavoro che viene portato avanti nel tempo, e che in qualche modo diventa un classico, assume su di sé il riflesso delle epoche che attraversa. E in questo processo l'opera si trasforma. La commedia Napoli milionaria! rappresenta un caso particolare. Nell'edizione del 1945 la conclusione della vicenda era sospesa, rinviata alla fine di quella nottata a cui allude il protagonista, ma che si prolungava nel “fuori scena”, una volta calato il sipario. Quando Eduardo, nel 1977, in pieni “anni di piombo”, adatta la commedia per farne un'opera lirica per il Festival di Spoleto con le musiche di Nino Rota, decide che quella nottata che avrebbe dovuto por fine alle ansie e ai patimenti della famiglia Jovine, non è passata per niente e dà alla vicenda una conclusione tragica: il figlio di Gennaro, Amedeo, che nella versione originaria rinunciava al furto per stare vicino alla famiglia e alla sorellina malata, muore durante un conflitto con la polizia. Certo, in questo caso si tratta non di una modifica alla commedia, bensì all'intreccio, impiegato per realizzare un'opera diversa, ma molti altri esempi si potrebbero fare di come le commedie si siano trasformate nel tempo. Non ti pago delle ultime edizioni non è la stessa commedia pubblicata nell'agosto del 1940 sulla rivista “Scenario”. L'uscita di Peppino dalla compagnia nel 1944 costrinse Eduardo a revisionare ampiamente il lavoro, e ad assumere su di sé parte di quel peso drammatico che era stato del fratello, protagonista assoluto del vecchio terzo atto. Quel personaggio, che Peppino aveva contribuito a creare, Eduardo in un certo senso lo incorpora nella propria interpretazione, nei monologhi in cui lo descrive con dovizia di particolari e con esilaranti effetti comici. Bene mio e core mio, commedia ironica e maliziosa sulla famiglia, nell'adattamento realizzato nel 1983 da Eduardo per la compagnia di Isa Danieli e Piero di Iorio, ha un carattere ancora più graffiante e amaro di quello dell’originale, risalente al 1955. E ancora, per tornare a Natale in casa Cupiello, nel momento in cui attraversa gli anni sessanta e settanta, la commedia viene contagiata, per così dire, dalla protesta giovanile e dal femminismo e anche i suoi personaggi femminili si trasformano: Ninuccia trova argomenti più forti alla sua fuga da un marito che non ama e che è stata costretta a sposare, e la Concetta di Pupella Maggio, dopo tanti anni di matrimonio con un marito inetto, non ha più la stessa rassegnata pazienza che aveva la Concetta di Nina De Padova e cede facilmente all'ironia e agli scatti di nervi. Questi cambiamenti a volte si depositano nel testo in forma di varianti, a volte sono affidati solo all'interpretazione del regista e degli attori. Ma c'è comunque una trasformazione continua delle commedie, almeno di quelle più fortunate che hanno avuto una vita scenica più lunga: come organismi viventi, esse si modificano, si stratificano e si sedimentano nel tempo. Il tempo per l’attore e per il pubblico Il tempo della clessidra o dell'orologio scorre sempre alla stessa velocità. Il tempo del teatro, no. Uno spettacolo breve ma noioso ci può sembrare eterno, uno divertente o interessante, anche se dura tre ore ci può lasciare con l’appetito insaziato. Un bell’esempio è la magnifica edizione di Toni Servillo di Sabato, domenica e lunedì, tre ore di spettacolo che volano in un minuto. Tanto soggettivo e a-cronologico è il tempo del teatro che può anche realizzarsi il paradosso di un aforisma di Eduardo: «Il pubblico italiano vuol venire a teatro tardi, se ne vuole andare presto a casa e vuol vedere uno spettacolo lungo»5. Roberto De Simone dà della percezione soggettiva del tempo a teatro una spiegazione lapidaria e affascinante: «il grande attore assorbe il tempo» dice, lo trattiene, lo trasforma e lo restituisce allo spettatore in forma di emozione. Perché questo avvenga, però, ricorda, non bastano né una bella commedia, né un bell’allestimento, né un bravo regista, occorre che ci sia anche un grande attore. Quando recitava, Eduardo spesso giocava col tempo (e col suo pubblico), come fa il gatto col topo: entrava in scena e procrastinava l’inizio del dialogo per una durata che potrebbe sembrare lunghissima, ma che lui riusciva a riempire, senza parlare, della sua sola, taciturna presenza. Il personaggio di Eduardo in Mia famiglia (1950) non parla per almeno metà del secondo atto. Don Peppino Priore di Sabato, domenica e lunedì (1959) si esprime più a silenzi che a parole. Nel Sindaco del Rione Sanità, una commedia che inizia e procede senza dialogo per una decina di minuti e più da quando si apre il sipario, il protagonista ha diverse scene quasi mute. Si è parlato fin troppo dei “silenzi di Eduardo”. La formula — come tutte le formule — lo irritava anche un po’. Ma è indubbio che più maturava nel tempo, più la sua arte di attore si faceva rarefatta, essenziale e un critico sottile come Cesare Garboli poteva descrivere la sua recitazione nell’ultima edizione di Natale in casa Cupiello, come una non-recitazione, una «taciturna presenza» e lo spettacolo come «un rito». Del resto questa capacità di giocare col tempo, di riempirlo con quel niente difficilissimo da raggiungere che è un'arte decantata, un artificio tanto rarefatto da diventare invisibile, era resa possibile dalla conoscenza che Eduardo aveva dei tempi teatrali, che gli permetteva di sovvertirne anche le regole tradizionali, senza per questo distruggere la sottile trama della relazione fra l’attore e il pubblico. Il tempo della vita. Il tempo oltre la vita Una volta, nel corso di una delle sue lezioni di teatro all'università di Roma, Eduardo diede una definizione molto suggestiva della vita dell'uomo: Io ho sempre considerato la terra, il mondo, una sala d'aspetto. Immaginate la sala d'aspetto di un dentista dell'Ottocento, dove arrivavano dei clienti con il mal di denti, che è la cosa più noiosa, fastidiosa... E in questa sala d'aspetto c'erano mille distrazioni: c'era la lanterna magica, c'era il cinema di allora che si faceva attraverso le silhouettes, c'erano le cartoline a doppio che davano il rilievo, tutte cose per distrarre. Poi c'erano libri, giornali dell'epoca, con disegni a colori secondo le tecniche del tempo. E uno stava lì in mezzo a tutte queste distrazioni e aspettava... Aspettava che cosa? Di andare a cavarsi un dente, un molare. Noi ci dobbiamo distrarre in qualche modo per tirarci questo dente definitivo. [...] E il dono che abbiamo avuto, di aver capito questo, ha fatto nascere Michelangelo, Picasso, Morandi, che hanno avuto delle soddisfazioni... E poi se ne vanno all'altro mondo e ti saluto! E viene la nuova generazione: il punto di arrivo, il punto di partenza... (Eduardo De Filippo, Lezioni di teatro all'Università di Roma «La Sapienza», a cura di P. Quarenghi, prefazione di F. Marotti, Einaudi, Torino 1986, p. 133) Certo per chi — e sono tanti nel nostro tempo — è abituato a considerare la propria singola vita come l'unico tempo possibile, questa idea dell’esistenza come una sala d'aspetto, sia pure piacevolmente allietata dalle distrazioni dell'arte, può apparire incomprensibile, assurda. Anche la religione tende a considerare la vita come un transito, ma quella di Eduardo è una concezione del tutto laica, che non prevede il passaggio ad alcun al di là. Per lui la morte è quel “dente definitivo” che tutti quanti dovremo prima o poi toglierci e non la porta di accesso a una realtà superiore. E però la 5 Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, a cura di Isabella Q. De Filippo, Bompiani, Milano 1985, p. 151. morte di ogni singolo uomo rappresenta anche qualcos'altro: il punto di partenza per chi viene al mondo dopo di lui: Si dice che nella vita dell’uomo c’è un punto di partenza ed un punto di arrivo, di solito riferiti all’inizio e alla fine di una carriera. Io, invece, sono convinto del contrario: il punto di arrivo dell’uomo è il suo arrivo nel mondo, la sua nascita, mentre il punto di partenza è la morte che, oltre a rappresentare la sua partenza dal mondo, va a costituire un punto di partenza per i giovani. Perciò a me la morte m'incuriosisce, mi sgomenta, ma non mi fa paura, perché la considero la fine di un ciclo — il mio ciclo — che però darà vita ad altri cicli legati al mio. Soltanto così, anche se non crediamo in un dio al di fuori di noi, possiamo sperare nell’immortalità [...], in quanto qualcosa di noi viene trasmesso ad altri esseri umani, giovani, i quali a loro volta, dopo aver esaminato il “lascito” e scartato quello che non gli serve, alla fine del loro ciclo passeranno la mano (come si dice a Chemin de fer) ad altri giovani. (Eduardo. Polemiche, pensieri, pagine inedite, cit., pp. 181-82) Questa idea che la morte sia un punto di partenza, non la fine di tutto, questa visione vichiana di cicli che generano un'eternità laica, un tempo oltre il tempo, è qualcosa di confortante e insolito, che dà spazio a una visione non meschina, non individualistica dell'esistenza. E in questa cornice si inserisce anche la definizione, originale e sanamente anacronistica, che Eduardo dà della tradizione: Questi miliardi di punti di partenza, che miliardi di esseri umani, morendo, lasciano sulla terra, sono la vita che continua. La vita che continua è la tradizione. Se un giovane sa adoperare la tradizione nel modo giusto, essa può dargli le ali. [...] Naturalmente, se si resta ancorati al passato, la vita che continua diventa vita che si ferma — e cioè morte —, ma se ci serviamo della tradizione come d’un trampolino, è ovvio che salteremo assai più in alto che se partissimo da terra! (Ivi, p. 182) Nel novecento, secolo di rivoluzioni e dissacrazioni, la tradizione è di solito qualcosa che riguarda il passato, e come tale va rigettata. Per Eduardo, invece, è qualcosa che riguarda il futuro: è un trampolino, quasi una rampa di lancio da cui partire per andare più lontano. L'idea che viene evocata, a questo punto, non è più temporale, ma spaziale. Ed è molto concreta: si tratta di esaminare il “lascito”, di recuperare ciò che può servire o piacere e abbandonare il resto. Proprio come faceva lui da bambino, quando osservava il lavoro degli attori della compagnia paterna: quando si serviva del “punto di partenza” fornitogli da quegli artisti, per muovere i primi passi, per cercare se stesso, il suo stile. Estratti da: Dario Fo parla di Dario Fo Intervista e saggio introduttivo di Erminia Artese Edizioni Lerici, 1977 [...] Tutto comincia da dove si nasce. Io, sono nato in un paesino del Lago Maggiore, San Giano, al confine con la Svizzera. Un paese di contrabbandieri e di pescatori diciamo di frodo. Due mestieri per i quali non basta aver fegato: occorre anche una grande fantasia. Ora chi usa la fantasia per trasgredire la legge ne tiene sempre da parte una riserva per divertire se stesso e gli amici. In quell’ambiente, ogni uomo è un personaggio e nello stesso tempo l’autore e il protagonista di una storia che racconta. Di quelle storie mi sono fatto un bagaglio da quando avevo sette anni, e frequentavo quei contrabbandieri e quei pescatori. Da loro ho imparato non solo i contenuti delle storie ma un modo di raccontarle. E prima di tutto un certo modo di guardare e leggere le cose della realtà. Il modo di usare gli occhi che aveva quella gente, classificando tutti in un baleno in personaggi o in coro, in costruttori di storie o in ripetitori (autori e attori), fu la mia arma principale quando arrivai in città (per noi città significa Milano). Dei miei compaesani, quelli che più mi piacevano erano i fabulatori, che giravano il lago Maggiore dalle mie parti, raccontando nelle piazze, nelle osterie, le loro storie, che non avevano letto in nessun libro. Erano storie che nascevano dall’osservazione della vita quotidiana, piene di un’amarezza che si sfogava in satira. Ma partendo da un caso qualunque le loro favole prendevano quota e spesso arrivavano ai toni dell’iperbole. Raccontavano sempre in prima persona. Ora avevano messo per rabbia troppa forza nel lanciare la lenza e avevano raggiunto campanili nascosti in fondo al mare. Ora si erano messi in gara per una corsa, ma avevano dimenticato di mollare gli ormeggi ed erano arrivati secondi al traguardo. Ora avevano fatto i furbi gareggiando nella corsa con le lumache e, quando la lumaca arrivata prima si era sfracellata contro una pietra, si erano commossi e non avevano avuto cuore di raccoglierla per mangiarla. Oppure raccontavano di esploratori del mondo sottomarino che scoprivano un paese telquesura, ma immobile e cristallino come tutti i suoi personaggi. Uno degli esploratori, qualche volta, penetrava in un palazzo dove c’erano tante statue nude: una rappresentava un uomo con le alette ai talloni — era Mercurio — l’altra una bella donna con l’arco in mano — Diana —. Se l’intruso si avvicinava a carezzare Diana, Mercurio strabuzzava gli occhi: si capiva che sarebbe scattato mandando all’aria la sua posa, se non fosse stato che era una statua, e le statue hanno il dovere di restare immobili, è il loro mestiere. Lo scatto c’era, ma appena l’estraneo tornava a girarsi verso di lui, la statua si affrettava a ricomporsi. Non sempre tornava a posto nel momento giusto: il visitatore lo coglieva immobile, ma ora con la testa girata, e gli occhi minacciosi, ora con il braccio proteso. […] Con i fabulatores avevo scoperto che esiste una cultura fatta da quelli che sono sempre stati definiti gli ignoranti, i paria della cultura ufficiale. Quando più tardi, ventenne, andai a studiare architettura a Brera, interessandomi di chiese romaniche mi resi conto che non erano opera di intellettuali e di artisti classificati come tali, ma di umili, semplici scalpellini. D. Se hai assimilato i modi di racconto dei tuoi amici fabulatori, i materiali per le tue storie, per le tue commedie li hai trovati più tardi anche nella produzione letteraria e teatrale colta, oltre che nella tradizione popolare… R. Cosa intendi per produzione colta? La rielaborazione che cultori del patrimonio e della tradizione popolare particolarmente dotati di fantasia fanno dei temi e di situazioni che scoprono in quella tradizione? Se è così questi raccoglitori di ogni epoca li ho saccheggiati. Per esempio ho fatto uno studio di tutte le chiavi di azioni comiche. Le ho trovate soprattutto nella drammaturgia del Quattro e del Cinquecento. Anche quelle di cui si trovano le matrici in Plauto (per non risalire più indietro) hanno la loro origine in giochi, scherzi, situazioni, diffuse tra le classi «incolte»: Plauto che certamente le conosceva, le raccolse e seppe esprimerle in un linguaggio articolato, e comporle in una macchina teatrale complessa. In questo consiste l’intervento dell’uomo di mestiere (non dell’intellettuale nel senso che intendiamo noi oggi) sui materiali popolari esistenti nella vita quotidiana, nel modo di divertirsi estemporaneo delle classi cosiddette «incolte». Le radici delle «comiche finali» che comici antenati dei Rame usavano a chiusura dei spettacoli — per fare un esempio — sono meccanismi di estrema semplicità, raccolti tra gli scherzi diffusi nei giochi consueti della vita di ogni giorno. Quei meccanismi elementari i comici li usarono per farli scattare come una macchina: una stanza affittata a tre persone, che non si conoscono e non si vedono mai fino a che ognuno dei tre si trova a dormire con uno o due sconosciuti. Il paio di pantaloni che due comici cercano di indossare insieme. Il qui pro quo della cavalla: un tale discorre di una ragazza con un mercante il quale crede che si stia parlando di una cavalla da vendere. Il famoso gioco dei tre gobbi. Ce n’è un numero incredibile. D. I tre gobbi sono anche la chiave di uno scenario dell’Arte. R. La Commedia dell’Arte è un repertorio infinito di situazioni comiche, raccolte dal teatro popolare del Quattrocento, rielaborate e moltiplicate negli sviluppi con gli strumenti del mestiere. Non bisogna cadere, invece, negli inganni che tendono quei borghesi che hanno costruito testi pseudo popolari e i loro esegeti. Quell’Alfabeto dei villani, per esempio, raccolto dal Lovarini l’ha scritto certamente un borghese, ha inserito detti di villani in una composizione che ne tradisce il modo di pensare: le prese di coscienza si capisce che sono borghesi. A un certo punto, mi ricordo, vi si dice che la lettura delle carte parla sempre di pezzorare. Questo pessimismo non è del villano. I villani del Ruzzante, per esempio, non sono pessimisti. Godono il poco o pochissimo che hanno, sesso e polenta, qualche volta sesso e fame. Il sesso, ecco, è un tema ricorrente della cultura popolare. C’è un uso della licenziosità sessuale che io metto sempre nelle mie commedie (facendo attenzione a non offrire alla censura l’alibi di colpire l’oscenità quando invece vuol colpire i significati politici e ideologici). Lo scurra, il parassita della latinità, ma soprattutto il buffone che usa l’oscenità per divertire, viene perseguitato dalla Controriforma perché nel teatro i Padri della Controriforma colpivano la vanitas vanitatum, il profano: ma la principale accusa che gli veniva fatta era proprio quella di corruzione per mezzo dell’oscenità. Ora il Comico, ancor prima che con l’Arte diventi un professionista, si rende conto, al contatto con il pubblico, della grande capacità liberatoria del gioco che si dice osceno nei confronti del potere della Chiesa, che usa anche la repressione moralistica per affermare la propria egemonia. La licenziosità non è volgarità. La scurrilità, il gioco su temi sessuali, è profondamente liberatorio. La cultura popolare ci ha lasciato contrasti imperniati tutti sul gioco sessuale. Mi viene in mente il dialogo bolognese tra madre e figlia, del Duecento: la ragazza esprime il suo desiderio di starsene abbracciata tutta nuda al suo ragazzo, con una tale intensità che pare che stia godendo di un amplesso. E quell’altra storia godibilissima, anch’essa bolognese, delle due donne che fanno una gran mangiata e si sbronzano insieme e intanto si fanno confidenze sui loro desideri amorosi, e poi si pisciano sotto, la fanno dappertutto, e infine si accordano per spartirsi l’amore di un «fantolino». E’ una storia di una oscenità pantagruelica, gioiosa, senza morbosità. Così è libero dal senso del peccato il contrasto Rosa fresca aulentissima, che è certamente scurrile — dicano quel che vogliano gli esegeti della cultura ufficiale —; ma che scurrilità sana, felice, senza turbamenti. E la storia di Arlecchino che sogna il suo sesso ingigantito? Là il gioco sessuale diventa grottesco, arriva a quel diapason iperbolico di cui dicevamo a proposito dei miei fabulatores. E’ solo un canovaccio. Arlecchino ascolta i grandi discorsi che due spacconi fanno delle loro straordinarie copule — almeno uno è un capitan Spaventa, certamente —: e io ho fatto l’amore con la regina, e io con una gigantessa, e io con una nana, fino a che quello più gradasso dice di aver fatto l’amore con la Morte. Il sesso è un essere parlante, un personaggio, nei discorsi di questi due. A sentirli Arlecchino resta allocchito. Mangia, si addormenta, e ha un incubo. Sogna che il suo sesso sia diventato enorme, tanto che non sa come tenerlo, è un gigante, non sa come nasconderlo: cerca di legarselo dietro, di far credere che sia una gamba. Lo camuffa da gatto: c’è un cane che lo vuole sbranare. Lo avvolge in una benda, gli mette poi una cuffietta, ora sembra un bambino: un gruppo di ragazzi che passano lo carezzano e lo baciano, lui si eccita ed esplode. Poi si sveglia e si sente solo e triste. I novellatori del Trecento e i commediografi del Cinquecento — certamente colti — hanno rielaborato temi e situazioni trovati in raccolte assai più antiche di testimonianze della tradizione orale, tramandati da interpreti rimasti oscuri. […] Il Comico, scavando nella tradizione popolare, ne assimila maniere e tecniche che diventano sue, sia quando scrive per il teatro che quando agisce sulla scena. Quando scrivevo le farse, per esempio, mi ero reso conto concretamente che non c’è vero teatro che non sia teatro di situazione. Ogni azione teatrale nasce da una situazione scenica pregnante di sviluppi di azione. Il dialogo è solo uno degli strumenti per esprimere questi sviluppi. Per esempio: un uomo nudo si è rifugiato in un bidone della spazzatura vuoto. Questa è gia una situazione: quando lo spazzino lo scopre, da quella prima situazione può nascerne una serie di altre, innumerevole. Il teatro che vuole basarsi su di un dialogo autonomo dallo sviluppo di un’azione, che non è espressivo di un’azione potenziale, non è teatro, è letteratura. Il linguaggio teatrale è sintetico, non consente indugi descrittivi della situazione o di stati d’animo, a meno che non siano parte del ritmo che si vuol tenere. […] D. Insomma, il teatro è di situazione quando gli sviluppi non dipendono dal dialogo, ma rispondono a una dinamica che potrebbe funzionare anche riducendo al minimo il dialogo? R. Ma nemmeno il dialogo è condizionato dal meccanismo delle situazioni. Dialogo e azione sono funzionali a una logica intrinseca, a una economicità di struttura, che ne assicura il funzionamento come macchine sceniche. Il testo delle nostre commedie del periodo ’59-65 venne pubblicato da «Sipario» con pochissime didascalie. Solo quando, nel ’66, Einaudi volle pubblicare in volume quelle commedie, Franca1 fece un lavoro di ricomposizione dell’aspetto scenico della nostra rappresentazione, ricostruendo tutte le azioni collettive e individuali mute, le mimiche, i lazzi, che concordavamo tra attori prima della messa in scena, e la loro articolazione con il dialogo. Era una parte rilevante dello spettacolo, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. […] Chi trova le proprie origini comiche nella tradizione popolare, trova inevitabilmente la satira. Ed è là che io le ho trovate, come si diceva… […] Sono intrinsecamente satiriche tutte le forme in cui si esprime il giullare, per il fatto stesso che egli — lo dice il Muratori — nasce dal popolo e dal popolo prende la rabbia per ridarla ancora al popolo, mediata dal grottesco, dalla ragione, perché il popolo prenda coscienza della propria condizione. La 1 Franca Rame, figlia d’arte, attrice e moglie di Dario Fo. nascita del giullare la racconto in Mistero Buffo. E’ una giullarata del Duecento, che ho trovato nella biblioteca di Ragusa, in siciliano. Il villano è schiacciato dalla protervia del padrone, il quale vuole portargli via la terra che ha reso fertile con anni di sudore e offeso dalla sua resistenza, lo punisce possedendogli la moglie davanti ai figli; un oltraggio che per il villano è gravissimo, lo colpisce nei legami che egli ritiene sacri, è un oltraggio che nessuna forma di vendetta può lavare. Quel villano troverà la salvezza in una reazione che nemmeno lui avrebbe mai immaginato, nel diventare giullare, appunto, per aprire gli occhi al popolo, insegnargli a capire i soprusi del padrone. D. Se il giullare ha dalla nascita una missione sociale, per farsi intendere dal suo pubblico, deve servirsi di una tecnica. In uno dei tuoi interventi tra un brano e l’altro di Mistero Buffo, tu hai fatto delle considerazioni sulla «pesca della risata». Sembrava che volessi parlare al pubblico delle astuzie che usi per creare un rapporto con loro. E non si trattava di un intervento estemporaneo: hai ripetuto quelle considerazioni per sere di seguito. R. Il comico pesca la risata quasi gettando con una battuta, un amo alla platea. Egli avverte a che punto la reazione del pubblico deve essere raccolta e, in un certo senso, l’amo tirato su, perché altrimenti si esaurirebbe la tensione che si è creata tra il palcoscenico e la platea. Ritirare l’amo non significa spegnere ma ridurre con una correzione del tiro, la portata della reazione del pubblico. L’abilità del comico sta nel sapere che se continua ancora per qualche minuto sullo stesso ritmo, spacca la capacità del pubblico di continuare su questa chiave. Così rompe l’azione scenica appigliandosi a qualcosa che ne è al di fuori (per esempio, il modo buffo di ridere di uno spettatore in sala; un cenno mimico a come parla La Malfa). Poi il Comico torna a gettare l’amo per la risata più grossa (anche se la risata si può pescare gettando l’amo più di una volta prima di lasciare prorompere una sola grossa risata). D. La pesca della risata scandisce il ritmo dello spettatore? R. Si può parlare a non finire di tecnica della risata. A Nancy, dove sono stato in settembre, Lecoq ha tenuto vere e proprie lezioni sulla tecnica della risata. Risata di testa, di gola, risata muta, la sganasciata, la risata che ti fa andare per terra. Ma io credo i vari modi di ridere dello spettatore si differenzino solo in due sensi: nel caso che siano o non siano il sintomo di una partecipazione allo spettacolo. La diversità è tra la reazione meccanica alla risata e il rapporto per cui il pubblico collabora alla costruzione dello spettacolo. Una cosa è la soddisfazione divistica del comico che vede gli effetti della sua tecnica e se ne compiace, e altra cosa è la reazione del comico a un tipo di riscontro che lo sollecita anche lì per lì, immediatamente, a sviluppare, magari improvvisando, il suo discorso, l’azione che sta portando avanti dalla scena, con quel pubblico. Il comico provoca la risata del pubblico con le sue risorse: ma la risata del pubblico è una risposta che a sua volta rinnova la carica del comico — non è solo una tecnica — alimenta la lievitazione delle sue reazioni sceniche forse, nel corso di quello spettacolo, magari solo per l’ulteriore esercizio del suo mestiere. […] E’ una scelta del comico. Tutto il teatro popolare vuole che il pubblico sia «dentro», che partecipi al ritmo della risata. D. Il fatto che tu abbia parlato al pubblico della «pesca della risata», a un pubblico non specializzato, di una qualunque sera, sotto il solito tendone del teatro circo, come si inserisce nella tecnica della risata? E’ una astuzia più sottile della tecnica di «ripescaggio della risata»? R. Ho potuto parlare al pubblico della pesca della risata, perché uno dei caratteri del teatro che noi abbiamo scelto è la mancanza della quarta parete. E’ quello che intendevo quando ho detto che il teatro popolare vuole che il pubblico partecipi alla gestazione della risata. […] Che significa la «quarta parete»? E’ quel momento magico determinato dalla cornice del palcoscenico che divide di fatto gli spettatori da chi recita. La quarta parete è soltanto questo spazio rettangolare? No, sono anche le luci di taglio che creano una determinata atmosfera, i controluce, i velatini rosati e ambrati sui riflettori, sono le scenografie fortemente accidentate e il clima d’acquario in cui sono immersi attori e oggetti, è il trucco livido da cadavere sulle facce degli attori, è il loro gestire ed emettere voce con determinate cadenze cantate sussurrate o gridate ad effetto, per cui lo spettatore si trova nella condizione di un guardone, a spiare una storia che non gli appartiene e che è appunto al di là della quarta parete. Quindi una concezione intimista, naturalista o all’opposto metafisica del teatro. E come si distrugge la quarta parete? Togliendo il sipario... così distruggi il momento magico dello stacco e crei il fatto della partecipazione per la sola ragione che hai tolto il sipario come fanno i brechtiani? Neanche per idea. Togliere il sipario, togliere il proscenio o spostare l’azione dalla scena nel corridoio della platea, con gli attori che si siedono sulle ginocchia dello spettatore, gli sputano in un occhio, lo mettono nella condizione di sentire i loro sudori, i loro spruzzi di saliva, la loro voce dentro le orecchie, il fastidio oppure il piacere... E’ questo distruggere la quarta parete? Il teatro borghese ha la quarta parete, certo. Dice Stanislavskij che quando un attore recita deve fare in modo che il pubblico che sta ascoltando si trovi par hasard, per caso, lì... deve farlo entrare nello stato d’animo di non esistere in quel momento nella sala, fargli dimenticare la finzione scenica, farlo sentire come uno che viene a rubare una storia, un dramma di altri. E per arrivare a questo devi eliminare ogni «a parte». Che cosa significa «a parte»? Significa quel mezzo per far partecipare il pubblico che viene da un teatro popolare... e state attenti, non da un teatro borghese... perché è vero che l’«a parte» è ancora dentro tutto il teatro del Seicento e del Settecento, ma il senso dell’«a parte » è già stato capovolto. L’«a parte» di tradizione popolare è quella situazione in cui l’attore dice, rivolto ad un altro personaggio: «Lei cosa crede, che io abbia paura?», e rivolto al pubblico: «Credo che non abbia proprio paura di niente… speriamo che ci caschi in questa mia violenza»; al personaggio: «Perché io sono capace anche di darle una coltellata!», e al pubblico: «Speriamo che non tiri fuori il coltello perché, per la miseria, mi tocca di scappare...». Tutto quello che è il secondo piano delle proprie considerazioni viene espresso direttamente. Bene, questo «a parte» era diventato una forma letteraria, di comodo, in un determinato teatro borghese. All’origine l’«a parte» era la distruzione della quarta parete. Che cosa significa? Significa che nel momento in cui l’attore diceva a un altro attore qualcosa e immediatamente replicava il contrario, al pubblico faceva il «commentario», criticava dal di fuori il personaggio stesso, si staccava razionalmente dal personaggio, insomma recitava epicamente... e per di più, rivolgendosi al pubblico, lo provocava... tanto è vero che l’uso dell’«incidente», per creare l’«a parte», era fondamentale in quel teatro... Che cos’è «l’incidente» nel teatro popolare del medioevo? Era l’espediente, per esempio, di introdurre in scena o in platea un cane, che si metteva a correre, scodinzolare, abbaiare e far casino buttando all’aria l’azione scenica... Serviva a fare in modo che l’attore, attraverso questo pretesto, avesse la possibilità di parlare col pubblico e rompere la quarta parete, perché quell’incidente gli permetteva di uscire, di distruggere il quadro in cui si raffigurava la scena. Così altri incidenti erano il bambino che piange, la lampada che si spegne... addirittura un principio d’incendio. […] Allora, quando siamo arrivati all’esigenza di distruggere la quarta parete, di arrivare a parlare di problemi collettivi, ci troviamo in completa alternativa rispetto alla preoccupazione di identificare l’attore col personaggio: io che sono attore e cerco di scoprire, di trovare dentro me stesso tutti gli orpelli, tutte le viscere, tutti i miei difetti, tutte le mie qualità, per vestire poi di me stesso il personaggio... questo è proprio Stanislavskij, cioè la peggiore posizione reazionaria, conservatrice, borghese della storia. Ma se io cerco di creare invece la visione di una comunità, di un coro, di una comunione, evidentemente non mi preoccupo tanto di parlare di me stesso, ma dei problemi che sono collettivi. Se io cerco problemi collettivi, il mio discorso, il mio linguaggio... sarà diverso... e sarà obbligato a essere epico. Ecco perché tutto il teatro popolare è sempre epico. Perché alla base c’è un fatto ideologico ben chiaro. C’è l’ideologia della comunità, della comunione degli interessi, che sono interessi sociali, interessi di vivere insieme, di produrre insieme, di dividere quello che si ottiene. Allora, di questo passo noi siamo arrivati a determinate esperienze. Siamo arrivati a capire, per esempio, che non bastava fare degli spettacoli di rottura per così dire, verticali, ma bisognava distruggere certe situazioni di dialogo... e abbiamo capito anche perché nel teatro medievale l’attore tendeva a presentarsi solo sul palcoscenico e costruire parecchi personaggi. Perché solo così poteva determinare con la propria presenza ripetitiva il momento appunto epico della rappresentazione, la coralità. [...] D. In che cosa si distingue dal teatro epico questo agire senza la quarta parete? R. Il teatro epico di Brecht è epico nella forma, non nella risultanza effettiva. Fa partecipare il pubblico attraverso il cervello, non attraverso gli elementi dello spettacolo: la risata, il fischio, il respiro, il presentimento, il disagio. Il teatro epico di Brecht esige che i personaggi vengano rappresentati, piuttosto che interpretati, perché esige creare nei confronti di essi un distacco critico da parte del pubblico. Il nostro teatro comico rivela le tecniche, è vero, ma non ponendosi il problema del distacco dell’attore dal personaggio: il comico non può fare a meno di vivere la sua parte sulla scena (non parlo del ruolo). […] Direi piuttosto che se crede nelle ragioni della sua comicità, non può non identificarsi con le diverse situazioni comiche con cui le esprime. Queste ragioni sono per me e per i miei compagni di lavoro le ragioni stesse per cui facciamo teatro. Voglio dire che la risata meccanica, quella provocata da meccanismi tecnici che il comico sa usare sulla scena, e che gli torna addosso e lui ci si specchia dentro, non ci interessa, per la ragione stessa che ci interessa provocare la risata satirica, che affronti con il pubblico la realtà che è scelta come tema di un’azione scenica. Spesso quella realtà è tragica, è un momento tragico della realtà sociale e politica in mezzo alla quale viviamo. Certo teatro che prende ad argomento quel genere di fatti, sembra l’orazione funebre su di un cadavere. Lo spettatore va al funerale e con il pianto funebre e la giaculatoria si libera dall’impegno civile e politico di partecipare al fatto tragico in cui sente di essere coinvolto. Perché, davanti a Pinelli2, non abbiamo fatto una pinellata, un dramma lamentoso e oratorio come hanno fatto tanti compagni, ma abbiamo preferito rappresentare una farsa3. Perché abbiamo preferito liberare lo spettatore dal timor panico del Potere, questo 007, questo gigante con i piedi di argilla. Abbiamo voluto far capire che quel Potere è becero, grossolano, cialtrone, se la fa addosso, fa una gaffe dopo l’altra, è idiota: prima di tutto non bisogna temerlo e bisogna sghignazzargli addosso. Il SID una macchina spaventosa? E’ un pupazzo stronzo, inefficiente, violento, anche perché è incapace di usare armi meno grossolane di quelle che ha. Non vogliamo che lo spettatore vada a casa contento perché si è indignato abbastanza e si è liberato e ora è in pace con se stesso. Vogliamo capire con il pubblico cosa c’è sotto quella macchina, perché esiste, se ne abbiamo colpa noi, come si fa a combatterla. Vogliamo smontare a pezzi tutte le macchine del potere: verranno fuori costruzioni grottesche. 2 Giuseppe Pinelli, anarchico milanese morto nel 1969, in circostanze misteriose, durante un interrogatorio di Polizia nel corso delle indagini sulla strage di Piazza Fontana. 3 Morte accidentale di un anarchico (1970): […] D. Non credi che se la didascalicità di Mistero Buffo non fosse vivificata dalla interpretazione del giullare Fo, perderebbe molto vigore, e con esso la capacità di coinvolgere il pubblico? R. Questo è il solito discorso dell’abilità del Comico, delle sue risorse personali, il discorso che abbiamo già fatto a proposito della «risata». Bene, le mie risorse personali di comico riesco a esprimerle perché credo nella funzione giullaresca del mestiere di comico. L’abilità del giullare medievale, la sua capacità di interpretare anche quindici personaggi come nel «Miracolo di Lazzaro», nel «Coro dei battuti»4 dipendeva dalla necessità di far tutto da solo: non era una velleità esibizionistica. Che i giullari medievali realizzassero lo spettacolo da soli ce ne rendiamo conto dalle didascalie dei testi e dalle loro allusioni a sdoppiamenti. Le invenzioni dei giullari anche più abili richiedevano l’interpretazione del pubblico. Il gioco delle allusioni, e la collaborazione del pubblico che le intendeva, raddoppiavano la carica di poesia e di comicità. Ecco che quella che chiamavi «operazione didascalica» non lo è in realtà, se si pensa che il pubblico non veniva addottrinato, ma stimolato nella fantasia: solo così poteva acquistare coscienza delle sue origini, del suo passato, della sua cultura. D. Il giullare può insegnare al popolo come «campare di cervello e non di piedi», perché Gesù Cristo un giorno lo ha preso per la testa, lo ha baciato e gli ha dato la parola, una «lingua che buca come una lama schiaccia vesciche dappertutto...». R. Il giullare ha ricevuto quel bacio perché era anche lui un «povero cristo», un villano che aveva subito dal padrone le peggiori angherie che schiavo possa immaginare. E’ questa esperienza che gli ha dato la ricchezza e la possibilità di aprire la mente agli altri con le sue buffonate. Non è il «miracolo» del bacio che ha dato al villano le nuove facoltà di giullare. E’ sentire di dover armare tutti i poveri cristi del mondo di rabbia ribelle, è questo che stimola il comico di oggi a farsi giullare, che gli fa guizzare la lingua in bocca e muovere il cervello e le gambe andare da sole, e lo costringe ad andare in piazza a chiamare la gente perché «faccia satira» con lui. Il giullare era un villano, un oppresso: come il villano forse è stato partorito anche lui da un asino, come racconta il giullare Matazone del primo villano nato sulla terra. E se il giullare avesse l’anima, la sentirebbe come un piombo, non potrebbe volare, perché l’anima gli peserebbe addosso, e le direbbe, come suggerisce Bonvesin de la Riva, «Ringrazia Dio, anima, che non hai il sedere perché te lo riempirei di pedate». E’ perché è nato senz’anima che il giullare può rifiutarsi di cedere ai ricatti della «buona coscienza» e pungere e mordere il padrone con la sua satira, e armare gli oppressi contro di lui. D. [...] Il [tuo] passaggio da buffone dei borghesi a giullare del popolo come si è articolato? R. Vorrei anzitutto dire come siamo usciti dal teatro borghese e perché. […] C’è stato un momento in cui ci siamo accorti che nonostante un grande successo e un pubblico che rappresentava la più alta percentuale che ci fosse mai stata in un teatro normale, provavamo quotidianamente la sensazione di essere i buffoni della borghesia, che la borghesia accettava che noi la criticassimo anche in maniera violenta, attraverso la satira e il grottesco, ma a condizione di criticarla dall’interno delle sue strutture. Allo stesso modo il buffone del re può permettersi di dire tutte le cose più pesanti nei confronti dello stesso 4 Momenti dello spettacolo di Fo Mistero buffo, rappresentato per la prima volta nel 1969. re, se lo fa alla corte, fra i cortigiani che ridono, applaudono e dicono: «Ma come è democratico questo re!» Era un modo di dimostrare che la borghesia era veramente democratica, comprensiva eccetera. Anche in Francia si trova questa grande tradizione. Mi viene da pensare a certi grandi personaggi. Al grande Charles, parlo del generale De Gaulle, faceva piacere essere messo in ridicolo, e questa in realtà era la chiave del suo successo presso la piccola borghesia. L’ho visto applaudire un attore che si divertiva a imitarlo! I grandi re, i potenti che capiscono certe cose hanno sempre pagato dei buffoni di corte perché facessero dell’ironia su di loro. Ma nello stesso tempo sappiamo bene che ogni volta che qualcuno esce da questa dimensione per andare a parlare ai contadini, agli sfruttati, agli operai, per dirgli certe cose, allora non lo si accetta. Ci si può prendere gioco del potere all’interno del potere stesso, ma se lo fai all’esterno, non te lo permetterà mai. Ecco perché siamo usciti dal «teatro normale» perché abbiamo rifiutato le sovvenzioni, il ricatto più violento che abbia mai inventato il potere, i premi speciali, i teatri pagati in anticipo, gli oneri eccetera. Inoltre il nostro teatro, il teatro borghese italiano (come quello francese, quello inglese e tedesco) non si rivolge alle grandi masse, ma alla borghesia... C’è qualche operaio, qualche studente povero che va a teatro, in loggione; ma in definitiva è sempre la borghesia che può permetterselo, dalla borghesia commerciante a quella aristocratica, «evoluta», colta. Uscendo da questa dimensione, ci siamo messi a completa disposizione della classe operaia. Questo vuoi dire che quando la borghesia viene a vedere i nostri spettacoli, si sente automaticamente estranea, non è più lei la padrona, non è più a casa sua, ma ormai l’operaio è a casa sua; gli operai, gli sfruttati in genere, e voglio dire con questo che ci sono certi impiegati, una parte della piccola borghesia, gli studenti, che da noi sono ormai proletarizzati. D. Quando nel ’68 siete usciti dal circuito borghese, avete lavorato per un certo periodo a fianco di organizzazioni dello spettacolo legate al partito comunista. R. Sì, siamo andati a recitare nelle «case del popolo». Si sa che sono state costruite dagli operai e dai contadini con le loro forze, con l’apparizione dei primi nuclei socialisti in Italia. Su queste case del popolo c’era scritto: «Se vuoi fare la carità a un povero, dagli cinque soldi: tre soldi per il pane, due soldi per la cultura». E cultura non voleva dire soltanto «saper leggere e scrivere» ma anche produrre, esprimere la propria creatività, a partire dalla propria concezione del mondo. La grave responsabilità dei partiti della sinistra tradizionale sta proprio nel fatto che non si sono messi al servizio della creatività del popolo che è straordinaria, enorme. In Italia, a forza di utilizzare intellettuali perché creassero, siamo arrivati a una situazione catastrofica. Fra gli uomini di cultura che dopo la guerra erano stati indicati come esempio, molti hanno tradito senza dignità. E’ il caso di Visconti, che oggi lavora con Rusconi. E’ anche il caso di Pasolini e di altri intellettuali che si sono venduti alla destra o alla socialdemocrazia. […] D. La vostra esperienza entro il circuito teatrale del PCI, l’ARCI, s è esaurita nel giro di una sola stagione. Come vedi, a ritroso, le ragioni di questa mancata intesa? R. Quando con l’«Associazione Nuova Scena» siamo entrati nell’ARCI speravamo che si stesse muovendo qualcosa di nuovo sotto la spinta del Sessantotto; ma sapevamo benissimo (conoscevamo la struttura burocratica del partito) cosa volevano dire le cooperative, chi c’era dietro le case del popolo, che interessi si muovevano. Non eravamo degli imbecilli, eravamo consci di andare a creare un grosso casino, che i nostri discorsi avrebbero fatto esplodere un sacco di contraddizioni tra il vertice e la base. E quando i burocrati hanno cominciato a spingerci fuori avevamo già preparato in anticipo le condizioni per ripiegare in altri spazi. Avevamo insegnato a gruppi autonomi di compagni, nelle varie città, a organizzare gli spettacoli con poche cose, a conquistare gli spazi: si possono adoperare degli spazi che nessuno aveva pensato mai di adoperare per il teatro. Spiegavamo addirittura come si montano le luci, come si fa l’attacco dell’Enel, dove si affittano le sedie, come si mette giù il parquet, come si vanno a prendere i tavoloni dai falegnami in affitto per coprire i fondi dei palazzetti dello sport. Le ragioni per cui abbiamo sciolto l’«Associazione Nuova Scena», con la quale lavoravamo nel circuito dell’ARCI, e abbiamo formato la Comune nell’ottobre ’70 le esponemmo in un documento del novembre successivo. Intendevamo mettere il nostro lavoro al servizio del movimento di classe: ma per noi «al servizio» non significava infilarsi in un piatto già confezionato; significava contribuire al movimento, essere presenti, collaborare alle sue lotte, per le sue reali esigenze. A giudicarla oggi, si deve dire che l’ARCI ha tradito l’assetto originario, cioè di associazione privata, è diventata l’ENAL di sinistra; non difende neanche più il diritto di autonomia dal controllo statale, accetta la censura, l’obbligo del nullaosta del Ministero; dà biglietti normali… […]. Dario Fo Manuale minimo dell’attore Einaudi, Torino 1987, pp. 81-85, 171-73, 243-45, 282-84. Parlare senza parole. Voglio cominciare parlando del «grammelot», attraverso il quale arriveremo a trattare della storia della Commedia dell’Arte e di un problema del tutto particolare, quello del linguaggio e della sua messa in pratica. Mostrerò il «grammelot» partendo d’acchito da un pezzo ormai classico di repertorio per far capire, a carte scoperte, come si articola. «Grammelot» è un termine di origine francese, coniato dai comici dell’arte e maccheronizzato dai veneti che dicevano «gramlotto». È una parola priva di significato intrinseco, un papocchio di suoni che riescono egualmente a evocare il senso del discorso. «Grammelot» significa, appunto, gioco onomatopeico di un discorso, articolato arbitrariamente, ma che è in grado di trasmettere, con l’ apporto di gesti, ritmi e sonorità particolari, un intero discorso compiuto. In questa chiave è possibile improvvisare — meglio, articolare grammelot di tutti i tipi riferiti a strutture lessicali le più diverse. La prima forma di grammelot la eseguono senz’altro i bambini con la loro incredibile fantasia quando fingono di fare discorsi chiarissimi con farfugliamenti straordinari (che fra di loro intendono perfettamente). Ho assistito al dialogo tra un bambino napoletano e un bambino inglese e ho notato che entrambi non esitavano un attimo. Per comunicare non usavano la propria lingua ma un’altra inventata, appunto il grammelot. Il napoletano fingeva di parlare in inglese e l’altro fingeva di parlare in italiano meridionalizzato. Si intendevano benissimo. Attraverso gesti, cadenze a farfugliamenti variati, avevano costruito un loro codice. A nostra volta, possiamo parlare tutti i grammelot: quello inglese, francese, tedesco, spagnolo, napoletano, veneto, romanesco, proprio tutti! Naturalmente per riuscirci occorre un minimo di applicazione, di studio e soprattutto tanta pratica. In seguito suggerirò alcuni accorgimenti tecnici. In questo caso, finalmente, è impossibile dettare delle regole, e tantomeno omologarle. Bisogna andare per intuito e per conoscenza quasi sotterranea, non si può certo elargire un metodo definito e spiegare tutto fino in fondo; però, osservando, si arriva a capire. Ecco il primo esempio. Consideriamo una favola di Esopo che forse molti già conoscono: la favola del corvo a dell’aquila. Prima inquadratura: l’aquila vola per il cielo disegnando larghi giri quando, seconda inquadratura, all’improvviso scorge in mezzo al gregge, un po’ in disparte, un piccolo agnello zoppicante. Terza inquadratura: allora volteggia largo, si getta in picchiata, va giù come un razzo, afferra con gli artigli il povero agnello a se lo porta via. Quarta: il contadino accorre urlando, lancia sassi, il cane abbaia, ma niente da fare, ormai l’aquila è lontana. Quinta: sul ramo di un albero c’è un corvo: «ah, ah, ah! — gracchia eccitato — non ci avevo mai pensato, guarda com’è facile acchiappare gli agnelli, eh, basta buttarsi giù! Cosa mi manca per fare altrettanto? Sono nero come l’aquila, ho gli artigli anch’io e li ho forti, perdío, ho delle ali larghe quasi come le sue, so fare volteggi e picchiate come lei». Detto fatto, sesta inquadratura: esegue il suo volteggio e mentre sta per buttarsi a picco su un agnello in disparte, come ha visto fare dall’aquila, si accorge che, più in là, pascolano delle pecore più grasse. «Ma quanto a stata scema quella! Come? Con tutte le pecore pasciute che ci stanno, perché dovrei limitarmi anch’io ad afferrare un agnello così smilzo? Mica son fesso come l’aquila, io! Io mi butto sulla pecora più grossa, così faccio un solo viaggio per garantirmi tutti i pasti della settimana». Si butta in picchiata abbarbicandosi con gran forza al vello della pecora, ma si accorge che è faticoso trascinarsela via. Improvvisamente sente il contadino urlare e il cane latrare. Spaventato sbatte le ali ma la pecora non si solleva, cerca di liberarsi del vello che lo ancora alla pecora ma, tira e molla, non ce la fa. È troppo tardi, ormai. Arriva il pastore che lo colpisce con legnate tremende, il cane gli salta addosso, l’addenta e lo sgozza. Morale: non basta possedere penne nere, né esibire un bel becco robusto o ali larghe e possenti. Per acchiappare pecore bisogna, soprattutto, essere nati aquile. Un’altra morale è questa: non è tanto difficile agguantare una preda, c’è solo da preoccuparsi di riuscire a battersela comodi senza essere poi battuti. Quindi, accontentati dell’agnello smilzo, la pecora grassa aspetta a portartela via quando attaccato al sedere avrai un reattore a tutta spinta. Ma in Esopo questa variante non c’è. Vediamo, ora, come può essere realizzato il racconto in grammelot della parabola in questione. La eseguo a soggetto, cosa che rende inevitabile l’improvvisazione. Ecco, qui posso svelare l’impiego di un metodo. Per eseguire un racconto in grammelot bisogna possedere una specie di bagaglio degli stereotipi sonori e tonali più evidenti di una lingua e aver chiari il ritmo e le cadenze proprie dell’idioma a cui si vuole alludere. Prendiamo una koiné pseudo-siciliano-calabrese, e su questa sequenza di sonorità costruiamo un grammelot. Quali punti fissi o cardini dobbiamo tenere presenti per la realizzazione? Prima di tutto informare il pubblico del tema che si intende svolgere, cosa che ho già fatto. A ciò bisogna aggiungere elementi chiave che caratterizzino, attraverso gesti e suoni, i caratteri specifici dell’aquila e del corvo. È ovvio che io non posso esporre i dialoghi al completo, ma solo accennarli, farli indovinare. Quanto più c’è semplicità e chiarezza nei gesti che accompagnano il grammelot, tanto più è possibile la comprensione del discorso. Ricapitolando: suoni onomatopeici, gestualità pulita ed evidente, timbri, ritmi, coordinazione e, soprattutto, una grande sintesi. Esegue iniziando con gesti minuti e in tono di conversazione familiare. Cresce poi nel ritmo e nella incisività. Commenta frasi didascaliche con sfarfugliamenti a «buttar via». Allarga la gestualità. Passa rapidamente da un’inquadratura all’altra. Accelera in progressione drammatica sollevando il tono della voce a le cadenze. Ogni tanto, nello sproloquio, mi sono preoccupato di inserire termini facilmente percepibili per la comprensione logica dell’ascolto. Quali parole ho pronunciato chiaramente, se pur storpiate? Aquila, pastore, corvo, corbazzo, e ho addirittura spiccicato i termini «picura» e «picuriddu» per agnello. Inoltre, col supporto dei gesti, ho indicato alcuni verbi come volare, urlare, abbaiare, correre, termini che pronunciavo storpiando in un facsimile meridionale ma che non arrivavano mai a caso. Infatti, il momento clou di questo lungo farfugliare è il raccordo con la parola giusta e specifica che stabiliamo insieme. «L’aquila vola a cerchio nel cielo», «il cane abbaia e ringhia», sono immagini che bisogna trasmettere in modo preciso e pulito. Questa è la chiave di esposizione obbligatoria nel gioco onomatopeico del grammelot. Se eseguo il grammelot francese, per esempio, sono costretto egualmente a riproporre immagini stabilite, passaggi chiari, mai equivoci, e una sintesi esatta degli avvenimenti che devo comunicare. [...] Altro mezzo importante per riuscire a farsi intendere è l’uso corretto della gestualità. Nel momento in cui alludo al volo, nella fase drammatica in cui, nelle vesti del corvo, cerco di risalire, mi pongo di profilo rispetto al pubblico che sta in sala perché è importante che si disegni lo sforzo del soggetto nel battere le ali. E ciò è reso più evidente se il mio corpo è visibile per intero, in silhouette, piuttosto che di fronte al pubblico. Potrei anche eseguirlo di fronte, ma per ottenere tutt’altro risultato. Le posizioni di maggiore effetto vanno ripetute ad immagine costante nei vari casi che determinano le varianti al tema. Per capirci meglio: primo volo, dell’aquila: mi pongo di profilo, mi chino in avanti, agito le braccia, roteo, alludendo a una virata. Secondo volo, del corvo: bisogna ripeterlo allo stesso modo, accentuandone, però, la goffaggine. Così ecco che nel primo caso lo spettatore sarà sollecitato a notare la facilità con cui l’aquila prende quota e vola via abbrancandosi l’agnello, e la seconda volta parteciperà all’impaccio del corvo che, goffo e maldestro, non riesce a districarsi. La ripetizione dei termini dell’azione, in entrambi i casi, perché funzioni, dev’essere appunto costante, quasi da sovrapporsi. La sintesi espressa mediante stereotipi con varianti nette costituisce una tecnica già sfruttata nei racconti delle pitture vascolari greche ed etrusche nonché negli affreschi di Giotto, nelle sequenze di immagini della vita di san Francesco o di Cristo, che qualcuno ha giustamente indicato come i più bei racconti a fumetto della storia dell’arte. D’altronde, la sequenza che ho eseguito potrebbe facilmente essere tradotta in fumetto. A questo proposito può essere di aiuto un’osservazione. A molti sarà capitato di assistere alla rappresentazione di un’opera recitata in una lingua sconosciuta, e di meravigliarsi del fatto che il discorso alle volte apparisse abbastanza comprensibile e anzi, in certi momenti, assolutamente chiaro. Certo i gesti, i ritmi, i toni e, soprattutto, la semplicità concorrevano in gran parte a far sì che la lingua sconosciuta non fosse elemento di grave impaccio. Ma questo non basta a spiegare il fenomeno. Ci si rende conto dell’esistenza di qualcosa di sotterraneo, di magico, che spinge il nostro cervello a intuire anche ciò che non è completamente e chiaramente espresso. Ci si accorge di aver acquisito nel tempo una quantità di nozioni del linguaggio e della comunicazione, con varianti a dir poco infinite. Le centinaia di storie che abbiamo immagazzinato, a partire dalle favole dell’infanzia per proseguire, con i cartoni animati, le storie raccontate coi film, con le commedie a teatro, dalla televisione, dai fumetti, concorrono a preparare il cervello alla lettura di una storia nuova raccontata anche senza parole intelligibili. [...] Ma perché non m’ami? Per anni hanno fatto di tutto, con articoli, saggi, dedicandomi perfino grossi volumi (vedi Puppa e Binni), per convincermi, per farmi capire che io mi salvo e cado in piedi come teatrante, non grazie alle mie qualità di scrittore di testi teatrali, ma grazie alle mie straordinarie doti di attore... di istrione. Io ho resistito, ma alla fine ho dovuto farmene una ragione e cedere. Sì, è vero, mi sono ormai convinto: ecco davanti a voi uno dei più prestigiosi attori che esistano al mondo. (Qualcuno dei presenti ha cominciato a tossire). Anzi, oltretutto ho scoperto che più è vistoso il successo di un mio lavoro, più è facile dimostrare che le mie qualità di interprete sono cresciute a livello divino e le qualità dell’opera sono precipitate a livelli infami. Io scrivo che è uno schifo, ma poi so porgere la schifezza con tal istrionismo e talento, che la rovescio. Sono un mostro, anzi sono proprio un padreterno! Meglio: sono alfine il padre del padreterno! — solo nel ruolo di comico, commediante, s’intende! (Mi arrivò un mugolio sommesso dalle prime file). E gli attori mi odiano, ho continuato: «Cosa fa ’sto padreterno che viene qua a rompere le scatole a noi normali?!» E naturalmente la mia meraviglia, il mio stupore, straripano quando mi accorgo che all’estero, impazziti, traducono e mettono abbondantemente in scena testi miei e di Franca. Perdío, anche quelli di una donna commediante, per giunta, ’sti megalomani, e li tengono in cartellone per anni, a Parigi, Londra, New York, Berlino... perfino in Giappone. A ’sto punto mi sono veramente reso conto che all’estero sono degli emeriti deficienti, non capiscono un ostrega di teatro; sono i trogloditi dello spettacolo. Gli butti lì qualsiasi cosa, anche la più strampalata che abbia l’imprimatur accademico, cioè testi quasi ignorati dalla nostra critica, e loro invece godono immensamente. La ragione è che, poveracci, non hanno autori di teatro. Noi, al contrario, possediamo a vagoni autori di talento, ma gli stranieri, imbecilli, non li conoscono, né si danno la pena di venir qui a cercarli. (Esplose l’applauso isolato di un anziano autore un po’ sordo). Pausa, quindi ho incalzato imperterrito: quindici anni fa viveva ed operava a Roma una associazione ristretta di scrittori teatrali di chiara fama che se ne stava abbarbicata come le zecche cavalline al ministro; vivevano lì, culo e camicia col ministro in carica (tale Andreotti), che gli aveva messo a disposizione alcune stanze con uso cucina e camera da letto, proprio nel fabbricato adibito al ministero dello spettacolo. Questa associazione viveva nella sofferenza più atroce: ne avevano veramente piene le scatole di dover sopportare l’esistenza di due analfabeti emeriti nel ruolo di autori. Disgrazia volle che uno degli zozzoni fosse il sottoscritto, l’altro poteva essere mio padre — tale De Filippo, Eduardo, mi pare — e io che gli venivo appresso, per caso mi ero trovato sulla stessa sua strada. Avevamo l’impudenza di continuare a produrre spettacoli e ci trovavamo imperterriti da anni in testa alle classifiche per pubblico e incassi. E le commedie avevamo l’impudenza di scriverle noi medesimi, due attori, e le mettevamo in scena pure. Due guitti comici! Robe da pazzi! Commedianti italiani che si permettono anche di fare gli autori e i registi italiani! Così questi autori di chiara fama, non rappresentati, di stanza al ministero (puntai distrattamente il dito verso un gruppo di scrittori veterani), hanno brigato finché sono riusciti a convincere il ministro a far promulgare una legge del tutto particolare. Questa legge impediva di riscuotere i denari del rientro ministeriale (la restituzione dell’importo versato al fisco durante la stagione) a quegli autori che nello stesso tempo si trovassero a ricoprire il ruolo di attori e capocomici. Funzionò per un anno. Poi fu ritirata. Eduardo ed io avevamo minacciato di scambiarci reciprocamente le commedie: lui avrebbe recitato un mio testo, io uno suo. Ma torniamo a noi. Ancora in molti interventi ho sentito ripetere il lamento sulla crisi dell’autore vivente. Si rappresentano solo opere di morti. Ma siamo sicuri che questi viventi siano vivi? (Dalla platea salì un brusio con sussulto di indignazione). Ma continuai spietato: guardandomi intorno a spulciare nella storia del teatro di tutti i secoli e di tutti i paesi, mi accorgo che laddove gli autori si trovavano ad essere veramente legati alla storia del loro tempo, immancabilmente potevano disporre di un pubblico che li applaudiva e li appoggiava. «Ipocrites», per i greci, non era solo colui che rispondeva al coro ma soprattutto era colui che sapeva raccontare le storie del mito traducendole nel linguaggio a nella dimensione leggibile al pubblico vivente che andava ad ascoltarlo. E non si trattava certo di blandirlo o gratificarlo, quello spettatore. Ho sottolineato «pubblico vivente» nel senso che si trattava di una platea di gente reattiva, partecipe, che applaudiva, insultava, s’incazzava a morte. Non per niente fra la scena e la platea c’era una fossa profonda come negli stadi per il gioco del football ai nostri giorni. [...] Recita come mangi! Elogio del dialetto. RAGAZZA Vicenza... anzi, sono di Schio. DARIO E parli il tuo dialetto? RAGAZZA Sì, abbastanza. DARIO Bene. Allora adesso cerca di raccontarci la stessa favola in veneto di Schio. Forza. RAGAZZA Fammi pensare un attimo... D’accordo, ci provo: «Z’era una rana che spanciugava derento a ’na gora fresca. Ûn bò vegne a desetarse a ’st’acqua ciara... Ûn ratín de campo el scorge e sbota imbalonato: “Ohi, che anemal tremendo. Ne g’ho gimai vedûi de sì grandi, de seguro Giove lo tegne par so mejor”». DARIO Stupendo, a parte che così come l’hai detta è di gran lunga più bella dell’originale tradotto... di’ la verità, lo sapevi già che ti avrei chiesto di tradurre in veneto ’sta favola e ti eri preparata in anticipo... magari facendoti aiutare da Tomizza in persona. E poi avrete apprezzato tutti il ritmo, la secchezza del discorso... dico, riuscire a non cadenzare in cantilena parlando in veneto... ce ne vuole. Brava! Il grande vantaggio di quest’ultima esibizione sta proprio nel fatto che la ragazza ha potuto esprimersi in dialetto. Il dialetto non lo impari a scuola, non c’è la maestra e il professore che ti insegnano il birignao... non si legge quasi mai. Le cadenze e i respiri, le parole, le costruzioni grammaticali sono autentiche, non c’è niente di costruito. Io uso spesso questo metodo: quando monto uno spettacolo e mi imbatto in attori che stonano e cantano con suoni artificiali, li invito a dire il testo che devono recitare prima con parole proprie, e poi tradotto nel loro dialetto d’origine. Li alleno a pensare la composizione delle frasi, i ritmi, nella forma del proprio linguaggio nativo. E vi assicuro che funziona subito, perché naturalmente si sbrogliano di tutti quei manierismi fonetici fasulli che hanno appreso sia scimmiottando certi attori famosi, sia nelle accademie scimmiottando i maestri di scimmiottamento. Ecco un consiglio davvero utile di cui, sono certo, gli aspiranti attori mi saranno grati: quando imparate un testo cercate di ritradurvelo prima con parole vostre, e poi nel vostro dialetto, se ne avete uno. È una grande sfortuna per un attore non possedere un dialetto come fondo alla propria recitazione. Ho conosciuto attori che ne erano privi: dicevano le battute proiettando fonemi piatti, asettici, e senza nessuna musicalità nei toni e nelle cadenze. Io stesso, quando scrivo un testo, mi trovo spesso ingrippato in una frase o in dialoghi, e allora non faccio altro che pensare il tutto nel mio dialetto d’origine; e poi lo ritraduco in italiano. Ma non ho inventato nulla di nuovo. Il primo a preoccuparsi del costruire attraverso il dialetto fu senz’altro Dante: a parte che, trasformando il volgare, ha inventato una lingua d’acchito... e che lingua! Per riuscirci ha fatto un fior d’inchiesta raccogliendo, nel De vulgari eloquentia, espressioni, termini, forme idiomatiche per tutta l’Italia e i dintorni, Provenza compresa. Un altro che s’è inventato una lingua propria è Alessandro Manzoni. Pochi sanno che l’autore dei Promessi Sposi non parlava che molto raramente l’italiano. Normalmente si esprimeva in dialetto, come in quel tempo tutta l’ aristocrazia milanese, del resto. In casa parlava spesso in francese e in francese svolgeva la corrispondenza. Ed è evidente che, quando componeva racconti o romanzi, strutturava il linguaggio partendo dal suo proprio naturale, cioè il dialetto milanese. Io ho provato a tradurre in dialetto lombardo brani interi dei Promessi Sposi, e tutto sta in piedi alla perfezione; anzi, vi assicuro che, se Manzoni avesse scritto direttamente in milanese come pensava, oggi sarebbe un romanziere universale... invece di ritrovarsi, com’è, relegato nell’ambito ristretto del nostro paese. E, per finire, c’è Pirandello, il massimo scrittore di teatro di questo ultimo secolo. Ecco un altro che scrive pensando sempre nel suo dialetto. Del siciliano sono i ritmi, la struttura grammaticale, la composizione idiomatica, per non parlare dell’arco generale del racconto scenico, il clima conflittuale dei personaggi, il paradosso tragico e grottesco insieme, tutto nasce dal lessico e dalla cultura sicilianovolgare. Quindi, se non ce l’avete un dialetto, trovatevelo! [...] Quell’opera ha un difetto: è bella alla lettura. Paradossalmente, e anche con un certo intento provocatorio, vado dicendo da anni che l’unica soluzione per risolvere il problema del rinnovamento del teatro, sarebbe quella di costringere gli attori e le attrici a scriversi personalmente le proprie commedie... o tragedie, se preferiscono. E non è soltanto una battuta di spirito. Prima di tutto, determineremmo una notevole crescita culturale dei teatranti, poiché minimamente sarebbero indotti a leggere, anzi, a studiare di più, a impararsi la sintassi e l’articolazione drammaturgica. Avremmo finalmente attori più preparati ideologicamente, in grado di saper parlare di ciò che stanno interpretando. Gli attori devono imparare a fabbricarsi il proprio teatro. A che serve l’esercizio dell’improvvisazione? A tessere e impostare un testo con parole, gesti e situazioni immediate. Ma soprattutto a far uscire gli attori dall’idea falsa e pericolosa che il teatro non sia altro che letteratura messa in scena, recitata, sceneggiata, invece che semplicemente letta. Non è così. Il teatro non c’entra con la letteratura, anche quando — con ogni mezzo — si vuole incastrarcelo. Brecht diceva giustamente di Shakespeare: «Peccato che sia bello anche alla lettura. Questo è il suo unico, grande difetto». E aveva ragione. Un’opera teatrale valida, per paradosso, non dovrebbe assolutamente apparire piacevole alla lettura: dovrebbe scoprire i suoi valori solo nel momento della realizzazione scenica. Mi possono raccontare ciò che vogliono, ma solo quando ho finalmente visto agite sul palcoscenico da attori opere come Don Giovanni o Il Tartufo di Molière, ho capito che si trattava di capolavori. Tempo fa ho assistito alla rappresentazione di una commedia di Goldoni che ritenevo minore, almeno così mi era parsa alla lettura. Si trattava di Una delle ultime sere di carnovale. Il regista si era limitato alla messinscena più lineare, gli attori erano più che modesti... eppure poche volte mi sono sentito così coinvolto in una rappresentazione teatrale. E dire che a me Goldoni, normalmente, non mi fa impazzire. Che dire poi di tutta l’opera di Ruzante. Chi è quell’ipocrita che vuol far credere si tratti di una grande produzione letteraria? Per secoli, infatti, i testi del Beolco sono rimasti sepolti proprio perché non rientravano nei canoni letterari, non erano omologabili: opere in dialetto che svolgono temi come la fame, il sesso, la miseria, la violenza... non potevano rientrare net «sublime» dell’arte. D’altra parte, il conflitto fra teatranti e letterati dura da sempre. Abbiamo già visto come Diderot fosse pieno di risentimento e disprezzo verso i comici dell’arte. Se vi volete divertire, potete leggere gli articoli di linciaggio che Gozzi e Ferrari (due esimi letterati veneziani) scrivevano contro il teatrante Goldoni. Ci sarebbe da collezionare volumi interi di libelli masticati con fiele ed estratto di veleno che accademici hanno sparato a grandine contro la gente che scrive per il palcoscenico. Lo stesso Shakespeare si prese caterve d’insulti da eruditi con l’anello al dito mignolo e la voglia d’alloro sulle natiche. Lo chiamavano «scuotiscene», «sproloquiatore insensato», «inanellatore di vetri colorati»... Lo stesso fecero con Molière. Insulti inauditi si beccò Euripide da quel reazionario, se pur colmo di talento, di Aristofane. Certo, il vantaggio di un autore che recita è quello di poter già sentire la propria voce e le risposte del pubblico nel momento stesso in cui stende la prima battuta sulla carta. Scrive un’entrata, un dialogo con altri attori, ma non immagina la scena come vista dalla platea, al contrario la vede direttamente agita sul palcoscenico e proiettata sul pubblico. Sembra una cosa da poco... eppure fu proprio la grande scoperta di Pirandello: «imparare a scrivere stando sulla scena». Pirandello non recitava di persona, ma viveva in simbiosi con gli attori. Pur di allestire le sue commedie, si trasformava in capocomico; la prima attrice della compagnia era spesso la sua donna. Nel teatro ci impegnava tutto, anche gli ultimi soldi. Non era uno di quelli che passano con il copione sotto il braccio a proporre i propri lavori direttamente all’impresario. Lui se le fabbricava lì, le commedie, nei camerini, scrivendo e riscrivendo durante le prove, fino all’ultimo minuto prima del debutto. È famosa una sua lite con la Borboni, proprio perché ’sto pazzo pretendeva che lei s’imparasse una nuova tirata di tre pagine sottofinale la sera stessa dell’andata in scena. I vecchi attori raccontano che anche dopo la prima Pirandello tornava a ripensarci, a riscrivere e a proporre cambiamenti, fino all’ultimo giorno di repliche. Scrivere sulla propria pelle: saggio su Antonin Artaud di Maia Giacobbe Borelli Breve storia d’Antonin Artaud e dei suoi amici La vita di Antonin Artaud (1896-1948), lo scrittore francese che ha rivoluzionato il teatro della seconda metà del ventesimo secolo, può essere suddivisa in alcune tappe fondamentali: la prima a partire dal periodo della sua adolescenza fino a giungere a Parigi nel 1920. Non è da sottostimare l’influenza cosmopolita delle sue origini familiari: Artaud nasce il 4 settembre 1896 a Marsiglia, figlio maggiore di una buona famiglia francese di origine levantina, che intreccia parentele pericolose per la salute - dato che le nonne Caterine e Marie Chilé erano sorelle, e quindi i due genitori, Euphrasie Nalpas e Antoine Roi Artaud, cugini primi tra loro - nonché radici greche, maltesi, italiane e forse armene. Nella sua genealogia familiare sono condensate interessanti vicissitudini che, nel XIX secolo, attraverso il commercio e la navigazione, avevano fatto del Mediterraneo il luogo degli scambi interculturali e delle enormi ricchezze mercantili di un’Europa pre-industriale, quella stessa che aveva a Marsiglia e a Genova i suoi affacci commerciali verso l’Oriente. La famiglia si considerava comunque francese: il bisnonno paterno, Mitre Artaud era nato a PuySainte-Réparade, il nonno paterno Marius-Pierre Artaud a Istres, sempre in Provenza, mentre il padre di Artaud, Antoine Roi, era nato a Marsiglia, sesto di nove figli. Varie erano le città da cui proveniva invece la famiglia materna, sparse in varie nazioni ma unite in un continuum liquido, il Mar Mediterraneo, che tutte le lambisce e che dà lavoro a tutti gli uomini della famiglia: Smirne, porto importante dove si incrociavano molti scambi commerciali e protettorato italiano in Turchia, Malta, protettorato inglese, Ankara, città turca, e l’isola di Tinos, nelle Cicladi greche. Nella città turca di Smirne erano nati la madre Euphrasie e il nonno materno Luigi Nalpas, che, come tutti i marinai e i mercanti del tempo, parlava italiano. Lì un bisnonno, Antonio Naltpassioglu, probabilmente di origine armena, aveva abbreviato il cognome in Nalpas. Il giovane Antonin cresce quindi all’interno di una famiglia benestante e cattolica, in ambiente poliglotta e cosmopolita, parlando indifferentemente greco moderno con la nonna, italiano con la balia e francese a scuola e in società. Comincia a pubblicare e ad esprimersi artisticamente molto presto: a quattordici anni scrive già alcune poesie, ispirate a Baudelaire, Rimbaud e Edgar Allan Poe, che saranno pubblicate nel 1916. Arrivato a Parigi nel primo dopoguerra, Artaud si avvicina al mondo letterario, psicoanalitico e cinematografico che era al centro della vita culturale francese, e entra a far parte del gruppo dei surrealisti di André Breton. Già conosce Jean Paulhan, personaggio che sarà per molti anni al centro della vita letteraria francese, che gli pubblica la Correspondance avec Jacques Rivière, corrispondenza cominciata nel 1923 e data alle stampe nel 1927, uno dei primi esempi in letteratura di pubblicazione di uno scambio di lettere che assume l’importanza non di documento accessorio della vita di uno scrittore, ma di corpus letterario in sé. Questa modalità, la pubblicazione delle sue stesse lettere agli amici, sarà una costante dell’opera di Artaud. In questa corrispondenza con Jacques Rivière, allora direttore della Nouvelle Revue Française, la migliore rivista letteraria dell’epoca, Artaud, giovane aspirante poeta, dichiara di cercare di aprire i cassetti superiori del suo cervello: Je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel1, scrive. Già allora dichiara che la sua principale opera è cercare di mantenere vivo un corpo e un pensiero attivo che non corra il rischio di sprofondare nell’abisso della follia, malattia di cui comincia a 1 Antonin Artaud, Correspondance avec Jacques Rivière, (lettera del 5 giugno 1923), in Œ., p. 69. Traduzione: Io sono alla ricerca costante del mio essere intellettuale. soffrire molto presto, ma neanche nell’inerzia vuota delle convenzioni. La ricerca di un pensiero attivo al di fuori delle convenzioni sarà portata avanti lungo tutto l’arco della vita, senza nessun tipo di compromesso personale e professionale. A Parigi ha inizio la sua attività teatrale, qui elabora la sua teoria dell’acte utile (atto utile) a teatro, allontanandosi dal gruppo dei surrealisti già dal 1926. Per Artaud l’azione fisica era lo strumento necessario alla creazione della propria personalità, per riuscire ad essere non solo quello che per origine, classe, destino, si è dalla nascita, ma soprattutto quello che concretamente si fa e si realizza di sé nel corso della vita. Decide quindi di allontanarsi da ogni movimento letterario che resta confinato in un ambito solo teorico, per dedicarsi al teatro come mezzo per cambiare effettivamente la sua vita. Entra così, a ventitrè anni, nel mondo teatrale, prima nella compagnia di Lugné-Poe e dall’ottobre del 1921 nell’Atelier di Charles Dullin, che, in uno scritto del 12 aprile 1948 indirizzato a Roger Blin, pubblicato poco dopo la morte di Artaud, così lo ricorda: Quando si ha avuto la fortuna di aver conosciuto un Artaud giovane, affascinante, al momento del dischiudersi di un genio che si manifestava così bene nei bozzetti delle scene che mi dava così come nelle sue trovate e nelle conversazioni appassionanti nelle rare ore di riposo che ci lasciava la lotta quotidiana, tu capirai caro Blin, che si abbia voglia di tenere solo per sé, questo gentile volto di un essere scomparso. Ancora prima della fondazione dell’“Atelier”, a rue Honoré Chevalier, dove io avevo aperto la scuola, Artaud viveva della nostra vita comune. La sua originalità faceva talvolta fatica a piegarsi al lavoro di squadra che ci era imposto dalle stesse condizioni dell’esistenza. Malgrado il suo collo di camicia che mancava sempre di un bottone e che uno straccio di cravatta mal annodato teneva a posto a fatica e malgrado il resto dei suoi abiti molto trascurati, un certo lato dandy gli proibiva per esempio di trascinare con noi la carriola che trasportava le nostre scene e i nostri costumi dalla rue Honoré Chevalier alla rue des Ursulines. Ci seguiva a distanza un po’ vergognoso. A parte ciò era di un impegno e di una docilità nel lavoro, esemplari, salvo in quello che riguardava gli esercizi meccanici di dizione ai quali si rifiutava energicamente. Adorava i nostri lavori d’improvvisazione a cui apportava una vera immaginazione poetica. Mentre io ero attirato dalla tecnica dei teatri orientali, lui andava in questo senso già molto più lontano di me e dal punto di vista pratico questo diventava talvolta pericoloso, quando per esempio ne Il piacere dell’onestà di Pirandello2, dove recitava un uomo d’affari, mi arrivava in scena con un trucco ispirato dalle piccole maschere di cui si servono come modelli gli attori cinesi, trucco simbolico che si trovava leggermente fuori posto in una commedia moderna.3 2 La Volupté de l’Honneur è il titolo con cui è tradotto in francese Il piacere dell’onestà, di Luigi Pirandello, messo in scena da Charles Dullin nel 1922. Il Petit journal del 23 dicembre 1922 ne parla come della coraggiosa opera di un giovane autore italiano. 3 Charles Dullin, Lettera a Roger Blin, pubblicata in K revue de la poesie, Parigi 1-2 giugno 1948 per commemorare la morte di Artaud. Nostra traduzione. In originale: Quand on a eu la chance d’avoir connu un Artaud jeune, charmant, au moment de l’éclosion d’un génie qui se manifestait aussi bien dans les croquis de décors qu’il me donnait que dans son invention de jeune acteur et dans les conversations charmantes aux rares heures de détente que nous laissait la lutte quotidienne, vous comprendrez, mon cher Blin, qu’on ait envie de garder pour soi seul, ce gentil visage d’un être disparu. Avant même la fondation de l’ « Atelier », rue Honoré Chevalier, où j’avais installé l’école, Artaud vivait de notre vie commune. Son individualité avait quelquefois de la peine à se plier au travail d’équipe qui nous était imposé par les conditions mêmes de l’existence. Malgré son col de chemise qui manquait toujours d’un bouton et que maintenait en place avec peine un chiffon de cravate mal noué et malgré le reste de sa mise assez négligée, un certain côté dandy lui interdisait par exemple de s’atteler avec nous à la carriole qui transportait nos décors et nos costumes de la rue Honoré Chevalier à la rue des Ursulines. Il nous suivait à distance un peu honteux. En dehors de cela il était d’une application et d’une docilité dans le travail, exemplaires, sauf en ce qui concernait les exercices mécaniques de diction auxquels il se refusait énergiquement. Il adorait nos travaux sur l’improvisation et y apportait une véritable imagination de poète. Comme j’étais attiré par la technique des théâtres orientaux il allait dans ce sens déjà beaucoup plus loin que moi et au point de vue pratique cela devenait quelquefois dangereux, lorsque par exemple dans La Volupté de l’Honneur de Pirandello, où il jouait un homme d’affaires, il m’arrivait en scène avec un Sulla multiforme attività dei primi anni di Artaud a Parigi, Evelyne Grossman scrive: L’alternanza regolare di periodi di straripante creatività seguiti da episodi di depressione e di sofferenza acuta caratterizza la quotidianità della vita di Artaud. Gli anni 1926-1927, in questo senso, non sfuggono alla regola. Da un lato scrive e pubblica molto (Fragments d’un Journal d’Infer [Frammenti di un giornale d’Inferno], L’Art et la Mort [L’arte e la morte]), getta le basi del Teatro Alfred Jarry, continua a lavorare nel cinema (Le Juif errant [L’ebreo errante] di Luitz-Morat, La passione di Giovanna D’Arco di Carl Dreyer, Verdun, visions d’histoire [Verdun, visioni di storia] di Léon Poirier), pubblica la sceneggiatura di La Coquille et le Clergyman [La conchiglia e il prete]; dall’altro, abbandona dopo una decina di sedute la psicanalisi, confessa di essere «ricaduto pesantemente nel laud[ano]», si lamenta di nuovo di una astenia vitale di fondo, di un’assoluta vacuità che lo tormenta. «Vorrei superare questo punto di assenza, d’inanità», scrive nel 1927. «Questa situazione di stallo che mi rende infermo, inferiore a tutti e a tutto. Non ho vita, non ho vita!!! La mia effervescenza interiore è morta.»4 I suoi scritti più noti sul teatro risalgono a questi anni. In un articolo del luglio 1934 Artaud, con il pretesto di una finta recensione a se stesso, spiega molto chiaramente la sua idea di teatro: farne una sorta di atto utile. A unire il teatro con la vita, in questa fase della sua ricerca, sembrano essere i Grandi Miti del Passato, che sono stati inventati per far durare e manifestare le ‘forze pure’: Tous les Grands Mythes du Passé dissimulent des forces pures. Ils n’ont été inventés que pour faire durer et manifester ces forces. Et hors de leur gangue scolaire et littéraire, Antonin Artaud veut tenter par le truchement d’une tragédie mythique d’en dire sur la scène les forces naturelles, et de rendre ainsi le théâtre à sa véritable destination. C’est à dire que par ce procédé le théâtre cesse d’être un jeu et le délassement d’une soirée éphémère pour devenir une sorte d’acte utile, et prendre la valeur d’une véritable thérapeutique où les foules antiques venaient puiser le goût de vivre, et la force de résister aux atteintes de la fatalité5. Occuparsi dei Grandi Miti del Passato, di metafisica e occuparsi di teatro sembrano per lui in questi anni momenti della stessa ricerca. C’est par la peau que l’on fera entrer la métaphysique dans les esprits, dichiara Artaud nel 19356. In mezzo a questo moltiplicarsi di attività, segno di effervescenza esteriore e di sofferenze interiori, si collocano i teatri di Artaud7: Non c’è il teatro di Artaud, ci furono i teatri di Artaud8, spiega Franco Ruffini. In questo modo lo studioso italiano identifica le varie tappe dell’attività teatrale di Artaud, distinguendo il teatro del segno credibile, degli esordi, da quello del segno concreto, degli anni del Théâtre Alfred Jarry, dal 1926 al 1929, per arrivare al teatro del segno efficace, che invece è altro dal teatro: Se continua ad avere il nome di teatro è solo per contiguità, perché il teatro è il territorio più vicino da cui si distacca9. maquillage inspiré par les petits masques dont se servent comme modèles les acteurs chinois, maquillage symbolique qui se trouvait légèrement déplacé dans une comédie moderne. 4 Evelyne Grossman, Antonin Artaud, un insurgé du corps [A.A., un insorto del corpo], cit., p. 30 5 Antonin Artaud, Articolo del luglio 1934, in Œ., p. 479. Traduzione: Tutti i Grandi Miti del Passato dissimulano delle forze pure. Essi non sono stati inventati che per far durare e manifestare queste forze. E al di fuori dei loro scarti scolastici e letterari, Antonin Artaud vuole tentare attraverso l’intermediazione di una tragedia mitica di dirne sulla scena le forze naturali, e di restituire così il teatro alla sua vera destinazione. Cioé con questo procedimento il teatro cessa di essere un gioco e lo svago di una serata effimera per divenire una sorta di atto utile, e prendere il valore di una vera terapia nella quale le folle antiche venivano ad attingere il gusto di vivere, e la forza per resistere agli attacchi del destino. 6 Antonin Artaud, Le Théâtre de la Cruauté, premier manifeste (1935), in Œuvres, p. 565. Traduzione: è dalla pelle che faremo entrare la metafisica negli spiriti. 7 Cfr. Franco Ruffini, I teatri di Artaud, crudeltà, corpo-mente, Il Mulino, Bologna 1996. 8 Franco Ruffini, I teatri di Artaud, crudeltà, corpo-mente, cit., p. 11. 9 Ibidem. È proprio questo ultimo periodo della ricerca di Artaud ad interessarci nel presente lavoro di studio: quella ricerca che Ruffini chiama del segno efficace e che Artaud stesso chiama de l’acte utile, ma già nel 1928, presentando il Théâtre Alfred Jarry, Artaud spiega come il teatro sia per lui un mezzo rivoluzionario, utile per raggiungere il cambiamento individuale, per tradurre quello che la vita dimentica, dissimula, o è incapace di esprimere10. A differenza di Franco Ruffini, e insieme a Marco De Marinis, a cui va il merito di aver per primo in Italia identificato nelle ultime produzioni di Artaud proprio quello che lui chiama un secondo Teatro della Crudeltà11, crediamo che questo periodo si inserisca a pieno titolo nel campo della ricerca teatrale. Fin dai suoi primi scritti Artaud lega strettamente il suo discorso teatrale alle tecniche del corpo, con la differenza che, se all’inizio sembra parlare di corpo principalmente come strumento al servizio delle necessità espressive dell’attore in teatro, nell’ultima parte della sua vita, dopo aver sofferto privazioni terribili sul suo stesso corpo, a causa della malattia e della guerra, il suo obiettivo diventerà diverso: capire non più come allenare ma come rifarsi un corpo, in scena e fuori. La tecnica del corpo e l’azione fisica saranno da lui utilizzate per agire nella vita, e non solo nell’arte del teatro. Per ricordare brevemente le tappe fondamentali di tutto il pensiero teatrale di Artaud, riprendiamo da Grossman le informazioni sull’attività del Théâtre Alfred Jarry: Nell’autunno del 1926, poco prima della sua esclusione dal gruppo surrealista, fonda con Roger Vitrac e Robert Aron il Teatro Alfred Jarry il cui finanziamento è largamente sostenuto da Yvonne e René Allendy, il celebre psicanalista che aveva fondato il gruppo di studi filosofici e scientifici della Sorbona. L’amicizia e l’entusiasmo di questa coppia avrebbero a lungo sostenuto i progetti di Artaud sia a teatro che al cinema. Il Teatro Alfred Jarry, il cui nome è un omaggio al maestro della patafisica, inventore del personaggio di Ubu Re e grande ispiratore del teatro Dada, s’inscrive nella linea del primo surrealismo. La sua ambizione è affermata in modo chiaro: farla finita con l’illusione e l’artificio, fare in modo che ogni pièce sia «una sorta di operazione magica» inscrivendo la realtà direttamente sulla scena — tutti principi che annunciano il futuro Teatro della Crudeltà. Paragonando uno spettacolo riuscito alle evoluzioni quasi coregrafiche di una retata di polizia (paragone che Breton gli avrebbe a lungo rimproverato), Artaud terminava nel 1926 il «Manifeste pour un théâtre avorté [Manifesto per un teatro abortito]» affermando la propria volontà di raggiungere il pubblico «nel modo più pericoloso possibile»: «Lo spettatore che viene da noi saprà che viene a sottoporsi a una vera e propria operazione, in cui non solamente il suo spirito, ma i suoi sensi e la sua carne sono coinvolti. D’ora in avanti andrà a teatro come va dal chirurgo o dal dentista. [...] Deve essere ben convinto che noi siamo in grado di farlo urlare.» In poco più di due anni di breve esistenza, in mezzo a innumerevoli difficoltà tecniche e finanziarie, a numerosi scandali e gazzarre surrealiste — quel che Artaud chiamerà più tardi con un po’ di magniloquenza «l’ostilità pubblica» —, il Teatro Alfred Jarry riuscì tuttavia a presentare quattro spettacoli, fra cui Il sogno di Strindberg (il 2 e il 9 giugno 1928) e Victor, ou les Enfants au pouvoir [Victor, o i bambini al potere], di Roger Vitrac (in dicembre 1928 e gennaio 1929). Le testimonianze che ci rimangono, così come certe fotografie d’epoca, consentono di immaginare la forza e l’inventività delle messe in scena di Artaud. Come i quattro «giacenti» collocati su delle barelle nella messa in scena del Sogno: dei manichini che raffiguravano dei malati. Redige ancora due progetti di messa in scena, uno per la Sonata degli spettri di Strindberg, l’altro per Le Coup de Trafalgar [Il colpo di Trafalgar] di Roger Vitrac, ma, a causa dei finanziamenti insufficienti, decide di porre fine all’esperienza del Teatro Alfred Jarry. Fallimento o successo? Il Teatro Alfred Jarry fu senz’altro, come sottolinea il critico Henri Béhar, «uno dei più rivoluzionari 10 Antonin Artaud, brochure del Théâtre Alfred Jarry, 1928, in Œ., cit., p. 283. Cfr. Marco De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud, il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948), Bulzoni, Roma 2006, p. 14. Prima edizione : I Quaderni del Battello Ebbro, Bologna 1999. 11 della prima metà del secolo». E fu in ogni caso una delle prime tappe che avrebbero portato Artaud ai grandi testi teorici degli anni trenta e alla sua definizione di un nuovo «Teatro della Crudeltà». È questo il linguaggio teatrale nuovo che Artaud intende mostrare e far sentire nella messa in scena del 1935 di una pièce di cui è lui stesso autore, I Cenci, tragedia in quattro atti da Shelley e Stendhal. Sarà il primo e ultimo spettacolo del Teatro della Crudeltà. [...] La messa in scena che Artaud concepisce per I Cenci è ampiamente descritta nelle lettere e nei testi redatti all’epoca; egli elenca il «movimento gravitazionale» che anima i personaggi, le vibrazioni delle onde Martenot che pongono lo spettatore «al centro di una rete di vibrazioni sonore», «quell’andirivieni matematico degli attori gli uni attorno agli altri, che disegna nell’aria della scena una vera e propria geometria», i manichini, le scene di Balthus. Con poche eccezioni la critica non fu buona. Colette tuttavia scrisse: «L’attore peggiore, Antonin Artaud, non è il meno interessante. Rauco, nero, angoloso, agitato, fa a pezzi il testo come peggio non si potrebbe, è insopportabile, eppure lo sopportiamo. Perché la sua è la luce della fede.» A causa di problemi finanziari, le recite si interrompono dopo diciassette rappresentazioni. In alcune note personali, a proposito di quel mese di dicembre del 1935, Artaud concluderà: «Mese maledetto di un anno maledetto, l’anno delle delusioni e della Sconfitta. Successo in senso Assoluto dei Cenci.» 12 Nel teatro, non più inteso come l’esperienza effimera di una sera, Artaud aveva cercato la forza per resistere alle prove del destino e per migliorare la vita stessa. Tracce di questo pensiero sono presenti in questi anni, insieme e a volte ancor prima della scrittura di quei testi che lo resero famoso negli anni Trenta, dalla pubblicazione sulla Nouvelle Revue Française del primo manifesto del Teatro della Crudeltà nel 1932, in poi. Per Anaïs Nin, che lo frequentò negli anni Trenta, Artaud è il demiurgo di un rito collettivo che agisce attraverso il contagio. Il teatro è questo rito da lui riportato alle sue primitive funzioni. Dopo aver assistito alla conferenza alla Sorbonne del 6 aprile 1933 sul teatro e la peste, la Nin scrive: Il teatro, per lui, è il posto dove gridare il dolore, la rabbia, l’odio, per rappresentare la violenza che c’è in noi. La vita più violenta può germinare dal terrore e dalla morte. Egli parlò degli antichi riti di sangue. Il potere del contagio. Il potere magico del contagio che noi abbiamo perso. Le religioni antiche sapevano come promuovere riti che rendevano contagiose fede ed estasi. Il potere dei rituali è andato perduto, ed è quanto lui vuole dare al teatro. Oggi nessuno può condividere i propri sentimenti con qualcun altro, e Antonin Artaud vuole che il teatro realizzi questo compito, di essere il centro di un rito che ci svegli tutti. Vuole gridare per suscitare ancora fervore ed estasi nella gente. Niente discorsi. Niente analisi. Contagio, mediante la rappresentazione di stati d’estasi. Non un palcoscenico fisso, ma un rituale in mezzo al pubblico13. Artaud menziona questa conferenza in alcune lettere che scambia con Rolland de Renéville. Sottoscrivendo le critiche che gli sono state rivolte, parla di qualcosa che oscilla perpetuamente tra il fallimento e la buffonata più completa, la cui grandezza vien fuori solo a momenti14. Nel 1933 Artaud scrive Héliogabale ou l’anarchiste couronné. Il progetto gli è stato commissionato dall’amico editore Robert Denoël15, che lo pubblicherà nel 1934. La creazione di quest’opera sembra una tappa importante nel percorso di ricerca di Artaud verso un corpo e una lingua che, attraverso la scrittura e l’esplorazione delle culture altre, in particolare la cultura orientale, oltrepassino tutti i limiti convenzionali. Scrivendolo, dopo aver letto gli storici antichi, Filostrato, Elio Lampridio, da cui riprende fedelmente alcune parti, ma anche Erodiano, Luciano o Cassio Dione, sceglie di rivalutare la figura di questo imperatore maledetto, Eliogabalo, e di stare dalla parte di un popolo, i siriani, per i quali 12 Evelyne Grossman, Antonin Artaud, un insurgé du corps [A.A., un insorto del corpo], cit., pp. 30-33. Anaïs Nin, Diario I (1931-1934), a cura e con un’introduzione di Gunther Stuhlmann, Bompiani, Milano 1979, p. 219. 14 Antonin Artaud, Lettera a Renéville dell’8 aprile 1933, in Franco Ruffini, I teatri di Artaud, crudeltà, corpo-mente, cit., p. 128 e in OC, V, pp.146-147. 15 Robert Denoël, editore a Parigi con Bernard Steele, morì in circostanze non chiare il 2 dicembre 1945. 13 le théâtre n’était pas sur la scène, mais dans la vie16. Così descrive il tempio di Hiérapolis: Sous le sol, le temple descend en spirales vers les profondeurs; les chambres des rites s’entassent, se succèdent verticalement; c’est que le temple est comme un vaste théâtre, un théâtre où tout serait vrai17. Ecco qui nuovamente trasparire la sua idea di un teatro dove, finalmente, tutto sia vero. Gli incontri con altre culture sono una delle chiavi che permettono di comprendere i suoi scritti sul teatro, dove l’arte è una necessità vitale che trasborda dai confini dello spettacolo per sfociare nella vita stessa e nella sua osservazione antropologica. Artaud fu, come sappiamo, molto colpito dalla scoperta del Teatro Balinese, prima all’esposizione coloniale di Marsiglia del 1922, poi a quella di Parigi del 1931, e dal suo viaggio in Messico, tra gli indiani Tarahumara, nel 1936. Queste esperienze di vita accompagnano la genesi e l’evoluzione delle sue teorie sulla recitazione, poi esplicitate nella raccolta Il teatro e il suo doppio scritta negli anni Trenta e pubblicata nel 1938. Ma di quale teatro sta parlando? La nostra ipotesi propende per considerare come teatrale anche la sua attività di scrittura nel complesso, nonostante gli spettacoli teatrali da lui prodotti siano limitati ai pochi esempi realizzati dal 1928 al 1935, di cui abbiamo riferito, coronati sempre da sonori fallimenti. Riassumiamo brevemente le sue teorie teatrali, pubblicate nel febbraio del 1938 nella raccolta di testi Le Théâtre et son Double [Il teatro e il suo doppio]: Quello che Artaud definisce «teatro», bisogna sottolinearlo, è allo stesso tempo molto di più e qualcosa di molto diverso da quello che si intende di solito con questo nome. Da qui i malintesi che talvolta accompagnano la ricezione delle sue teorie in Europa e negli Stati Uniti. Per lui ogni parola supera i propri limiti, va oltre un significato specifico, e la parola «teatro» non sfugge alla regola: ciò che egli intende effettivamente inventare sotto il vecchio nome di teatro, è proprio un’altra scena in cui la parola «ossificata», «le parole [...] gelate» del teatro occidentale potranno riprendere alito e vita, in cui sarà ritrovata la «vecchia efficacia magica» di un linguaggio in atto. Di cosa si tratta? Addirittura di «rimettere in discussione l’uomo sotto il profilo organico». Che cos’è il Doppio per Artaud? Il rovescio invisibile della realtà, una forza vitale transpersonale che esiste prima di incarnarsi nelle singole forme corporee. È là, in questo spettro senza individualità né limiti che l’attore ricaverà la propria forza: «bisogna considerare l’essere umano come un doppio, come il kha delle mummie egiziane, come uno spettro perpetuo dal quale si irradiano le forze dell’affettività. Uno spettro plastico e mai totalmente realizzato, di cui il vero attore imita le forme, imponendogli le forme e l’immagine della propria sensibilità». L’intero luogo teatrale, lo spazio indistinto della scene e della sala, della scena e della vita, è quel luogo virtualmente infinito in cui si articola per Artaud un corpo senza limiti. Il Doppio è dunque una massa indistinta e amorfa, un «intreccio fibroso» di materia che costituisce la «base organica» del teatro. È proprio sulla scena allora che si inventa un nuovo linguaggio nello spazio, «a metà strada fra il gesto e il pensiero», che si avvale della forza di proiezione delle sillabe, dei gesti sonori proferiti nell’aria: incantamenti, ripetizioni ritmiche, vibrazioni. [...] Solo allora il teatro può tornare a essere un atto vivo e magico18. Secondo le parole di Evelyne Grossman, il teatro di Artaud si gioca esattamente in una tensione tra la rappresentazione e l’impossibilità a rappresentare, impossibilità di cui cercò continuamente di espandere i limiti. Mantenendo viva questa tensione, le sue teorie teatrali hanno rivoluzionato la scena e il pensiero teatrale proprio per la novità con la quale nella biografia di Artaud vediamo accostati e confusi, nel senso di fusi insieme, i due termini di arte e vita. E la sua biografia, facendo confluire il teatro in questa sua tensione esistenziale al cambiamento sociale, cambiamento inteso 16 Antonin Artaud, Héliogabale ou l’anarchiste couronné, 1934, in Œ., p. 416. Traduzione: il teatro non era sulla scena ma nella vita. 17 Ivi, p. 417. Traduzione: Sotto terra, il tempio scende a spirale verso il profondo; le camere dei riti si ammucchiano, si succedono verticalmente; il tempio è come un vasto teatro, un teatro dove tutto sarebbe vero. 18 Evelyne Grossman, Antonin Artaud, un insurgé du corps [A.A., un insorto del corpo], cit., pp. 30-33. esclusivamente come cambiamento individuale, rimane un contesto essenziale per la comprensione delle sue opere e del suo pensiero19. Nel 1935 Artaud scrive: N.B. N’importe qui ne sait plus crier en Europe, et spécialement les acteurs en transe ne savent plus pousser des cris. Pour de gens qui ne savent plus que parler et qui ont oublié qu’ils avaient un corps au théâtre, ils ont oublié également l’usage de leur gosier. Réduits à des gosiers anormaux ce n’est meme pas un organe mais une abstraction monstrueuse qui parle: les acteurs en France ne savent plus que parler20. Poi sulla sua idea di teatro scenderà il sipario spesso e buio dei molti anni di ricovero psichiatrico. La tappa seguente della sua vita, a partire dal settembre 1937, riguarda infatti le circostanze della sua follia: viene reimpatriato da Dublino e internato in una clinica psichiatrica. Solo l’intervento dei suoi numerosi e autorevoli amici gli permetterà di uscire nel maggio 1946 dalla clinica di Rodez. Gilles Deleuze, ha contribuito a creare, con i suoi scritti, il mito di “Artaud le Schizo” che avrebbe raggiunto l’apice della letteratura, proprio perché era schizofrenico21 e che, proprio grazie alla sua psicosi, sarebbe riuscito a uscire dalla sua soggettività per entrare nel flusso anonimo del desiderio. In un recente dialogo tra Evelyne Grossman e Jacob Rogozinski troviamo riproposti i termini della questione: secondo la prima, che ben distingue tra delirio e follia, la voce dei poeti ispirata dal delirio non è necessariamente irrazionale, può anche essere creativa, mentre Jacob Rogozinski sostiene che la follia porti con sé sempre quella che Michel Foucault chiama un’assenza d’opera22, una vera e propria impossibilità di comunicare. Secondo Jacob Rogozinski è fuorviante pensare, come fa Deleuze, che esista una follia gaia e creatrice, e che l’opera di Artaud sia stata aiutata da questo tipo di follia, dato che, al contrario, Artaud non fu questo poeta geniale perché era pazzo, ma proprio perché lo è stato, e il suo ritorno alla scrittura è la storia di una sorta di «uscita dall’inferno», d’una lotta contro la follia. Non ha scritto tanti ammirevoli testi perché la sua «schizofrenia» lo avrebbe felicemente liberato dall’illusione di essere un io, ma per riappropriarsi del suo io, del suo nome, del suo corpo, per farli rinascere strappandoli a 23 questa tasca nera nella quale erano sprofondati . La sua opera si situerebbe quindi sul punto limite, lì dove cercava di resistere al vuoto della follia, a questo fondo nero dove l’arte prende la sua energia ma rischia sempre di soccombere. Al contrario, per Evelyne Grossman le parole di Deleuze che esaltano la schizofrenia d’Artaud, sono un elogio del delirio più che della follia vera e propria. Delirio inteso nel senso etimologico24: quello che esce dal percorso lineare, scarta direzione: le curve, i mulinelli, le 19 Cfr. E. Grossman, Ecrire le théâtre, in Artaud/Joyce, le corps et le texte, Paris, Nathan, 1996, oppure Ead., Artaud, “l’aliéné authentique”, Tours Éditions Farrago, 2003. 20 Antonin Artaud, Un athlétisme affectif, 1935, in Œ., p. 589. Traduzione: Non c’è più nessuno che sia capace di gridare in Europa, e specialmente gli attori in trance non sanno più emettere grida. Non sanno più fare altro che parlare, in teatro, hanno dimenticato di avere un corpo; e allo stesso modo hanno dimenticato come far funzionare la propria gola. Ridotti a gole anormali: non è neppure un organo, ma un’astrazione mostruosa che parla: gli attori in Francia non sanno fare altro che parlare. 21 Gilles Deleuze e Felix Guattari, L’Anti-Œdipe, Minuit, Parigi 1972, p. 160. 22 Cfr. Michel Foucault, La follia, l’assenza d’opera, in Storia della follia nell’età classica, Paris 1961. 23 Jacob Rogozinski, Deleuze lecteur d’Artaud – Artaud lecteur de Deleuze, in AA.VV., Gilles Deleuze, l’intempestif, Rivista Rue Descartes n°59, PUF, Parigi 2008, p. 79. Nostra traduzione. In originale: Artaud n’était pas ce poète de génie parce qu’il était fou, mais bien qu’il l’ait été, et son retour à l’écriture est l’histoire d’une «sortie de l’enfer», d’un combat contre la folie. Il n’a pas écrit tant de textes admirables parce que sa «schizophrénie» l’aurait heureusement délivré de l’illusion d’être un moi, mais pour se réapproprier son moi, son nom, son corps, pour les faire renaître en les arrachant à cette poche noire où ils avaient sombré. 24 Delirio deriva dal verbo latino deliràre, composto dalla particella DE = da indicante allontanamento e LIRA= solco, affine al greco LISTRON= zappa, vanga. In origine delirare significava Uscir dal solco o come diciamo oggi dal seminato, poi Uscir dalla via della ragione, Vaneggiare, Farneticare. forze che deviano il significato delle parole dal senso comune verso un esterno che le fa traboccare. Dice a questo proposito Marco De Marinis nel suo recente studio sul secondo Teatro della Crudeltà: Nella clinica di Rodez, e soprattutto successivamente, Artaud riprese (dopo il buio dei primi internamenti) a pensare e a fare teatro, anche se si trattò di qualcosa di radicalmente diverso da quello che siamo abituati ad associare alla parola “teatro” (e anche rispetto alla sue elaborazioni degli anni Trenta). E tuttavia, a ben vedere, si trattò di qualcosa di non inconcepibile in questi termini per noi, che siamo eredi oggi, a fine secolo, delle rivoluzioni sceniche del Novecento25. Ancora nel luglio 1947 Artaud darà il nome di teatro a quello che per lui è molto seriamente l’esercizio di un atto pericoloso e terribile che agisce nella vita: Le théâtre vrai m'est toujours apparu comme l'exercice d'un acte dangereux et terrible, où d’ailleurs aussi bien l’idée de théâtre et de spectacle s’élimine que celle de toute science, de toute religion et de tout art26. Dopo l’internamento psichiatrico ritorna a Parigi, andando a vivere ad Ivry, dove trascorre i suoi ultimi due anni di vita, e dove realizza le sue ultime opere e attività: la conferenza al Théâtre du Vieux-Colombier (dal titolo Histoire vécue d’Artaud-Mômo. Tête à tête, par Antonin Artaud, 13 gennaio 1947), la registrazione di Pour en finir avec le jugement de dieu, la scrittura di Suppôts et suppliciations 27, raccolta di testi scritti tra il marzo 1945 e il febbraio 1947 che uscirà solo nel 1978. Inoltre scrive Ci-gît28, iniziato durante un breve soggiorno a Sainte-Maxime nel settembre 1946 e pubblicato nel dicembre 1947, e il breve testo Van Gogh, il suicidato della società29, tra il febbraio e il marzo 1947. Quest’opera andrà subito in stampa, ricevendo nel gennaio 1948 il Premio Saint-Beuve. Nel settembre 1946, Artaud firma, caso piuttosto unico per un autore vivente, l’accordo per la pubblicazione delle sue opere complete con l’editore Gallimard. All’epoca erano già previsti i primi quattro volumi, ne usciranno in tutto ventisei. Il mese prima aveva già preparato la presentazione dell’opera30, in cui scrive: Moi poète j’entends des voix qui ne sont plus du monde des idées. Car là où je suis il n’y a plus à penser. La liberté n’est plus qu’un poncif plus insupportable que l’esclavage. Et la cruauté l’application d’une idée. Carné d’incarné de volonté osseuse sur cartilages de volonté rentrée, mes voix ne s’appellent pas Titania, Ophélie, Béatrice, Ulysse, Morella ou Ligeia, Eschyle, Hamlet ou Penthésilée, elles ont un heurt de sarcophage hostile, une friture de viande brulée, n’est pas Sonia Mossé […] Une descente a pic dans la chair sèvre d’appeler la cruauté à demeure, la cruauté ou la liberté, Le théatre c’est l’échafaud, la potence, les tranchées, le four crématoire ou l’asile d’aliénés31. 25 Marco De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud, il Secondo Teatro della Crudeltà (1945-1948), Bulzoni, Roma 2006, p. 14. Prima edizione : I Quaderni del Battello Ebbro, Bologna 1999. 26 Antonin Artaud, Le théâtre et la science, in Œ., p. 1544 e anche in Cahiers 329, Ivry, luglio 1947. Traduzione: Il teatro vero mi è sempre parso come l’esercizio di un atto pericoloso e terribile, dove sia l’idea di teatro che di spettacolo si eliminano come quella di tutta la scienza, di tutta la religione e di tutta l’arte. 27 Antonin Artaud: Suppôts et suppliciations [Succubi e supplizi], in OC, vol. XIV* e XIV**, Paris 1978. 28 Antonin Artaud, Ci-gît, K éditeur, Paris dicembre 1947. 29 Antonin Artaud: Van Gogh le suicidé de la societé [Van Gogh, il suicidato della società] (1947), in Œ., pp. 14391463, e in OC, vol. XIII, Paris 1971. Testo scritto nel febbraio-marzo 1947 e pubblicato dall’editore K di Parigi nello stesso anno. 30 Antonin Artaud, Préambule, in Œ., p 19-22. 31 Ivi, p. 22. Traduzione: Io poeta sento voci che non sono più del mondo delle idee,/ poiché dove sono non c’è da pensare, / la libertà non è altro che un luogo comune più insopportabile della schiavitù, / e la crudeltà l’applicazione di un’idea. / Carnato d’incarnato di volontà ossosa su cartilagine di volontà rientrata, le mie voci non si chiamano Titania, Ofelia, Beatrice, Ulisse, Morella o Ligeia, / Eschilo, Amleto o Pentesilea, / hanno un urto di sarcofago ostile, Infine sopraggiunge la malattia e, nella notte tra il 3 e il 4 marzo 1948, la morte. La lotta contro la sofferenza del corpo è testimoniata nei suoi ultimi cahier e da lui personificata nei testi dove parla degli esseri che cercano di succubarlo, esseri con i quali identifica il tumore mal diagnosticato che gli devasta gli organi interni e che lui presentiva parlando della bestia che gli rodeva l’ano32. una frittura di carne bruciata, non è vero Sonia Mossé […] / Una discesa a picco nella carne libera di chiamare la crudeltà a dimora, la crudeltà o la libertà. / Il teatro è il patibolo, la forca, la trincea, il forno crematorio o il manicomio. 32 Paule Thévenin, Antonin Artaud dans la vie, in Antonin Artaud, ce Désespéré qui vous parle, Seuil, Paris 1993, p. 68. 1. Biografia di Antonin Artaud1 1896 Antoine Marie Joseph Artaud nasce a Marsiglia il 4 settembre. È il primo di nove fratelli. 1901 Si ammala gravemente di meningite. D’ora in poi soffrirà di emicrania, disturbi nervosi, esaurimento a balbuzie. 1905 Nei frequenti soggiorni a Smirne presso la nonna materna, Artaud studia il greco e l’italiano. 1906 La morte di Germaine, la sorellina di sette mesi, lo addolora profondamente. 1910 Artaud inizia a scrivere poesie, firmandosi con lo pseudonimo di Louis des Attides, e pubblica insieme con i compagni di classe una rivista di poesia. 1914/15 Artaud soffre sempre più intensamente di depressione, brucia le proprie poesie e abbandona la scuola prima degli esami di maturità. È ricoverato nella casa di cura La Rouguière, nei dintorni di Marsiglia. 1916 A settembre è chiamato a compiere il servizio militare ed è destinato a Digne. 1917 A gennaio è congedato dal servizio militare per problemi di salute. Si sottopone a varie terapie. A causa della sifilide che gli viene diagnosticata, assume massicce dosi di arsenico, mercurio a bismuto. 1918/19 È trasferito in una casa di cura a Neuchâtel. Gli prescrivono il laudano, che innesca la dipendenza dagli stupefacenti che segnerà tutta la sua vita. Inizia a dipingere e a disegnare. 1920 Artaud si trasferisce a Parigi a si affida alle cure del dottor Edouard Toulouse. 1921 A febbraio intraprende la carriera di attore con Lugné-Poë al Théâtre de l’Oeuvre, che però abbandona a maggio. Scrive anche per la rivista di Lugné-Poë «Le Bulletin de l’Oeuvre». A settembre lavora al Théâtre de l’Atelier dl Charles Dullin, per il quale non solo recita, ma progetta anche i costumi a le scenografie. Lì conosce, in autunno, l’attrice rumena Génica Athanasiou, con la quale inizia una relazione che durerà, con qualche interruzione, fino al 1927. 1922 Tramite André Masson, Artaud conosce Joan Miró, Armand Salacrou, Jean Dubuffet e Roger Vitrac, tra gli altri. 1923 Ad aprile passa dal teatro di Dullin alla Comédie des Champs-Elysées, la compagnia di Georges e Ludmilla Pitoëff. 1924 Primo ruolo cinematografico in Fait divers di Claude Autant-Lara. Pubblicazione del suo primo testo teorico sul teatro, L’Evolution du décor. A giugno lascia la Comédie des Champs-Elysées. Lavora nel film Surcouf roi des corsaires di Luitz-Morat. A settembre muore il padre. Su invito di André Breton, in autunno Artaud si unisce ai surrealisti. 1925 Dirige il numero 3 di «La Révolution surréaliste». Impersona Marat nel film Napoléon di Abel Gance e recita nel film Graziella di Marcel Vandal. Dirige il Bureau Central de Recherches Surréalistes, che cessa l’attività ad aprile. A maggio, rappresentazione di Au pied du mur di Louis Aragon al Théâtre 1 Da Antonin Artaud. Volti / Labirinti / Film / Disegni e documenti, a cura di Jean Jacques Lebel, 5 Continents, Parigi 2005, pp. 42-44. du Vieux-Colombier. A luglio, la «Nouvelle Revue Française» pubblica L’Ombilic des Limbes di Artaud. 1926 Ad agosto Artaud recita in Le Juif errant di Luitz-Morat. Pubblicazione del manifesto Le Théâtre Alfred Jarry. A novembre, a causa di divergenze di opinioni, è estromesso dal gruppo surrealista. Lavora nel dramma Matusalemme di Iwan Goll. 1927 Periodo di astinenza dalle droghe a Marsiglia. Scrive la sceneggiatura per La Coquille et le clergyman. Carl Theodor Dreyer sceglie Artaud per il ruolo del monaco Massieu nella Passione di Giovanna d’Arco. A ottobre iniziano le riprese di Verdun, visions d’histoire di Léon Poirier. 1928 Prima proiezione di La Coquille et le clergyman, che Germaine Dulac ha adattato allo schermo. Artaud protesta per la riduzione cinematografica. Lavora nel film L’Argent di Marcel L’Herbier. A dicembre, prima rappresentazione teatrale di Victor ou les enfants au pouvoir di Roger Vitrac, con la regia di Artaud. 1929/30 Artaud recita in diversi film: Tarakanova di Raymond Bernard, La Femme d’une nuit di Marcel L’Herbier e Die Dreigroschenoper di G.W Pabst. Provino per La Fin du monde di Eugène Deslaw. 1931 Lavora in due film di Raymond Bernard, Faubourg Montmartre e Les Croix de bois. Ruolo secondario nella versione in musica di Mater dolorosa di Abel Gance. Si interessa al teatro Balinese. 1932 Riprese di Coup de feu à l’aube con la regia di Serge de Poligny. A ottobre esce Le Théâtre de la Cruauté (primo manifesto) di Artaud. Recita in L’Enfant de ma soeur di Henry Wulschleger. Tentativo di disintossicazione, a dicembre, presso l’Hôpital Henri-Rousselle. 1933 Pubblicazione del secondo manifesto di Le Théâtre de la Cruauté. Artaud conosce Anaïs Nin. Nuovo periodo di astinenza dalle droghe in Costa Azzurra. Lavora per il film di Fritz Lang La leggenda di Liliom. Esce Sidonie Panache di Wulschleger. 1934 Ad aprile Artaud pubblica Eliogabalo o l’anarchico incoronato. All’inizio di maggio, scrive la prefazione al catalogo delta mostra di Balthus alla Galerie Pierre. A ottobre inizia a scrivere I Cenci. Tragedia in quattro atti e dieci quadri da Shelley e Stendhal. Disintossicazione in una clinica privata di Parigi. 1935 Il 7 maggio, prima rappresentazione dei Cenci al Théâtre des Folies-Wagram, con scenografie a costumi ideati da Balthus. Nuovo tentativo di disintossicazione all’Hôpital Henri-Rousselle. Recita i suoi ultimi ruoli cinematografici in Cesare e Lucrezia Borgia di Abel Gance e Koenigsmark di Maurice Tourneur. A ottobre conosce la giovane artista belga Cécile Schramme. 1936 Da gennaio a ottobre soggiorna in Messico: incontra Diego Rivera e vive con la tribu indiana dei Tarahumara, partecipando al rito del peyotl. 1937 Nuovo tentativo di disintossicazione nella clinica del dottor Bonhomme a Sceaux, nei dintorni di Parigi. S’interrompe la relazione con Cécile Schramme. Artaud riceve un bastone che a suo avviso possiede poteri magici ed era appartenuto a san Patrizio. Ad agosto si reca in Irlanda per restituire il bastone al popolo irlandese a approfondire la conoscenza dei riti celtici. Invia i cosiddetti “sortilegi” a Lise Deharme e Jacqueline Breton, tra gli altri. A settembre è incarcerato a Dublino per oltraggio al pudore e infine è rimpatriato. Il 30 settembre è ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Le Havre e il 16 ottobre è trasferito all’istituto Quatre-Mares di Sotteville-les-Rouen. 1938 Il I° aprile è trasferito alla clinica Sainte Anne di Parigi. Ad Artaud è diagnosticata una malattia mentale incurabile. 1939 A febbraio è ricoverato all’istituto di cura di Ville-Evrard, vicino a Parigi. Invia “sortilegi” a Sonia Mossé, Roger Blin e Adolf Hitler, tra gli altri. 1941 D’ora in poi, Artaud si firma Antonin Nalpas. 1943 Dall’istituto Chezal-Benoit, Artaud viene trasferito alla casa di cura di Rodez. A giugno, il dottor Gaston Ferdière to sottopone alla prima seduta di elettroshock, che gli provocherà lesioni alla spina dorsale. Artaud è incoraggiato a disegnare, scrivere e leggere. A ottobre subisce un nuovo trattamento di elettroshock con dodici scariche. 1944 Artaud ricomincia a disegnare e scrivere. A maggio è sottoposto a una terza serie di elettroshock, ne seguiranno una quarta a settembre e una quinta a dicembre, ciascuna di dodici scariche. Nel complesso, Artaud subisce cinquantuno elettroshock nell’arco di diciannove mesi. La sua spina dorsale riporta lesioni permanenti. A questo proposito scrive: «Mi hanno [...] sottoposto a una cura che non smette di indignarmi. Questa cura si chiama elettroshock; consiste nell’immergere il paziente in un flusso di corrente, al fine di annientarlo». 1946 Sulla base di una garanzia finanziaria da parte dei suoi amici, Artaud viene dimesso a maggio. L’8 giugno tiene la conferenza Les malades et les médecins, trasmessa il giorno seguente dall’emittente radiofonica RDF. Ad agosto inizia una serie di ritratti di personaggi, tra i quali figurano Jacques Prevel, Roger Blin, Sima Feder, Mania Oïfer e Jean Dubuffet. 1947 Il 13 gennaio Artaud si esibisce per tre ore nella rappresentazione Tête à tête, par Antonin Artaud al Théâtre du Vieux-Colombier, con letture di prose a poesie. A febbraio scrive Van Gogh, il suicidato della società e in primavera realizza altri ritratti e autoritratti. Alla Galerie Pierre si apre a luglio una mostra di ritratti e disegni di Artaud. Scrive Succubi a supplizi e, a novembre, Per farla finita col giudizio di dio. Le condizioni psichiche di Artaud peggiorano sensibilmente. 1948 Per il 2 febbraio, l’emittente RDF disdice la trasmissione del dramma radiofonico Per farla finita col giudizio di dio, che viene soppresso all’ultimo minuto per blasfemia e oscenità. Numerosi intellettuali solidarizzano con Artaud a chiedono invano la trasmissione del dramma. Artaud muore di cancro il 4 marzo a Ivry. 2. Evelyne Grossman Antonin Artaud, un insurgé du corps [A.A., un insorto del corpo] Gallimard, Parigi 2006, pp. 28-43. «Frantumare il linguaggio per raggiungere la vita, significa fare o rifare il teatro […]. Bisogna credere ad un senso della vita rinnovata dal teatro, in cui l’uomo impavidamente si fa padrone di ciò che ancora non esiste, e lo fa nascere. E tutto ciò che non è nato può ancora nascere a patto che non ci accontentiamo di rimanere semplici organi di registrazione.» Le théâtre et la culture, 1935 Capitolo 2 VERSO UN TEATRO DELLA CRUDELTA’ Dal Teatro Alfred Jarry (a sinistra, Artaud fotografato da Elie Lotar per i fotogrammi dell’opuscolo Le Théâtre Alfred Jarry et l’hostilité publique [Il Teatro Alfred Jarry e l’ostilità pubblica]) al Teatro della Crudeltà (qui a fianco, un bozzetto di Balthus per il costume del Conte Cenci). «Io uso, scriverà Antonin Artaud nel 1935, la parola crudeltà nel senso di fame di vita.» Il Teatro Alfred Jarry L’alternanza regolare di periodi di straripante creatività seguiti da episodi di depressione e di sofferenza acuta caratterizza la quotidianità della vita di Artaud. Gli anni 1926-1927, in questo senso, non sfuggono alla regola. Da un lato scrive e pubblica molto (Fragments d’un Journal d’Infer [Frammenti di un giornale d’Inferno], L’Art et la Mort [L’arte e la morte]), getta le basi del Teatro Alfred Jarry, continua a lavorare nel cinema (Le Juif errant [L’ebreo errante] di Luitz-Morat, La passione di Giovanna D’Arco di Carl Dreyer, Verdun, visions d’histoire [Verdun, visioni di storia] di Léon Poirier), pubblica la sceneggiatura di La Coquille et le Clergyman [La conchiglia e il prete]; dall’altro, abbandona dopo una decina di sedute la psicanalisi, confessa di «Vi ho detto che le sedute di psicanalisi alle quali avevo finito per prestarmi hanno lasciato in me un’impronta indelebile. Conoscete bene la ripugnanza soprattutto istintiva e nervosa che manifestavo per questo tipo di trattamento quando vi ho conosciuto. [...] ho potuto constatare i benefici che ne ho tratto [...] ma dal profondo del mio essere continuo a rifuggire la psicanalisi, e la rifuggirò sempre, così come rifuggirò ogni tentativo di rinchiudere la mia coscienza in precetti o formule, o in una qualsiasi organizzazione verbale.» Lettera al dottor Allendy, 1927. essere «ricaduto pesantemente nel laud[ano]», si lamenta di nuovo di una astenia vitale di fondo, di un’assoluta vacuità che lo tormenta. «Vorrei superare questo punto di assenza, d’inanità», scrive nel 1927. «Questa situazione di stallo che mi rende infermo, inferiore a tutti e a tutto. Non ho vita, non ho vita!!! La mia effervescenza interiore è morta.» Nell’autunno del 1926, poco prima della sua esclusione dal gruppo surrealista, fonda con Roger Vitrac e Robert Aron il Teatro Alfred Jarry il cui finanziamento è largamente sostenuto da Yvonne e René Allendy, il celebre psicanalista che aveva fondato il gruppo di studi filosofici e scientifici della Sorbona. L’amicizia e l’entusiasmo di questa coppia avrebbero a lungo sostenuto i progetti di Artaud sia a teatro che al cinema. Il Teatro Alfred Jarry, il cui nome è un omaggio al maestro della patafisica, inventore del personaggio di Ubu Re e grande ispiratore del teatro Dada, s’inscrive nella linea del primo surrealismo. La sua ambizione è affermata in modo chiaro: farla finita con l’illusione e l’artificio, fare in modo che ogni pièce sia «una sorta di operazione magica» inscrivendo la realtà direttamente sulla scena — tutti principi che annunciano il futuro Teatro della Crudeltà. Paragonando uno spettacolo riuscito alle evoluzioni quasi coregrafiche di una retata di polizia (paragone che Breton gli avrebbe a lungo rimproverato), Artaud terminava nel 1926 il ____________________________________________ «Manifeste pour un théâtre avorté [Manifesto René e Yvonne Allendy (in alto). Lei farà parte delle per un teatro abortito]» affermando la propria «filles de coeur à naître [le figlie di cuore che devono volontà di raggiungere il pubblico «nel modo ancora nascere]» di Artaud. più pericoloso possibile»: ____________________________________________ «In Les Enfants au «Lo spettatore che viene da pouvoir [I bambini al noi saprà che viene a sottoporsi a una vera e propria operazione, in cui non potere], la pentola è in piena ebollizione. Già solamente il suo spirito, ma i suoi sensi e la sua carne sono coinvolti. D’ora il titolo indica in avanti andrà a teatro come va dal chirurgo o dal dentista. [...] Deve essere un’irriverenza radicale ben convinto che noi siamo in grado di farlo urlare.» per i valori costituiti. In gesti insieme In poco più di due anni di breve esistenza, in mezzo roventi e pietrificati, questo lavoro traduce a innumerevoli difficoltà tecniche e finanziarie, a la disgregazione del numerosi scandali e gazzarre surrealiste — quel che pensiero moderno e la sua sostituzione con... Artaud chiamerà più tardi con un po’ di che cosa? Ecco in ogni magniloquenza «l’ostilità pubblica» —, il Teatro modo il problema cui a Alfred Jarry riuscì tuttavia a presentare quattro grandi linee il lavoro dà risposta: Con che spettacoli, fra cui Il sogno di Strindberg (il 2 e il 9 cosa pensare? E che giugno 1928) e Victor, ou les Enfants au pouvoir cosa rimane?» Théâtre Alfred Jarry. [Victor, o i bambini al potere], di Roger Vitrac (in Programma della dicembre 1928 e gennaio 1929). Le testimonianze stagione 1928. che ci rimangono, così come certe fotografie d’epoca, consentono di immaginare la forza e l’inventività delle messe in scena di Artaud. Come i quattro «giacenti» collocati su delle barelle nella messa in scena del Sogno: dei manichini che raffiguravano dei malati. Redige ancora due progetti di messa in scena, uno per la Sonata degli spettri di Strindberg, l’altro per Le Coup de Trafalgar [Il colpo di Trafalgar] di Roger Vitrac, ma, a causa dei finanziamenti insufficienti, decide di porre fine all’esperienza del Teatro Alfred Jarry. Fallimento o successo? Il Teatro Alfred Jarry fu senz’altro, come sottolinea il critico Henri Béhar, «uno dei più rivoluzionari della prima metà del secolo». E fu in ogni caso una delle prime tappe che avrebbero portato Artaud ai grandi testi teorici degli anni trenta e alla sua definizione di un nuovo «Teatro della Crudeltà». In un articolo comparso il 5 giugno 1928 su «Paris Midi», Paul Achard fa la cronaca della gazzarra surrealista del 2 giugno 1928, in occasione della prima rappresentazione del Sogno, terzo spettacolo del Théâtre Alfred Jarry: «Alcuni incidenti hanno segnato la rappresentazione del Sogno di Strindberg data sabato scorso al Théâtre Alfred Jarry, nella messa in scena di Artaud. La tempesta era nell’aria? Si è trattato di una provocazione orchestrata? La messa in scena non ha creato sconcerto con una scenografia ridotta al minimo e le luci al massimo [...]? Certamente ci furono numerose interruzioni [...]. Il regista Artaud a un certo punto si è fatto largo in scena fra gli attori interdetti e ha detto press’a poco queste parole: “Strindberg è un ribelle, proprio come Jarry, come Lautréamont, come Breton, come me. Noi rappresentiamo questo lavoro come se vomitassimo contro la sua patria, contro tutte le patrie, contro la società!” Il 9 giugno 1928, la seconda rappresentazione del Sogno è stata interrotta da una zuffa con i surrealisti, venuti di nuovo a disturbare lo spettacolo [pagina a sinistra]. André Breton, Pierre Unik e Georges Sadoul sono stati arrestati dalla polizia e rilasciati il giorno dopo.» La Coquille et le Clergyman Le sue riflessioni su teatro e cinema sono contemporanee e strettamente legate. Esse partecipano della stessa volontà di ripensare completamente la questione dello spettacolo e della rappresentazione. Il suo scopo? Impedire col gesto vivo, con la forza in atto, la propensione di ogni figura a prendere forma, a solidificarsi — in altre parole, a diventare cadavere. Ora, nessuna arte meglio del cinema può secondo lui far sorgere le forze invisibili della psiche, dar loro corpo. Lo schermo cinematografico è come un tessuto tattile in cui si proiettano i nostri sogni: «La pelle umana delle cose, il derma della realtà, ecco cos’è il cinema prima di tutto», scrive. In un articolo del 1927 intitolato simbolicamente «Stregoneria e cinema», evoca «quella specie di eccitazione fisica che viene comunicata direttamente al cervello dalla rotazione delle immagini»: il cinema emana «un’atmosfera di trance». In breve, conclude, «l’epoca d’oggi è bella per gli stregoni e per i santi, più bella di quanto non sia mai stata. Una sostanza impalpabile prende corpo, cerca di raggiungere la luce. Il cinema ci avvicina a questa sostanza». Questi fotomontaggi illustravano il volumetto Le Théâtre Alfred Jarry et l’hostilité publique [Il Teatro Alfred Jarry e l’ostilità pubblica] redatto tra la fine del 1929 e l’inizio del 1930 da Roger Vitrac con la collaborazione di Antonin Artaud. Il libretto, di 48 pagine, ricordava i quattro spettacoli già dati e presentava un montaggio di lettere e articoli che offrivano una sfaccettata rassegna stampa delle opinioni della critica teatrale dell’epoca sui diversi spettacoli rappresentati. Si apriva con la seguente dichiarazione: «Il Théâtre Alfred Jarry, consapevole della sconfitta del teatro di fronte allo sviluppo dilagante della tecnica internazionale del cinema, si propone con mezzi specificamente teatrali di contribuire alla distruzione del teatro quale attualmente esiste in Francia, coinvolgendo in tale distruzione tutte le idee letterarie o artistiche [...], tutti gli artifici plastici su cui questo teatro è fondato [...]». Qui a fianco, in alto, tre foto di Artaud scattate da Élie Lotar per il fotomontaggio. Ma — e qui sta l’inconciliabile paradosso — se i sogni sono semplicemente riprodotti sulla pellicola, realizzati (in tutti i sensi del termine) sullo schermo, dov’è la stregoneria? La magia dell’invisibile scompare se la tecnica, supplendo all’irrappresentabile, permette di dar forma alla forza dei sogni. Nel 1928, in occasione della prima proiezione pubblica de La Coquille et le Clergyman, film realizzato da Germaine Dulac a partire dalla sua sceneggiatura, i surrealisti organizzano una memorabile gazzarra in sostegno ad Artaud che si considera tradito. Come sottolineava recentemente il cineasta André S. Labarthe, non si può non riconoscere la fedeltà di Germaine Dulac, una cineasta d’altronde affermata, ad Antonin Artaud, ma è proprio questo tipo di sapere che Artaud rifiuta. Le immagini girate riproducevano la sua sceneggiatura ma non avevano saputo coglierne l’energia originaria. Una volta realizzato, calibrato, il film non era altro che un film morto. La stessa constatazione si ripeterà, vent’anni più tardi, con la trasmissione Pour en finir avec le _______________________________________ Artaud fotografato da Armand Salacrou verso il 1927. jugement de dieu [Per farla finita col giudizio di dio], che apparirà ai suoi occhi come un fallimento. «Dove è la macchina, scriverà allora, là c’è l’abisso e il niente». Ecco allora la questione fondamentale che sarà esplorata da tutta la sua opera: come bucare l’occhio dello spettatore perché finalmente egli veda e perché vedere ridiventi un atto di tutto il corpo, uno «scalpiccio d’ossa, di membra e di sillabe». Anche se continuerà ancora per qualche tempo a elaborare diversi progetti cinematografici (in particolare la creazione di una società per la produzione di cortometraggi), a cercare dei finanziatori con l’aiuto di Yvonne Allendy, a recitare in numerosi film spesso per ragioni alimentari, la magia del cinema per lui è scomparsa per sempre. L’avvento del cinema “parlante” non farà che accentuare il suo rifiuto di questa «macchina dall’occhio implacabile» alla quale opporrà da quel momento «un teatro di sangue, un teatro che a ogni rappresentazione avrà fatto acquistare corporalmente qualcosa». Nel 1933, in un articolo intitolato «La vecchiaia precoce del cinema», ne scrive l’elogio funebre: «Il mondo del cinema è un mondo morto, illusorio e smembrato. [...] Non ricrea la vita. Delle onde vive, inscritte in un numero di vibrazioni fissate per sempre, sono onde ormai morte. Il mondo del cinema è un mondo chiuso, senza relazione con l’esistenza.» Reciterà un’ultima volta durante l’estate 1935 in Lucrezia Borgia di Abel Gance poi in Kœnigsmark di Maurice Tourneur. Saranno i suoi ultimi ruoli al cinema. «Ho cercato [...] di realizzare un’idea di cinema visivo in cui la psicologia stessa viene fagocitata dalle azioni. [...] I sogni hanno qualcosa di più di una logica tutta loro. Hanno una loro vita, in cui si manifesta una verità intelligente e oscura. Questa sceneggiatura cerca di raggiungere l’oscura verità dello spirito, in immagini che si generano da sé, e che non traggono il loro significato dalla situazione in cui si sviluppano ma da una sorta di necessità interiore che sia in grado di proiettarle nella luce di un’evidenza senza rimedio.» La Coquille et le Clergyman. La prima del film La Coquille et le Clergyman ebbe luogo il 9 febbraio 1928 allo Studio des Ursulines [cinema d’essai in rue des Ursulines]. Durante i pochi mesi delle riprese, Artaud subissò Germaine Dulac di domande, consigli, suggerimenti. Così, a proposito della scenografia della sala da ballo [qui sopra la scena in cui il prete penetra nella casa], approva la pavimentazione, ma rifiuta le pareti, aiutandosi con uno schizzo esplicativo: «forse queste pareti a zig-zag mi danno un po’ fastidio. Se il muro è proprio necessario lo preferirei su uno o due piani [...]». Il teatro e il suo doppio La raccolta di testi intitolata Le Théâtre et son Double [Il teatro e il suo «Gli attori con i loro costumi compongono dei doppio] comparirà nel febbraio del 1938. Qualche mese prima, al suo veri e propri geroglifici ritorno da un viaggio in Irlanda, Antonin Artaud era stato costretto al che vivono e si muovono. [...] Sono come grandi ricovero nell’ospedale psichiatrico dei Quatre-Mares di Sotteville-lèsinsetti...». Rouen; poté vedere il libro solo parecchio tempo dopo la pubblicazione. «Sul teatro balinese», Gli articoli e le lettere che compongono il volume vanno dal 1931 al 1931 [Les danses de Bali à l’exposition coloniale 1935. Se aveva effettivamente deciso nel 1930 di mettere fine de Vincennnes, 1931, all’esperienza del Teatro Alfred Jarry non aveva tuttavia abbandonato il «L’Illustration».] progetto di rivoluzionare l’idea stessa di teatro. Durante quei cinque anni, a partire dalle prime note redatte sotto la grande impressione suscitata dalla scoperta dei danzatori balinesi all’Esposizione coloniale del 1931 a Parigi, fino al fallimento della rappresentazione dei Cenci e alla sua partenza per il Messico all’inizio del 1936, egli elabora in effetti il nucleo essenziale delle sue teorie teatrali, quelle che costituiscono ciò che è stato chiamato da qualcuno il primo Teatro della Crudeltà. Quello che Artaud definisce «teatro», bisogna sottolinearlo, è allo stesso tempo molto di più e qualcosa di molto diverso da quello che si intende di solito con questo nome. Da qui i malintesi che talvolta accompagnano la ricezione delle sue teorie in Europa e negli Stati Uniti. Per lui ogni parola supera i propri limiti, va oltre un significato specifico, e la parola «teatro» non sfugge alla regola: ciò che egli intende effettivamente inventare sotto il vecchio nome di teatro, è proprio un’altra scena in cui la parola «ossificata», «le parole [...] gelate» del In una lettera a Jean teatro occidentale potranno riprendere alito e vita, in cui sarà ritrovata la Paulhan, Artaud rivela «vecchia efficacia magica» di un linguaggio in atto. Di cosa si tratta? il titolo del libro che raccoglierà i suoi Addirittura di «rimettere in discussione l’uomo sotto il profilo organico». scritti sul teatro. Fra Che cos’è il questi, un testo del 1931 in cui analizza un Doppio per quadro esposto al Artaud? Il Louvre, Le figlie di Loth (qui sopra), per rovescio parlare de «La messa invisibile della in scena e la metafisica»: «Il suo realtà, una forza pathos [...] è vitale transpercepibile anche da personale che lontano, colpisce lo sprito con una sorta di esiste prima di folgorante armonia incarnarsi nelle visuale, la cui acutezza, voglio dire, singole forme agisce di prepotenza e corporee. È là, in si scarica in una sola occhiata. Prima ancora questo spettro di aver visto di che si senza tratta, s’intuisce di aver individualità né davanti qualcosa di grande, e l’orecchio ne limiti che è scosso quasi quanto l’attore ricaverà l’occhio. [...] Affermo in ogni modo che la propria forza: «bisogna considerare l’essere umano come un doppio, come questo dipinto è ciò il kha delle mummie egiziane, come uno spettro perpetuo dal quale si che dovrebbe essere il teatro, se solo sapesse irradiano le forze dell’affettività. Uno spettro plastico e mai totalmente parlare il linguaggio realizzato, di cui il vero attore imita le forme, imponendogli le forme e che gli è proprio.» l’immagine della propria sensibilità». L’intero luogo teatrale, lo spazio indistinto della scene e della sala, della scena e della vita, è quel luogo virtualmente infinito in cui si articola per Artaud un corpo senza limiti. «Come ogni cultura magica espressa da appropriati geroglifici, anche il vero teatro ha le sue ombre; e fra tutti i linguaggi e tutte le arti è il solo le cui ombre abbiano travolto i loro limiti. [...] Il che significa rifiutare le limitazioni abituali dell’uomo e delle sue facoltà, e allargare all’infinito le frontiere di ciò che chiamiamo la realtà» (Prefazione a Il teatro e il suo doppio). Il Doppio è dunque una massa indistinta e amorfa, un «intreccio fibroso» di materia che costituisce la «base organica» del teatro. È proprio sulla scena allora che si inventa un nuovo linguaggio nello spazio, «a metà strada fra il gesto e il pensiero», che si avvale della forza di proiezione delle sillabe, dei gesti sonori proferiti nell’aria: incantamenti, ripetizioni ritmiche, vibrazioni. La crudeltà? Un’azione articolata che anima il corpo-geroglifico dell’attore, fra unione e separazione, geometria di linee, «gioco di giunture». Niente a che vedere, sottolinea Artaud, o almeno non solo, col sadismo e il sangue, si tratta di una «crudeltà pura, senza strazio della carne». Solo allora il teatro può tornare a essere un atto vivo e magico. I Cenci «Balthus ha ritratto Iya Abdy [qui sotto] come un primitivo avrebbe dipinto un angelo; con un mestiere così sicuro, con una analoga comprensione degli spazi, delle linee, dei vuoti, delle luci che definiscono lo spazio; e nel ritratto di Balthus Iya Abdy è viva: grida come una figura in rilievo di un racconto di Achim d’Arnim. [...] E quello stesso Bathus, che fa di Iya Abdy un fantasma che si è incarnato come per miracolo, ha creato per lo spettacolo dei Cenci una scenografia da fantasmi, grandiosa come le rovine che si vedono nei sogni [...]». Les Cenci [I Cenci], 1935. È questo il linguaggio teatrale nuovo che Artaud intende mostrare e far sentire nella messa in scena del 1935 di una pièce di cui è lui stesso autore, I Cenci, tragedia in quattro atti da Shelley e Stendhal. Sarà il primo e ultimo spettacolo del Teatro della Crudeltà. Al centro dell’opera il motivo dell’incesto, tema feticcio di Artaud, metaforaschermo, come si dice di certi sogni, di quella perdita dei limiti individuali, di quella porosità dei confini fra vita e morte, fra noi e gli altri, che rende indefiniti i suoi personaggi. Personaggi che si dissolvono continuamente, i cui contorni si sciolgono come si liquefà dentro un vaso la testa del prete nella sua sceneggiatura. Il conte Cenci è dunque un personaggio luciferino che, per sfidare l’ordine del mondo, raggiunge il fondo dei propri desideri: fa uccidere i suoi due figli e stupra la figlia Beatrice. Al di là del rovesciamento dei valori morali, del caos che rappresenta, Cenci incarna la rottura dei limiti fra i membri di una famiglia, che si divorano a vicenda e si scambiano i ruoli in un massacro programmato in cui non si sa più chi sia il carnefice e chi la vittima. Per Les Cenci, Balthus ha concepito una scenografia (qui a fianco) «costruita come un rudere, con impalcature e teli drappeggiati al posto dei fregi». Sulla parte destra della scena si ergeva un arco di trionfo sormontato da un elmo gigantesco ispirato a Piranesi. Dietro il palazzo, un tempio romano con il suo frontone, sormontato da un’impalcatura di travi tenute insieme da corde. Pagina precedente, I atto, scena 3 dei Cenci, nella scenografia realizzata. L’ossessione del padre incestuoso incarnato qui da Artaud, interprete del personaggio del conte Cenci, tornerà di nuovo nei suoi testi del 1945 dal manicomio di Rodez, sotto i tratti mitici delle sue «filles de coeur à naître [figlie di cuore che devono ancora nascere]» (le sue due nonne, sua sorella Germaine, e altre donne, morte o vive, che ha amato): esse tornano a ossessionare il suo corpo per esserne rimesse al mondo, «egli resuscita la loro anima per dar loro un corpo penetrandole dopo che loro lo hanno contenuto». La messa in scena che Artaud concepisce per I Cenci è ampiamente descritta nelle lettere e nei testi redatti all’epoca; egli elenca il «movimento gravitazionale» che anima i personaggi, le vibrazioni delle onde Martenot che pongono lo spettatore «al centro di una rete di vibrazioni sonore», «quell’andirivieni matematico degli attori gli uni attorno agli altri, che disegna nell’aria della scena una vera e propria geometria», i manichini, le scene di Balthus. Con poche eccezioni la critica non fu buona. Colette tuttavia scrisse: «L’attore peggiore, Antonin Artaud, non è il meno interessante. Rauco, nero, angoloso, agitato, fa a pezzi il testo come peggio non si potrebbe, è insopportabile, eppure lo sopportiamo. Perché la sua è la luce della fede.» A causa di problemi finanziari, le recite si interrompono dopo diciassette rappresentazioni. In alcune note personali, a proposito di quel mese di dicembre del 1935, Artaud concluderà: «Mese maledetto di un anno maledetto, l’anno delle delusioni e della Sconfitta. Successo in senso Assoluto dei Cenci.» Ha cominciato a prendere contatti in vista del suo viaggio in Messico, alla ricerca di quelle che egli considera le sorgenti vive della cultura, la sopravvivenza «di un naturalismo imbevuto di magia, [...] nel sottosuolo della terra e nelle strade dove ancora l’aria si muove». «I Cenci [...] non sono ancora il Teatro della Crudeltà, ma lo preparano», afferma Artaud nel 1935. «Nello scrivere i Cenci ho imposto alla mia tragedia il movimento della natura, quella specie di gravitazione che muove le piante, e gli esseri come le piante, e che si ritrova nel sommovimento vulcanico della terra.» Qui sotto e in alto a sinistra, il copione di regia annotato da Roger Blin, in cui sono tracciate le traiettorie di quelle «grandi forze» che sono i personaggi. A sinistra, in basso, la fotografia della scena in questione: atto IV, scena 1, Beatrice Cenci [Lady Abdy] e gli assassini [Roger Blin e Henri Chauvet]. 3. Guillaume Fau L’atelier de la cruauté [Il laboratorio della crudeltà] in Antonin Artaud, a cura di Guillaume Fau, Bibliothèque National de France-Gallimard, Paris 2006, pp. 96-98. Nel febbraio del 1948, quando la trasmissione Pour en finir avec le jugement de dieu [Per farla finita col giudizio di dio] è stata appena censurata, Artaud scrive: «[...] ecco perché non mi avvicinerò più alla Radio, e mi consacrerò ormai in modo esclusivo al teatro così come lo concepisco, un teatro di sangue, un teatro che a ogni rappresentazione avrà fatto acquistare “corporalmente” qualcosa sia a chi recita che a chi viene a veder recitare, d’altra parte non si recita, si agisce. Il teatro è in realtà la genesi della creazione».2 Abbandonato dopo l’insuccesso pubblico dei Cenci nel 1935, reso impossibile dai numerosi ricoveri seguiti al ritorno dall’Irlanda nel 1937, il teatro è qui evocato da Artaud, pochi giorni prima della sua morte, in termini che si ricollegano all’universo concettuale elaborato negli anni trenta: centralità del motivo della crudeltà, partecipazione dello spettatore e dell’attore a un rituale della scena che dovrebbe “compensare” la mancanza di vita, definizione di un linguaggio specificamente teatrale fondato sul corpo e l’azione piuttosto che sul testo e la psicologia, integrazione, infine, di tutti questi elementi con una metafisica. Persistenza notevole di un pensiero la cui genesi va ricercata nell’esperienza teatrale e cinematografica degli anni venti, che Le Théâtre et son Double [Il teatro e il suo doppio] riunirà in raccolta nel 1938. Recitare «Gli attori in Francia sanno solo parlare.»3 È come attore che Artaud fa i suoi primi passi a teatro, all’inizio degli anni venti: prima con Lugné-Poe, al Théâtre de l’Oeuvre, poi, a partire dal 1921, nella compagnia di Charles Dullin. Lì entra in contatto con l’avanguardia teatrale del dopoguerra (Baty, Pitoeff e Jouvet, che incontra a quell’epoca, saranno con Dullin i fondatori del Cartel nel 1927), osserva le loro messe in scena, qualche volta prende parte anche alle produzioni realizzando alcune scenografie. Molto presto, pubblica diversi resoconti di spettacoli: Elektra, di Hoffmansthal (Théâtre de l’Oeuvre, 1920), La Nuit des Rois [La notte dei re], da Shakespeare, con la regia di Jacques Copeau (Vieux-Colombier, 1921) e Sei personaggi in cerca d’autore, di Pirandello, nella messa in scena di Pitoeff (Comédie des Champs-Élysées, 1923) attirano la sua attenzione, ma i pochi articoli che consacra al théâtre de l’Atelier testimoniano della nascita di un pensiero sul teatro, e più precsamente, sull’attore. Installatosi a place Dancourt dal 1922, Dullin vi organizza dei corsi d’arte drammatica ed è proprio il suo lavoro sulla recitazione dell’attore che affascina dapprima Artaud. Ne L’Atelier de Charles Dullin [Il laboratorio di C.D.] («Action», anno 2°, fine 1921-inizio 1922), egli descrive l’ideale ascetico di attore che Dullin intende imporre sulla scena: «Una perfetta pulizia morale e di fede presiede agli sviluppi di questa interessante falange e già cominciano a emergere incontestabili personalità di attrici e di attori».4 Di colpo, Artaud pone dunque al centro della sua riflessione la questione etica della compagnia e la sua capacità di rivelare il talento dell’attore. Egli assimila già questo ideale a quello dell’attore giapponese: «Si tratta di attori che danno come un’immagine ideale di ciò che potrebbe essere l’attore completo nella nostra epoca e si avvicinano al tipo eterno dell’attore giapponese che ha sviluppato in sé fino al parossismo l’accrescimento di tutte le sue potenzialità fisiche e psichiche».5 Qualche mese più tardi, Le Théâtre de l’Atelier («La Criée», n. 17, ottobre 1922) mette l’accento sugli esercizi d’improvvisazione diretti da Dullin e sottolinea i vantaggi che ne derivano all’espressività: «Gli 2 Lettera a Paul Thévenin, 24 febbraio 1948, in Oeuvres [Opere], p. 1676; Oe. C. [Opere complete], t. XIII, p. 147. 3 Oeuvres, p. 589; Oe. C., t. IV, p 132. 4 Oe. C., t. II, p. 134. 5 Ibid. artisti dell’Atelier si sono già esercitati in vere e proprie sedute di improvvisazione davanti a gruppi di spettatori estremamente ristretti. Si sono rivelati inaspettatamente abili a rappresentare, con poche parole, pochi atteggiamenti, poche espressioni del volto, caratteri, tic, personaggi della nostra umanità, o anche sentimenti astratti, elementi come il vento, il fuoco, vegetali o pure creazioni dello spirito, sogni, deformazioni, e tutto questo all’impronta, senza testo, senza indicazioni, senza preparazione.»6 Nel 1938, Le Théâtre et son Double [Il teatro e il suo doppio] effettuerà un lavoro di messa a punto e di ulteriore teorizzazione in rapporto a questi primi testi: in effetti quella raccolta fa il punto rispetto alle esperienze giovanili, prende le distanze da certe posizioni adottate negli anni venti e ne sviluppa altre in modo considerevole. Nella Deuxième lettre sur le langage [Seconda lettera sul linguaggio] (28 settembre 1932), Artaud rifiuta anche il metodo dell’improvvisazione, di cui aveva sottolineato i vantaggi nel 1922: «I miei spettacoli non avranno niente a che vedere con le improvvisazioni di Copeau. Per quanto siano profondamente radicati nel concreto, all’esterno, benché si sviluppino in piena natura e non nelle stanze chiuse del cervello, non per questo sono lasciati al capriccio dell’ispirazione incolta e irriflessiva dell’attore.»7 Più avanti, Artaud spiega la sua posizione: nell’improvvisazione, è la sottomissione dell’attore al linguaggio a inficiare una tecnica di cui, qualche anno prima, lodava i vantaggi: «Si tratta di sostituire al linguaggio articolato un linguaggio di natura diversa, che avrà le stesse possibilità espressive del linguaggio verbale, ma la cui fonte sarà rintracciata in un punto ancora più nascosto e remoto del pensiero.»8 Ormai, il teatro che auspica è un teatro di segni. Tutto si svolge come se l’attore dovesse ormai recitare non più a partire dai «rapporti inclusi e fissati nelle stratificazioni della sillaba umana, che essa stessa ha ucciso richiudendosi» ma affidandosi alle risorse del solo spazio scenico: «Questo linguaggio mira dunque a inglobare e a utilizzare l’estensione, cioè lo spazio, e nell’utilizzarlo, farlo parlare: io prendo gli oggetti, le cose che si trovano nello spazio come delle immagini, come delle parole, e le metto assieme e faccio in modo che si rispondano a vicenda seguendo le leggi del simbolismo e delle analogie viventi.»9 All’improvvisazione si sostituisce allora un tipo di recitazione basata sul gesto, il corpo e l’investimento fisico, quell’«atletica affettiva» dell’attore che un altro testo del Théâtre et son Double prova a definire al di là della parola e del tipo di rappresentazione che essa determina: «Per sfruttare la propria affettività come un lottatore si serve dei muscoli, bisogna considerare l’essere umano come un Doppio [...] come uno spettro perpetuo dal quale si irradiano le forze dell’affettività. Uno spettro plastico e mai totalmente realizzato, di cui il vero attore imita le forme, imponendogli le forme e l’immagine della propria sensibilità.»10 Nel frattempo, Artaud è stato molto colpito dalla scoperta del Teatro Balinese, prima all’esposizione coloniale di Marsiglia del 1922, poi a quella di Parigi del 1931.11 Questa esperienza, che accompagna la genesi e l’evoluzione delle sue teorie sulla recitazione fin dall’inizio degli anni venti, è una delle chiavi che permettono di comprendere il ruolo che l’urlo e la trance saranno chiamati a giocare nel Teatro della Crudeltà: «Non c’è più nessuno che sia capace di gridare in Europa, e specialmente gli attori in trance non sanno più emettere il proprio grido. Non sanno più fare altro che parlare, in teatro, hanno dimenticato di avere un corpo; e allo stesso modo hanno dimenticato come far funzionare la propria gola.»12 Artaud continuerà la sperimentazione sonora attraverso il dispositivo musicale dei Cenci, messo a punto con Roger Désormière, poi, negli ultimi anni della sua vita, in modo indiretto con le glossalalie e con la trasmissione radiofonica Pour en finir avec le jugement de dieu. [...] 6 Ibid. Oeuvres, p. 571; Oe. C., t. IV, p. 106. 8 Ibid,, p. 572; p. 106. 9 Ibid., p. 572; p. 107. 10 Oeuvres, p. 585; Oe. C., t. IV, p. 126. 11 Una registrazione d’epoca, realizzata durante l’Esposizione coloniale del 1931, quella visitata da Artaud, è stata ritrovata. Vedi cat. 106. 12 Oeuvres, p. 589; Oe. C., t. IV, p. 132. 7 4. Antonin Artaud, Un’atletica affettiva13 Bisogna ammettere nell’attore l’esistenza di una sorta di muscolatura affettiva corrispondente alla localizzazione fisica dei sentimenti. L’attore è simile a un vero a proprio atleta fisico, ma con questo sorprendente correttivo: all’organismo atletico corrisponde in lui un organismo affettivo, parallelo all’altro, quasi il suo doppio benché non operante sullo stesso piano. L’attore è un atleta del cuore. Anche per lui vale la divisione dell’uomo totale in tre mondi; e all’attore compete la sfera affettiva. Gli compete organicamente. I movimenti muscolari dello sforzo fisico sono come l’immagine di un altro sforzo, doppio del primo, e nei movimenti dell’azione drammatica si localizzano nei medesimi punti. Là dove l’atleta s’appoggia per correre, l’attore si appoggia per urlare una spasmodica imprecazione, ma la sua corsa è proiettata verso l’interno. Tutti i mezzi della lotta, del pugilato, dei cento metri a del salto in alto trovano analogie organiche nell’esercizio delle passioni; hanno gli stessi punti fisici di sostegno. Però con quest’altro correttivo: qui il movimento è rovesciato e, per quanto si riferisce ad esempio al problema della respirazione, mentre il corpo dell’attore è sostenuto dal respiro, il respiro del lottatore o dell’atleta si sostiene sul corpo. Il problema del respiro è, di fatto, fondamentale; ed è inversamente proporzionale all’importanza dell’azione esterna. Più la recitazione è sobria e contenuta, più il respiro è ampio e denso, sostanziale, sovraccarico di riflessi. Viceversa, a una recitazione impetuosa, gonfia, esteriorizzata, corrisponde una respirazione ad ansiti brevi e schiacciati. È certo che a ogni sentimento, a ogni movimento dello spirito, a ogni sussulto dell’affettività umana, corrisponde un respiro che gli è proprio. Ora i tempi della respirazione hanno un nome che la Cabala ci insegna; sono loro a conferire una forma al cuore umano e un sesso ai movimenti delle passioni. L’attore è soltanto un empirico grossolano, un praticone guidato da un vago istinto. Eppure, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non si tratta di insegnargli a sragionare. Si tratta di farla finita con quella specie di selvaggia ignoranza in mezzo alla quale procede come in una nebbia tutto il teatro contemporaneo, incespicando continuamente. L’attore dotato trova nel proprio istinto di che captare e irradiare certe forze; ma si meraviglierebbe assai se gli si rivelasse che queste forze — che percorrono una traiettoria materiale attraverso gli organi a negli organi — esistono, in quanto non ha mai lontanamente pensato che potessero davvero esistere. Per sfruttare la propria affettività — come un lottatore si serve del suoi muscoli, bisogna considerare l’essere umano come un Doppio, come il Ka delle Mummie egiziane, come uno spettro perpetuo dal quale s’irradiano le forze dell’affettività. Uno spettro plastico e mai totalmente realizzato, di cui il vero attore imita le forme, imponendogli le forme e l’immagine della propria sensibilità. Su questo doppio il teatro esercita la sua influenza, modellando questa effige spettrale; e come tutti gli spettri questo doppio ha la memoria lunga. La memoria del cuore è duratura, ed è certo col cuore che l’attore pensa; ma qui il cuore è preponderante. Questo significa che in teatro, più che in qualunque altro luogo, l’attore deve prender coscienza del mondo affettivo, attribuendo però a questo mondo virtù che non sono quelle di un’immagine, ma comportano un significato materiale. Sia o no esatta questa ipotesi, l’importante è che sia verificabile. Si può ridurre fisiologicamente l’anima a una matassa di vibrazioni. 13 Da Antonin Artaud, Il Teatro e il suo Doppio, Einaudi, Torino 1968, pp. 242-49. Si può vedere questo spettro d’anima intossicato dalle sue stesse grida, altrimenti a che cosa corrisponderebbero i mantra indù, queste consonanze, queste accentuazioni misteriose, dove le nascoste forze materiali dell’anima, braccate sin nelle loro tane, vengono a svelare alla luce i loro segreti. Credere a una fluida materialità dell’anima è indispensabile nel mestiere dell’attore. Sapere che una passione è materia, che è soggetta alle fluttuazioni plastiche della materia, garantisce un dominio sulle passioni che allarga la nostra sovranità. Raggiungere le passioni attraverso le loro forze, anziché considerarle astrazioni pure, conferisce all’attore una maestria che lo eguaglia a un autentico guaritore. Sapere che l’anima ha uno sbocco corporeo permette di raggiungere l’anima in senso inverso; e di ritrovarne l’essenza grazie ad analogie di tipo matematico. Conoscere il segreto del ritmo delle passioni, di questa sorta di tempo musicale che ne regola il battito armonico, ecco un aspetto del teatro cui da tempo il nostro moderno teatro psicologico ha sicuramente cessato di pensare. Questo tempo può essere scoperto per analogia; e lo si ritrova nei sei modi di ripartire il respiro e di conservarlo come un elemento prezioso. Il respiro ha sempre tre tempi, come tre sono i principi alla base di ogni creazione, che nel respiro stesso possono trovare il loro simbolo corrispondente. La Cabala suddivide il respiro umano in sei arcani principali, il primo dei quali, il cosiddetto Grande Arcano, è quello della creazione: ANDROGINO EQUILIBRATO NEUTRO MASCHIO ESPANSIVO POSITIVO FEMMINA ATTRATTIVO NEGATIVO Ho pensato dunque di applicare la conoscenza dei diversi tipi di respiro non soltanto al lavoro dell’attore, ma anche alla sua preparazione tecnica. Se infatti la conoscenza della respirazione illumina il colore dell’anima, a maggior ragione può provocarla, facilitarne l’effusione. È certo che, se il respiro accompagna lo sforzo, la produzione meccanica del respiro svilupperà nell’organismo al lavoro uno sforzo di analoga qualità. Tale sforzo avrà il colore e il ritmo del respiro artificialmente prodotto. Lo sforzo accompagna per simpatia il respiro, e in base alla qualità dello sforzo da produrre, un’emissione preparatoria di respiro renderà questo sforzo facile e spontaneo. Insisto sul termine spontaneo, perché il respiro riaccende la vita, l’infiamma nella sua sostanza. Ciò che il respiro volontario provoca è una riapparizione spontanea della vita. Come una voce nei colori infiniti, ai cui margini dormano dei guerrieri. La campana del mattino o la buccina della guerra suonano per gettarli regolarmente nella mischia. Ma basta che un bambino gridi «al lupo!» ed ecco che gli stessi guerrieri si svegliano. Si svegliano nel cuore della notte. Falso allarme: i soldati s’apprestano a rientrare. Ma no: si imbattono in gruppi ostili, sono caduti in un’autentica imboscata. Il bambino ha gridato in sogno. Il suo inconscio, più sensibile, è incappato fluttuando in un branco di nemici. Nello stesso modo, con mezzi indiretti, la menzogna prodotta dal teatro ricade su una realtà più temibile dell’altra, che la vita non poteva sospettare. Nello stesso modo, con la sensibilità affinata del respiro, l’attore scava la propria personalità. Il respiro che nutre la vita permette infatti di ripercorrerne le fasi gradino per gradino. E un attore può ritrovare attraverso il respiro un sentimento che gli manca, a patto di combinarne giudiziosamente gli effetti, e di non sbagliarsi di sesso. Il respiro infatti è maschio o femmina: meno di frequente è androgino. Ma può trovarsi anche a dover rappresentare qualche preziosa condizione interiore. Il respiro accompagna il sentimento, e si può penetrare nel sentimento attraverso il respiro, purché si sia riusciti a scegliere fra i respiri quello che meglio conviene a un dato sentimento. Esistono, come abbiamo detto, sei combinazioni principali di respiri. NEUTRO NEUTRO MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE NEUTRO NEUTRO FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE MASCHILE MASCHILE FEMMINILE FEMMINILE MASCHILE NEUTRO NEUTRO Un settimo stato, al di sopra del respiro, lo stato di Sattwa, attraverso la porta della Guna superiore, congiunge ciò che è manifestato a ciò che non è manifestato. Se qualcuno poi dovesse dirci che l’attore, non essendo per sua essenza un metafisico, non deve preoccuparsi di questo settimo stato, risponderemo che secondo noi, poiché il teatro è il simbolo perfetto e più completo della manifestazione universale, l’attore porta in sé il principio di questo stato, di questo percorso di sangue attraverso il quale penetra in tutti gli altri, ogni volta che i suoi organi virtuali si destano dal loro sonno. Certo, nella maggior parte dei casi, è l’istinto che supplisce alla mancanza di una nozione che non si riesce a definire; e non è affatto necessario cadere da tali altezze per riemergere fra le passioni medie che abbondano nel teatro contemporaneo. Ma il sistema della respirazione non è fatto per le passioni medie. E non sarà certo una dichiarazione d’amore adultero, a esigere il reiterato esercizio del respiro, secondo un procedimento già più volte sperimentato. È a una qualità sottile del grido, a disperate rivendicazioni dell’anima che può predisporci un’emissione sette o dodici volte ripetuta. E questo respiro va localizzato, va suddiviso in stadi che combinano contrazione a decontrazione. Ci serviamo del nostro corpo come di un crivello attraverso il quale passano la volontà e il rilassamento della volontà. Il tempo di pensare a volere, e noi proiettiamo con forza un ritmo maschio, seguito senza soluzione di continuità troppo sensibile da un prolungato ritmo femminile. Il tempo di pensare a non volere, o anche di non pensare, ed ecco che uno stanco respiro femminile ci fa aspirare una stagnazione da cantina, il fiato madido di una foresta; e su questo stesso ritmo prolungato emettiamo un’espirazione pesante; intanto i muscoli del nostro intero corpo, vibranti per zone muscolari, non hanno cessato di lavorare. La cosa importante è prender coscienza delle localizzazioni del pensiero affettivo. Un mezzo di riconoscimento è lo sforzo, ed i punti su cui poggia lo sforzo fisico sono i medesimi sui quali poggia l’emanazione del pensiero affettivo. Gli stessi servono da trampolino all’emanazione di un sentimento. Bisogna notare che tutto ciò che è femminile, ciò che è abbandono, angoscia, richiamo, invocazione, ciò che tende verso qualcosa in un gesto di supplica, s’appoggia anch’esso sui punti di sforzo, ma come un tuffatore che prenda slancio dal fondo marino per risalire alla superficie: c’e come una proiezione di vuoto, là dove c’era la tensione. Ma in tal caso il maschile torna a incombere sulla sede del femminile come un’ombra; mentre quando lo stato affettivo è maschio, il corpo interno compone una sorta di geometria inversa, un’immagine dello stato capovolto. Prender coscienza dell’ossessione fisica, dei muscoli sfiorati dall’affettività, equivale, come nel gioco dei respiri, a scatenare l’affettivita potenziale, a darle una portata sorda ma profonda e di inconsueta violenza. Risulta così che qualunque attore, anche il meno dotato, può accrescere attraverso questa conoscenza fisica la densità interiore e il volume del suo sentimento, e a questa presa di possesso organica fa seguito una corposa trasposizione. È utile a tal fine conoscere certi punti di localizzazione. L’uomo che solleva pesi, li solleva con le reni, e con una contorsione delle reni sostiene la forza moltiplicata delle braccia; è abbastanza curioso constatare come inversamente ogni sentimento femminile, ogni sentimento che scava — il singhiozzo, la desolazione, l’ansimare spasmodico, la trance — realizzi il suo vuoto all’altezza delle reni, proprio nel punto in cui l’agopuntura cinese libera le congestioni del rene. La medicina cinese procede infatti essenzialmente sul vuoto e sul pieno. Convesso a concavo. Teso rilassato. Yin a Yang. Maschile femminile. Altro punto d’irradiazione: il punto della collera, dell’aggressione, del morso — è il centro del plesso solare. Qui si puntella la testa per lanciare moralmente il proprio veleno. Il punto dell’eroismo e del sublime è quello stesso del senso di colpa. Quello dove ci si batte il petto. Il luogo dove ribolle l’ira, che s’arrovella e non si fa avanti. Ma dove la collera si fa avanti, indietreggia il rimorso: è il segreto del vuoto e del pieno. Una collera acuta e dilacerata comincia con uno strappo neutro e si localizza sul plesso con un vuoto rapido e femminile; poi, bloccata sulle due scapole, si rivolta come un boomerang e sprizza faville maschie che si consumano senza procedere oltre. Per perdere il loro accento mordente conservano la correlazione del respiro maschile: espirano con accanimento. Ho inteso indicare soltanto qualche esempio dei fecondi principi che costituiscono la materia di questa trattazione tecnica. Altri, se ne hanno il tempo, tracceranno l’anatomia completa del sistema. Ci sono nell’agopuntura cinese 380 punti, 73 dei quali, i principali, servono alla terapeutica abituale. Assai meno numerosi sono gli sbocchi rudimentali della nostra umana affettività. E assai meno numerosi i punti d’appoggio che è possibile indicare come base di un’atletica dell’anima. Il segreto consiste nell’esacerbare questi punto d’appoggio, come una muscolatura da mettere a nudo. Il resto finisce in grida. * Per ricostituire la catena, la catena di un tempo in cui lo spettatore cercava nello spettacolo la propria realtà, bisogna permettere a questo spettatore di identificarsi nello spettacolo, in ogni suo respiro e in ogni suo ritmo. Non è sufficiente che lo avvinca la magia dello spettacolo; non lo avvincerà se non si saprà dove prenderlo. Non è più il tempo di una magia aleatoria, di una poesia che non è sostenuta dalla scienza. In teatro poesia a scienza devono ormai identificarsi. Ogni emozione ha basi organiche. E coltivando l’emozione nel proprio corpo l’attore ne ricarica il voltaggio. Sapere in anticipo quali punti del corpo bisogna toccare significa gettare lo spettatore in trances magiche. A questa scienza preziosa la poesia teatrale si è da tempo disabituata. Conoscere le localizzazioni del corpo significa dunque ricostituire la catena magica. E io posso col geroglifico di un respiro ritrovare un’idea di teatro sacro. NB. Non c’e più nessuno che sia capace di gridare, in Europa, e specialmente gli attori in trance non sanno più emettere il proprio grido. Non sanno più fare altro che parlare, in teatro, hanno dimenticato di avere un corpo; e allo stesso modo hanno dimenticato come far funzionare la propria gola. Ridotti a gole anormali : neppure un organo, un’astrazione mostruosa che parla. Perché gli attori in Francia non sanno fare altro che parlare. L’ultimo Artaud (1946-1948) 1. Post-scriptum da Per farla finita col giudizio di dio, edizioni Stampa alternativa, Viterbo, 2001. Traduzione di Marco Dotti. Chi sono? Da dove vengo? Sono Antonin Artaud e che io lo dica come so dirlo immediatamente vedrete il mio corpo attuale andare in frantumi e ricomporsi sotto diecimila aspetti notori un corpo nuovo nel quale non potrete dimenticarmi mai più. 2. Testimonianza di Barrault. Da Jean Louis Barrault. L’homme théâtre..., in Artaud et le théâtre di notre temps, «Cahiers de la Compagnie M. Renaud-J.L. Barrault», Juillard, Mai 1958, pp. 46-48. Nostra traduzione. Il carattere grandioso di Antonin Artaud mi ha sempre colpito. Avevo “assorbito” Charles Dullin fino al punto da assomigliargli. Dovevo subire Artaud in modo identico, fino al mimetismo. Artaud fra l’altro si divertiva molto quando gli facevo la sua imitazione e mi ricordo che un giorno, durante una di queste imitazioni, scappò via completamente esaltato, urlando per strada: «Mi hanno rubato la personalità! Mi hanno rubato la personalità!». Non lo rividi per tre giorni. Ma quando ci siamo ritrovati, abbiamo riso di cuore. [...] Certamente insoddisfatto delle gioie artificiali che il teatro procura, egli trasferì le proprie possibilità teatrali nella vita. Visse il suo personaggio in modo autentico e si consumò con esso. Diventò teatro. La sua vita è una tragedia perfetta. Aveva una fronte straordinaria che portava sempre protesa in avanti come per illuminarsi la strada. Da questa fronte grandiosa spuntavano ciuffi di capelli. I suoi occhi azzurri e penetranti rientravano nelle orbite come per poter scrutare più lontano. Occhi da uccello rapace — da aquila. Il naso sottile e affilato era tutto un fremito... La sua bocca, come l’intero Artaud, si tormentava da sola. La colonna vertebrale era tesa come un arco. Le braccia magre, dalle mani lunghe, come due steli ritorti e forcuti, sembrava volessero dilaniargli il ventre. La voce, che aveva origine nelle cavità più remote, era proiettata verso la testa con una forza talmente inusuale, che veniva a schiantarsi contro i risuonatori della fronte. Era allo stesso tempo sonora e sorda, forte e con rotture improvvise. Era un aristocratico, nel senso profondo del termine. Artaud era un principe. I suoi pensieri erano folgoranti e luminosi. Era un personaggio di fuoco, il figlio stesso di Prometeo. […] Era un personaggio doppio. Da un lato era di una lucidità vertiginosa e di un umorismo divertentissimo. Aveva consapevolezza di tutto, in modo costante e anche in modo allarmante. Consapevolezza di tutto ciò che avveniva, in un dato momento, attorno a lui: a destra, a sinistra, davanti, dietro, vicino, lontano. Captava il Presente in tutti i sensi, con tutti i sensi. Una percezione da occhio di mosca. L’altro Artaud era un personaggio infervorato e appariscente. Dava l’impressione di un motore d’aereo montato su una macchina da turismo. Senza calmanti, Artaud esplodeva da tutte le parti. Era di una bellezza regale. Era capace di conquistare. Naturalmente io divoravo: Il teatro e la peste – Il teatro della crudeltà – e i vari testi che la N.R.F. aveva appena riunito sotto il titolo Il teatro e il suo doppio. Il teatro e il suo doppio è senza dubbio la cosa più importante sul teatro scritta nel XX secolo. [...] Artaud era prima di tutto un poeta. Era uno scrittore meraviglioso, si sa; ma era anche un attore. E ha sempre recitato da poeta. Aveva recitato con Dullin agli inizi dell’Atelier. Un giorno, in un lavoro che Dullin stava mettendo in scena e in cui Artaud doveva interpretare il ruolo dell’imperatore Carlomagno, ecco che nel corso di una prova, Artaud avanza verso il trono a quattro zampe. Dullin temeva Artaud e diffidava delle sue reazioni. Tuttavia questo salire sul trono a quattro zampe gli sembrava... un po’ troppo... stilizzato. Quindi con molta calma cerca di dissuadere Artaud da questa interpretazione e tenta di indirizzarlo verso una stilizzazione più verosimile, ma di colpo Artaud si rialza, si mette dritto, le braccia alzate in verticale, l’aria da imperatore, e replica: «Ah! se voi lavorate nel campo della verità! Allora!...». 3. Testimonianza di Dullin. Charles Dullin. Lettera a Roger Blin del 12 aprile 1948, pubblicata in K revue de la poesie, Parigi 1-2 giugno 1948, per commemorare la morte di Artaud. Ricordo di Artaud giovane. Nostra traduzione. [...] Ancora prima della fondazione dell’“Atelier”, a rue Honoré Chevalier, dove io avevo aperto la scuola, Artaud viveva della nostra vita comune. A volte la sua originalità faceva fatica a piegarsi al lavoro di squadra che ci era imposto dalle stesse condizioni dell’esistenza. Malgrado il suo collo di camicia sempre senza bottone, tenuto a posto a fatica da uno straccio di cravatta mal annodato, e malgrado il resto dei suoi abiti molto trascurati, un certo lato dandy gli proibiva per esempio di mettersi con noi alla carriola che trasportava le nostre scene e i nostri costumi dalla rue Honoré Chevalier alla rue des Ursulines. Ci seguiva a distanza un po’ vergognoso. A parte ciò era di un impegno e di una docilità nel lavoro, esemplari, salvo in quello che riguardava gli esercizi meccanici di dizione ai quali si sottraeva energicamente. Adorava i nostri lavori d’improvvisazione e vi contribuiva con una immaginazione da vero poeta. Mentre io ero attirato dalla tecnica dei teatri orientali, lui era in questo senso già molto più avanti di me e dal punto di vista pratico questo diventava talvolta pericoloso, quando per esempio ne Il piacere dell’onestà di Pirandello, dove recitava un uomo d’affari, mi arrivava in scena con un trucco ispirato alle piccole maschere di cui si servono come modello gli attori cinesi, trucco simbolico che si trovava leggermente fuori posto in una commedia moderna. 4. Scritto di Artaud dal quaderno 211, 4 e 5 febbraio 1947, pubblicato in Les Temps Modernes, n. 40, février 1949, ora in A. Artaud Oeuvres, a cura di E. Grossman, Gallimard, Paris, 2004, p. 1185, traduzione nostra. Ricordo di un’esperienza di elettroshock. Nostra traduzione. […] Sono morto a Rodez sotto un elettroshock. Dico morto. Legalmente e clinicamente. Il coma da elettroshock dura un quarto d’ora, una mezz’ora circa. E poi il malato respira. Bene, un’ora dopo lo shock non mi ero ancora risvegliato e avevo smesso di respirare. Sorpreso dalla mia anomala rigidità un infermiere era andato a cercare il primario, il quale dopo avermi auscultato non trovò più in me alcun segno di vita. – Io ho dei ricordi della mia morte in quel momento, ma non è su di essi che mi baso per denunciare il fatto. Mi attengo scrupolosamente alle informazioni che mi furono date dal dottor Jean Dequeker, giovane interno alla clinica di Rodez che le apprendeva dalla bocca dello stesso dottor Ferdière. E costui gli disse che quel giorno mi aveva creduto morto, e che aveva già fatto chiamare due guardiani dell’ospedale per dar loro ordine di trasportare il mio corpo alla camera mortuaria perché un’ora e mezzo dopo lo shock non ero ancora tornato in me. – E sembra che sia stato proprio nel momento in cui gli infermieri entrarono per portar via il mio corpo che questo ebbe un impercettibile sussulto, dopo di che, di colpo, mi risvegliai. Io però ho un altro ricordo della cosa. – Ma questo ricordo l’ho conservato per me, segreto, fino al giorno in cui il dottor Jean Dequeker, da testimone esterno, mi confermò il fatto. E questo ricordo è che tutto ciò che il dottor Jean Dequeker mi raccontò io l’avevo visto non da questo lato del mondo ma dall’altro, e precisamente dalla cella in cui aveva avuto luogo lo shock, e sotto il suo soffitto, benché a momenti per me non ci fossero né cella né soffitto, ma da un metro circa al di sopra del mio corpo, nell’aria, come una specie di mongolfiera fluidificata che si teneva in equilibrio fra il mio corpo e il soffitto. E certo non dimenticherò mai in nessuna delle vite possibili l’orribile varco di questo sfintere repellente e asfissiante attraverso il quale la massa criminale degli esseri impone all’agonizzante di passare prima di restituirgli la libertà. Al capezzale di un morente ci sono più di diecimila esseri e me ne sono reso conto in quel momento. 5. Maurice Saillet, articolo sulla serata al Vieux-Colombier, «Combat», 24 gennaio 1947, Oeuvres, cit. p. 1190. Nostra traduzione. Tutto questo si svolgeva al teatro del Vieux-Colombier, lunedì 13 gennaio 1947 alle 21. Gran ressa all’entrata; gli amici conosciuti e sconosciuti di Antonin Artaud, non sapendo di essere così numerosi, avevano per lo più dimenticato di prenotare. Correva voce che Gide e Breton, invitati dal poeta, se ne fossero andati per mancanza di posti. Li si rivide, però, all’interno, l’uno in prima fila, l’altro piuttosto indietro, su uno strapuntino. In totale quasi novecento persone — di cui duecento in piedi, e talvolta su un piede solo — riuscirono a entrare nella piccola sala. La seduta durò fino a mezzanotte, in un silenzio opprimente [...]. Quando entrò in scena, con quel suo viso smagrito e devastato, che evoca allo stesso tempo quello di Baudelaire e quello di Edgar Poe; quando le sue mani nervose presero a volare come uccelli attorno al viso, e a frugare senza sosta quel viso; quando si mise a declamare con voce rauca, interrotta da singhiozzi e balbettamenti tragici, i suoi bei poemi, appena udibili — ci sentimmo trascinati in una zona pericolosa e come rispecchiati da questo sole nero, vinti dalla “combustione generalizzata” di un corpo in preda alle fiamme dello spirito. [...] Dopo la lettura drammatica dei suoi poemi, Antonin Araud raccontò della sua vita con un tono da conversazione. La storia del suo viaggio a Dublino e del suo arresto non ci persuasero affatto. E l’episodio inedito del viaggio presso i Tarahumara non sembrò certo all’altezza di quello pubblicato. Rianimò la nostra attenzione descrivendo una straordinaria esperienza di sdoppiamento e i tormenti dell’elettrochoc: “E quando ci si risveglia, si è incapaci di ritrovare il proprio io, la vita si è abbassata di una tacca e si è perduta una buona parte dell’euforia originaria.” Parlò anche dei sortilegi, ma poiché le sue rivelazioni cadevano nel vuoto, fece appello pateticamente a che si condividesse “almeno” la sua credenza. Gli capitò anche di interrompersi e di perdere il filo del racconto: “Mi metto al vostro posto, e mi rendo conto benissimo che tutto quello che dico non è affatto interessante. È ancora teatro. Come fare per essere veramente sinceri?” Questo stato di sincerità totale, fisiologica, lo ritrovò leggendo il suo poema sull’Incondizionato, è la derisione di ciò che noi chiamiamo pomposamente la nostra “condizione umana”, e che non cessa di minacciarci. Perché noi siamo una barca alla deriva, che pensa di raggiungere il porto, che sogna di essere al riparo, ma che può essere solo in mare aperto, alla mercè dell’incondizionato. Antonin Artaud ci gettava in faccia i magnifici brani del suo testo e la parola “carnaccia”, che ci riguardava, colpiva duro. Questa straziante lezione di umiltà terminava il nostro incontro con colui che un tempo scriveva a Jacques Rivière: “Posso dire, io, davvero, di non essere al mondo e non si tratta di un semplice atteggiamento dello spirito.” 6. Brano di una lettera di Artaud a André Breton, attorno al 1° marzo 1947, pubblicata in «L’Ephémère”, n. 8, hiver 1968, ora in A. Artaud Oeuvres, a cura di E. Grossman, Gallimard, Paris, 2004, pp. 1207-18. Nostra traduzione. Caro amico, voi mi avete aspramente rimproverato la seduta del Vieux-Colombier che era la prima occasione che avevo trovato per dire il fatto suo al pubblico di una società che mi aveva tenuto internato 9 anni, fatto demolire dalla sua polizia la colonna vertebrale a sprangate, fatto colpire con due coltellate nella schiena da dei protettori, arrestato e messo in prigione, deportato, fatto aggredire su una nave, tenuto tre anni in isolamento durante i miei primi tre anni d’internamento, fatto avvelenare sistematicamente per cinque mesi in uno dei suoi asili per alienati (quello di Sotteville-lès-Rouen, ottobre 1937-marzo 1938). Per fare questo è forse vero che ho riunito della gente in un teatro, ma dire, come dite voi nella vostra lettera, che restavo uomo di teatro, per il solo fatto che comparivo su un palcoscenico, è un’ingiustizia gratuita perché io credo, per quanto possa esserci della vanteria nel dirlo, che nessun uomo di teatro, da che il teatro esiste, abbia mai assunto, prima di me, l’atteggiamento che ho tenuto quella sera sulla scena del Vieux-Colombier, e che è consistito nello sbraitare su un palcoscenico delle eruttazioni piene d’odio, coliche e crampi al limite della sincope, ecc., ecc. Oltre a riunire delle persone in una sala, mi restava anche di lanciare invettive a questa società nella strada, ma è difficile, perché le strade sono piene solo di passanti frettolosi, e per invitarli ad ascoltare ci vogliono le barricate e le bombe, ma come è possibile che non abbiate notato che sulla scena del Vieux Colombier anch’io mi sono reso conto dell’inutilità del mio tentativo e che rinunciando a leggere il discorsetto che mi ero preparato ho fatto fagotto e sono partito, gettando al pubblico l’ultima strofa di un poema: tous les exercices de la yoga ne valent pas les desquamations du con d’une moniche morte quand la boniche qui le porte pisse en écartelant son pis pour traverser la syphilis perché tutt’a un tratto mi sono reso conto che era passato il tempo di riunire gente in un teatro, anche per dirle delle verità e che con la società e il suo pubblico non c’è più altro linguaggio che quello delle bombe, delle mitragliatrici, delle barricate e di tutto quel che segue. Ma come, André Breton, dopo tutto questo e dopo avermi rimproverato la mia apparizione in un teatro, mi invitate a partecipare a un’esposizione, in una galleria d’arte iper-chic, ultra-fiorente, rinomatissima, capitalista (ha avuto dei fondi da una banca comunista) e in cui qualunque manifestazione non può più avere altro carattere che quello stilizzato, limitato, angusto, fisso di un tentativo d’arte. In una galleria si vende pittura, si comprano quadri, è un luogo di commercio, come quelli dei Gesuiti nelle Indie o quello di Lally Tollendhal, gli oggetti esposti sono messi in casse (nella bara) o in vetrine, in incubatrici, non è più vita; tutti gli snob vi si danno appuntamento, come, ahimè, all’Orangerie si sono dati appuntamento davanti a Van Gogh che avrebbe meritato ben altra sorte. Perché non c’è niente che metta al tappeto la cosmografia, l’idrografia, la demografia, la scienza delle eclissi, degli equinozi e delle stagioni come un dipinto di Van Gogh. No, non posso assolutamente partecipare a una esposizione, e soprattutto in una galleria, tanto più che nel vostro progetto c’è un’ultima cosa che mi ha fatto trasalire d’orrore: questo parallelismo dell’attività surrealista con l’occultismo e la magia. — Io non credo più a nessuna nozione, scienza o conoscenza e soprattutto a una scienza occulta. Della natura e delle cose ho una mia idea personale, che non assomiglia per niente a quella di chiunque altro e non ammetto che delle civiltà, delle nazioni, delle religioni e delle culture vengano a scocciarmi con le loro concezioni e vengano a dirmi: sulla natura profonda del caos e della cacofonia dell’ingiustizia e del crimine del creato, ecco cosa è stato trovato dai tuoi padri antenati e ciò che è, pensa, sotto il giogo dello Zodiaco dalle dodici case. [...] Io ho le mie idee sulla nascita, la vita, la morte, la realtà e il destino e non ammetto che mi se ne imponga o suggerisca nessuna, perché non condivido nessuna delle idee generali sulle quali potrei avere con qualcun altro l’occasione di incontrarmi. Voi avete dunque suddiviso questa esposizione in 15 sale, ciascuna con un altare, sul modello, a quel che dite, dei culti Vudù o Indiani, e rappresentando i 15 gradi o tappe di una completa iniziazione. È qui che tutta la mia fisiologia si ribella perché non vedo cosa ci sia al mondo a cui si possa essere iniziati. Ogni esperienza è assolutamente personale, e l’esperienza di un altro non può servire a nessuno al di fuori di lui se non si vogliono creare quei sordidi pulviscoli di alter ego che compongono tutte le società viventi e in cui tutti gli uomini sono fratelli, in effetti, perché abbastanza codardi, abbastanza poco fieri per desiderare di essere usciti da qualcosa di diverso che una stessa, identica figa, da simili coglione, dalla stessa insostituibile e disperante coglioneria, che si fa presto a conoscere, perché tutti, dalla nascita, sono costretti a pensare la stessa cosa sul più gran numero di questioni. Un bel modo, d’altronde, di perdere la realtà autentica, l’universale, per confinarsi nella conoscenza di un particolarismo da castrati e da pedanti che riguarda un numero molto limitato di individui. Inoltre penso che non ci sia una realtà universale, un assoluto da conoscere al quale si debba essere condotti, cioè iniziati. Le iniziazioni non hanno mai sortito altro risultato che di rinchiuderci in questi ignobili ersatz yo ana ka nemkon nestrura kom nestrura kahuna di esplicitazione di un meccanismo cosmico che non esiste, e di rivelazione di un sedicente segreto di pulcinella custodito gelosamente sotto le defecazioni di solenni sbruffoni che hanno vissuto solo delle loro menzogne e dell’ingenuità dei gonzi che li seguivano. Non c’è nessun cosmo e ogni uomo è un mondo a sé, a lui dunque spetta iniziarsi, facendolo vivere, cioè creandolo con braccia, mani, piedi e col soffio della sua personale e inespugnabile volontà. [...] 7. Antonin Artaud, Cinquanta disegni per assassinare la magia, L’Obliquo, Brescia, 2002, traduzione di Carlo Pasi. Non si tratta di disegni nel senso proprio del termine di una qualsiasi incorporazione della realtà attraverso il disegno. Essi non sono un tentativo per rinnovare l’arte a cui non ho mai creduto del disegno no ma per comprenderlo bisogna dapprima collocarlo sono 50 disegni presi da quaderni di note letterarie, poetiche, psicologiche, magiche, magiche soprattutto magiche innanzitutto e sopra di tutto. Sono dunque mescolati a delle pagine sdraiati su delle pagine dove la scrittura tiene il primo piano della visione, la scrittura, la nota febbrile, effervescente, ardente la bestemmia l’imprecazione. D’imprecazione in imprecazione queste pagine avanzano e come dei corpi di sensibilità nuovi questi disegni eccoli qua che li commentano, li arieggiano e li rischiarano Non sono disegni non raffigurano niente, non defigurano niente, non sono lì per costruire edificare istituire un mondo perfino astratto. Sono delle note, delle parole, dei trumeau. poiché ardenti, corrosivi, incisivi, scaturiti da non so quale turbinio di vetriolo sotto mascellare, sotto spatulare, sono lì come inchiodati e destinati a non più muoversi. Trumeau dunque ma che faranno la loro apocalisse poiché ne hanno troppo detto per nascere e troppo detto nascendo per non rinascere e prender corpo allora autenticamente. Ma tutto ciò non sarebbe niente se ci si dovesse attenere, non uscire dalla pagina scritta poi illustrata dalla luce come vacillante di questi disegni i quali non vogliono dire niente e non rappresentano assolutamente niente. Per capire questi disegni integralmente bisogna 1° uscire dalla pagina scritta per entrare nella realtà ma 2°uscire dal reale per entrare nel surreale, l’extra-reale, il sovrannaturale il soprasensibile dove questi disegni non cessano di tuffarsi perché provengono e non sono infatti che il commento d’un’azione che ha avuto realmente luogo, che la figurazione sulla carta circoscritta da uno slancio che ha avuto luogo e ha prodotto magneticamente e magicamente i suoi effetti, e perché essi non sono questi disegni la rappresentazione o la figura d’un oggetto d’uno stato di testa o di (cuore), d’un elemento e d’un avvenimento psicologico, sono puramente e semplicemente la riproduzione sulla carta d’un gesto magico che io ho compiuto nello spazio vero con il respiro dei miei polmoni e le mie mani, con la mia testa e i miei 2 piedi con il mio tronco e le mie arterie ecc,Quando scrivo, io scrivo di solito una nota d’un colpo solo ma ciò non mi basta, e cerco di prolungare l’azione di quello che ho scritto nell’ atmosfera, allora mi alzo cerco delle consonanze, delle adeguazioni di suoni, dei dondolamenti del corpo e delle membra che diano atto, che chiamino gli spazi ambienti a sollevarsi e a parlare poi mi avvicino alla pagina scritta e …….. ma dimenticavo di dire che queste consonanze hanno un senso, io soffio, canto, modulo ma non a caso no io ho sempre come un oggetto prodigioso o un mondo da creare e da chiamare. Ora io conosco il valore plastico oggettivo del soffio, il soffio è qualcosa nell’aria non è dell’aria mossa solamente, è una concretizzazione della massa nell’ aria e che deve essere sentita nel corpo e con il corpo come un agglomerazione in somma atomica d’elementi e di membra che in quel momento fanno quadro. Una materia molto aldilà di quella dello zucchero d’orzo nasce in quel momento istantaneamente nel corpo, materia elettrica che potrebbe spiegare se fosse essa stessa esplicabile la natura di certi gas atomici di certi atomi repulsivi. Dico atomi come se dicessi pezzo di muro, parete vulcanica, arteria in fusione di un vulcano, muraglia di lava in marcia verso un rovesciamento del l’immediato divenire, i miei disegni dunque riproducono queste forme così apparse, questi mondi di prodigi, questi oggetti dove la Via è fatta e ciò che chiamiamo la Grande Opera alchemica ormai polverizzata poiché noi non Non siamo più nella chimica ma nella materia e io credo proprio che la materia parlerà Antonin Artaud 31 gennaio 1948 8. Lettera a Paule Thévenin del 24 febbraio 1948, da Per farla finita col giudizio di dio, cit. martedì 24 febbraio 1948 Paule, sono tristissimo e disperato. Il corpo mi duole da tutte le parti, ma soprattutto ho la sensazione che gente sia rimasta delusa dalla mia trasmissione. Là dove c’è la macchina c’è sempre l’abisso e il nulla, c’è sempre una interposizione tecnica che deforma e annichilisce quanto è stato fatto. Le critiche di M. e di A.A. sono ingiuste ma hanno la propria origine da un errore di trasposizione, ecco perché non toccherò mai più la Radio e mi consacrerò ormai esclusivamente al teatro così come lo concepisco un teatro di sangue, un teatro che ad ogni rappresentazione avrà fatto guadagnare corporalmente qualcosa tanto a colui che recita quanto a colui che vede recitare, del resto non si recita si agisce. Il teatro in realtà è la genesi della creazione. […] 9. Artaud, Aliéner l’acteur, quaderno 298, maggio 1947, in «L’Arbalète», n. 13, estate 1948, poi in A. Artaud, Oeuvres, a cura di E. Grossman, Gallimard, Paris, 2004, pp. 1520-23. Nostra traduzione. Il teatro è lo stato, il luogo, il punto, in cui afferrare l’anatomia umana, e attraverso di essa guarire e dettar legge alla vita. Sì, la vita coi suoi slanci, i suoi nitriti, i suoi borborigmi, i suoi buchi vuoti, i suoi pruriti, i suoi rossori, i suoi arresti, i suoi maelström sanguinolenti, le sue stizzose precipitazioni di sangue, i suoi cambi d’umore, le sue riprese, le sue esitazioni. Tutto questo si discerne, si trova, si scruta e si mette in luce su ogni parte del corpo umano, ed è mettendo in attività, o meglio in un’attività parossistica, un certo numero di membra, come le membra di quel formidabile feticcio animato che è l’intero corpo di un attore completo, che si può vedere, come messa a nudo, la vita, nella trasparenza, nella presenza delle sue forze primigenie, dei suoi poteri inutilizzati, e che non sono ancora serviti, no, non sono ancora serviti, a correggere una creazione anarchica, di cui il vero teatro era nato per riassestare le irascibili e impetuose gravitazioni. — Sì, la gravitazione universale è uno scisma, una terribile precipitazione passionale che si corregge sulle membra di un attore non in stato di frenesia né di isteria, né di transe, ma all’ultimo filo tagliente della lisca, all’ultima e più estrema parte della misura parietale del suo sforzo. Parete dopo parete, l’attore sviluppa, apre o richiude dei muri, delle facciate passionali e sovranimate di superfici in cui s’inscrive la furia della vita. Muscolo dopo muscolo sul corpo dell’attore traumatizzato con metodo, si può cogliere lo sviluppo degli impulsi universali e su di lui correggerli. [...] Sì, l’uomo ebbe bisogno, a un certo punto, di un corpo-scheletro nuovo, che crepitò e si insinuò nell’aria come le fiamme furtive di un focolare. E il teatro era questa forza che faceva burro [burrificava] dell’anatomia umana, questa incandescenza di un fuoco innato dal quale furono sgranati gli scheletri originari, questa forza d’umore esplosiva, questa specie di tumore collerico in cui si fuse lo scheletro primigenio. E attraverso l’agitarsi ritmico di tutti gli scheletri evocati, la forza innata del teatro cauterizzava l’umanità. / Ed era là che l’uomo e la vita venivano, di tanto in tanto, a farsi rifare. [...]
Scarica