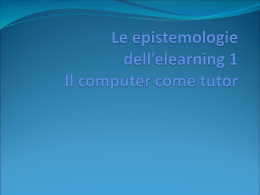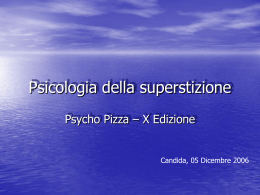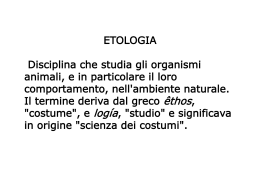SECONDO INCONTRO METODOLOGICO Storia delle idee e interdisciplinarità Giovani studiosi a confronto Torino, 15/05/2012 Sara Miglietti (Scuola Normale Superiore, Pisa) IL PROBLEMA DELLA VOLONTÀ D’AUTORE tra filologia, ermeneutica filosofica e storia delle idee: riflessioni a margine di un’edizione di Bodin Sono molto grata alla prof.ssa Albertone, al prof. Pasini, al prof. Adamo e agli amici del Gruppo Interdisciplinare per avermi offerto quest’occasione di confronto e discussione. Nel mio intervento vorrei proporre alcune riflessioni nate nel corso delle mie ricerche di dottorato, mentre lavoravo intorno al concetto di “volontà d’autore” tentando soprattutto di individuare un metodo efficace per lo studio evolutivo di testi filosofico-politici. Per la mia tesi mi sono occupata della Methodus di Jean Bodin, il più importante pensatore politico francese del XVI secolo, meglio noto per i Six livres de la République. La Methodus è una sua opera giovanile: la prima edizione uscì a Parigi nel 1566, dieci anni prima della République, di cui peraltro anticipava numerose idee. Nel 1572, sei anni dopo la prima edizione, ne uscì presso il medesimo stampatore una seconda, che era frutto di una revisione integrale. Confrontando le due re dazioni dell’opera si scopre in effetti un cospicuo numero di varianti che nessuno ha mai studiato finora; a dire il vero, nessuno si era ancora occupato di portarle alla luce, sebbene molti fossero già al corrente della loro esistenza. Per colmare questa lacuna ho quindi realizzato un’edizione critica della Methodus collazionando i testi delle prime due edizioni, le uniche direttamente supervisionate e autorizzate da Bodin. In un secondo tempo mi sono concentrata sulle varianti per ef fettuare uno studio evolutivo del pensiero di Bodin nel decennio 1566-1576, ossia negli anni che portano dalla Methodus alla République. Come gli studiosi sanno da tempo, nel corso di quel decen1 nio si compì uno spettacolare rovesciamento delle concezioni politiche di Bodin: dalla Methodus egli emerge ancora come un tradizionale sostenitore di una monarchia limitata da un certo nume ro di consuetudini e di freni costituzionali, nonché tenuta al rispetto delle leggi positive; nella République, invece, si trova formulata quella concezione originale della sovranità indivisibile e absolue, cioè sciolta dall’obbedienza a consuetudini e leggi civili, per cui Bodin resterà famoso nella storia del pensiero politico. Che cosa può esser successo nel corso di quel decennio per indurlo a un ripensamento così radicale? Verso la fine del mio intervento tornerò su questo interrogativo per illustrare il punto di vista che ha dominato la critica fino ad oggi, e per avanzare un’ipotesi al ternativa, cui sono approdata proprio attraverso lo studio delle varianti tra le due redazioni della Methodus. Per ora mi soffermerò su alcune questioni metodologiche emerse nel corso del mio lavoro, e sulle quali mi piacerebbe raccogliere i vostri commenti. Il mio obiettivo, come ho detto, era quello di realizzare un’edizione critica di un testo ricco di contenuti politici e caratterizzato da una complessa storia evolutiva. Obiettivo duplice, quindi, critico-editoriale da un lato ed ermeneutico dall’altro: in primo luogo, infatti, si trattava di stabili re il testo critico in conformità alla tradizionale prassi filologica; bisognava poi chiedersi perché Bodin avesse sentito l’esigenza prima di scrivere e poi di riscrivere la Methodus, e che ruolo essa svolgesse nell’economia generale del suo pensiero. Se in sede critico-editoriale la mia adesione alle tecniche della bibliografia testuale (definita da Philip Gaskell come quella branca della filologia che si occupa dell’edizione critica di testi a stampa) era in un certo senso obbligata dalla natu ra stessa del mio lavoro, in sede interpretativa mi si offriva la libertà di scegliere l’approccio che ritenevo più efficace. Ho contratto un debito particolarmente forte con l’ermeneutica storico-filosofica di Quentin Skinner: mi convinceva infatti la sua scelta di trattare i testi politici come azioni verbali o atti linguistici (speech-acts), sulla scia della filosofia di Austin. (Sarei meno incline ad adottare indiscriminatamente l’approccio skinneriano per ogni sorta di produzione testuale, come lo stesso Skinner si dichiara invece pronto a fare). Conformemente a questo metodo, mi riproponevo di studiare il significato della Methodus in relazione al suo contesto storico e culturale, per capire quali effetti Bodin potesse avere avuto intenzione di produrre nello scriverla; mi riproponevo inoltre di studiare l’evoluzione interna del pensiero bodiniano attraverso un’analisi accurata degli scarti linguistici presenti tra le due redazioni dell’opera. Il mio tentativo di coniugare approccio testuale filologico e approccio contestuale skinneriano si è subito scontrato con una prima difficoltà. Sarebbe naturalmente utopistico pensare di po ter scindere nettamente le due fasi del lavoro – quella critico-editoriale e quella interpretativa – dal momento che nel ricostruire un testo si dispiega già, più o meno consapevolmente ma sempre in misura maggiore di quanto sarebbe forse auspicabile, una certa interpretazione del testo stesso, e a sua volta la ricostruzione del testo reagisce sulle fasi ulteriori del processo ermeneutico. L’integrazione tra i due approcci doveva quindi avvenire nella forma non di un’alternanza discipli nare (discipline diverse che intervengono in momenti diversi per effettuare operazioni diverse), ma in quella di un’alleanza multidisciplinare che fondesse sistematicamente tecnica filologica e processo ermeneutico. A un simile approccio multidisciplinare si opponeva però il fatto che gli strumenti concettuali di cui fanno uso bibliografia testuale e storia delle idee skinneriana, pur es sendo apparentemente molto simili, sono carichi in realtà di implicazioni diverse, se non addirittura incompatibili. Emblematico in tal senso è il concetto di intenzione, vera chiave di volta tanto della pratica filologica che del metodo ermeneutico di Skinner. Lo scopo dell’attività critico-editoriale consiste 2 nella ricostruzione di un testo critico, un testo cioè che “riflette le intenzioni dell’autore con più esattezza di qualsiasi testo particolare esistente” (Tanselle 1980). Quando gli editori critici si trovano alle prese con opere di cui esistono più edizioni, le quali si distinguono per un numero più o meno cospicuo di varianti (da una singola parola a intere frasi, paragrafi o capitoli), sorge il problema di quale redazione l’editore debba ragionevolmente scegliere come base del proprio testo critico: la più antica? la più recente? la più completa? la più diffusa, ovvero quella che ha maggior mente condizionato la ricezione dell’autore? Pur non esistendo un criterio rigido e valido in tutti i casi, si è soliti scegliere come testo-base l’ultima edizione licenziata in vita dall’autore, in quanto si ritiene che il fine di ogni editore critico sia, parafrasando Greg, la ricostruzione di un testo che rappresenti “l’ultima volontà dell’autore circa la forma in cui l’opera doveva essere presentata al pubblico” (Greg 1966). Per questo si tende senz’altro ad accettare tutte le varianti introdotte nelle edizioni più recenti, purché queste siano direttamente ascrivibili all’autore. In altre parole, vige in genere la prassi di considerare l’ultima edizione licenziata in vita dall’autore come l’edizione “definitiva”, quella che invera e rende così virtualmente superflue tutte le edizioni precedenti. Ora, mi pare che questo presupposto fondamentale della bibliografia testuale si porti dietro, per lo più inconsapevolmente, una filosofia implicita secondo cui la revisione di un testo sarebbe testimonianza di un indefesso lavorio migliorativo da parte dell’autore, affaccendato a limare la sua opera, a perfezionarla, a renderla sempre più conforme alle sue intenzioni iniziali. Si presuppone cioè che l’autore abbia fin dal principio una chiara idea dell’Opera che intende realizzare, e che la revisione sia motivata da un desiderio di approssimarsi sempre di più all’Idea nell’atto della sua concreta realizzazione. Da questo punto di vista, il risultato finale (cioè lo stato che si suppone incarnare “l’ultima volontà d’autore”) costituisce non solo il perfezionamento, ma l’inveramento del principio, mentre tutti gli stati precedenti vengono sbrigativamente liquidati come tentativi imperfetti, resi ormai superflui dall’Opera finita. Esporre in apparato le varianti risalenti a stati precedenti ha certamente lo scopo tecnico di documentare la stratigrafia interna del testo e/o di rivelare eventualmente i punti in cui l’editore si è permesso un intervento critico; ma nel fatto di promuovere a testo le varianti appartenenti allo stato “che incarna l’ultima volontà dell’autore”, relegando invece in apparato tutte le altre, si può anche vedere, io credo, un’operazione latentemente teleologica: una tendenza a consacrare il prodotto finale come intrinsecamente preferibile – perché più “certo”, più “riuscito”, più “autentico”, più “vero” - rispetto a tutti quelli che lo han no preceduto. Nel senso più debole, si tende a considerare l’ultima edizione licenziata dall’autore come la più “certa” o la più affidabile, in quanto si suppone che l’autore l’abbia ripulita da eventuali errori di stampa e/o interventi tipografici non autorizzati, provvedendo inoltre a rettificare errori sostanziali dipendenti dalla sua precedente ignoranza (per esempio date, nomi, ecc.). In questo senso si può essere d’accordo che l’ultimo testo licenziato dall’autore rappresenti un oggettivo miglioramento rispetto alle redazioni precedenti e che sia dunque ragionevole assumerlo come testo-base; anche se occorre ammettere che gli stessi errori ci rivelano spesso molte cose interessanti intorno ai loro autori, e vale la pena di non liquidarli troppo in fretta come semplici elementi deteriori di un testo. Il teleologismo potenzialmente connesso al concetto di “ultima volontà dell’autore” appare più evidente quando si accorda una preferenza alla redazione più tarda in base all’idea che essa rappresenterebbe il momento in cui l’autore, dopo lungo e tormentato percorso, ha raggiunto uno stato di pieno appagamento nei confronti della sua opera (appagamento che si dà per scontato non sussistere fino a quel momento, altrimenti perché l’autore si sarebbe 3 affaticato a tornare sul suo lavoro?). Solo nell’ultima redazione – l’edizione “definitiva” - l’autore sarebbe finalmente riuscito a esprimere il suo pensiero in modo completamente autentico e artisticamente riuscito. Questo approccio mi pare molto insoddisfacente, non solo perché pretende di razionalizzare a posteriori e in ottica teleologica il processo di revisione editoriale di un autore, ma anche perché si danno numerosi casi di revisioni che hanno prodotto versioni indubbiamente meno “autentiche” di quelle originali: si pensi soltanto alle autocensure o alle “correzioni d’auto re coatte” studiate da Luigi Firpo (1961). In altre parole, non sempre quello che viene dopo è preferibile a ciò che viene prima, ma occorre giudicare caso per caso. (D’altronde, proprio a partire da considerazioni analoghe uno dei principali esponenti della bibliografia testuale, G.T. Tanselle, ha sferrato un potente “inside attack” al doppio concetto di volontà d’autore e di testo-base: cfr. Tanselle 1976 e 1994). Ancora più insoddisfacente mi pare poi la concezione secondo cui l’ultima reda zione sarebbe preferibile alle precedenti in quanto più “vera” - intendendo questa parola in senso forte, epistemologico. La tentazione di scartare a priori questa concezione sarebbe forte, se solo essa non fosse ancora notevolmente diffusa in alcuni campi della storia intellettuale – in particolare tra gli storici della scienza, parte dei quali continua tuttora a parlare di un progresso costante e irreversibile retto da una razionalità interna e scandito da grandi “scoperte”. Mi pare dunque che il concetto d’intenzione che sostiene la pratica della bibliografia testuale sia, per il suo latente teleologismo, strutturalmente inadatto a pensare l’evoluzione del pensiero di un autore in modo veramente adeguato. Fin tanto che si associa il lavoro critico-editoriale a una missione di ricostituzione dell’ultima volontà dell’autore, ci si condanna a squalificare tutti gli stadi intermedi tra la princeps e l’ultima edizione licenziata in vita dall’autore come semplici gradini di una scala che possiamo “wittgensteinianamente” buttare giù una volta che siamo arrivati in cima. Ed è un peccato che sia così perché la filologia, attirando la nostra attenzione sull’importanza delle varianti e dotandoci di tecniche utili a gestirle, potrebbe darci e anzi ci dà tutti gli strumenti necessari a studiare l’evoluzione del pensiero dei nostri autori. A patto che ci li beriamo delle latenti implicazioni filosofiche del suo concetto di “ultima volontà d’autore” e assumiamo come sfondo della nostra indagine un’altra prospettiva. E’ qui che, con qualche significativa limitazione su cui tornerò più avanti, il metodo ermeneutico di Quentin Skinner può fornire un utile correttivo. Quella stessa tensione tra le due metodologie che mi sembrava inizialmente rappresentare una difficoltà si è quindi, in ultima analisi, rivelata salvifica per il mio lavoro. La proposta di Skinner di trattare i testi politici “as elements in a wider discourse, whose contents change with changing circumstances” (Skinner 2002 : 5-6) permette a mio avviso di mantenere l’intenzione dell’autore al centro dell’attenzione, senza cadere però nella trappola teleologica, bensì restituendo agli stadi intermedi della storia di un testo tutto il valore autonomo che meritano. Per Skinner, infatti, l’intenzione dell’autore non si esercita in relazione a un’idea astratta dell’opera che lui o lei intende realizzare, ma in relazione a un contesto storico e linguistico ben determinato su cui lui o lei intende agire. Grazie a questa torsione totale del concetto di intenzione, l’approccio skinneriano ci permette di concepire i vari stadi della storia di un testo come altrettante reazioni a un contesto in mutamento, o come altrettanti tentativi di modificare un contesto che resiste ai cambiamenti ritenuti desiderabili dall’autore. In questo senso, ogni fase della storia di un testo ha il suo significato e la sua compiutezza, in quanto si configura come una risposta specifica a un problema specifico in una congiuntura storica specifica. La particolarità del testo non è più una scoria di cui liberarsi una volta che disponiamo di un’“edizione definitiva” in carnante “l’idea”; la cosiddetta “edizione definitiva” non è altro, infatti, che un testo particolare 4 tra tutti gli altri, in quanto la particolarità rappresenta la cifra costitutiva, la ragion d’essere di ogni testo. La domanda diventa a questo punto: è lecito utilizzare immediatamente la storia del testo come cartina di tornasole per studiare l’evoluzione del pensiero di un autore? Domanda che ne richiama naturalmente una più ampia: fino a che punto il pensiero di un autore trova espressione nelle sue opere, e fino a che punto le opere di un autore sono testimonianza di nient’altro che del suo pensiero? Tali domande meritano senza dubbio di essere poste: in effetti, soprattutto nella prima età moderna sono innumerevoli i testi modificati dai loro autori per ragioni che hanno poco o nulla a che vedere con spontanei ripensamenti o con una volontà di miglioramento: censura, autocensura, desiderio dello stampatore di aumentare o viceversa contrarre le dimensioni dell’opera a fini commerciali, ecc. ecc. A questi interventi editoriali non si accompagna per forza un’oggettiva evoluzione del pensiero dell’autore: sarebbe quindi rischioso dedurre automaticamente dal cambiamento testuale un cambiamento di opinione. Ancora più numerosi sono i testi ripubblicati a distanza di anni senza subire alcuna alterazione, nonostante il pensiero dell’autore si sia nel frattempo profondamente modificato – talvolta anzi proprio perché il pensiero dell’autore si è profondamente modificato, al punto che questi preferisce abbandonare il testo a se stesso, e talvolta disconoscerlo, piuttosto che imbarcarsi in una sua totale riscrittura. Bisogna quindi esercitare una certa cautela nel costruire teorie evolutive sulla base degli indizi che ci fornisce la storia interna di un testo; ma resta comunque indubbio che i testi, se analizzati con il giusto bagaglio tecnico e concettuale, siano in grado di rivelarci parecchie cose sul percorso intellettuale dei loro autori. Finora ho cercato di mostrare perché ritengo che l’emerneutica skinneriana, grazie alla sua particolare declinazione del concetto di intenzione, possa costituire un efficace contraltare al concetto di volontà d’autore dominante nel campo della bibliografia testuale, e perché il connubio tra tecnica filologica (purgata da certi suoi impliciti teleologismi) ed ermeneutica skinneriana possa costituire uno strumento efficace per lo studio evolutivo dei testi – in particolare, mi pare, di quelli politici, che più di altri sono direttamente legati al contesto storico in cui nascono. “Strumento efficace” non vuol dire però panacea che risolve tutti i problemi. Mi pare in effetti che il metodo skinneriano non sia completamente scevro da difficoltà, alcune delle quali mi si sono presentate con forza nel corso delle mie ricerche sul pensiero politico di Bodin. All’analisi di queste difficoltà vorrei quindi dedicare la seconda parte del mio intervento. Nel fare appello a una storia del pensiero politico di tipo contestuale, C.H. McIlwain affermava che ogni studioso di tale disciplina dovrebbe preoccuparsi di capire non solo che cosa pensavano gli autori, ma anche come essi pensavano (McIlwain 1918 : vii). L’osservazione mi sembra cruciale: in filologia, capire come pensano gli autori è fondamentale per scegliere tra lezioni di uguale forza e soprattutto per congetturare. Spesso, infatti, la scelta tra due o più lezioni alternative si basa interamente sulla considerazione che una di esse è più “tipica” di quell’autore rispetto alle altre. Inutile dire che c’è un rischio fortissimo di sovrapporre involontariamente il nostro universo mentale a quello dell’autore, dando luogo a una filologia e a un’ermeneutica deviate dal pregiudi zio. Lo stesso Skinner è ben conscio di questo problema, che è storico ancor prima che meramente filologico: la storia, infatti, consiste nella gestione di oggetti linguistici e concettuali ingannevolmente familiari, ma il cui reale significato è definito dal loro rapporto a “paradigmi” culturali spesso assai distanti dal nostro. Il rischio, allora, è di lasciarsi abbagliare dalla loro apparente prossimità, proprio come ci si lascia abbagliare dai “false friends” di una lingua straniera, e man5 care totalmente di cogliere il loro reale significato. Non limitarsi a rilevare “che cosa” pensano gli autori, ma sforzarsi di capire “come” pensano, significa proprio concepire ogni espressione linguistica e concettuale non come un’entità dotata di significato proprio e analizzabile isolatamente, ma come un frammento comprensibile soltanto in rapporto al suo contesto di origine. In questo, McIlwain e Skinner si mostrano perfettamente concordi. Ho però l’impressione che l’approccio di Skinner non aiuti veramente a capire come pensano gli autori – non, almeno, nella misura che sarebbe necessaria in lavori critico-editoriali simili al mio. Lo stesso Skinner nega espressamente che il suo metodo permetta di, o aspiri a, penetrare i processi mentali dell’autore studiato: “My aspiration is not of course to enter into the thought-processes of long-dead thinkers; it is simply to use the ordinary techniques of historical enquiry to grasp their concepts, to follow their distinctions, to appreciate their beliefs and, so far as possible, to see things their way” (Skinner 2002 : 3). L’obiezione che gli si potrebbe muovere è ovvia: com’è possibile “grasp their concepts” e soprattutto “see things their way” se non ci preoccupiamo di accedere ai loro “thoughtprocesses”? Vale a questo punto la pena di chiedersi se non sia possibile estendere il metodo skinneriano al di là delle intenzioni esplicitamente formulate da Skinner stesso (un’operazione di per sé altamente anti- skinneriana!), trovando il modo di accedere, per quel poco che ci è possibile, ai pro cessi mentali degli autori che studiamo. Penetrare un processo mentale significa capire in che modo una determinata persona collega nozioni, costruisce inferenze, determina l’ignoto sulla base di ciò che le è noto; in una parola, significa capire come quella persona ragiona. Ciò che interessa non è tanto il punto di partenza o il punto d’arrivo del ragionamento, ma il modo in cui si passa dal primo al secondo: è il movimento del pensiero e non il suo contenuto a importare qui. Possiamo quindi riformulare il nostro problema come segue: è possibile, sulla base del metodo skinneriano, cogliere il pensiero in movimento? Facciamo un piccolo passo indietro. Secondo Skinner, il pensiero di un autore si muove sempre all’interno di un quadro di possibilità definito dal contesto storico e culturale della sua epoca; entro questi limiti esso gode di una relativa libertà di “autodeterminarsi”. Ciò significa che il pensiero non è rigidamente condizionato dalle norme linguistiche, concettuali ed epistemiche del mondo circostante, ma non fluttua nemmeno nel vuo to siderale: è situato, ma non determinato, ed è proprio questo piccolo ma significativo distinguo a rendere ragione dell’esistenza e della possibilità stessa dell’innovazione. Il contributo originale di un autore consiste in gran parte nel suo uso anticonvenzionale delle norme linguistiche, concettuali ed epistemiche del suo tempo: per cogliere l’originalità di un autore è quindi necessaria una perfetta conoscenza del suo contesto. Skinner suggerisce perciò di studiare come prima cosa il contesto e dedurne le norme dominanti, per poi analizzare il discorso dell’autore nella sua interezza e individuare i punti in cui tale discorso contraddice apertamente le norme o introduce scarti ironici o risemantizza il linguaggio già esistente. Per esempio (cfr. Skinner 2002), il fatto che Machiavelli usi la parola “virtù” in modo ben diverso dalla norma cristiana dominante apparirà evidente nel momento in cui si osserverà che egli la riferisce anche a individui moralmente depre cabili ma resisi illustri con le loro grandi imprese. Di per sé, l’uso della parola “virtù” potrebbe ingannarci e indurci a credere che il discorso di Machiavelli obbedisca alle convenzioni linguistiche del suo tempo; a un più attento esame si nota però che Machiavelli usa la parola per burlarsi della norma che regola il suo normale utilizzo, e rendere così ancor più marcatamente sovversivo il suo discorso. Vediamo qui in azione due principi chiave del metodo skinneriano: 1) l’attenzione al 6 contesto, da cui va dedotta la norma; 2) la considerazione olistica del discorso dell’autore, necessaria per individuarne gli scarti rispetto alla norma. Il principale difetto di questo approccio, mi pare, sta nel fatto di concepire testo e contesto come unità in sé compiute, e proprio in quanto tali immediatamente confrontabili. Testo e contesto sembrano universi statici e chiusi, benché largamente comunicanti. Non a caso Skinner presta grande attenzione ai rapporti biunivoci tra testo e contesto in un dato momento, ma si pone di rado il problema dell’evoluzione diacronica di tali rapporti; esamina sistematicamente gli influssi reciproci tra pensiero e realtà, ma solo in qualche occasione s’interessa ai processi del pensiero, a quel “pensiero in movimento” che abbiamo visto costituire un oggetto di studio fondamentale tanto per il filologo che per lo storico delle idee. Partendo da considerazioni simili, alcuni critici (cfr. Femia 1981; Nederman 1985) hanno sottolineato la natura “atomistica” del metodo skinneriano, spingendosi ad affermare che esso sarebbe strutturalmente inadatto a trattare di “processi” – siano essi storici o intellettuali – in quanto tende a trattare testi ed eventi come “episodi particolari”, il cui senso non dipende dalla loro collocazione all’interno di macrostrutture diacroniche come la tradizione intellettuale o il processo storico, ma dalla loro relazione puntuale, singolare e irripetibile con un dato contesto a sua volta singolare e irripetibile. Personalmente non mi sentirei di dire che il metodo di Skinner sia di per sé inadatto a trattare casi “dinamici” - quelli in cui entra in campo il problema di un’evoluzione interna al pensiero dell’autore. D’altronde, nel corso della sua carriera, lo stesso Skinner ha gestito egregiamente casi simili: celebre il suo studio del 1996 sull’evoluzione dell’atteggiamento di Hobbes nei confronti della retorica – una parabola che va da un’iniziale simpatia a un completo rigetto (negli Elements e nel De cive), per approdare infine a posizioni più temperate nel Leviatano. Resta vero però che il modo in cui Skinner rende ordinariamente ragione dei processi evolutivi, sia storici che intellettuali, non è sempre soddisfacente. Un caso emblematico riguarda proprio l’evoluzione del pensiero di Bodin nel periodo 15661576, cioè nei dieci anni che intercorsero tra la Methodus e la République – un problema di cui mi sono personalmente occupata nella mia tesi. Nel secondo volume delle Origini del pensiero politico moderno, Skinner s’interroga estesamente sulle ragioni che portarono Bodin ad abbandonare il costituzionalismo difeso nella Methodus per elaborare la sua dottrina della sovranità indivisibile e assoluta. Conformemente al suo metodo, lo storico di Cambridge comincia con l’individuare il contesto della République: siamo nel 1576, “al culmine della rivoluzione ugonotta” (p. 408) che mira a contestare la legittimità del potere monarchico e a difendere una visione costituzionalista, se non addirittura popolare, dell’ordinamento francese. Quattro anni prima, nell’agosto del 1572, ha avuto luogo la strage di San Bartolomeo, nella quale migliaia di francesi di fede riformata sono rima sti uccisi con l’indiretta connivenza della famiglia reale. Questo evento costituisce uno spartiacque nell’atteggiamento degli ugonotti nei confronti della monarchia francese: persa ogni fiducia nella possibilità di ottenere dal re garanzie per la propria chiesa, gli ugonotti sviluppano una teo ria politica profondamente critica nei confronti della monarchia (sono i cosiddetti teorici monarcomachi). E’ proprio a partire dal 1572, dice Skinner, che “il partito degli ugonotti si trovò sottoposto ad un attacco crescente da parte di numerosi scrittori politici che fino ad allora si erano limitati ad adottare una posizione moderata e perfino radicalmente costituzionalista” (p. 408). Tra questi, naturalmente, troviamo Bodin. Skinner condivide l’opinione già difesa da altri studiosi (cfr. in particolare Salmon 1973 e Franklin 1973), secondo cui la République non può essere pienamente compresa “se non come una reazione ideologica all’apparente minaccia del nuovo costituzionalismo” (Salmon 1973), ossia quello degli ugonotti all’indomani di San Bartolomeo. Nella République, 7 afferma Skinner, “ripetutamente Bodin indica che è sua intenzione rispondere a questi ‘uomini pericolosi’, i quali con il pretesto della libertà popolare ‘eccitano i sudditi alla ribellione contro i loro principi naturali, aprendo la porta a quella anarchia ch’è peggio di qualsiasi tirannide del mondo, sia la più aspra’” (p. 410). Ne consegue che la teoria della sovranità formulata da Bodin nella République “è una thèse de circonstance” (p. 412, citando Salmon 1973), figlia cioè di un momento storico ben preciso; e forse – questo è il passo logico ulteriore che vorrei contestare a Skinner – Bodin non l’avrebbe mai formulata se questo momento storico non si fosse verificato. A mio avviso la ricostruzione di Skinner presenta un fondamentale difetto, quello di confon dere significato e genesi di un’opera: di nuovo, sembra che il metodo skinneriano sia molto più adatto a individuare che cosa dice un autore, che non a capire come sia arrivato a dirlo. Non c’è dubbio che non possiamo interpretare correttamente la République se ignoriamo la storia francese di quegli anni, le lotte tra ugonotti e cattolici, l’emergere delle teorie monarcomache, ecc. Ma non è affatto detto che il contesto, di per sé, ci aiuti a capire quali strade Bodin percorse per arrivare al suo capolavoro. Affermare che il solo contesto basti a spiegare la genesi di un’opera equivale ad annichilire l’autonomia del pensiero che in quell’opera si esprime: nel nostro caso, per esempio, si finirebbe per dire che Bodin non avrebbe mai cambiato le sue opinioni sulla sovranità se non fosse stato per San Bartolomeo. Di fronte all’enormità di una simile conclusione persino Skinner fa un passo indietro, precisando in una nota a pié di pagina: “credo che Salmon forse tenda a sopravva lutare la misura in cui la concezione di Bodin possa essere spiegata in termini del suo desiderio di rispondere agli ugonotti rivoluzionari degli anni ’70. Non è errato affermare che un motivo ulteriore possa essere stato il suo desiderio di ripudiare le proprie posizioni precedenti e di attaccare l’intera tendenza verso il costituzionalismo che si era sviluppata tra gli scrittori politici francesi dopo il 1560” (p. 427). Ma questa precisazione, che contraddice peraltro la tesi espressa a più ri prese in tutto il capitolo, non sembra sufficiente a cautelare Skinner dalle conclusioni paradossali cui si giunge spingendo le sue premesse metodologiche fino alle estreme conseguenze. E queste conclusioni non sono solo paradossali; sono proprio false, almeno nello specifico caso di Bodin. Esaminando le varianti introdotte nella seconda edizione della Methodus, uscita nel 1572 pochi mesi prima della strage di San Bartolomeo, è possibile constatare che Bodin, a quell’epoca, si trovava già impegnato in un processo di revisione strutturale della sua teoria politica. Il sesto capitolo dell’opera, dove si affronta la questione della sovranità, fu infatti ampiamente rimaneggiato in una direzione che è già quella dell’assolutismo della République. Ciò significa che la strage di San Bartolomeo, la radicalizzazione del partito ugonotto e l’emersione delle teorie monarcomache ebbero tutt’al più un effetto di rinforzo nei confronti di una conversione che Bodin aveva già inaugurato da tempo, per ragioni evidentemente teoriche e non soltanto storico-pratiche. Se resta esatto affermare che la République va letta nel contesto di quei dibattiti, di quelle lotte, sarebbe invece un errore ricondurre la sua origine esclusivamente a tale contesto. CONCLUSIONI Il metodo skinneriano era venuto in mio soccorso per correggere quello che mi appariva come un limite della bibliografia testuale, ossia la sua concezione teleologica dell’intenzione dell’autore. In questo caso è stata invece la bibliografia testuale, e in particolare la critica delle varianti, a per mettermi di individuare e, per quanto mi è stato possibile, superare una difficoltà latente nel metodo skinneriano. La lezione che ne ho tratto è che soltanto un approccio multidisciplinare, il qua 8 le associ strettamente metodo filologico e metodo contestuale, permette di studiare la storia evo lutiva dei testi in modo veramente rispettoso ed efficace. Preso da solo, il metodo contestuale tende a farci dimenticare che dietro ogni pensatore politico c’è, innanzitutto, un pensiero, il quale obbedisce almeno in parte a logiche proprie ed evolve non di rado secondo una razionalità interna, condizionata ma non determinata dalle vicissitudini del mondo storico. E’ questa un’obiezione che non sono certo la prima a muovere a Skinner. L’accusa di non aver saputo conciliare storia e filosofia e di essersi preoccupato esclusivamente della prima risuona per esempio nelle parole di Schochet (1974): “History and philosophy cannot be reduced to or eliminated in terms of one another. Nonetheless, Skinner seeks to resolve the dilemma by dealing with only one part of it – the history – and generally ignoring the philosophy... the philosophical analysis of historical texts becomes invalid and impossible”. Quello che spero di aver mostrato è che non soltanto l’analisi filosofica, ma la stessa analisi storica dei testi (in termini genetici ed evolutivi) diventa estremamente difficile se si vuole seguire dogmaticamente il metodo di Skinner. Credo quindi che un buon metodo di approccio all’edizione e all’interpretazione dei testi politici possa consistere in una solida tecnica filologica sostanziata da un’ermeneutica d’ispirazione skinneriana, ma più sensibile di quest’ultima alla distinzione tra significato e genesi dei testi, nonché al fatto che il pensiero conserva sempre un certo grado di autonomia dal contesto esterno. BIBLIOGRAFIA FEMIA 1981. An historicist critique of “revisionist” methods for studying the history of ideas (cfr. Tully 1989) FIRPO 1961. Correzioni d’autore coatte, in AA.VV., Studi e problemi di critica testuale, Bologna, Commissione per i Testi di Lingua. FRANKLIN 1973. Jean Bodin and the rise of absolutist theory, Cambridge, Cambridge University Press. GASKELL 1972. A new introduction to bibliography, Oxford, Clarendon Press. GREG 1966. The rationale of copy-text, in The collected papers of Sir Walter W. Greg, Oxford, Clarendon Press. McILWAIN 1918. The political works of James I, Cambridge, Cambridge University Press. NEDERMAN 1985. Quentin Skinner’s State: Historical Method and Traditions of Discourse, in “Canadian Journal of Political Science” (18/2), 339-352. SALMON 1973. Bodin and the Monarchomachs, in Jean Bodin: Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München, a cura di H. Denzer, Monaco, C.H. Beck. SCHOCHET 1974. Quentin Skinner’s method, in “Political Theory”, (2/3), 261-2 76. SKINNER 1989. Le origini del pensiero politico moderno. Vol. II: L’età della Riforma, Bologna, Il Mulino. SKINNER 1996. Reason and rhetoric in the philosophy of Hobbes, Cambridge, Cambridge University Press. SKINNER 2002. Visions of politics. I: Regarding method, Cambridge, Cambridge University Press. STOPPELLI 1987. Filologia dei testi a stampa, a cura di P. Stoppelli, Bologna, Il Mulino. TANSELLE 1976. Il problema editoriale dell’ultima volontà dell’autore (cfr. Stoppelli 1987). TANSELLE 1980. Il concetto di esemplare ideale (cfr. Stoppelli 1987). TANSELLE 1994. Editing Without a Copy-Text, in “Studies in Bibliography” (47), 1-22. 9 TULLY 1989. Meaning and context. Quentin Skinner and his critics, a cura di J. Tully, Princeton (NJ), Princeton University Press. 10
Scarica