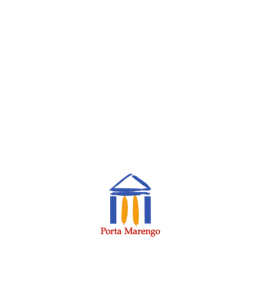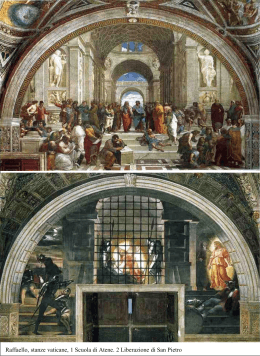Anno 1 Numero 40 - 24.11.2008 Il melodramma o l’arte delle rivoluzioni mancate Editoriale di Gian Maria Tosatti A parte tutto, il genere per cui gli italiani sono famosi nel mondo è il melodramma. Sarà per via del fatto che la musica non ha frontiere, sarà per il fatto che per almeno un paio di secoli l’italiano è stata, internazionalmente, la lingua ufficiale all’opera, ma non c’è poesia, dramma, romanzo, film che sia in grado di competere con la Bohème, Tosca, il Don Carlos, Traviata o Lucrezia Borgia in quanto ad immagine del Bel Paese nel mondo. Sono tutte storie di rivoluzioni mancate, ubriacature romantiche piene appunto di melanconia. E allora l’aggettivo “melomane” potrebbe designare sì gli appassionati di questo genere musicale, ma per assonanza potrebbe fornire un identikit anche dei protagonisti di tali vicende, di quelle inventate, come Rodolfo, Violetta, Mario, e di quelle vere, che invece riguardano un po’ tutti noi. Eh sì l’aggettivo “melomane” (se lo facciamo discendere neoetimologicamente da “melo-mania”), con quella vaga assonanza che lo associa all’idea di maniacalità e dunque di patologia sembra proprio attagliarsi allo spirito del popolo italiano. Il colpo d’occhio è immediato per chiunque passi un periodo anche breve al di là dei confini nazionali. Al ritorno, quel clima da Ottocento, da opera lirica, da rivoluzione sognata titanicamente, ma appunto sognata, salta all’evidenza di occhi meno assuefatti. Gli ingredienti ci sono tutti e rigorosamente intercambiabili (come nelle vecchie compagnie di giro), i buoni(sti) che consegnano al cielo i loro propositi di cambiamento (riformista), i cattivissimi laidi e bugiardi (col trapianto di capelli e la tinta), i buoni(sti) che vanno in Africa per adottare (a distanza) mandrie di bambini e i cattivissimi che per definire quelli con la pelle nera passano da uno sprezzante “abbronzati” (quando sono giornalisti o presidenti degli Stati Uniti) ad un più classico “bingobongo” (quando sono semplici immigrati). I buoni(sti), paladini continuamente insidiati dall’umana imperfezione dei propri colonnelli e i cattivissimi solidi nella compagine e pronti a marciare “come un sol uomo”. E in mezzo ai poli, per fare il quadro drammaturgico più completo, le mezzane e gli sgherri, i Villari (giusto per stare alla stretta attualità) e i redivivi squadristi. Eccolo qua il melodramma già pronto. Gli ingredienti ci sono tutti, precotti e pronti ad amalgamarsi appena spunta fuori un libretto buono. Il carrozzone, col suo carico di nasi finti, è pronto a ripartire. E gli Italiani stanno a guardare, come appunto i melomani, che vanno all’opera a “sentire fortemente”, a sognare la rivoluzione nelle Fiandre di Don Carlo e Rodrigo, facendo battere il cuore al ritmo del più bel duetto della storia della musica, oppure a piangere con Tosca che chiama Mario senza risposta e lancia l’ultima maledizione a «Scarpia davanti a Dio!» prima di gettarsi dal castello. Poi riprendono i loro cappotti, salgono sull’autobus, e per dirla alla napoletana “se vann’a cuccà”. Insomma, ecco, la melo-mania degli italiani è una grande forma d’intrattenimento compulsivo di massa. Ogni giorno una storia nuova da seguire e poi domani si vedrà. Si segue la fiction politica come fosse vera, si segue la politica in televisione come fosse fiction. Si soffre, veramente, a volte, anzi spesso si paga, in una forma di meticciato col reality show collettivo. Ogni volta sul piatto c’è la voglia di cambiare le cose, di fare la rivoluzione, ma poi... E’ sempre un destino più grande quello che mutila i sogni degli eroi melodrammatici, un destino da maledire, ma a cui arrendersi restando appassionatamente a guardare, in platea, ancora una volta, la stessa opera. P.S. Italiani, popolo di melomani, amanti della musica e del canto. Nessuno escluso. Da quelli che si commuovono con le parole dell’inno di Forza Italia (esistono!) a quelli volevano una nuova era della politica e poi si sono ritrovati al Circo Massimo il 25 ottobre a cantare “bandiera rossa” sulle note dell’inno nazionale. E gli studenti? No, loro ci stanno provando veramente. Eppure il rischio di mandare segnali contraddittori c’è. Il rischio che l’assenza di un segnale al momento giusto venga avvertito come segnale negativo e il loro movimento venga percepito nello spirito delle rivoluzioni mancate di altri molteplici melodrammi. Pensano a ristrutturare il futuro, è vero, pensano a rifondare il sistema. Ma l’uomo della strada, l’uomo che legge il Corriere della sera per capire come va il mondo, l’uomo che non fa distinzione fra le scorie del passato che si riversano sul presente e il lavorio dell’oggi che tende a edificare il domani, quell’uomo che vede la realtà solo sui piani sovrapposti dell’attualità oggi potrebbe dire: dov’erano gli studenti in queste settimane mentre si truccavano i concorsi per i 3000 posti da ricercatore? E qualcuno potrebbe rispondere: in un’altra piazza, a cantare. Il doppio mito di Saturno I diversi volti della malinconia nel coerentissimo ragionamento di Daniel Birnbaum per la Biennale di Torino senso, di uscire dai meccanismi associativi classici dell’arte contemporanea e ottenere un idea generale di maggiore respiro che prende forma, come è naturale per la filosofia, in un filo sottilissimo tracciato con precisione matematica. Ed è, infatti, questa esatta coerenza che segue il dipanarsi della Triennale nelle diverse sedi (Castello di Rivoli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Promotrice delle Belle Arti) senza mai cedere a stupire, in parte per meriti propri e in parte per una certa disabitudine che si ha in Italia per le mostre ben curate. Fatto sta che diversi elementi concorrono a far sì che il viaggio del visitatore, per quanto sballottato in tre punti assai distanti uno dall’altro nella topografia del capoluogo piemontese, non subisca mai strattoni permettendo all’attenzione di non calare mai e di non produrre in alcun caso un sovraccarico visivo che richieda uno stacco. Insomma, caso assai raro nel Bel Paese, la Triennale si riesce a vedere, tutta d’un fiato, riuscendo a seguire il suo flusso abbacinante dall’inizio alla fine. Merito va certamente alla scelta degli artisti (ben 50!) e delle loro opere. E una parte del merito va anche all’attenzione che gli si è dedicata, riuscendo a dare sempre lo spazio necessario perché ogni opera possa sviluppare una esposizione ottimale alla percezione del visitatore. di Gian Maria Tosatti «Mi sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni, mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo». (Fabrizio De Andrè – Anime salve) La domanda è: “di che tipo di malinconia ci parla Daniel Birnbaum?” oppure, più semplicemente: “ c h e c o s ’ è l a m a l i n c o n i a ? ” . Pe r c h é i l ragionamento del curatore della seconda Triennale di Torino (nonché della prossima Biennale di Venezia) è sofisticato e per quanto si svolga semplicemente nelle sue note introduttive, in realtà si mostra disseminato di crateri profondi, gole da capogiro, come quelle che punteggiano le 50 lune di Saturno (questo il titolo della mostra), pianeta della malinconia, ma prima di tutto metafora perfetta per dare forma al pensiero di Birnbaum. E’ questo astro, cui è collegato un mito, a fare da punto di contatto tra l’idea curatoriale e il lavoro degli artisti. Saturno, divoratore dei propri figli per i greci e portatore di un’età dell’oro nella tarda mitologia romana. Tale bilico a strapiombo fra il cannibalismo e l’energia, fra i risvolti del nero, sembra essere il filo di rasoio su cui con estrema precisione il curatore ha costruito un viaggio attraverso un sentimento profondamente contemporaneo. La sua formazione filosofica permette, in questo E sulla dicotomia malinconia-energia si gioca il principale fuoco della mostra. In tutte le opere è fortissima una tensione che presuppone il passaggio, una forza fisica che sviluppa energia, fino ad arrivare in certi casi alla superproduzione di azioni che si identifica con l’ossessività del malinconico. In ogni caso sembra il movimento ad essere grande protagonista, partendo dalle due personali, quella dedicata a Olafur Eliasson, il cui lavoro artistico è centrato da sempre sui movimenti delle grandi forze e che qui prosegue il suo ragionamento sulla luce in relazione ai movimenti dei corpi celesti, e quella dedicata a Paul Chan, in cui la stasi del punto d’osservazione nel suo video My birds… trash… the future (ispirato ad Aspettando Godot di Beckett) diventa superficie erosa e discarica delle ondate di movimenti che continuamente la stravolgono. Una sezione estremamente ricca quella dedicata all’artista sino-americano, che, per quanto possa essere percepita come una sproporzione, ha tuttavia il merito di riuscire a presentare con la giusta chiarezza l’importantissimo lavoro sul linguaggio che Chan porta avanti e che vede anche nel video Happines (Finally) After 35,000 Years of Civilization (after Henry Darger and Charles Fourier) un esempio di malinconia frutto della sterilità meta-mediale di un’azione (in cui non a caso è inserita una irrazionale vena sessuale) che fa perdere completamente la cognizione della ripetizione (tecnica) a loop inserendosi in una prospettiva temporale indifferentemente lineare. E una stasi prossima al collasso, ma di segno opposto, perché forzata disperatamente nelle sue pareti perimetrali, è anche quella che sta al centro del lavoro di Andrea Geyer, che nel suo Audrey Munson Project ha fotografato gli alberi visibili dalle finestre di un manicomio in cui per 65 anni è stata rinchiusa quella che negli anni ’20 era considerata come la più richiesta modella dagli artisti newyorkesi. Su tali immagini Geyer ha impresso brevi strofe di poesie che parlano della malattia mentale femminile, andando così a realizzare un ciclo di opere estremamente duro sul modo in cui nel Novecento l’accusa di insanità mentale e l’interdizione fosse usata come forma di controllo sulle donne. Ma anche il tema del doppio, visto come necessità di completezza attraverso l’immagine speculare fa parte di un universo malinconico fondato sulle tensioni. E’ questo il tema del video Les ruissellements du diable di Karen Cytter, ispirato all’opera omonima di Julio Cortazar e alla poetica di Lygia Clark (uno dei riferimenti strutturali di Birnbaum), in cui i piani dell’indentità si mescolano per una irresistibile forza inerziale di attrazione e generazione. E lo stesso tema, visto però in una prospettiva soggettiva è quello che porta Giuseppe Pietroniro, uno dei molti artisti italiani coinvolti, a proseguire qui la sua ricerca sulla necessità di una moltiplicazione dell’immagine che però nel riprodursi esclude l’osservatore. Tra queste grandi dorsali dell’esposizione si intrecciano altre dinamiche immediatamente derivate dal concetto di malinconia. E’ il caso del complesso lavoro sull’utopia realizzato da Robert Kusmirowski, che in DATAmatic 800 ricostruisce, in una stanza visibile attraverso una finestra, il primo grande computer per calcoli matematici, in una operazione installativa che tende a ragionare sulle utopie attraverso la ricostruzione dei luoghi entro cui esse hanno preso forma. E, in fine, il rapporto tra terrestre e altrove, nella misura della distanza fra l’uomo e lo spazio, vede nel pathosformel di Wilhelm Sasnal, ispirato direttamente a Saturno una delle espressioni più sintetiche e d’impatto (vedi l’opera DrivingSleeping) di questa Triennale torinese. Fame di niente In “The Burning Plain” la bulimia sentimentale di Arriaga si arrende alla meccanica di Federico Pontiggia All'orizzonte, un camper abbandonato in fiamme. Una donna (Charlize Theron) che lavora in un ristorante chic di Portland. Un funerale in una città sulla frontiera Usa-Messico, con un ragazzo e una ragazza che incrociano lo sguardo. Una bambina che vede l'aereo del padre schiantarsi al suolo in Messico... Che cosa cambia quando un premiato e stimato sceneggiatore esordisce alla regia? Quasi nulla, almeno nel caso del messicano Guillermo Arriaga che, dopo la separazione dal connazionale Alejandro Gonzalez Inarritu, ha portato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e ora in sala la sua opera prima, The Burning Plain. Protagonista una tragedia bifamiliare, nelle sue molteplici conseguenze, seguita con la consueta - vedi gli script di Amores perros, 21 grammi e Babel - struttura a incastro: azione, tempo e luogo giostrate dalla penna di Arriaga per trarne una materia infuocata, burning. Ammesso che funzioni sulla carta - troppo scoperto il salto tra passato e presente, nonostante la giovane Mariana (Jennifer Lawrence, premio Marcello Mastroianni quale miglior attrice emergente al Lido) rimanga (sic!) innominata per quasi un'ora - questo meccano è oggi usurato sullo schermo, anche grazie alla fortuna dei titoli dell'accoppiata Inarritu-Arriaga. Servirebbe per svecchiarlo - ma oggi la linearità non è già tornata a essere l'opzione più innovativa? - una regia non subordinata alla sintassi della sceneggiatura, capace di liberarsi dalla punteggiatura della pagina per offrire traiettorie, squarci e sguardi di cinema per il cinema, ovvero pura narrazione per immagini, chiamate a esistere in sé e per sé, senza dover intenzionalmente ricoprire la minima funzione didascalica. Ebbene, questo non avviene, nonostante la strada messa in discesa da un cast affiatato e di livello: l'intensa Charlize Theron, nei panni di Sylvia, dal Messico transfuga a Seattle, lasciandosi alle spalle una bambina e, invano, il senso di colpa; Kim Basinger, prova coraggiosa e sofferta la sua, per un ritorno alle scene da moglie adultera e madre di famiglia alla deriva, e ancora l'ottima teen Jennifer Lawrence, J.D. Pardo e José Maria Yazpik. Fatiche sprecate dalla ricerca di geometrie drammaturgiche che finiscono per raffreddare le emozioni, ancora vibranti nell'interpretazione particolare degli attori ma rese atone dal quadro cartesiano generale: se i tasselli sono infuocati, il mosaico audiovisivo paga lo scotto, perché costretto e asfittico tra l’ascissa e l’ordinata tracciate sulla carta. «Esiste una sottile linea fra tragedia e felicità: come già insegnavano Shakespeare e Sofocle, in un minuto può cambiare tutto», ha detto Arriaga di questo esordio dietro la macchina da presa, con protagonista Mariana/Sylvia, interpretata adolescente in Messico dalla Lawrence e, poi, emigrata a Portland e di ritorno in patria con il volto della Theron. Proprio all’attrice sudafricana, il neo-regista affida un ruolo preminente anche dal punto di vista ideologico: «La società contemporanea reprime la morte e anche il corpo umano. Per questo, il film si apre con il corpo nudo di Charlize: il corpo ha un potere sovversivo, è molto eloquente, quando sei nudo sei autenticamente te stesso. Questa prima scena racchiude il significato del film, ovvero la sua onestà e le sue contraddizioni: Sylvia ha un modo blasè di mostrarsi nuda, come se per lei non fosse assolutamente un problema, invece intuiamo come la sua vita sia piena di difficoltà». Difficoltà che fanno capo, essenzialmente, alla malinconia, il vero leitmotiv di The Burning Plain, anche sotto il profilo meta-cinematografico. Malinconica è Sylvia, costretta a rimpiangere le non-scelte del passato, che incarna la mancanza, il manque à être, “risolto” in una bulimia sessuale, che è fame patologica e insoddisfabile, indifferente all’oggetto e sterilmente alimentata proprio da quella malinconia. Questa malinconia è subito - e opportunatamente - “messa a nudo” da Arriaga, quale spia di un desiderato ritorno alle origini, nello spogliarsi di tutte le successive sovrastrutture della vita, leggi colpe e dolori. Se il rogo omicida innescato da Mariana non ha mai smesso di ardere, ecco che quella combustione manda in fumo ogni successiva progettualità, con un odore di bruciato che diventa quello dell’intero film. Quella roulotte, seppur adulterina, era il locus amoenus, e la sua distruzione è quella di tutti i suoi epigoni: il Burning del titolo è malinconia allo stato puro, ovvero impossibile (participio presente) presenza di quanto si è già consumato. Rimane, appunto, una malinconia vischiosa, poeticamente resa con grande efficacia, ovvero sentita e partecipata: che Arriaga si sia guardato in casa, alla malinconica fine del suo idillio con Inarritu? Stanze in fondo Si è conclusa a Parma l’ultima edizione di “Natura Dèi Teatri” di Massimo Marino Opere Pazienti racconta una ferita e uno splendore: la mansuetudine, la malattia, la sofferenza, la rassegnazione, e la rabbia, la voglia saturnina di rifondere un mondo fuori dai cardini con l’arte. L’acrostico di questa edizione del festival Natura Dèi Teatri, organizzato da Lenz Rifrazioni, ricorda – casualmente – quello di Ospedale Psichiatrico, e non a caso si apre nella reggia di Colorno, che fu, nel suo abbandono novecentesco, luogo di reclusione manicomiale. Inizia con una versione poetica, struggente, malata della favola di Cappuccetto Rosso, un percorso itinerante in 17 stanze del piano nobile dell’edifico settecentesco, in attesa di tornare a Parma, per il resto della rassegna, negli spazi industriali di Lenz, che ora giacciono nel vuoto degli abbattimenti della zona intorno alla stazione, soggetta a una ristrutturazione urbanistica. Il capannone di Lenz aspetta un rinnovamento che dovrebbe farne il centro culturale pulsante del nuovo quartiere, anche se in queste operazioni, a capitale pubblico-privato, si sa dove si inizia e non si capisce dove porterà la speculazione, in agguato anche alle spalle di un progetto interessante sulla carta, elaborato dallo studio Mbm Arquitectes di Barcellona, quello che ha ridato vita a parte della città catalana in occasione delle Olimpiadi. Per questo il festival inizia con Spazi nel vuoto, un incontro sul tema del teatro che inventa i propri luoghi, tra memoria e progetto, tra uso (o ridefinizione) di contenitori esistenti e invenzione, sempre con la guida di un’etica, una poetica, una drammaturgia, una identità artistica. Poi Lenz dà la dimostrazione di cosa vuol dire “vivere gli spazi”, con il bellissimo Consegnaci, bambina, i tuoi occhi, dalla Ballata di Cappuccetto Rosso di Federico García Lorca. Il testo è un poema giovanile, inedito fino a pochi anni fa, in cinque parti: uno stupito canto all’amore e allo smarrimento, che trasforma Cappuccetto in una specie di Dante persa in un surrealista bosco dove fiori, uccelli, acque vogliono i suoi occhi capaci di guardare il mondo con incanto. La bambina delle favole, in preda all’ansia, si affida a un ruscello, che la trasporta in un paradiso inerte, dove i santi vegetano nella paura dell’irruzione dell’inferno. Le farà da guida San Francesco, tra stanze polverose come quelle di un museo, come la religione cattolica vista da Federico ventenne, nella fase di una prima ribellione tutta affidata allo stupore della poesia. Caperucito (così suona Cappuccetto in spagnolo) è Barbara Voghera, una delle attrici “sensibili” di Lenz: una donna down che lavora con la compagnia da alcuni anni, donando profondità vertiginose ai suoi personaggi. I suoi occhi leggermente asimmetrici, in qualche momento fissati come su un altrove o su un’interiorità vicina e imprendibile, diventano i protagonisti di questo viaggio per fuggire da chi vuole rapire lo sguardo, la capacità di vedere, discernere, immaginare. E gli oggetti, di Maria Federica Maestri, che firma anche la regia e che con Francesco Pititto è l’anima immaginativa della compagnia, ci precipitano in un bosco con il rumore, i colori, le asprezze dei nostri giorni, con papaveri fatti di sportelli rossi di furgoni e fiumi come una teoria di lavandini, con gli occhi di Caperucito duplicati nelle prime stanze, inquadrati in specchi, in cornici, in stucchi. Salverà la bambina un ambiguo San Francesco, che appare con in bocca un uccellino, come un lupo. È un’attrice, Valentina Barbarini, rasata e con un saio, pronta a indossare nelle sue dolci e insidiose trasformazioni altre pelli. Il paradiso di García Lorca diventa un viaggio tra le decorazioni e le boiserie rococò del palazzo e le figure di quel paradiso inquietante e dimenticato, popolato da santi interpretati da ex malati reclusi in quelle stanze quando erano manicomio, fermi, seduti, immagini di un tempo che non passa, che ancora ferisce. Ci sono giocattoli, fiori di plastica, apparizioni attraverso fughe di stanze, croci indossate per un cammino di liberazione che assomiglia a una passione dalla protagonista, piccola, inerme, dalla voce densa come miele, piena di tremori e piccole sicurezze, con il calore vibrante e un po’ rauco di chi sa, nonostante la paura, dove andare. Tra i santi abbandonati, in trionfi di panini, con le mandibole in eterno movimento, c’è il mangia-sempre-tutto San Tr i p p o n e ( S a n A p a p u c i o P a p p a g o r g i a nell’originale). E ci sono anche dèi pagani, come Eros, che ferisce a morte Caperucito. Solo una vecchia Madonna, interpretata da Francesco, lupo amoroso e feroce nei panni sadomaso di una giovane bagascia, potrà medicarla, precipitandola, tremante ancora di quella bestia fuggente che è amore, nel bosco dell’incubo iniziale. Mentre le parole del poeta parlano dei sogni che non devono morire e affidano la custodia di questa campionessa dell’immaginazione e di una fanciullezza minacciata e svanita a una lepre e a un lupo (ancora), la fantasia degli autori, più perfidamente, ci insinua l’idea che nessuna consolazione sia possibile in quella foresta insidiosa, mortale, che è la vita. Sta in bilico tra le crepe dell’anima e dei tempi con la sua irriducibile soggettività, quella che l’arte esalta come atto di ribellione. Si ostenta e si sottrae per sondare le strade dei territori del sacro e dell’umano attraverso le seduzioni, gli errori, l’ansia più disperata e volgare. Per salvare almeno un gesto, un respiro, una possibilità. Vita d’interni “Sonja” e “Long life”, a Le Vie dei Festival un dittico sulla malinconia del regista lettone Alvis Hermanis di Mariateresa Surianello Il festival è pieno di performance che sfidano lo spettatore a guardare e a riguardare, più a fondo, senza lasciarsi sedurre. Sono magari movimenti minimi, disposti in serie ordinate, apparentemente sempre uguali, come in Ordinale, un breve intenso studio di Habillé d’eau, o lettere dalla prigionia in Germania di un marito alla moglie, che fotografano un tempo coatto e quotidiano, apparentemente senza sviluppo, in Così lontano, così vicino dei performer Ottonella Mocellin e Nicola Pellegrini. Così l’altra opera di Lenz, Chaos, dal primo libro delle Metamorfosi di Ovidio invoca un altro sguardo. Qui non siamo davanti a un ipermondo terminale, ma alle origini del cosmo, all’indistinzione della materia originaria che precipita nell’individuazione delle cose. Appare l’età dell’oro che svilisce in quella del ferro, fino alla fuga per malinconico dispetto degli orrori umani della vergine Astrea, indietro fino alla ribellione dei giganti, dal cui sangue infetto nacquero gli uomini. Immagini, primissimi piani di dettagli dei corpi, circondano tre ragazze e un uomo maturo nudi e rasati, prima ombre, poi presenze ora mitiche ora abbigliate da bordello, incorniciate dai versi latini di Ovidio o dal grido di parole d’amore e disperazione di Romeo e Giulietta, da suoni lancinanti o da refrain consolanti. Un corpo di plastica, un corpo incrostato di superfetazioni o denudato, un corpo poema o immagine, un corpo tradito, un corpo implorante, un corpo così presente da risultare vacuo, da svanire, da gridare, è quello delle fantasie ossessive di Lenz. In Italia, il nome di Alvis Hermanis circola da un triennio, ma in maniera epifanica. Per questo la scelta di Natalia di Iorio di incentrare le romane “Vie dei festival” sul lavoro del regista lettone ha un po’ il sapore della scoperta e insieme della definitiva consacrazione. Classe 1965, fondatore e direttore del Nuovo Teatro di Riga, Hermanis è apprezzato in tutta Europa, da Edimburgo ad Avignone, ma gira anche in Sudamerica. Lo scorso anno, tra l’altro, gli è stato conferito il Premio Europa Nuove Realtà Teatrali, a Salonicco, dove – accomunati dal medesimo previsso - premiata è stata anche un’altra personalità teatrale dell’Est, Biljana Srbljanovic, anche lei ex, jugoslava, come Alvis Hermanis è ex, sovietico. Al Teatro India, che in questi giorni ha ospitato Sonja e Long life, Hermanis addirittura c’era già stato, nel 2005, per il Festival dell’Unione dei Teatri d’Europa, ma quella volta aveva portato una produzione della Schauspielfrankfurt, Das Eis (Il ghiaccio) e non la sua compagnia. Ora invece col focus di Cadmo, il regista ha mostrato due spettacoli particolarmente significativi della sua poetica, due lavori diversi, ma molto simili per la capacità di toccare l’intimità profonda dello spettatore e quindi di emozionare. Interessante anche il ribaltamento cronologico della programmazione, Long life, del 2003, è stato proposto dopo Sonja, che Hermanis ha messo in scena tre anni dopo, nel 2006, quasi fosse un restringimento dell’obiettivo, un andare ancora più a fondo nell’intimità che veniva scoperta in Long life. Con Sonja (lo scorso anno si è visto a “Vie Scena Contemporanea” di Modena), tratto da un racconto della scrittrice russa Tatiana Tolstaya, si entra in una sorta di stanza della memoria, condotti da due ladri d’appartamento, con tanto di volto coperto da una calza. Nel rapido cambio di registro della pièce, che coincide col travestimento di uno dei due, compare la figura della protagonista del titolo, immediatamente pronta ad avviare il suo menage quotidiano di solitudine e misere gioie. Guidata dalla voce ironica e sprezzante dell’altro, che diviene narratore, Sonja si trascina per la stanza, silenziosa e malinconica, eseguendo ogni minimo gesto suggerito da quella voce. Gli occhi fissi e persi nel vuoto e la testa (con i bigodini) inclinata sembrano richiamare con smaccata parodia i motivi dell’iconografia classica della melanconia (può essere utile Saturno e la melanconia di Klibansky, Panofsky, Saxl). Farcisce torte, mette al forno polli e si cuce vestitini fiorati di pessimo gusto con un bisogno di dare e darsi cieco e disperato, che magnetizza lo spettatore. In una scenografia realistica prende forma l’esistenza grottesca di una donna brutta e stupida, oggetto di scherno da parte dei vicini, che arrivano all’estrema perfidia, quando inventano per lei uno spasimante, appassionato, sposato e grafomane. Per uno scherzo atroce e senza ritorno, inizia una lunga relazione epistolare, un amore folle che solo la guerra, arrivata fino a Leningrado, può annullare nella tenebre della tragedia mondiale. In Long life, che appunto nel percorso creativo di Hermanis arriva prima di Sonja, la narrazione è invece affidata esclusivamente al dettaglio scenografico, di un realismo scioccante, tanto è minuzioso nella ricostruzione dei particolari che fino alla fine ci si meraviglia di scoprire, e a una partitura fisica ineccepibile a storpiare corpi ed espressioni del volto. Il resto è solo un borbottio continuo, incessante. Una cantilena significante di una condizione estrema eppure ancora vitale. Quando viene rimossa la quarta parete – uno alla volta si levano i pannelli che chiudono la scena – davanti agli occhi degli spettatori si apre un museo dell’intimità domestica stratificata da anni di vita vissuta in uno stesso spazio. Siamo in un appartamento coabitato da cinque vecchi, due coppie uomo-donna e un uomo singolo, che osserviamo dal mattino, al risveglio, e fino a sera, di nuovo al letto. Un giorno come un altro vissuto col bagno e la cucina in comune, in quelle stanze piccole e piene di pezzi di vita, in cui ogni azione minima dà senso al resto dell’esistenza. Davvero struggente questo affresco calligrafico che si fa portatore di un tema tabù della nostra società, la vecchiaia. E quasi a voler ancora insistere a giocare col tempo e col suo inesorabile trascorrere, il regista lettone è approdato ora a The sound of silence (da noi ha debuttato a Napoli, lo scorso giugno, al Teatro Festival Italia). Ha preso i cinque vecchi di Long life e li ha riportati in quello stesso appartamento collettivo, quaranta anni fa, nel 1968. Un altro lavoro senza parole, costruito su una colonna sonora di Simon & Garfunkel, perfettamente descrittiva di quell’epoca. I magici anni che Alvis Hermanis considera quelli della nostra “ultima utopia”. Che cos’è la malinconia? Dalla tesi di laurea del medico di Van Gogh una definizione del male “diffuso in tutta la natura” di Paul-Ferdinand Gachet Temperanza del corpo e dell’anima: questa è per l’uomo la legge di un equilibrio stabile. Non ci sarebbero più allora in lui e tra i suoi simili né malati né folli. Ma al posto di questo cosa abbiamo invece? L’accrescimento nell’uomo che vive in società delle sue infermità morali e fisiche, la diminuzione della longevità umana, la degenerescenza, l’impoverimento, l’imbastardimento delle razze. E’ noto che i nostri padri erano più robusti e più forti di noi. E’ noto che vi erano meno folli e suicidi in altri tempi di quanti ce ne sono oggi (…) Non vogliamo essere accusati di avere uno spirito retrogrado o nemico del progresso; ma tuttavia dobbiamo ammettere che la civiltà, il progresso si portano appresso un interminabile corteggio di mali. La storia è qui per istruirci. Quale è stato il momento del marasma, della decadenza della Grecia e di Roma? Quello del loro apogeo, della loro civiltà. Non so quale storico ha sagacemente scritto che un popolo non è mai così vicino alla propria rovina come quando si avvicina al massimo della propria civilizzazione (…) La civiltà, il lusso, l’accresciuto benessere materiale, la fonte di nuovi bisogni e di piaceri divenuti indispensabili, rimpiazzano la semplicità dei tempi antichi. E con essi, la mollezza e la pigrizia, che producono l’atrofia, l’insterilimento del popolo che aveva donato delle leggi al mondo (…) Quale furore ci spinge verso il declino? La legge inesorabile che regge tutte le cose, e tutti gli esseri. Sic fata voluere, dicevano gli antichi (…) Anche senza andare così lontano, cosa troviamo ripiegandoci sul piccolo angolo della nostra sfera territoriale, ad esempio nel nostro paese? (…) Malthus nella sua curiosa opera ci dimostra che, senza alcun ostacolo, la popolazione cresce in proporzione geometrica di 2, 4, 8. Mentre i mezzi di sussistenza non offrono che un rapporto di 2, 3, 4, cosa che non di meno produrrebbe una crescita quasi illimitata della popolazione (…) Secondo Malthus le cause di questo fenomeno sono di due ordini: Gli ostacoli preventivi alle nascite; Gli ostacoli repressivi che diminuiscono la longevità umana. Tra i primi ci sono il celibato, la deboscia, la miseria. Questi elementi primordiali portano con sé l’incontinenza, la prostituzione, la poligamia. Tra i secondi compaiono le conseguenze delle infrazioni alle leggi di natura, la scarsa igiene, le abitazioni insalubri, l’aria inquinata, l’insufficienza del vestiario, la fame o un’alimentazione insufficiente, l’ubriachezza, l’intemperanza… e aggiungiamo a queste cause le cause morali (…) Avremo così delle cause di diverso ordine che scaturiscono dai nostri costumi, dalle nostre passioni, dal nostro stato sociale. Possiamo riassumerle in due specie: Quelle che cadono sotto i nostri sensi e che sono tangibili generano le malattie fisiche; Quelle che non affettano i nostri organi, e che sono immateriali, generano le cosiddette malattie mentali. Che sia tuttavia chiaro che noi siamo forzati a stabilire questa partizione da esigenze di analisi, ma che da questo non inferiamo che cause morali non possano produrre altro che malattie morali e cause fisiche soltanto malattie fisiche. Essendo l’uomo un’unità sotto ogni aspetto, i suoi differenti elementi possono produrre reazioni differenti che talvolta, partendo dall’intelligenza, affetteranno il corpo, talaltra, invece, partendo dal corpo lederanno gli organi; le une e le altre di queste cause agiscono di concerto, oppure associate in questa o quella proporzione, saranno di natura tale dal portare offesa alle leggi che presiedono all’equilibrio di questa stessa unità, ferme restando le individualità, creando in tal modo delle condizioni anormali. A partire da questo momento, l’uomo malato esiste. Delle lesioni materiali, la febbre, un’emorragia, una congestione di questo o quell’organo, ci indicano che l’equilibrio è rotto in seno all’economia fisica, che la forza vitale che presiede agli atti e ai movimenti è disturbata, modificata, lesa. Ma se in assenza di questi sintomi solo le funzioni dell’intelligenza vengono turbate; se la vita di relazione dell’uomo con i suoi simili e il mondo esterno è minacciata o annientata, e questo a danno delle leggi di natura e del più tenace di tutti gli istinti, quello di conservazione; se, in una parola, il soggetto non sembra più godere di tutta la potenza di scelta che possiede allo stato normale, su se stesso, sui propri istinti, sugli oggetti esterni, sui suoi simili; se infine non sembra più possedere l’integrità della propria volontà, del suo libero arbitrio, si dice allora che è pazzo; che egli non è più come dicono i giuristi compos mentis. Ha perduto la ragione, e con essa il diritto di deliberazione, non solo su se stesso, ma sugli altri (…) La malinconia è diffusa in tutta la natura. Ci sono degli animali, dei vegetali ed anche delle pietre che sono malinconici. Quando essa si manifesta, sembra che la creatura s'ispessisca, che si stringa su se stessa, che si raggomitoli e che debba occupare il minor posto possibile nello spazio. L'atteggiamento del malato è assai particolare. Il tronco sempre piegato sul bacino, le braccia portate verso il petto; le dita raggrinzite, piuttosto che piegate. La testa china a metà sul petto e leggermente inclinata sia a destra che a sinistra. Tutti i muscoli del corpo, soprattutto i flessori, sono in una semi-contrattura permanente. I muscoli sopracciliari, contratti in maniera permanente, sembrano nascondere l'occhio e aumentano la sua cavità. La bocca è chiusa in una linea dritta, sembra che le labbra siano scomparse. Lo sguardo è fisso, inquieto, obliquo, diretto verso il basso o di lato. Sembra che ci sia in tutto l'essere un ostacolo che ha rallentato, diminuito, o addirittura impedito completamente il movimento vitale. Di fronte a questo ostacolo, il pensiero, il movimento si scontrano senza fine. Questo stato costante, permanente, concentrico e indefinito di incubazione è il punto culminante, la pietra di paragone di ogni delirio malinconico. Ad un alto grado, la creatura malinconica assume tutti i caratteri dell'inerzia più completa. Il principio vitale, che presiede a tutto l'essere, tace, ed assieme a lui gli organi, i sensi, la mente, gli istinti e le passioni sono colpiti da mutismo. L'uomo assomiglia a un vegetale, a una pietra. la differenza settimanale di cultura on-line su www.differenza.org direttore responsabile Gian Maria Tosatti in redazione Graziano Graziani, Attilio Scarpellini, Mariateresa Surianello. La rivista è finanziata nell'ambito del progetto Scenari Indipendenti, promosso dalla Provincia di Roma in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio.
Scarica