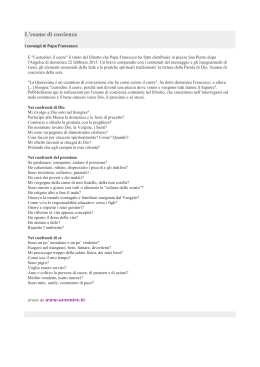Domenica La di DOMENICA 27 MARZO 2005 Repubblica il viaggio Dove nascono le fiabe di Andersen CONCITA DE GREGORIO e PIERO OTTONE la memoria Elezioni, l’arte perduta del comizio FILIPPO CECCARELLI e GOFFREDO DE MARCHIS Giovani per sempre Hanno “cinquantacinque anni o meglio”, non si sentono finiti e vogliono riprendersi il tempo perduto. In Italia, come in America FOTO CORBIS MICHELE SMARGIASSI «È VITTORIO ZUCCONI TRIESTE vero, gli anziani sono un problema», ammette Annamaria Crisafulli, 64 anni, ex commessa, in pensione da tre. «Per esempio mia suocera, 84 anni, malata... ». Signora, mi perdoni, io veramente parlavo di lei... «Io? Anziana io?», più che offesa è sbalordita, «io ho appena cominciato a vivere, voglio fare tutto, non mi bastano le ventiquattr’ore». «Anziane noi?», corrono a darle man forte le amiche. Attorno a un tè fumante, nella pausa-merenda delle prove di danza al circolo anziani Pino Zahardi Trieste, se ne coalizzano una dozzina, tutte tra i 55 e i 70: guardandole, capisci la gaffe. Come posso chiamarvi, allora? Pausa pensosa. «Signore mature...», «Donne grandi...». Poco convinte anche loro. «Donne di mezza età...». Ridono. Non ci sono parole, questo è il guaio. Cercansi urgentemente definizioni appropriate. La vecchiaia giovane è un oggetto sociale non identificato nell’Europa che incanutisce impetuosamente. Senior? Veterani? Nonni? Il vuoto di nomenclatura tradisce un vuoto di percezione sociale. Segue nella pagina successiva A ORLANDO (Florida) l mercato del tempo perduto, ricomperare la propria giovinezza di seconda mano costa appena mille euro al metro quadrato. Mille e cento, via, se proprio volessi avere anche la vista sul green, l’uso del calesse da golf con il muso da Rolls Royce e il garage bi-auto, ma in compenso il biliardo, la canasta, la piscina coperta, l’artrosi, le vene varicose e la cellulite sono gratis. Un bargain, un affarone, mi fa notare con tono soffice Mike Yarborough, l’agente immobiliare addestrato a non alzare mai la voce per evitare che il cliente anziano si ecciti troppo e gli prenda un coccolone prima di entrare nel cocoon, prima di avere firmato il contratto di acquisto di una casa nel villaggio degli uomini ragno, nel guscio dei vecchi che raggrinziscono eternamente, senza morire mai. Comperare una casa nel cocoon alle porte di Orlando è effettivamente uno scherzo rispetto ai prezzi immobiliari nelle città dei vivi. Duecentomila dollari per 230 metri quadrati di villetta monofamiliare nuova di zecca, protetta dall’alta cinta muraria che fascia tutto il villaggio, non comprerebbero un monolocale a Manhattan. Segue nella pagina successiva cultura Il film ritrovato di Rodolfo Valentino DAVIDE CARLUCCI e ANTONIO MONDA le tendenze Il trucco per coprire la crisi NATALIA ASPESI e LAURA LAURENZI l’incontro Sean Connery: scrivo le mie memorie MARIA PIA FUSCO 26 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 la copertina Società che cambia Se li chiami anziani ti guardano quasi increduli, accusano la società italiana di ignorarli e ghettizzarli. Adesso vogliono riprendersi il tempo perduto. Con gli interessi La seconda vita dei nuovi vecchi C MICHELE SMARGIASSI (segue dalla copertina) hi sono mai questi vecchi che non vogliono essere vecchi (il 72% degli ultrasessantenni dichiarano al Censis di «non sentirsi anziani»), anzianità attiva che precede di molto l’anzianità involutiva, terza età ringiovanita dalla comparsa in scena della quarta (in Italia 18 mila over-65 vivono coi genitori), adulti dall’aria evergreen, autosufficienti, che già oggi sono dieci milioni, che nel 2030 sorpasseranno per numero la generazione lavorativa (i 3059enni), che nel 2040 saranno oltre un terzo della popolazione italiana? Sono i grandi “Innominati”. Solo gli americani, geniali inventori di acronimi sociologici, hanno coniato per loro un nomignolo da cuccioli, woof, well-old older folks (più o meno: vecchietti in gamba). Nessun gruppo sociale emergente è mai stato così sottovalutato, anzi ignorato. Eppure esistono. I nuovi vecchi sono sempre di più, sempre più renitenti alla rottamazione, sempre più insofferenti per il ghetto sociale in cui sono confinati. Almeno in Italia. Due anziani su tre intervistati a Prato dall’Asel pensano che la società li consideri «un peso»; un altro 25%, che si «disinteressi completamente» di loro. Hanno voglia di viaggiare (il 10 per cento va in pensione solo per questo), ma per l’industria del turismo esistono solo in formato comitiva e come riempitivo per la bassa stagione. Si sentono in forma (interrogati dal Censis, il 64% si ritengono in buona o ottima salute a 69 anni, il 45% ancora a 79) ma vengono maltrattati dalle assicurazioni sulla vita. Pagano le tasse (quasi un terzo dell’Irpef viene da redditi di pensione) ma per oltre sei parlamentari su dieci, sondati da Ageing Society italiana, garantire la loro salute è un «dovere oneroso». Non c’è convegno che non li definisca «una risorsa», ma il massimo che la collettività propone loro è un po’ di lavoretti socialmente utili. Come se i pensionati dovessero solo essere aiutati a ingannare il tempo (la parola passatempo, per un anziano, ha un tono vagamente menagramo). Ma in Italia, primato europeo, la speranza di vita in salute supera ormai i 72 anni (e cresce di tre mesi all’anno). L’età media di pensionamento, a dispetto degli sforzi, è salita faticosamente a 58 e mezzo. Dunque chi oggi lascia il lavoro può ragionevolmente contare almeno su una dozzina d’anni di vita energica, attiva, piena. Ma piena di cosa? Dodici anni sono un tempo di vita troppo lungo per spenderlo dirigendo il traffico davanti alle scuole o guardando passare i carrelli della spesa nel corridoio condizionatodiuncentrocommerciale.Dodicianni sono un arco di vita autentica, che autorizza, anzi obbliga a fare progetti, che consente di raggiungere obiettivi personali, magari quelli lasciati nel cassetto in un’esistenza all’insegna del “prima il dovere”; sonouncapitaleditempodainvestireperfino in nuove stagioni del cuore: nel due per cento dei matrimoni italiani almeno uno degli sposi ha oltre sessant’anni. La realtà e le statistiche Il contrasto tra la realtà personalmente vissuta e lo specchio statistico è stridente. Accanitamente perseguita dalla scienza, la longevità è una catastrofe se vista dall’oblò dei conti pubblici. «Gli anziani attivi sono un prodotto maturo del welfare, non la sua patologia», protesta Betty Leone, segretaria nazionale dello Spi-Cgil, il sindacato pensionati che ha appena festeggiato il tremilionesimo iscritto e il sorpasso sull’ex sindacato più forte d’Europa, il tedesco IG Metall; «ma per godere finalmente del loro segmento di vita libera sembra quasi che debbano chiedere il permesso ai giovani». E se si fossero stufati di chiederlo? Se stessero diventando intransigenti, rivendicativi, perfino «SPIetati», come grida il manifesto per il tesseramento allo Spi di Bologna? In Francia un severo libretto di Per realizzare i loro sogni fondano circoli come il Pino Zahar di Trieste, per “non sentirsi solo dei nonni” Régis Debray, filosofo, amico di Che Guevara, consigliere di Mitterrand, oggi sessantatreenne, sta sollevando un vespaio di polemiche: s’intitola Le plan vermeil(il vermiglio, oltralpe, è il colore degli anziani: da noi si tradurrebbe “Il piano d’argento”), e lancia la «modesta proposta» di un ammutinamento senile: andiamocene via da questa società futurocentrica, ossessionata dal corpo giovanile; lasciamo questi eterni ragazzini ai loro miti adolescenziali, emigriamo tutti in Alvernia e lì fondiamo Bioland, colonia della nuova vita, gioiosa e intensa, vietata ai minori di sessant’anni. Provocazione letteraria, stile Swift? Mica tanto. L’Italia in fondo è già piena di piccole Biolandfondate e interamente autogestite da anziani, non per scelta, ma perché non c’è altro modo per non cedere all’emarginazione e alla solitudine. «Tutto quello che vede l’abbiamo fatto da soli», Mario Zancolich fa strada nei quattrocento metri quadri del circolo Zahar, uno dei 1200 circoli associati all’Auser, la più diffusa tra le associazioni ricreative per anziani. Caffè, sale prove, biblioteca, laboratorio informatico, tutto autogestito, tutto autofinanziato con cappuccini e aperitivi. «Il Comune ci delega la questione anziani, e ci chiede pure tremila euro d’affitto». Eppure anche nella canuta Trieste, 105 mila pensionati su 200 mila abitanti, eterna duellante con Bologna e Genova ai vertici delle classifiche di invecchiamento, l’esistenza di un posto così ha del miracoloso. Attorno c’è il mostro di Rozzol Melara, un quadrilatero grigio di duecento metri di lato per diciassette piani d’altezza ribattezzato Spielberg, labirinto inquietante di corridoi deserti, follia dell’edilizia popolare anni Settanta, 630 famiglie arrivate e invecchiate tutte assieme. «Quando entrai io, nel ‘78, il problema era il teppismo dei ragazzini. Ora è la solitudine dei vecchi». Proprio nel cuore del cubo, doveall’inizioc’eraundoposcuola,inuna decina di locali senza finestre, cinque anni fa una ventina di anziani «spietati» ha creato un circolo. «Voi siete matti», dissero in Comune, consegnandogli le chiavi. Ora sono duecento iscritti che s’affollano ai corsi di videocamera creativa, recitazione, drammaturgia, danza-terapia, computer, hanno un paio di compagnie teatrali che vanno in tournée tra Veneto e Slovenia, sono l’unica oasi di vitalità nel deprimente paesaggio del quartiere. «Vengo per non stare in casa»: Angela Noviella, 56 anni, pensionata Alcatel, smacchina in Internet cercando una colonna sonora in Mp3 per lo spettacolo di danza, «chi sta in casa deperisce». Il consumo di antidepressivi tra gli anziani è raddoppiato in dieci anni: sono il terzo farmaco più diffuso tra gli over-60. Per non parlare del sedativo elettronico: «La tivù, grande addormentatrice», solitudine mascherata, cattiva zia che tutte le teste si porta via. In una saletta del circolo stanno montando un distributore automatico di vhs a uso interno, 50 centesimi ogni prestito: «Almeno decidiamo noi cosa vedere». Ma è ancora poco. Bisogna uscire di casa, per non languire. In un altro quartiere periferico e invecchiato di Trieste, Giarrizzole, il dirigente Spi Giorgio Uboni per tutta la scorsa estate ha cercato di sottrarre i coetanei all’abbraccio catodico soporifero e debilitante. «Abbiamo piantato un chiosco in piazza, così, solo per incontrarci, parlare. Ne abbiamo tirati fuori di casa una cinquantina: tutte persone sane, in forze, attive: ma impaurite e diffidenti». Hanno l’incubo delle malattie, e non s’accorgono che il cavallo di Troia del decadimento fisico è proprio la solitudine. «Chi si chiude in casa invecchia prima»: Pino Sfregola infatti non ci sta mai. Piuttosto va sottoterra: ci va una volta alla settimana, infila casco e imbragatura e scende nel ventre del Carso. Può finalmente fare lo speleologo a tempo pieno, a settantun anni suonati, da quando, diciassette anni fa, s’è pensionato. Come ha passato tutto questo tempo, Pino? «Quante ore ha per ascoltarmi?», ride. «Vengono qui per non sentirsi nonne, per accudire un po’ se stesse dopo aver accudito gli altri per sessant’anni», dice delle sue allieve la maestra di danza, Silvia Radin, una ragazzina di 52 anni («ma ho iniziato a lavorare a 14»). Una che ha accudito fin troppo è Eliana Jerman, ex infermiera: «Tutto quel che ci propongono è fare volontariato… D’accordo, ma con misura. Ora che posso, finché posso, vorrei dedicarmi a me stessa». Egoisti? No: auto-risarciti. Il mondo della produzione e del profitto li tratta come vuoti a perdere: «Siamo in coda all’Europa per le politiche di permanenza al lavoro oltre i cinquant’anni», informa Maria Luisa Mirabile, direttrice della Rivista delle politiche sociali, «e il motivo principale è che sono i datori di lavoro a non volere i senior». Ma hanno poi tanta voglia, i senior, di sgobbare ancora? La metà dei lavoratori cinquantenni, ha scoperto un’inchiesta Iress, vuole lasciare il lavoro prima possibile. Del resto, i nuovi anziani sono forse la prima generazione nella storia ad avere trascorso lavorando meno di metà della propria vita. Il Maggio dei sessantottenni Egocentrici per obbligo, per sopravvivenza, più che per orgoglio o ribellione. Ma la pentola della scontentezza coi capelli bianchi sta bollendo. «I veri nuovi vecchi dobbiamo ancora vederli, ma sono già dietro l’angolo», prevede Costanzo Ranci, sociologo, «e saranno radicalmente diversi. I sessantenni d’oggi, nati negli anni Quaranta, «leva dell’industrializzazione», hanno conservato un’etica del sacrificio, del lavoro, della sobrietà, della parsimonia, che fa loro accettare una posizione sociale da “invisibili”. Ma fra pochi anni, anche da noi come già in America, diventeranno anziani i figli del babyboom, la “leva del benessere”, generazione abituata ai consumi, acculturata, ribelle alle imposizioni. Il rischio è questa risorsa venga ghettizzata». Ma i nuovi anziani d’Italia non sono remissivi. Se troveranno le strade sbarrate dall’incomprensione delle generazioni più giovani, forse se le apriranno da soli. La svolta è vicina, forse è già iniziata: i sessantottini sono ormai sessantottenni. Cova un’epoca di rivolte senili, esploderà il radioso Maggio dei nonni? «Basterebbe che facessero valere le carte che hanno in mano», frena Sebastiano Porcu, sociologo coinvolto nel progetto Sage (Supporting active ageing in Europe), «dimostrando che ciò che danno alla società è più di quanto ricevono». Che siano i nonni pensionati a mantenere i nipoti precari, ormai è un’ovvietà di massa. Ma oltre a questa tardiva paghetta, cosa possono dare, gli anziani, ai ragazzini? A Sono, Yane, Zen e Cosimo (nomi d’arte), il circolo Zahar ha dato posto, computer e strumenti per comporre la loro musica. «Hip-hop», spiega Zancolich facendo un po’ finta di sapere cos’è. Sano alza il volume al massimo: «Se a uno piace la musica, gli piace anche questa». Comunque nessuno viene a protestare. I woof sono generosi e pazienti. Del resto, hanno una vita davanti. DOMENICA 27 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 27 CIRCOLO RICREATIVO Nelle foto di questa pagina i frequentatori del circolo Pino Zahar di Trieste. Gli iscritti sono duecento e affollano i corsi di danza, di videocamera creativa, recitazione e informatica. Nel circolo poi c’è anche una biblioteca e i passatempi tradizionali, come le carte e le bocce. Nella foto qui sotto, anziani americani su un campo da golf Nella Disneyland degli eterni ragazzi Y FOTO FABIO CUTTICA/CONTRASTO (segue dalla copertina) es sir, sorride complice Mike l’agente, schiudendo una porta tagliafuoco che si spalanca sul teatrino privato, e poi c’è questo. “Questo” sono le lezioni settimanali di danza, che un gruppo di Fred vacillanti e di Ginger cadenti sta praticando sul palcoscenico. Lei balla?, s’informa garbato Mike. Solo il tip tap, mento per non deluderlo. Abbiamo anche un circolo del tip tap, mi frega lui. Avrei dovuto immaginarlo e ora sono incastrato. Che faccio, firmo? Compero e mi seppellisco anche io qui, dentro uno di questi gusci di lusso dove i vecchi americani vengono per esorcizzare la paura della vita? Era appena passata una bufera di fine inverno sulla Florida, quando ho bussato alla porta dello Spruce Creek Country Club, fingendomi (fingendomi?) un potenziale cliente per una di queste cittadelle per “anziani attivi” che stanno spuntando a migliaia in America, pronte ad accogliere l’assalto dei 60 milioni di baby boomer, dei figli del dopoguerra con abbastanza soldi in tasca e abbastanza complessi da Peter Pan in testa per non volere arrendersi al tempo. Il vento del Sud ovest che aveva spinto via la tempesta sollevava dalla sabbia delle paludi della Florida disseccate dalle ruspe una nebbiolina gialla sottilissima e abrasiva sotto i denti, che sfuocava il profilo del villaggio. Lo sprofondava in una quieta, scolorita malinconia da foto ricordo ingiallita. Non c’erano grida di bambini, liti di amanti, risa di ragazze eccitate a smuovere la nebbiolina sabbiosa del Country Club, riservato, mi aveva avvertito la brochure, a coloro che hanno «55 anni o meglio», nel senso che l’anagrafe dell’illusione deve rovesciare il tempo e convincere i clienti che la vecchiaia è tanto migliore, quanto più è avanzata. Gli anni d’oro Come altri “gusci” identici a questo, riprodotti a centinaia soprattutto negli stati della “cintura del sole” dove le ossa si intiepidiscono, anche questo è stato costruito da una società fondata da uno di quei geni del marketing che l’America produce come nessun altra nazione, dal signor Del E. Webb. Negli anni ’50 e ’60, molto prima che la vecchiaia diventasse l’affare che oggi è, fece per gli anziani quello che il suo contemporaneo Walt Disney stava facendo per i bambini. Costruire città dei sogni, dal nulla, completamente artificiali. Non fu un caso se questo signor Del Webb morto nel 1974, l’uomo che inventò la formula dei golden years, gli anni d’oro per la vecchiezza, era stato l’imprenditore edile che aveva costruito il primo albergo casinò di Las Vegas, il Flamingo, per il mafioso Bugsy Siegel, e poi l’hotel più famoso nella storia di quell’altra città dell’assurdo, il Sahara. Già 46 anni or sono, nel 1959, quando i figli del boom anagrafico erano soltanto “baby” , aveva visto quello che nessuno allora aveva neppure immaginato. Che gli uomini e le donne di «55 anni o meglio» non vedessero l’ora — dopo avere allevato i figli, smerdato il sederino ai nipoti, sepolto i loro vecchi e finito di pagare mutui e affitti — di mandare tutti a quel paese e di chiudersi nella ricompensa dell’egoismo, dopo tanto altruismo. Quando aprì la sua prima Disneyland per artritici, in Arizona, promise ai finanziatori che avrebbe avuto 10mila visitatori e avrebbe impiegato un anno per vendere le 237 villette progettate. Arrivarono 100mila visitatori soltanto nel primo week end. Le villette andarono esaurite prima che il sole della domenica tramontasse dietro i cactus e le mesas di Phoenix. Anche qui, a Spruce Creek, il ruscello della balsa, mi dovrei affrettare, perché, La vita artificiale del villaggio di Orlando, in Florida, dove sono ammessi solo quelli che hanno 55 anni o meglio stronomici tra le signore, con tenzoni di ethnic cooking, fra ex mamme che a casa si erano scocciate di cucinare, ma qui affettano, trinciano e friggono con la furia del rimorso e della nostalgia. Ecco l’abbondanza di piscine, coperte e scoperte, riscaldate e naturali, in una delle quali si possono tuffare anche i bambini, quando i genitori, con la promessa di portarli prima a Disneyworld, riescono a rimorchiarli per una visita ai nonni, ma come sei cresciuta, ma come sei carina, ma come vai a scuola, ma che palle nonna, prima di tornare ciascuno al proprio guscio. Possono trascorrere al massimo trenta giorni all’anno, i parenti se non hanno 18 anni («diciotto anni o peggio?» tento di scherzare con Mike, senza successo). E se qualcuno volesse tenersi, nella propria villetta, i nipotini per 31 o 32 giorni che succede, convocano un plotone di esecuzione e giustiziano l’infame a colpi di putter da golf? «No, purché i vicini non si lamentino del rumore che fanno». Dormi piccolino, dormi, che altrimenti arriva l’orco con la camicetta di nylon a fiori e ti mangia. Non vedo neppure una faccia nera, un uomo o una donna di colore, nella monotonia dei pallori sovrastati da permanenti bluette e da oneste calvizie. «È un caso» si affretta a dirmi Mike, «noi siamo aperti a tutti». Sarà. Scivoliamo in auto, dentro il silenzio sabbioso di questo che sarebbe in fondo il solito, desolante sobborgo americano riprodotto con lo stampino, se soltanto si vedesse ogni tanto un lampo di vita. E per lo shopping, per la salute, come fanno i 5000 che già vivono qui? «Vanno fuori, oltre il muro, oltre il giardino». Sulla statale 27, quella che sale da Orlando, ospedali, cliniche, laboratori, gabinetti medici, pompe funebri (il signor Bruce) si azzuffano come puttane fameliche in un angiporto militare per cercare clienti. Per dieci miglia, sulla statale 27 viaggiando verso l’aeroporto, conto 74 insegne di dentisti, 22 laboratori radiologici, 18 negozi di ottica e insegne di ogni specialità medica (ostetricia esclusa) appresa nelle facoltà e poi mi stanco di contare. FOTO CORBIS VITTORIO ZUCCONI mi informa con ogni premura per le mie coronarie Mike l’agente, il 95% dei 4.500 lotti è stato già venduto nei due anni dall’inaugurazione. Resta soltanto un ultimo spicchietto di terra adiacente la “riserva naturale” per gli animali selvatici lasciato libero per legge, un lembo delle paludi originarie dove qualche anatroccolo occasionale ancora inciampa e qualche alligatore giustamente preoccupato osserva con occhi a pelo d’acqua i nuovi predator umani. Da dove vuole cominciare la visita? s’informa Mike. Dalla clubhouse del golf? No grazie, non gioco. Dalla palestra? No, grazie, non sollevo altri pesi che il mio. Dalla piscina? No, una piscina é una piscina, vista una, viste tutte. Cominciamo dalla bacheca, gli propongo. Mike si stringe nelle spalle. Il cliente, soprattutto quando ha «55 anni o meglio», è un animale bizzarro. Ma dalla bacheca, se quel brav’uomo sapesse che non sono un cliente ma un ficcanaso, mi terrebbe lontano, perché su quel lungo rettangolo di sughero al quale gli uomini e le donne ragno appendono i loro messaggi, è scritta la verità che i dèpliant e i videoclip di coppie festosamente mature non raccontano, la storia della fine. Non ci sono annunci funebri, perché nel villaggio della giovinezza di seconda mano non ci sono ambulatori né cimiteri, è proibito ammalarsi e tanto meno morire, non ci sono anziani malati, degenti, assistenze sanitarie, tonfi e sibili di macchine per la respirazione o patologie visibili che possano inquinare il sogno. Chi se ne deve proprio andare, essendo “migliorato” troppo oltre i 55 anni, viene discretamente portato via di notte, dalle lunghe Cadillac nere del temuto signor Bruce, il più apprezzato dei ben 20 impresari di pompe funebri che si sgomitano sulle pagine gialle locali. Quello che resta il mattino dopo, è la richiesta di un nuovo “quarto” per il bridge, appesa con la puntina da disegno su questa bacheca. È l’annuncio della vendita di un cart da golf divenuto “inaspettatamente disponibile”, di automobili “praticamente nuove” senza più conducente, di piccoli animali, gattini, cagnetti, canarini, pescetti, “rimasti orfani” che cercano adozione, i surrogati, e dunque la incolpevole vendetta, di quei figli dimenticati. Obituaries, annunci funebri per interposto micio, e nessuno più triste di quello di una certa Linda ottantenne, che ha appeso alla bacheca la speranza di trovare un altro dancing partner, ora che il suo «compagno di ballo per mezzo secolo, danza con gli angeli». La voce di Mike, un po’ ansioso e forse insospettito dal tempo che consumo a leggere i piccoli annunci della tenera tristezza, mi trascina via ad ammirare lo splendore della palestra, dove un paio di asciutti vegliardi dai polpacci di ferro pompano sulla cyclette immobile per correre via dal tempo. Le attrezzature di acciaio inossidabile della grande cucina comune, dove si tengono fieri tornei ga- Salgono i prezzi La nuova vecchiaia protetta, curata, longevizzata dalla medicina, viziata dalla giovinezza nell’America della prosperità kennedyana e dall’autoindulgenza degli anni ’70, è il lago di Tiberiade che attira i pescatori di ogni business, dalla ortodonzia ai fabbricanti di quei carriolini da golf carrozzati sport che vedo sciamare ovunque. Ai vecchi, ai vecchi è il grido di battaglia del marketing, delle reti tv, dei pubblicitari delusi dai giovani e dai teen ager che non hanno soldi da buttare. La terza età è il serbatoio del “disposable income” come dicono gli economisti, del reddito disponibile, finita l’emorragia dei mutui, degli studi, di quel racket legalizzato e specializzato in estorsione di genitori ansiosi conosciuto come “college”. Per la finale del campionato di football, il Superbowl, i ricercatori di mercato costretti a spendere due milioni e mezzo di dollari per 30 secondi di spot durante la partita, hanno puntato tutti i loro messaggi sui «55 anni o meglio», La star del supershow nell’intervallo, non era piú una pettoruta signora di colore con il seno all’aria come Janet Jackson, ma era il 62enne Paul McCartney. «Ha tempo fino al 31 marzo per decidersi», mi sollecita Mike seguendomi fino alla macchina a noleggio davanti alla sorta di castello di Cenerentola che segnala l’ingresso nel paradiso del tempo perduto, dietro i cancello di ferro battuto che la notte si chiudono per aprirsi soltanto all’alba (o se deve passare il signor Bruce). «Dal primo aprile aumentiamo i prezzi». Pazienza. Via, via. Scappo con una voglia bruciante di motorini smarmittanti, metallari rock, bambini urlanti, pannolini fetidi, baiadere ignude, martelli pneumatici. Anche mille euro al metro quadro sono troppi, per vivere in un cimitero di vivi. 28 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 la memoria Campagna elettorale Parlare in pubblico non era una forma di comunicazione politica, era più semplicemente la politica. Uno spettacolo che aveva i suoi segreti, i suoi specialisti, come Fanfani, Nenni, Di Vittorio e Almirante. Un rito collettivo che adesso è scomparso Ucciso dalla televisione L’arte perduta del comizio Il gesto scurrile di Bossi Gli oratori, ovvero i “comizianti”. Ha detto una volta Gianfranco Fini che il segreto di un buon comizio è il microfono. Vero. Ma un tempo era la voce, che doveva essere tonante. È da qui, forse, da questa necessità vocale, teatrale e primordiale, che occorre partire per comprendere lo stile ta casistica, un’amena letteratura a proposito di comizi buffi e infamanti. Il senatore Luigi Angrisani, per dire, alla metà degli anni cinquanta caudillo di un partitino che come simbolo recava un gallo, era noto nelle piazze della Campania per presentarsi ai comizi con un gallo, vero, sulla spalla. La leggenda tramanda che il pennuto facesse chicchirichì a comando — ma c’è anche chi dice che a comandare il gallo fosse un crudele congegno elettrico. E tuttavia, a parte l’animale, è sicuro che un bel giorno Angrisani ebbe il cuore di sventolare dal palco, a mo’ di virile trofeo, gli slip della moglie di un suo acerrimo rivale, senatore socialista della Valle di Diano. Così andava, e così forse rischia ancora di andare la politica: ieri sui palchi, oggi in quei luoghi deputati dell’indecenza che sono i talk-show. Per cui Togliatti, ad esempio, che sembrava un sorvegliatissimo professore di liceo, arrivò a promet- Il senatore a vita: rischiai pure di trovare moglie Andreotti: contro i comunisti il fascino della Pampanini GOFFREDO DE MARCHIS C Sandro Pertini aggrediva a freddo uno dei presenti per ravvivare una giornata soporifera. Il senatore Angrisani invece si presentava con un gallo sulla spalla, che cantava a comando LA MORTE DAVANTI ALLA FOLLA Nelle tre foto sopra, dall’alto in basso: un comizio di Alcide De Gasperi dal balcone della sede romana della Democrazia cristiana in piazza del Gesù; Sandro Pertini parla in piazza del Duomo a Milano il 26 aprile 1945; Giovanni Berlinguer, colpito da malore in piazza delle Erbe a Padova il 7 giugno 1984, viene portato a braccia giù dal palco. Morirà quattro giorni dopo ROMA on un comizio aveva anche trovato moglie, anzi due. E se non ne avesse avuta già una, chissà come sarebbe finita. «Parlai in un piccolo comune del Viterbese e i frati cappuccini della zona mi scrissero una bella lettera. Avevo fatto una buona impressione e mi avrebbero dato il voto. Aggiunsero una postilla: “Onorevole, le vorremmo presentare due ragazze in età da marito”. Risposi: “Vi ringrazio, ma sono sposato da sette anni”». Giulio Andreotti ricorda l’epoca dei comizi «con molta nostalgia. Guardavi la gente negli occhi, sentivi l’umore. A volte partivi in un modo e poi eri costretto a rettificare il tiro...». Amarcord, c’era una volta. «La televisione ha messo a terra il comizio. Ormai esistono solo le tavole rotonde, i convegni e naturalmente la tv». Durante un tour elettorale in Ciociaria, si portò dietro Silvana Pampanini e lanciava pagnotte dal balcone. Era anche quello un buon sistema per conquistare consensi? «Mai lanciato pagnotte, è una leggenda. Lo dissero i comunisti ai quali rubammo la scena. Era la campagna per le elezioni del 1953, un voto infuocato. Il Pci aveva organizzato a Sora un festival di musica leggera con artisti internazionali. Internazionali si fa per dire, secondo me erano di Frascati... Noi rispondemmo con la Pampanini. Beh, la Pampanini fu portata in trionfo, tutti la volevano vedere. E toccare... Lei smarrì un orecchino e io le feci un regalo quando tornammo a Roma. Fatto sta che la gente dimenticò il festival organizzato dai comunisti». La sua prima volta in piazza? «Poche settimane dopo la Liberazione, nel ‘46, a Lanuvio, un paese vicino Roma. Mi sentivo un naufrago perché non ero abituato a intervenire in pubblico. Ed ero tutto incriccato: io sono già curvo di natura, ma quel giorno feci un viaggio di quaranta chilometri su una di quelle motociclette a tre ruote, seduto dietro...». Qual è il segreto di un buon comizio? «La cosa più importante era rispondere bene alle interruzioni. La gente partecipava, contestava. Una volta, dalla folla uno mi gridò: “Agrario”. Io ribattei: “Non lo sono perché non possiedo terreni, ma lo prendo come un augurio”. Era il giorno in cui mi notarono quei frati cappuccini». La “piazza” più calda? «Nel ‘72 parlai a Napoli, piazza Plebiscito era stracolma. E i napoletani sono molto più caldi dei romani, rimasi impressionato». Fra i grandi oratori c’erano anche i democristiani? «Tenevamo bene la piazza. Certo, Nenni era un grande trascinatore. Togliatti meno, era più razionale e il clima che lo circondava era molto disciplinato. Pajetta era bravissimo alla radio e mi spiegò che aveva frequentato una scuola di dizione. A quell’epoca sembrava strano, ma aveva ragione lui». Lei è diventato anche un personaggio televisivo. Significa che non è molto diverso parlare in pubblico o davanti a una telecamera? «È molto diverso. A un comizio tu parli con gente che sta ferma lì. Mi ricordo le vecchiette che venivano con le sedie e io a volte mi arrampicavo su un tavolino per farmi vedere meglio. Un comizio ha più toni, in tv il messaggio dev’essere semplice e chiaro. Perché nelle case ti guardano distrattamente: squilla il telefono, bolle il latte, il ragazzino deve fare la pipì. Inutile dire che il comizio è più affascinante». Le regole sono completamente diverse? «La battuta pronta ci vuole sia in tv che in piazza. Feci una tribuna televisiva da presidente del Consiglio, quelle che andavano in onda il venerdì sera, ultimo giorno di campagna elettorale. Pavolini, un giornalista dell’Unità, mi attaccò: “Avete fatto poco e quel poco lo avete fatto solo perché vi abbiamo spinto noi comunisti”. Gli avrei dovuto rispondere con i fatti: crescita economica, tasso di disoccupazione... Insomma, ero lì in veste di presidente del Consiglio, non di dirigente di partito... Invece usai la tecnica dei comizi: “Allora potevate spingere un po’ di più”. Una colpo secco, andò bene. La televisione è uno strumento complicato, sei in diretta e devi stare attentissimo a quello che dici». Nei comizi, no? «C’erano più margini di manovra, più tempo per spiegare. Intendiamoci, in pubblico bisogna stare attenti lo stesso. La scorsa settimana, per esempio, sono andato a parlare in una scuola elementare di Milano. Qualche domanda dei bambini era suggerita dai maestri, ma altre erano spontanee. Un fuoco di fila. Mi sono divertito. Quasi come a un comizio». FOTO PUBLIFOTO Le manette di Adele Faccio E per ognuno che abbia più di quarant’anni, c’è almeno un comizio che resta impresso nel cuore. Si pensi all’intensità drammatica dell’ultimo Berlinguer, a Padova, 7 giugno 1984, piazza piena e allegra, poi il volto contratto sui maxischermi, «e all’improvviso — ha ricordato lo scultore Elio Armano — l’atmosfera è virata dal bianco al nero, istantaneamente, come una foto quando la sviluppi». Oppure si pensi ad Adele Faccio che all’Adriano offre i polsi al commissario di Ps, brillano le manette mentre Pannella commenta l’arresto in diretta. O all’esordio di Giorgio Almirante ai funerali di Mantakas: occhi gelidi, voce metallica: «Romani — pausa — questo non è un comizio, è un rito!». Impossibile individuare con precisione l’inizio della crisi rituale, appunto, il punto di frattura, l’indebolirsi dell’impatto emotivo e persuasivo del comizio dal vivo. I primi segni, forse, alla metà degli anni settanta; gli sforzi della Dc di riempire le piazze ai tempi del divorzio; scenette a loro modo emblematiche come quella che vide l’onorevole Granelli zittito da una vecchietta, a Trieste: «Ma che ne vuoi sapere tu di cazzo e fica?»; o il flop finale di Fanfani a Roma, di cui si parla nel recente Piazza del Gesù di Peppe Sangiorgi (Mondadori) come di un evento certamente traumatico, ricordando che per quell’occasione erano state arruolate la bellezza di 35 bande musicali. E certo che se ne fanno ancora, oggi, di comizi. Magari con Bocelli e Clarissa Burt come madrina per l’Usa day. Eppure il raduno cerimoniale appare irrimediabilmente a rischio, o in disuso, per non dire che è tenuto in dispregio dall’attuale classe politica. O almeno: appare per lo meno significativo, se non altro dal punto di vista del linguaggio, che giorni orsono Pierluigi Bersani abbia accusato un avversario (Tremonti) di tenere «comizi della domenica». E quando se no? Era quello il giorno dei comizi, come da poesia di Rocco Scotellaro: «La città si è riunita nelle chiese e nei teatri/ a battere le mani...». Le mani del pubblico, ma anche gli occhi ben aperti, le bocche serrate, le orecchie dritte, ciascuno pronto a scattare nell’applauso, «e le donne preparano già il grido più forte./ Avviene al nostro comizio volante/ come quando un uomo cade sui suoi passi/ e i marciapiedi si svuotano in quel punto./ Noi pure così protesteremo ai divini potenti/ come la grandine schiaffeggia la terra». E c’era in effetti da considerare anche una valenza climatica, oltre che sensoriale, per il comizio perfetto: da tenersi in “piazzaiolo”, e quindi semplice, ma al tempo stesso enfatico, colorito, vibrante, non di rado cedevole alle lusinghe della più scoperta demagogia. Roba da uomini, comunque, perché il comizio è irredimibilmente maschio, e tanto lo è che fra i suoi epigoni merita senz’altro di essere annoverato Umberto Bossi, l’inventore dello slogan «la Lega ce l’ha duro», e del quale qui non si può fare a meno di ricordare la performance, pure con coreografia fallica, tenuta in un caldo e umido capannone della campagna bergamasca, ai danni della Margherita Boniver. E insomma la sventurata aveva detto qualcosa sul pericolo che la Lega scegliesse la lotta armata, e allora il senatùrappoggiò il gomito sulla balaustra del palco, e tenendo alzato il braccio nudo prese a roteare il pugno accompagnando il movimento con voce roca: «Ah, bonassa! Sì, siamo armati, ma di questo qui!». E naturalmente c’è tutta una straluna- ratore rosso. A Napoli, confusi tra la folla di piazza Plebiscito, poteva capitare che i missini liberassero centinaia di topolini, creando il dovuto panico. E se don Camillo, nei romanzi di Guareschi, scioglieva le campane proprio quando Peppone incominciava a parlare, beh, nel 1953, ai tempi della campagna elettorale contro i “forchettoni”, giusto in prossimità dei comizi dc i comunisti facevano lentamente salire in cielo dei palloncini da cui pendevano enormi forchette di cartone. Il pubblico si distraeva; gli oratori non potevano far finta di nulla. FOTO AP A h, chi se li ricorda più i bei comizi di una volta! Mai così pochi, in quest’ultima campagna elettorale, mai così poco affollati. E allora tanto vale abbandonarsi alla nostalgia, e tornare per un attimo sotto i mille e mille balconi delle piazze e piazzette d’Italia, nei cento e cento cinema Astra e teatri Verdi, sui palchetti e perfino sui camioncini. Perché c’erano comizi all’aperto e al chiuso, “di mercato”, “di vicolo”, “di caseggiato”, oltre che “volanti”: e a proposito della varietà motorizzata vada un pensiero ai poveri oratori dell’Unione dei comunisti italiani (ml) che votati alle più assurde tabelle di marcia, andavano famosi per montare gli altoparlanti nei posti sbagliati, nelle ore sbagliate, e parlavano al nulla. Non era una forma di comunicazione politica, il comizio. Era, più semplicemente, la politica. Ma ci si andava come a uno spettacolo. Nel 1954 Leonardo Sciascia arriva in corriera ad Agrigento per sentire Fanfani: «Nella piazza della stazione c’era un gran palco; una prora di nave pareva, tutta fitta di lampade, a due piani (...) Quando Fanfani apparve sul palco, e sventolava un fazzoletto bianco, ci furono cinque minuti di urrà. Poi attaccò: tirò fuori un foglietto, otto domande che i comunisti gli avevano rivolto, disse che democraticamente avrebbe risposto. Alla prima disse che c’era una sola risposta da dare, il titolo di un’opera di Leoncavallo: Pagliacci». Ma i comizi potevano anche ispirare poesia. Ne Le ceneri di Gramsci Pier Paolo Pasolini descrive una manifestazione missina: «Una smorta folla empie l’aria/ d’irreali rumori. Un palco sta/ su essa, coperto di bandiere,/ dal cui bianco il bruno lume fa/ un sudario, il verde acceca, annera/ il rosso come di vecchio sangue. Arista/ o tetro vegetale guizza cerea/ nel mezzo la fiammella fascista». un giorno né troppo caldo, né troppo freddo, ma soprattutto un giorno senza pioggia. C’era una tecnica, c’era una sapienza, c’era perfino una scienza, tanto che il professor Andreatta, prima di fissare una data, consigliava agli organizzatori di riguardarsi il bollettino meteorologico dei sette anni precedenti. Ma c’era anche disincanto, e scaramanzia. Nenni, per dire, diffidava delle folle eccessive, mai illudersi: «Piazze piene, urne vuote» scuoteva la testa con sperimentata e personalissima amarezza. E comunque tutto poteva succedere, in piazza. In verità era soprattutto un’arte a rischio, il comizio: ma un’arte, a suo modo altrettanto fantastica, era pure quella di disturbare i comizi degli avversari. A Bologna i più anziani ancora ricordano i “frati volanti” che i Comitati civici, con la benedizione del cardinal Lercaro, spedivano sotto i palchi con l’obiettivo di confutare rumorosamente le tesi dell’o- FOTO OLYCOM FILIPPO CECCARELLI DOMENICA 27 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 29 FOTO REPORTERS ASSOCIATI “VOTA ANTONIO VOTA ANTONIO” L’ONOREVOLE TOTÒ Il film si intitola “Gli onorevoli”, diretto da Sergio Corbucci, con Totò, Peppino De Filippo, Walter Chiari, Gino Cervi. Totò è Antonio La Trippa, che partecipa alle elezioni come rappresentante del Partito nazionale della restaurazione, e che sveglia all'alba i suoi coinquilini urlando dalla finestra con il megafono: “Vota Antonio, vota Antonio” tere calci nel sedere a De Gasperi; mentre il giovane Andreotti, che nei suoi giri elettorali in Ciociaria si portava dietro la Pampanini (per l’entusiasmo le sparì un orecchino) venne accusato dall’Unità di aver lanciato dal balcone pagnottelle, divertendosi poi a guardare la zuffa che si sviluppava. Così come, sempre sul piano dell’inevitabile degenerazione comiziale, altri pure rispettabili padri della Patria a tal punto recitavano da sciogliersi regolarmente in lacrime, come l’oratore politico di Trilussa: «E lì rimise fora l’ideali,/ li schiavi, li tiranni, le catene,/ li re, li preti, l’anticlericali.../ Eppoi parlò de li principi sui:/ e allora pianse: pianse così bene/ che quasi ce rideva puro lui!». Si contano sulle punte di una mano, dopo tutto, i grandi del comizio, eleganti interpreti dei loro stessi personaggi, non guitti da sceneggiate ed effettacci. Di sicuro era bravo Almirante, non a caso figlio e nipote di attori. E Pertini, insuperabile FOTO AGF I PERSONAGGI FOTO ANSA AMINTORE FANFANI Toscano di Pieve Santo Stefano, Fanfani è stato uno dei politici democristiani più rappresentativi del dopoguerra. Per cinque volte presidente del Consiglio, più volte ministro, muore nel 1999 a 91 anni FOTO AGF GIUSEPPE DI VITTORIO Nato a Cerignola nel 1892, dirigente del Pci, è il leader storico della Cgil che inizia a guidare in clandestinità negli anni Trenta. Muore a Lecco nel 1957, dopo un incontro con i delegati sindacali FOTO ANSA PIETRO NENNI Nato a Faenza nel 1891, è uno dei padri storici della sinistra e del Partito socialista italiano. Negli anni del primo centrosinistra diventa vice premier e ministro degli Esteri. Muore il primo gennaio del 1980 GIORGIO ALMIRANTE Nato a Salsomaggiore nel 1914, ha aderito alla Repubblica sociale di Salò per poi diventare nel dopoguerra leader della destra italiana e segretario del Msi. Muore il 22 maggio del 1988 nel rianimare il comizio soporifero, come racconta il giornalista Stefano Scansani nel suo Politica, brutta bestia (Tre lune, 2001): individuava qualcuno lì presente, anche dei suoi, e lo aggrediva a freddo; una sera prese di petto il segretario della federazione di Mantova che parlottava alle sue spalle: «Ecco, dimmi tu, compagno, se m’è consentito di proseguire il comizio con te che mi parlotti da tergo, suvvia!». E sempre più rabbioso scattava porgendogli il microfono: «Ecco, vai avanti tu che hai più lingua, perdio!». Poi Nenni, la cui oratoria di piazza, secondo lo storico Giuseppe Tamburrano, aveva al contrario di Pertini la regolarità ritmica di un esercizio di solfeggio, da potersi addirittura misurare con il metronomo: «Cari compagni — tic toc — ve lo spiego io — tic toc — cos’è — tic toc — il socialismo!». Tic toc. Ma sopra tutti eccelleva nell’arte del comizio Giuseppe Di Vittorio, l’agitatore di Cerignola divenuto leader del sindacalismo comunista, capace di suscitare la più prodigiosa identificazione con le masse: «Quando parlava — ha scritto Davide Lajolo — stava con te non solo con gli occhi». Ascoltandolo, chiunque del suo mondo pensava che avrebbe parlato così, dicendo quelle stesse cose, nello stesso modo, con le stesse parole. È del resto, il comizio, un’esperienza emotiva quasi sconvolgente anche da parte dell’oratore, quanto di più simile a uno stato di trance, o a una rivelazione del numinoso. Lo fa capire Achille Occhetto nella sua autobiografia Secondo me (Piemme, 2000), ricordando ciò che provò intervenendo ai funerali di Togliatti, in piazza San Giovanni, di fronte a un milione di persone: «All’improvviso il silenzio totale, rotto solo dai singhiozzi, si squarciò in un boato che sembrava venire dal fondo della piazza e che come un’immensa onda rotolava maestoso fino a infrangersi sui rostri del palco. Non proverò mai più — confessa — una simile impressione. Quella di aver dato voce, attraverso una evocazione magica, quasi medianica, a un sentimento così vasto». Poi senza che nessuno lo proclamasse, tantomeno in piazza, la politica smise di affacciarsi dai balconi, staccò i fili degli altoparlanti, smontò i palchi nelle piazze, ripose le bandiere. E cominciò a vivere e ancora di più a rispecchiarsi nella televisione, anche se in realtà, a pensarci bene, ancora una volta il cinema era stato anticipatore. La lezione di Walter Chiari È del 1963 Gli onorevoli, film a episodi di Sergio Corbucci. C’è qui un comizio di Totò, da una finestra, con un rudimentale megafono di latta: «Vota Antonio, vota Antonio». Ma c’è anche — e qui la pellicola si fa profetica — un Peppino De Filippo, candidato del Msi, che a Tribuna politicacomincia a parlare come ha sempre fatto in piazza: «Camerati!». «Alt!» lo interrompe subito Walter Chiari, nei panni di un regista un po’ effeminato, «Alt!». E dice una cosa molto vera: «Guardi che lei qui non parla ai suoi, lei è in televisione, lei parla a tutti». Non c’è nemmeno bisogno di ricordare la lezione di McLuhan sul mezzo che è il messaggio. Più che uccidere il comizio, la tecnologia del piccolo schermo l’ha stravolto, esteso, moltiplicato e triturato fino a renderlo irriconoscibile. Due anni dopo Gli onorevoli, nel 1965, la Rai inaugurò un ciclo in cui ciascun partito metteva in onda un proprio comizio. Si videro così Malagodi, il “comandante” Achille Lauro, Pajetta, il missino Tripodi che se la prendeva con i capelloni, Forlani da una palestra, Nenni al Quirino interrogato da Biagi, Zavoli e Silone con Sophia Loren fra il pubblico. Si videro, appunto. Ma non scaldavano, erano lontani, immateriali, fantasmatici. A distanza di quarant’anni il comizio sopravvive come un residuo di gloriosa dignità, però adattabile al nuovo. C’è oggi Berlusconi che cammina sul palco avanti e indietro, microfono in mano, stile convention o scuola quadri d’intrattenimento sulle navi. Può dire tutto e il contrario di tutto, ormai, il Cavaliere. A Olbia, nel maggio del 2002, ha rifatto le corna, parlato di supposte, affrontato il tema della sua vita sessuale. «So che state costruendo un porto per barche da 50 metri — ha concluso sorridendo — Ma la mia non ci sta». Quindi si è congedato: «Ora dobbiamo andare tutti a casa. Vorrei dire: a vedere Canale 5. Ma non posso per via del conflitto d’interesse». E insomma, tra nostalgia e studi televisivi si comincia con un requiem e si finisce con uno sketch: ah, come è destinato ancora a cambiare, il comizio. 30 LA DOMENICA DI REPUBBLICA Tempi moderni FOTO CGE oro no. Non ce l’hanno. Non l’hanno mai avuto, non lo vogliono e non lo compreranno. Se glielo regalano, lo regalano a loro volta e senza neppure aprire la scatola. Niente protesi dell’onnipotenza. Niente aggeggio per il controllo universale (non degli altri, ma degli altri su di noi). Niente moltiplicatore d’ansia. Niente quadratino pieno di parole, Mercurio alato di chissà quali novità o sventure. Niente trillo che pare un concerto di orchestre tascabili. Niente messaggini. Niente videochiamate. Niente voce che dice «l’utente non è raggiungibile, si prega di riprovare più tardi». Con loro, invece, si prega di non provarci mai più. Sono i resistenti al telefonino. I senzacellulare. MinoLA SCHEDA SEGRETA ranza silenziosa che infatti non squilla, pur possedendo ragioni che vibrano. Lo fanno, spiegano, come forma di libertà. Per riprendersi il tempo. Per non farsi trovaALBERTO ZIPARO Professore universitario re. Per non cercare e non essere cercati. Per non rispondere alla fatidica domanda: dove sei? E a te che ti frega? Mica facile trovarli, niente comodo chiamarli: non hanno il cellulare, dove diavolo li cerchi? Nel mondo ci sono un miliardo di telefoni portatili, e se ne vendono 550 milioni all’anno (in Europa, solo gli inglesi ne hanno più di noi). In un paese come l’Italia, con 48 milioni di telefonini nel 2004, poco meno di uno e mezzo a LA MALEDIZIONE testa esclusi neonati e ottuagenari, i senzacellulare sono quasi una realtà da museo del silenzio. Ne abbiamo scovati e scelti cinque: ascoltiamo la loro voce, in diretta, FERDINANDO CANAVESE Primario pediatria dal vivo. Al massimo, un po’ gracIl critico letterario chiante da un telefono fisso. Giovanni Tesio, italianista, scrive di libri e insegna letteratura moderna e conIl primario temporanea all’Università del PiemonFerdinando Canavese è un medico pieno te Orientale. Gli piace, confessa, non di lavoro. È responsabile della chirurgia farsi trovare. «È una forma di libertà, e pediatrica e della Dea all’ospedale infannon è vero che si perdono occasioni fontile “Regina Margherita” di Torino. «Mai damentali: quelle, proprio perché hanavuto il cellulare e vivo benissimo, come no bisogno di più tempo, arrivano lo benissimo ha vissuto l’umanità per mistesso o non arrivano mai. Il cellulare è lioni di anni. Si tratta di un oggetto abusaun moltiplicatore d’ansia, me ne accorto, ormai non serve solo per parlare ma io go osservando chi lo usa: parlano e guarho quasi sessant’anni, e per me il telefono dano ossessivamente il coso, aspettanè una cosa che trasporta la voce e stop. do chissà quale messaggino che cambi Credo che il portatile sia la benedizione di la vita. Non è un bello spettacolo. Una chi cerca e la maledizione di chi è cercato. volta si faceva con l’orologio, che io inVedo queste madame in auto, in centro: fatti non porto: è anche una forma di liguidano e parlano, ovviamente senza aubertà del corpo, non voglio trasportare ricolare. Non nego che possa essere cooggetti, non ho la catenina e sopporto a modo, infatti mia moglie ce l’ha, e io a volfatica il portafoglio. Le novità tecnologite ne approfitto: ma ho dato il numero solo alla fidata caposala. Se avessi anch’io il che non mi incuriosiscono, avevo detto “mai dire mail”, poi ho capitolato accorcellulare, immagino che in vacanza mi gendomi che può servire. Anche il techiamerebbe l’amico dell’amico per dirlefonino, beninteso: infatti scrocco le mi che il suo bambino è caduto in spiagchiamate, con parsimonia. A me piace gia e ha picchiato la testa contro l’omnon farmi rintracciare, e lavorare con brellone, e adesso ha la fronte un po’ roslentezza. Amo mantenere le distanze e sa, e cosa deve fare... Ho due figli di 26 e 31 non essere invaso, preferisco tenermi anni, il più grande è senza cellulare, forse un po’ a lato delle cose. Certo è dura: nei l’ho contagiato, non so. Chi lo usa non è bar, i telefoni pubblici non esistono più sicuro, è solo più preoccupato. Certo quasi più, ma la resistenza non è mai coè difficile farne senza, visto che le cabine sono quasi sparite. Il direttore generale moda. Credo che il telefono portatile abbia risvolti psicologici e filosofici, un dell’ospedale prova a convincermi, insipo’ perché l’uso dell’oggetto muta il ste ma io resisto. E convivo col fastidio di soggetto, un po’ perché risponde al bisentire gli squilli in treno, tremendi, opsogno di controllo che si riduce all’essepure allo stadio quando un deficiente re controllati. C’è anche da riderne. Un chiama l’amico per dirgli che c’è appena mio amico si stava confessando per la stato il gol. Mah». comunione della figlia, era in convento e durante il sacramento squillò il cellulare del frate, dall’altra parte della grata. Costui chiese scusa e poi rispose, chiac- ‘‘ A quelli che insistono dico di avere il telefonino segreto: cioè la scheda. Parla solo quando decido io FOTO ALESSANDRO CONTALDO PHOTONEWS ‘‘ ‘‘ Il cellulare è la benedizione di chi cerca e la maledizione di chi è cercato: io vivo benissimo senza nei vari uffici, e gli spostamenti legati al mio lavoro forse giustificherebbero il possesso del cellulare. Invece no: così riesco a filtrare le chiamate, a selezionare. Ascolto le mie numerose segreterie telefoniche, tutti possiedono i miei numeri, però poi scelgo io con chi riparlare. Ogni due o tre ore controllo, taglio, richiamo. La rete delle relazioni professionali e umane non ne risente per nulla, anzi: i rapporti veri si intensificano, quelli fittizi svaniscono all’istante e senza scocciature. Le persone che mi cercano le richiamo quasi sempre al cellulare, e non mi sento incoerente perché non sono ideologico rispetto a questo, e neppure snob. È solo una comodità, una forma di protezione contro le parole vane che ci stanno invaL’ARTE DEL VIVERE LENTI LE OCCASIONI IMPORTANTI dendo. Un fatto di libertà. E non credo sia così vero che nei luoghi pubblici, o meglio nei nonluoghi che finiamo per frequenLAURA COLOMBO GIOVANNI TESIO tare spostandoFisioterapista Critico letterario ci, le stazioni, gli aeroporti, i telefoni pubblici siano spariti. Anzi, è bellissiI NUMERI mo vedere una batteria di dodici telefoni liberi alla stazione Secondo l’ultima ricerca Termini: prima Eurostat, il 91% degli dell’epoca del italiani possiede un cellulare cellulare, era impensabile. Mia madre è anziana e insiste, è rimasta l’unica ormai, vorrebbe che mi comSono i telefonini venduti in Italia, prassi il telefoniquasi uno per ogni residente. Gli no per potermi utenti sono 41 milioni sempre raggiungere, forse si sentirebbe più LA PROFEZIA sicura ma io mica l’abbandono. E poi mi piace scherzare, dico a tutti che posIl 18% degli italiani non ha più siedo il telefonilinea fissa. Tre milioni le famiglie no segreto. Cioè che hanno solo il cellulare la scheda, ogMARIO CAPANNA getto più comoEx leader politico do da portare, più sottile e sida suicidio. Come capirete, io non ho lenzioso. Parla solo quando decido io». neanche la segreteria telefonica e prediliIl 43,8% delle famiglie italiane go la voce umana: peraltro è facilissimo La fisioterapista possiede più di un cellulare. Un Laura Colombo è una mamma quarantrovarmi, visto che sto sull’elenco telefoprimato per l’Europa tenne di due figlie, una piccola e senza celnico dell’Umbria. Il cellulare è un bisogno lulare, una più grande con. «Il papà le disindotto di questi tempi sciocchi, forse la se che è come un albero dai tanti rami, e causa non ultima del rincoglionimento con i suoi soldi poteva decidere se comgenerale: è provato che le onde magnetiprarsi le scarpe nuove, se pagare la rata deche non fanno benissimo ai neuroni. Un gli scout oppure acquistare il telefonino. po’ mi sento un profeta, perché l’avevo Lei ha scelto il telefonino e mi chiede cosa capito dall’inizio e me ne vanto: gli amici La metà di quelli che hanno un aspetto a comprarmene uno. Non succepossono testimoniare, nessuno di loro cellulare lo usano per non più di derà mai. Chi mi vuol bene e mi fa dei remai si sognerebbe di regalarmene uno. Io 10 minuti al giorno gali, sceglie libri. Io e mio marito Felice non so che se ti cercano davvero, ti trovano: vogliamo essere trovati, rintracciati, e la chi mi conosce, sa quando sono a casa e sera stacchiamo anche la linea fissa. quando può telefonarmi, oppure venirQuando vado in pullman, sento squilli inmi a trovare. C’è anche l’altra faccia della visibili nelle tasche di gente muta. Cominmedaglia, cioè il bisogno di chiamare chierando tranquillamente. Accadde ciano a frugare, ansiosi, finché il prescelto qualcuno sul famigerato cellulare: e vado due volte nella stessa confessione». trova il suo oggetto, proprio quello. Dieci in bestia quando sento la voce della sisecondi dopo, la scena si ripete e le parole gnorina, quando non c’è campo, quando Il leader che seguono sono assurdamente vuote: cominci a parlare e poi salta la comunicaMario Capanna, voce più ascoltata del “Ciao, siamo solo a Nichelino, stiamo arrizione per una galleria, una montagna o ‘68 italiano e oggi presidente del consiglio vando”. Embè? Senza telefonata, non archissà che altro. Non è da mentecatti rendei Diritti genetici contro Ogm e biotecrivavano? E poi quella domanda terribile: dersi prigionieri di una cosa simile? I ritnologie, risponde da un telefono fisso dove sei? Io non voglio dirlo, scusate. Facmi dell’uomo devono essere umani, altrinella sua casetta in Umbria. «Senza cellucio la fisioterapista e abito fuori Torino, menti è finita. Guardo i poveretti che parlare si sta divinamente, perché è una terpuò succedere che si rompa l’auto e che un lano per strada, o nel pullmino all’aeroribile seccatura dover avere un rapporto cellulare serva davvero, però rifiuto l’ipoporto, e intuisco una profonda solitudine minuto per minuto con un aggeggio tectesi: dopo, diventerei prigioniera di quella interiore che ci si illude di superare così. nico. Se decidi che ti può essere utile anbreve comodità. Non ho neanche il banPiù chiacchieri e meno pensi, eppure soche solo una volta, cosa che corrisponde comat, non ho la tessera prepagata del suno ottimista, la gente capirà e tornerà inal vero, sei fregato per sempre: è la carapermarket. Voglio riprendermi il tempo, dietro, sarà come smettere di fumare». mella che prepara il veleno. C’è gente che con lentezza. Scrivo ancora a mano, non Il professore se lo porta anche in bagno, c’è chi resta a ho l’e-mail, scrivo lettere. Immagino la Alberto Ziparo, cinquantenne, insegna guardarlo per ore, muto, aspettando la faccia di chi le troverà nella sua buca, all’ourbanistica e pianificazione ambientale svolta esistenziale. Ma pensate come mi dore della carta e dell’inchiostro, alle maall’Università di Firenze, ma vive a Reggio sentirei se mi trillasse una tasca mentre ni che l’apriranno. Non c’è paragone». Calabria. Lavora come docente e consusto qui, adesso, a decidere quale rametto lente un po’ in tutta Italia, eppure riesce a potare del melo o dell’ulivo. La crisi psifarlo senza trilli tascabili. «Ammetto di chica sarebbe letale. Oppure sei lì che stai avere a disposizione molti telefoni fissi scrivendo o pensando, e l’affare suona: Voglio riprendermi il mio tempo, con lentezza. Scrivo ancora a mano, scrivo lettere, non mando mail FOTO ALESSANDRO CONTALDO PHOTONEWS L TORINO La tribù superstite dei senzatelefonino ‘‘ Non è vero che si perdono occasioni: quelle fondamentali arrivano lo stesso o non arrivano mai ‘‘ Ho capito sin da subito che è un oggetto inutile: chi mi conosce sa come, dove e quando trovarmi FOTO FOTOGRAMMA MAURIZIO CROSETTI Un primario, un critico letterario, un ex leader del ’68, un professore universitario e una fisioterapista: persone normali, con lavori normali che hanno deciso di fare una cosa speciale: vivere senza cellulare. Una minoranza, certo, ma molto motivata e decisa a non arrendersi FOTO ALESSANDRO CONTALDO PHOTONEWS le storie/1 DOMENICA 27 MARZO 2005 91% 57mln 18% 43,8% 50% DOMENICA 27 MARZO 2005 le storie/2 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 Restauri creativi Quattro anni fa l’italo-svedese Daniele Kihlgren si è innamorato dell’aria tersa e delle antiche case di Santo Stefano di Sessanio, sulle pendici del Gran Sasso. Oggi, dopo quattro milioni di euro spesi, un borgo dove erano rimasti solo 70 abitanti sta per diventare un rivoluzionario “villaggio-albergo” insieme medioevale e modernissimo L’uomo che rifà i vecchi paesi ANTONELLO CAPORALE L’ S. STEFANO DI SESSANIO uomo che compra i paesi è giovane, nemmeno quarant’anni. Biondo, il padre è svedese, la mamma milanese, ha il passo scapestrato e le voglie di un figlio di papà. Più che camminare è come se dondolasse, più che spiegare, domanda: «Cosa te ne sembra?». Daniele Kihlgren iniziò nemmeno quattro anni fa a chiedersi come spendere i soldi di famiglia, come investirli, tenerli al riparo dalle sue mani e dalla sua testa votata alla speculazione filosofica più che al mercato immobiliare. Se lo chiedeva senza sapere cosa rispondersi. Se lo chiedeva e intanto viaggiava sulla sua moto tra le montagne dell’Abruzzo remoto e sacro. Capitò per caso, ma nella vita quasi tutto accade per caso, in un borgo dalla luce abbagliante, costruito sulle pendici del Gran Sasso, integro nella sua struttura, persino maestoso come villaggio d’altura. Fermandosi e oziando, come un viaggiatore sfaccendato, vide che a Santo Stefano di Sessanio le pietre, quelle pietre, custodivano niente: dei tremila abitanti originari, soltanto settanta resistevano alla neve dell’inverno. Nessun gatto, qualche cane sì. Daniele s’infatuò del nulla, di quel paesaggio dalla luce viva, di quelle case dritte e fredde, le masserie, le tavole per pavimento, gli attrezzi di montagna. Avendo qualche spicciolo in tasca decise di acquistare una casetta: «Me la vendettero a sessantamila lire al metro quadrato. Io comprai senza sapere cosa farne, mi piaceva troppo». Memoria delle pietre Piaceva troppo, e questo gli bastò. Perché prima una, poi un’altra, poi un’altra ancora, il giovanotto finì per riempire la busta della spesa e trovarsi in mano un intero quartiere per qualche milione di lire. Puro e semplice diletto. Aveva optato, in luogo di un viaggio alle Maldive, per questo condominio abruzzese. Nella vita a volte si incontrano le persone giuste. E a questo ragazzo intrigato dalla memoria delle pietre capitò di fare la conoscenza di un architetto pescarese, Lelio Oriano Di Zio, che aveva battuto l’Abruzzo in cerca di borghi da restaurare. Li aveva trovati e proposti ad acquirenti sempre disattenti. L’architetto col pallino del vecchio capì presto che, se voleva campare, doveva disegnare il nuovo. «Solo villette a schiera mi chiedevano. E io le facevo. A volte venivano belle, a volte brutte». Finalmente l’architetto s’imbatte in Kihlgren, nel milanesone con la motocicletta e i soldi. Gli spiega cosa si sarebbe potuto fare, gli dice quanto avrebbe potuto rendere quella pazzia. «Mi affascinò subito — ricorda Daniele — e presto dovetti decidere se affidarmi totalmente a lui oppure cambiare strada. Avevo già comprato qualcosa, l’idea mi elettrizzava e così decisi presto cosa fare. Presi Lelio e gli dissi: io mi affido totalmente a te. Tu pensa a come tirar fuori la vita da queste case, ed io ci metto i soldi». Quattro anni fa successe questo. Dopo quattro anni e quattro milioni di euro spesi, Santo Stefano inaugura in Italia un modello unico di restauro conservativo che punta al recupero completo dell’integrità originaria del patrimonio. Le pietre rimesse, i legni ritrovati, le finestre, i mattoni. La conservazione di tutti gli elementi architettonici identificativi, la demolizione di ogni superfetazione, alterazione, sovrapposizione, l’eliminazione di ogni intonaco o pittura nuova. Indietro negli anni, in una corsa a ritroso alla fine dell’Ottocento. Le stanze contadine ritornate a splendere nella loro illuminata e imperiosa vetustà, nelle loro forme e condizioni, negli spazi destinati ad accogliere gli uomini del secolo scorso. Ritrovate le stanze, il modello di restauro per essere economicamente sostenibile doveva avere una destinazione d’uso commercializzabile. E dunque l’albergo. Non centralizzato ma diffuso, non consueto ma imprevedibile. Al massimo della conservazione dunque, è stato contrapposto il massimo della tecnologia nei servizi. Luci, riscaldamenti, comunicazioni gestite vie internet, secondo i modelli abbaglianti di questa nostra modernità nell’era interattiva e globale dei chip e del computer. Se la prima industria italiana è il sole, se il futuro dell’industria del turismo sono i borghi e i paesi dell’osso appenninico, se è vero che Toscana e Umbria sono ormai sature e San Gi- “Il modello si può replicare altrove. Prima ci siamo guardati intorno in Abruzzo, poi siamo andati in Campania, domani forse in Lucania” BORGO A CINQUE STELLE In alto, una veduta e, qui sopra, un particolare di Santo Stefano di Sessanio, in Abruzzo. Un rigoroso restauro lo sta trasformando in paese-albergo mignano è sazia di inglesi e americani che l’hanno conquistata a suon di dollari, allora — si è detto Kihlgren — il Sud interno resta una prateria tutta da scoprire, l’osso, la parte più povera e svantaggiata della penisola, il crinale di montagne che dall’Abruzzo avanza giù fino in Campania, poi in Lucania, quindi in Calabria. Può essere questa la terra promessa, il domani di un turismo selettivo, colto e danaroso. Il giovane Kihlgren si è fatto allora due conti: ha speso quattro milioni di euro per recuperare un intero borgo e ha visto che già oggi quei quattro milioni sono divenuti otto. Se lasciasse tutto e ripartisse in motocicletta, avrebbe di che sfamarsi. Già oggi, infatti, il mercato immobiliare di Santo Stefano è così acceso e vivo da aver fatto decuplicare i valori, portato alle stelle le quotazioni, raccolto portafogli generosi e appassionati. Kihlgren non venderà però. Non solo non venderà, ma continuerà ad acquistare. «Il modello di Santo Stefano si può replicare. Questo ci siamo detti e questo abbiamo fatto. Ci siamo prima guardati intorno in Abruzzo, che è una regione ancora vergine, tutta da scoprire e da amare. Poi siamo andati in Campania, nella speranza che si possa avanzare ancora. La Lucania? Chissà». Occhi puntati e orecchie dritte. L’uomo compra i paesi, a pezzi o a interi bocconi. Trattative riservate («come mi muovo e chiedo qualcosa, vedo che i prezzi lievitano fino a deflagrare») e passo felpato. C’è quel borgo che si chiama Buonanotte, l’altro vicino al lago di Bomba. E la meraviglia di Rocca Calascio. Poi Monteverde sul Bello, e ancora in Campania, vicino a San Felice a Cancello, nella piana deturpata dalle cave e dalla camorra, un gioiellino nascosto, dimenticato ma ancora integro. «Ho solo paura degli autobus. Non voglio farne dei paesi finti, perciò l’interesse è maggiore dove l’ospitalità diffusa possa coniugarsi a una stanzialità significativa. Voglio la qualità, il mio progetto è innanzitutto culturale, perciò prima di met- tere mano al restauro di Santo Stefano abbiamo sottoscritto un’intesa, una carta dei valori con il Museo delle Genti d’Abruzzo per la conservazione e la promozione dei caratteri propri della cultura materiale, delle merci e dei mestieri, dell’artigianato storico. Abbiamo firmato un impegno a fare tutto nella più completa e fedele ortodossia architettonica, nell’attitudine — quasi talebana — a lasciare ogni cosa al suo posto, non rubare un metro quadrato, un sigillo, una porta, uno scranno di questi posti». Arredamento d’epoca Del resto fa molto chic ricreare l’atmosfera. Ma ricreare l’atmosfera costa, e stare dentro una casa contadina, ogni stanza col suo camino, arredata con il recupero dei mobili tradizionali fino ai dettagli più minuti, i materassi di lana, le lenzuola degli antichi corredi, le coperte fatte a mano con i telai di legno e i colori naturali, ma servita dal teleriscaldamento, con la gestione dell’energia a mezzo di segnali a bassa tensione per evitare inquinamenti elettromagnetici, e i sanitari extralusso, è un piacere che si paga. Albergo diffuso va bene, cultura povera, siamo d’accordo, ma le cinque stelle sono garantite. I raffinati, dal passo lento e dal portafoglio pingue, avranno quest’altra meta per stuzzicare i loro pensieri e le loro opere. E per far sì che i torpedoni non abbiano mai voglia di lasciare l’autostrada, Kilghren ha deciso di fare ancora di più: «Dove investiamo, e qui a Santo Stefano siamo quasi alla fine della realizzazione, vogliamo finanziare gli enti locali che si impegnano a buttar giù le superfetazioni di cemento, noi li chiamiamo detrattori architettonici. Credo che sia la prima volta che un privato spende i suoi soldi per garantirsi un piano regolatore senza volumi e cubature aggiuntive». La prima volta, sì. Ed è quasi un mondo capovolto. L’imprenditore Kilhgren, l’immobiliarista Kilhgren non vuole che si costruisca, e anzi chiede, dove lui decide di recuperare gli stabili, che si butti giù qualcosa di nuovo. E pur di vedere le ruspe in azione, paga. Paga lui, come paga, nel Salento, Coppula Tisa, l’associazione guidata da Edoardo Winspeare, giovane e promettente regista cinematografico, anch’egli salentino doc, che acquista le case abusive al solo fine di farne un cumulo di macerie. «Siamo per il bello», dice Winspeare. Il sole, il mare. Il sole, il mare e la montagna, aggiunge Kihlgren. L’ultima lezione per far soldi: dichiarare guerra all’alluminio anodizzato. 32 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 il viaggio Duecento anni fa, il 2 aprile, nasceva Hans Christian Andersen e Copenaghen sta per celebrare l’anniversario con feste mirabolanti e testimonial da tutto il mondo. Siamo andati sui luoghi del grande scrittore, nei suoi boschi e nelle sue piccole città di legno e cristallo, per cercare le radici dimenticate di un’arte singolare Storie da bambini Alla sorgente delle favole a sorgente delle favole esiste. È una casa gialla di legno alta così, storta e alta che non ci si sta ritti dentro, e un dolore nel cuore. È un tavolo da ciabattino e la paura di essere diversi. È una mamma troppo alta con un naso troppo grande, troppi mariti, una mamma triste con un vestito solo — marrone, a fiori rosa — che tutti i giorni va giù al fiume a lavare, le mani nell’acqua gelata. È un padre che puzza di colla da scarpe ti costruisce pupazzi di legno e poi muore soldato, un nonno pazzo che gira per strada con un cappello di carta e i bambini che ti canzonano e dicono che sei matto anche tu come tuo nonno. È il tetto coperto di muschio il gelo d’inverno e in casa una candela sola, il chiavistello chiuso della prigione all’angolo della strada e il carceriere con quella cosa legata alla cintura: il mazzo di tutte le chiavi del mondo, cento chiavi meravigliose che di sicuro aprono ogni porta. È il sogno di scappare da qui, di non esserci mai nato: di essere il figlio del re, quello che sta nella reggia illuminata e calda, di certo ha sette materassi per dormire, essere la regina della neve, quella che fa diventare tutti di ghiaccio con lo sguardo così quando sei una statua questo dolore qui che abita dentro non si sente più. È il sogno di essere il mercante ricco e furbo, una sirena, un baccello che fiorisce e diventa una pianta magnifica, un cigno bianco. Di essere un altro, diventare finalmente l’altro che da qualche parte sei. Fiorire, trasformarsi. Avere un acciarino che esaudisce i desideri. È l’ago della nonna che si rompe, è una trottola vecchia per giocarci e una palla presuntuosa che non vuole parlare con te che sei un bambino strano: brutto, solitario, lungo e silenzioso. Il pozzo delle favole sei tu, qui in questo posto in miniatura dove dopo due secoli tutto profuma ancora di candele e si sporca di cenere: sei tu e basta allungare la mano per prenderne una. Cosa vuoi diventare, Hans Christian, stasera prima di andare a dormire sulla tua panca? Vuoi essere il cane con gli occhi grandi come la torre rotonda di Copenaghen, la bambina alta come un mignolo che vola via su una rondine, il baule pieno di tesori, l’usignolo dell’imperatore che guarisce da ogni male? C’è una stupenda casa per bambini qui a Odense, a dieci metri dalla casa dove nel 1805 è nato Andersen, la madre lavandaia il padre ciabattino. Si chiama “Scatola di legno”, “Fyrtojet”. Un posto di betulla e di vetro dove tutti si tolgono le scarpe, entrando. Hanno in dono una valigetta rossa di cartone, si apre e dentro c’è un fiocco di neve di carta, uno spicchio di specchio, un caleidoscopio di legno. Le madri vengono ad allattarci i figli neonati, bambini bianchi e rosa che sgusciano dai cappucci delle tute da sci. La nonne, quasi ragazze anche loro, vengono a portarci i nipoti a giocare. Nessuno piange, nessuno strilla, nessuno rivendica. Ci si dipinge il viso, all’ingresso: due ragazzi coi pennelli lo fanno. Ci si maschera con dei mantelli neri di piume, degli abiti di raso bianchi e azzurri, si mettono cappelli e si impugnano spade di cartone, bacchette da fata. Poi si corre dentro la casa e si diventa qualcun altro. C’è una bambina stamani seduta sul trono della regina della casa dei giochi. Si chiama Hanna. È una bambina bionda con gli occhi di ghiaccio, come tante qui. Guarda gli altri e li gela con lo sguardo, cattiva. Due servitori vanno ad omaggiarla, due paggi minuscoli. Lei li asseconda condiscendente, un po’ sorpresa al principio di essere stata riconosciuta ma poi no perché è ovvio: è lei, oggi, la regina. Torna a fare statue con gli occhi, li stringe perfida. La cattiveria dei bambini I bambini amano Andersen perché possono essere come lui molto cattivi. Cattivi di una cattiveria nitida, utile e senza colpe. Possono essere egocentrici, anzi sempre lo sono: esistono loro, poi il mondo. Possono risentirsi moltissimo di quel che a un adulto sembra niente. Possono immaginare quel che poi si dimentica. Indossare un ditale ed essere Una famiglia poverissima, una madre con troppi uomini intorno, un fisico sgraziato e una fisionomia ripugnante. Per il piccolo Hans Christian immaginare un Altrove, un mondo incantato, era una scelta necessaria tole, corde, giocattoli di latta. No, non abbiamo la carta di credito, siamo un negozio molto antico, sa. No, non possiamo spedire niente, no, non facciamo la ricevuta, vede com’è antica la cassa? Se vuole gliene scrivo una a mano. Ecco, così, con la firma del signor Krambod in bella calligrafia. La Danimarca, il mondo intero celebrano i due secoli dalla nascita di Andersen: fuochi d’artificio e spettacoli mirabolanti in ogni dove, testimoni in arrivo dai quattro cantoni del globo. Sabato prossimo, il 2 di aprile, sono duecento anni esatti e arrivano a Copenaghen e a Odense per la festa Roger Moore e Suzane Vega, Pelè e Isabel Allende. Vincenzo Cerami e Paolo Maldini, per l’Italia, al galà. Celebrano lui perché certo che il luogo dove nascono le favole è in principio l’animo e la mente di un uomo, di quest’uomo. Hans Christian Andersen era bruttissimo, alto un metro e 85 in un tempo e in un luogo in cui tutti gli altri erano almeno 25 centimetri più bassi di lui — illustrano le riproduzioni d’epoca nel museo della casa natale. Aveva gli occhi liquidi di cera e una fronte che pareva una montagna, un naso sterminato, le occhiaie gonfie: era «davvero orrendo», sintetizzano i libri per ragazzi. Nasceva in una famiglia poverissima da una madre che aveva già avuto una figlia da un padre diverso dal suo e che avrebbe avuto altri uomini dopo. Una madre costretta a mendicare, da bambina. Per la Piccola fiammiferaia, per il Brutto anatroccolo potrebbe bastare già questo pezzo di storia. Però poi c’è il luogo: questo posto lindo e minuscolo dove gli orrori sono tutti chiusi dentro casa, dove fuori sono solo boschi e castelli, il castello di Amleto e quello dei conti dei signori, i mulini, le lavandaie, i pazzi, le streghe. «La strega era ripugnante, col labbro inferiore che scendeva fino al petto», dice la descrizione all’inizio dell’Acciarinoed è uguale alle vecchie senza denti delle foto di paese esposte qui. L’ago da rammendo voleva essere un ago da ricamo, la sirena avere gambe da donna, il piccolo Claus essere ricco come il grande Claus. Il soldatino di stagno voleva essere amato dalla balleri- na e solo il bambino nel corteo sapeva dire che i vestiti nuovi dell’imperatore erano una truffa, perché tutta quella gente presuntuosa e stupida, avida del proprio piccolo potere omaggiava il sovrano assecondando la truffa ma il bambino no. Il bambino sì che lo vedeva nudo. Anche adesso, sui giornali danesi — su tutti — c’è una pagina per i bambini dove i piccoli possono dire ciò che vogliono: che quel parco è mal tenuto e che nella loro scuola la maestra è cattiva. I bambini sono tutti imperatori, qui nella terra in miniatura. L’industria più importante è ancora quella dei giochi. A Legoland si celebra Andersen, ovviamente: la nuova linea di mattoncini si chiama Belville ci si possono fare sirene e stagni. Arrivano piccoli ogni giorno da tutto il mondo a costruire navi e grattacieli coi mattoncini rossi e gialli: spagnoli, giapponesi, cileni. Godono del culto della miniatura che qui è virtù nazionale: nel museo accanto al municipio della Capitale è esposto il più piccolo fenicottero di corallo mai scolpito, ci vuole un microscopio per vederlo. Il vanto della città della Lego è una reggia in scala ridotta di legno e pietre preziose, custodita come un vero tesoro in una stanza ombrosa. Nei bagni delle case ci sono lavabi piccoli per i piccoli, e sui rubinetti c’è scritto a quanti gradi uscirà l’acqua perché i bambini non si brucino. Andersen con le sue forbici enormi (esposte, al museo: grandi come un coltello da pane) ritagliava miniature di carta velina impalpabili, mostri meravigliosi: un impiccato grande come l’unghia di un mignolo, un uomo a tre teste più piccolo di una moneta. Le figurine, riprodotte oggi a centinaia di migliaia, adornano le finestre si illuminano e fanno ombre con le candele nelle case, decorano le uova di pasqua, sono sui tappeti e nelle cartoline. I bambini imparano da piccoli, a scuola, a ricamare coi pastelli i bordi dei quaderni. LE MOSTRE IN ITALIA Qualche cenno sul moltissimo che c’è in Italia (visitare il sito www. andersen. it) solo nel mese di aprile. A Roma il 2 alla libreria Mel Giannino Stoppani prima dello spettacolo «I vestiti nuovi dell’imperatore» del Teatro Verde. A Bologna si inaugura il 13, insieme alla Fiera del libro per ragazzi, la mostra in due sezioni «Illustrare Andersen». Nella rassegna «Fieri di leggere» della Giannino Stoppani di Bologna si inaugura il 15 una mostra di Beatrice Alemagna: «Pensieri illustrati di una bambina di vetro». Ancora a Bologna, dal 13: «Sirenette di carta e soldatini di inchiostro» a cura della rivista Andersen (dal 15 maggio Vittoriale di Roma). A Milano il 21 (Feltrinelli di corso Buenos Aires) presentazione del romanzo «Peer Fortunato». ‘ L’insegnamento della diversità Di Andersen resta soprattutto il valore — l’insegnamento — della diversità, in un paese che oggi vorrebbe chiudere le frontiere agli immigrati. Era omosessuale, dicono adesso. Anzi, amava uomini e donne ma non ha mai avuto rapporti in vita sua: non se ne trova cenno in nessuna delle molte biografie, né nei suoi minuti diari. Certo, parlava molto di sesso, anche — dicono gli studenti che ci scrivono tesi di laurea: perché cosa sarà mai il «seme straniero di orzo» che la fattucchiera dà alla madre che non può avere figli e da cui nasce Mignolina? E cosa ci faceva in casa il sacrestano che la contadina chiude nella credenza al ritorno del marito? È morto ricco, Andersen. Col foulard di seta e il nastro azzurro al collo. Senza tornare a Odense a vedere la madre, è morto nella villa di campagna dei Melchior, una delle tante famiglie che lo hanno infine mantenuto. È morto come voleva essere da piccolo: il figlio del re. Però gli è successo come nelle sue fiabe: la sfortuna del destino segnato si baratta sempre con qualcosa. Le gambe per camminare in cambio della vita, mia piccola sirena. Due ragazze col chador vogliono metterne uno anche alla statua della Sirenetta, qui al porto stamattina: cercano di legarglielo al collo, il velo vola in mare, i turisti scattano foto e ridono. Andersen, anche nelle ville dove ha viaggiato e vissuto, portava con sè un rotolo di canapa per fuggire dalla finestra in caso di incendio. Non che ne avesse mai patito uno: temeva il fuoco, solo. Faceva sogni orribili, non sopportava alcun rumore. Poi di giorno raccontava storie tristi e bellissime, parabole di astuzia e di resurrezione. Storie dove si vince davvero solo quando si muore, dove gli oggetti si animano e diventano migliori degli uomini, o peggiori se è il caso: l’amore passa, se neanche la trottola riconosce più la palla con cui voleva fidanzarsi, dopo cinque anni passati a marcire in una grondaia. Storie così tutto il giorno fino alla sera, e poi nei letti finalmente di lino di nuovo i suoi incubi, gli incendi immaginari. Non si scappa mai davvero, infine: non c’è un posto dove scappare da sé. Nemmeno qui in questo posto incantato. Nemmeno alla sorgente delle favole. FOTO CORBIS L ODENSE soldati dentro un’armatura, vedere un rospo e diventare cicogna per divorarlo. Duecento anni dopo qui nel posto delle favole i bambini sono tutti Andersen: sono le sue fiabe, i suoi viaggi fantastici, la sua vanità e il suo malanimo, la sua voglia di scappare, i suoi travestimenti e le sue paure. Vivono ancora nei suoi boschi e nelle sue città piccole di legno e di cristallo, e non importa se al posto della nave per andare da un’isola all’altra ora c’è il ponte sospeso più lungo d’Europa. Non importa se nei piatti di ceramica bianchi e blu — le porcellane danesi, che prodigio di armonia — invece delle casette sono dipinte le fabbriche, perché i giovani designer della Royal Copenaghen hanno l’arbitrio di descrivere nei vassoi di portata ciò che vedono, perciò le ciminiere, anche. Non importa quel che è cambiato perché quello che è rimasto uguale è ciò che conta: il freddo è lo stesso freddo, i cigni che scivolano goffi camminando sul ghiaccio sono uguali, i boschi ordinati come se qualcuno avesse messo gli alberi in fila, le case piccole, le torri minuscole, gli smerli dei castelli, i re nei castelli. Le candele alle finestre e le tende fatte di ricami, i narcisi che fioriscono nei bulbi basta appena un po’ di terra che poi non è neanche terra, per farli crescere: è sabbia. Il caldo dentro le case da gnomi, le teiere che fumano. Le biciclette al posto delle carrozze. Il mare, immenso. Uguali sono i poveri e i ricchi, gli orfani e i ragazzi che partono soldati, gli amori infelici, uguale è nel cuore di ciascuno quel che avrebbe potuto essere e non è: bastava niente, si poteva nascere la principessa amata dal suo principe e invece c’è stata una strega un errore un ritardo un sortilegio. È andata così. Non come doveva, nel sogno. Non come nelle fiabe. C’è un negozio al numero 24 di Nedergade, due strade dietro a quella in cui viveva lui. Non si sa come stia in piedi, quella casa, sembra disegnata da un bimbo di tre anni: per salire al primo piano c’è una scala di legno ripida come quelle delle barche, in tutte le case ce n’è una così. Ha trecento anni, il negozio: allora era già lì. Vende lanterne e chiavistelli, pitali e piatti di peltro, trot- FOTO ROGER VIOLLET CONCITA DE GREGORIO Com’era bello, fuori, in campagna! Era estate! Il grano era giallo, l’avena verde, il fieno era stato raccolto in mucchi nei prati, dove la cicogna passeggiava con le sue lunghe zampe rosse... da IL BRUTTO ANATROCCOLO LA DOMENICA DI REPUBBLICA 33 FOTO CORBIS DOMENICA 27 MARZO 2005 LA CASA-MUSEO Qui accanto, un’illustrazione d’epoca per la fiaba “La regina della neve” Sotto da sinistra, “Il brutto anatroccolo”, “La sirenetta” e “La piccola fiammiferaia”. Nella pagina di sinistra, Hans Christian Andersen e la sua casa natale a Odense, oggi trasformata in museo Il paese della convivenza perfetta Il capolinea Danimarca PIERO OTTONE H ‘ Ecco! Incominciamo. Quando arriveremo alla fine di questa storia, ne sapremo più di quello che sappiamo ora: sapremo che tutto fu opera di uno spirito malvagio, uno dei più cattivi, il diavolo in persona! ‘ FOTO CORBIS FOTOTECA ANDO GILARDI da LA REGINA DELLA NEVE - tratto da FIABE di Hans Christian Andersen, Einaudi Lontano, in alto mare, l’acqua è azzurra come petali di bellissimi fiordalisi e trasparente come cristallo purissimo... da LA SIRENETTA ‘ Faceva un freddo tremendo; nevicava, e saliva la buia notte; era anche l’ultima sera dell’anno, la vigilia di Capodanno. da LA PICCOLA FIAMMIFERAIA o, per così dire, la Danimarca in casa, avendo sposato una danese, ma quando sono andato a Copenaghen per la prima volta, mezzo secolo fa o poco più, neanche sapevo che la mia futura sposa esistesse, e non sospettavo che quel paese relativamente minuscolo avrebbe acquistato un certo peso nella mia vita. Ero stato qualche giorno in Norvegia, a Oslo, a Bergen, fra i fiordi e le isolette. Poi andai a Stoccolma. La Danimarca concludeva il breve reportage in Scandinavia. Andai a vedere le solite cose, parlai con un po’ di gente, secondo gli usi del mestiere. E tornai in Italia con un’immagine chiara nella testa: la Scandinavia rappresenta il capolinea della civiltà. All’immagine sono rimasto fedele da allora, anche attraverso le croci e delizie, intervenute nel frattempo, della vita coniugale. I danesi, come i cugini scandinavi, hanno alle spalle un passato avventuroso. Hanno combattuto guerre cruente; conquistato terre straniere, Inghilterra compresa; incrociato le spade con gli svedesi, con i tedeschi, con i russi. Hanno fatto fuoco e fiamme, insomma. Poi si sono ritirati in buon ordine in quel loro paese che sembra un giocattolo, nelle casette bianche e rosse col tetto di paglia, fra i boschi lussureggianti (piove spesso) e i prati fioriti, sempre laboriosi, naturalmente, perché bisogna lavorare per vivere, ma risoluti a vivere in pace col mondo, senza dare fastidio a nessuno e chiedendo che non gli si dia fastidio. Forse Nelson (col bombardamento, 1801, di Copenaghen) e Bismarck (con la guerra brutale del 1864) hanno dato una mano. Quando, dopo l’ultima guerra, i vincitori offrirono alla Danimarca la restituzione di una regione che era stata annessa nell’altro secolo dai prussiani, i danesi risposero: no, grazie. Meglio vivere tranquilli, evitare le complicazioni. Al momento dell’ultima prepotenza, l’aggressione di Hitler, i soldati in grado di opporre resistenza erano due o trecento. Perché capolinea della civiltà? Perché i danesi, in quel loro giardino fiorito, fra campagne ben coltivate, nelle città ridenti, all’ombra di castelli graziosi che si rispecchiano in laghetti verdazzurri, hanno inventato forme di convivenza quasi perfette, che non possono essere migliorate: assistenza ai vecchi e ai malati, borse di studio, giustizia sociale, treni puntuali, burocrazia efficiente. E dietro le siepi di quel loro giardino, magico e miracoloso, raccontano favole. Le favole di Hans Christian Andersen, appunto: il grande favolatore, l’unico grande genio che hanno offerto alla letteratura mondiale. Che ebbe, per la verità, una vita abbastanza tormentata. Ragazzo povero nato a Odense all’inizio dell’Ottocento, arrivato a Copenaghen avendo pochi soldi in tasca e gli zoccoli ai piedi, con la passione del teatro e le idee confuse, brutto e sgraziato (gli dicevano che somigliava a una giraffa), fu afflitto per tutta la vita, anche dopo avere raggiunto il successo, da mille nevrosi e idiosincrasie, un giorno atterrito all’idea di avere inghiottito uno spillo, un’altra volta convinto di diventare cieco, perseguitato dal mal di denti, senza mai capire se fosse omosessuale o eterosessuale. Ma poi nelle favole sublimava le sue pene. «Mi stavano nella mente come un granello, ci voleva soltanto un soffio di vento, un raggio di sole, una goccia d’erba amara, ed esse sbocciavano»: così lo cita Knud Ferlov, che insegnò danese all’università di Roma, nella prefazione all’ottimo libro con più di cento fiabe, tradotte per Einaudi da Alda Manghi e Marcella Rinaldi. Il soffio di vento, il raggio di sole furono spesso procurati dall’Italia, che scioglieva le sue ansie. Venne varie volte fra di noi. Trovava divertenti anche le nostre pecche, il vetturino che sbagliava indirizzo e lo imbrogliava, i briganti che insidiavano le strade («speriamo che mi facciano fuori, così avrò il piacere di morire in Italia»), i mezzani che gli offrivano «un ragazzo o una ragazza», a scelta. Alle offerte peccaminose resisteva: scriveva agli amici che manteneva la sua «innocenza», anche se, aggiungeva, «nessuno ci crederà». La pedofilia gli faceva orrore. Ma fra di noi stava bene: «A Parigi si gela, a Napoli bolle il sangue». Insomma: i danesi ci insegnano le regole della convivenza perfetta, noi offriamo serenità… Ma qui dovrebbe prendere la parola l’altra metà del mio ménage, e io mi fermo. 34 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 Il 6 maggio il latin lover più famoso di tutti i tempi compirebbe centodieci anni: un anniversario che sta scatenando in giro per il mondo iniziative e omaggi. Ma l’evento che riporterà alla ribalta la star del muto è il ritrovamento di una pellicola dimenticata nel magazzino di un collezionista olandese. L’opera, di cui anticipiamo in esclusiva alcuni fotogrammi, è stata restaurata e sarà presentata in anteprima mondiale ad Amsterdam il 5 aprile e a maggio al Festival di Cannes Il film fantasma del pioniere dei sex symbol sta dando nuova linfa alla valentinomania, sindrome che ottant’anni fa trascinò i suoi fan verso ogni genere di delirio: dai CASTELLANETA (Taranto) leggendari suicidi delle ammiratrici alon è rimasto più nessuno, l’indomani della morte, alle processioni a Castellaneta, che ricordi delle dame in nero nel cimitero di Los Anquell’assolato pomeriggio geles dov’è sepolto; dalle vendite miliodi fine narie all’asta di ogni settembre 1923. Rosua reliquia fino ai tendolfo Valentino, già tativi di colloquiare con consacrato mito a Hollui nelle sedute spiritilywood, arrivò nel paeche. Oggi il mito risorge se natale con la sua Buin forme più lucide, nei gatti blu e — come ritermini di una riconsicorda nel diario privato derazione degli aspetti — tutti i ragazzini, ai meno noti dell’attore, quali la sua auto doveva ma con eguale devo«sembrare un drago zione. Rinasce, non a sbuffante che scivola caso, in un ex convento magicamente lungo la di clarisse trasformato strada», si aggrappavain museo dal Comune no «al paraurti o a quadi Castellaneta, paese lunque altra sporgenza di allevatori che finora per scroccare un pasal suo figliolo più illusaggio». La memoria stre aveva dedicato bar, diretta di quel grande camicerie, villaggi turievento nella piccola stici; e un monumento provincia tarantina s’è che rende così poca persa con la scomparsa giustizia all’efebico e Da IL MIO DIARIO PRIVATO della signora Rita, mormuscoloso attore da Lindau editore 2004 ta vecchissima tre anni meritarsi, nel 1961, un fa, che raccontava a tutposto in Mondo cane, il ti di aver ospitato il divo primo documentario nella sua casa di famiglia, «era così bello» trash sulle schifezze del pianeta. e lei era ancora innamorata, a distanza di L’organizzatore del museo è un attotanti anni. re-regista romano originario di CastellaI coetanei di Valentino oggi di anni ne neta, Fabio Salvatore. Per festeggiare il avrebbero centodieci, età che il più grancompleanno, oltre alla rassegna Il mio de seduttore del cinema di tutti i tempi sogno si sta avverando che si chiude il 6 compirà il 6 maggio. Un genetliaco che maggio a Roma, sta preparando una mo- DAVIDE CARLUCCI N ‘‘ Rodolfo Valentino Le mie ambizioni volavano molto più in alto della terra e abbracciavano le stelle immortali. Volevo il successo Ottanta minuti intitolati Beyond the Rocks, interpretati insieme a Gloria Swanson: dovevano servire da lancio per la coppia stra fotografica (sempre nella Capitale), un festival cinematografico, uno short movie, una linea di merchandising con l’immagine stilizzata di «Rudy» su 110 tshirt diffuse a tiratura limitata. Il pezzo forte del museo, invece, è un assaggio dell’evento cinematografico destinato a rilanciare la fama mondiale del divo del muto. Un minuto di pellicola, trasposto in un dvd a disposizione dei visitatori, che vede Rudy gettarsi in acqua per salvare Gloria Swanson sul punto di annegare. È l’unico frammento in circolazione di un piccolo capolavoro perduto e ora recuperato: il film, di cui anticipiamo in questa pagina alcune immagini, è Beyond the Rocks, del 1922. Il Nederlands filmmuseum ha scoperto tra il 2002 e il 2004 la pellicola, dimenticata nell’umido magazzino di un collezionista olandese, e ne ha già ultimato il restauro. Il film sarà presentato ad Amsterdam in anteprima mondiale il 5 aprile e al festival di Cannes a maggio. «La pellicola — spiega Giovanna Fossati, responsabile dei restauri — si trovava all’interno di un grosso archivio contenente migliaia di pizze. Abbiamo dovuto inventariare tutti i film e, rullo dopo rullo, ricostruire gli ottanta minuti di durata di Beyond the Rocks». La Swanson interpreta il ruolo di una ragazza, Theodora, che deve sposare per volontà del padre un uomo molto più anziano. Dopo il matrimonio incontra il rampollo di una ricca famiglia di madre italiana — dalla quale ha ereditato la bellezza — che l’aveva già stregata, da ragazzina, con il suo fascino: è Lord Hector Bracondale, interpretato da Rodolfo Valenti- DOMENICA 27 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 35 DALLA PAGELLA ALLE CANZONI I CIMELI DEL MUSEO DI CASTELLANETA A scuola era un disastro: nell’anno scolastico 1904-1905 la pagella di Rodolfo Alfonso Raffaello Filiberto Guglielmi, esposta nel museo di Castellaneta, è una sfilza d’insufficienze. Solo in "calligrafia" il futuro Valentino strappa un sei. Netta la bocciatura in tutte le altre materie, da Italiano (5) a Disegno (2). Un dvd a disposizione dei visitatori del museo propone anche due rare registrazioni dei dischi incisi da Valentino, El relicario e The Kashmiri song. Tra le altre memorabilia, foto inedite, un pezzo della tenda de Il figlio dello sceicco e immagini del funerale. Nella foto qui a sinistra, l’estratto dell’atto di nascita di Rodolfo Valentino; in quella a fianco, la pagella È stato lui a inventare la Hollywood dei divi ANTONIO MONDA P IL CAPOLAVORO PERDUTO Nelle foto in queste pagine, alcune scene di Beyond the Rocks, il film del 1922, scomparso per decenni e ora recuperato, che ha come protagonisti Rodolfo Valentino e Gloria Swanson no, aitante e ricco playboy che con Gloria, fatica di Valentino che, per rispettare la però, scopre il vero amore. Per salvare la censura statunitense, era costretto a forma e l’onore, tuttavia, entrambi rinuncontenere la durata dei suoi baci entro i ciano alla relazione. Sarà poi il marito a dieci piedi di pellicola. Per il pubblico euscoprirla e a decidere di sacrificarsi per la ropeo quel limite non valeva e «così — rifelicità della giovane moglie. Con la morcorda la Swanson — la scena di ogni bate del terzo incomodo, l’amore ostacolacio fu girata due volte», una per la versioto della coppia Swanne americana e l’altra son-Valentino può fiper quella europea». I nalmente trionfare. fan di Valentino — proLa trama non è granmette la Milestone, la ché, ma è normale per società americana che un film-veicolo che docurerà la distribuzione veva servire solo a far — possono stare tranrecitare insieme due quilli: il film restaurato star: la Swanson all’esarà messo in commerpoca era la diva più pacio nella sua versione gata di Hollywood, con europea, con i baci in cachet dieci volte supemisura «extended». Bravo cantante, ecriori a quelli di Valenticellente danzatore, atno, promettentissimo tore superbo, Rudy era emergente ma non anappassionato d’arte e cora la stella di Sangue e amava scrivere. Pubarena. Il film, ambienblicò una raccolta di tato tra l’Inghilterra, la poesie — Day dreams, Svizzera e l’Africa, è ricmezzo milione di copie co di trovate e momenvendute nel 1923 — che ti spettacolari: lui salva sosteneva gli fossero lei in due occasioni (olDa IL MIO DIARIO PRIVATO state dettate da grandi tre che dall’annegaLindau editore 2004 scrittori del passato nel mento, mentre sta per corso di sedute spiritiprecipitare da una rupe che, attraverso la scritnelle Alpi svizzere) e intura automatica. Una poesia invoca sieme sognano di trasmigrare verso altre «pietà, pietà per quelli come loro/che soepoche storiche, per esempio a Versaillo scorgono cieli grigi/da strette finestre les, alla corte di Re Sole. Espedienti un di occhi tristi/Quando tutto intorno è glopo’ forzati che, secondo la critica dell’eria celeste». In Money, invece, il denaro è poca, servivano solo a giustificare un «Arlecchino nel grande carnevale della vicambio di costume per la Swanson. Nelta./Il segno del dollaro è la tua maschera». la sua autobiografia, l’attrice ricorda la ‘‘ LA BIOGRAFIA LA NASCITA Rodolfo Valentino nasce a Castellaneta il 6 maggio 1895. Ha un fratello più grande, Alberto, e una sorella più piccola, Maria LA PARTENZA Il 23 dicembre 1913 Rodolfo si imbarca alla volta di New York con un biglietto di seconda classe sul transatlantico Cleveland Rodolfo Valentino Alle volte, in gran segreto, mi do dei pizzicotti, alla vecchia maniera, per essere certo che non sia tutto un sogno IL SUCCESSO Comincia come ballerino, poi passa al cinema. La consacrazione nel 1921 con il film “Lo sceicco”. Nella sua breve vita girerà 37 pellicole LA MORTE Rodolfo Valentino muore a New York, una settimana dopo essere stato operato per ulcera perforata e peritonite, il 23 agosto 1926 NEW YORK uò sembrare un paradosso, ma il mito retrò di Rodolfo Valentino poggia le radici nella sua sorprendente, ambigua e seducente modernità. Al di là del fascino spudoratamente latino, l’antica malinconia dello sguardo, e la naturalezza del suo “bedroom smile”, ciò che ne ha fatto la prima e più importante incarnazione del “latin lover”, è stata l’attenzione spasmodica al culto della propria immagine ed il modo in cui ha saputo gestire mediaticamente i pochi talenti e le molte stravaganze, trasformando i capricci, gli infantilismi e persino le debolezze in modelli mitici ed inarrivabili. Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Filiberto Guglielmi di Valentina D’Antonguolla utilizzò per intero il proprio nome fin quando gli servì a darsi un tono di nobiltà, ma lo cambiò non appena si rese conto che era improponibile per le esigenze di immediatezza del cinema. Nella propria autobiografia, scritta quando aveva solo ventotto anni, confessò che il suo destino era segnato dal fatto di essere nato nel 1895, lo stesso anno in cui fu inventata la settima arte, ma l’unico sogno che ebbe fin quando visse in Italia fu quello di andar via da Castellaneta ed affermarsi come ballerino. Si trasferì in America a diciotto anni, e comprese immediatamente che nel secolo che era iniziato da poco l’immagine sarebbe stata importante come la sostanza, e, soprattutto, che le relazioni avrebbero avuto maggior peso dell’effettiva qualità. Il suo primo lavoro fu quello di gigolò, e fu grazie a una signora attempata che non riusciva a resistere alla sua «bellezza all’olio d’oliva» che riuscì a lavorare come giardiniere presso il miliardario Cornelius Bliss, il quale lo prese in simpatia fin quando non scoprì che si divertiva a guidare di nascosto le sue motociclette. Utilizzò la carta intestata con l’indirizzo di Bliss per scrivere alla madre di una inesistente ricchezza raggiunta nel paese delle opportunità, e quando venne licenziato in tronco fu costretto a dormire per un lungo periodo a Central Park. Il momento più disperato della sua vita coincise con l’incontro con Bonnie Glass, che lo fece debuttare come ballerino al Maxim’s e seguì i primi passi dell’irresistibile ascesa nel firmamento dello spettacolo. Sin dai primi passi comprese che la settima arte aveva bisogno di una personalità assolutamente nuova, e contrariamente a quanto gli suggerivano gli agenti decise che avrebbe esaltato la propria avvenenza prettamente latina. Il “Signor Rodolfo”, come si firmò in quei primi anni, si fece notare per un’inedita e rivoluzionaria sensualità, che si esprimeva in particolare nelle scene in cui dimostrava il proprio talento di ballerino. Ma la modernità del personaggio risiede soprattutto nell’aver intuito immediatamente i meccanismi fondamentali di una Hollywood ancora in via di formazione. Dal momento in cui venne consacrato divo di prima grandezza nei Quattro cavalieri dell’apocalisse, nel quale lanciò la moda del tango, Valentino comprese che il lin- guaggio delle immagini in movimento si ciba di fotogrammi anche nella quotidianità, e che la sorte di un sex symbol è quella di eternare in ogni momento il gioco della seduzione. La sua sessualità fu incerta come quella di molti divi contemporanei, dei quali fu un antesignano anche per la capacità di manipolare scientificamente il proprio look: si fece crescere la barba ad uso e consumo dei fotografi, e se la tagliò di fronte allo scatto degli obiettivi per il sollievo di milioni di fan. Discusse nel dettaglio i costumi, le pettinature e persino la lunghezza delle basette, e considerò la privacy un controsenso rispetto alla sua vita da star. Negoziò con i giornalisti la possibilità di fotografare la sua splendida tenuta di Falcon Lair, e riuscì a far diventare notizia perfino i cambi di arredamento. Il matrimonio di sei ore con Jean Acker precede di quasi cento anni il gesto analogo di divi contemporanei, che riflettono tuttora con i loro publicist su come Valentino abbia fatto a far attribuire le responsabilità di questo fiasco morale e sentimentale alla sua partner, “colpevole” di non aver rivelato di essere lesbica. Quando sposò Natasha Rambova senza preoccuparsi di annullare il matrimonio precedente, venne incarcerato per bigamia, ma riuscì a trasformare il caso in un nuovo strumento mediatico, affermandosi come una star al di sopra delle convenzioni. Il trionfo sul grande schermo con Lo Sceicco e L’Aquila gli diedero la forza di sfidare i capi degli studios, che ebbe l’intelligenza di mettere l’uno contro l’altro, riuscendo sempre a strappare i contratti alle condizioni più favorevoli. L’indipendenza di carattere assolutamente inedita nella Hollywood di quegli anni ingigantì il suo mito agli occhi dei fan, ma fu anche il motivo per cui cominciarono a propagarsi le dicerie relative alla sua sessualità, alle quali rispose facendosi vedere perennemente in giro con la moglie Natasha e la sensualissima amante Pola Negri. Restaurò la propria fama con un libro di poesie crepuscolari che divenne un immediato best seller, e con innato senso dello spettacolo sfidò a un incontro di boxe un giornalista che lo aveva definito «un piumino di cipria rosa». Il giorno in cui crollò al suolo per un ulcera perforante che lo uccise dopo otto giorni di agonia, capì immediatamente di essere arrivato alla fine del suo viaggio. Aveva compiuto da poco trentun anni e aveva sentito l’ebbrezza di aver conquistato un mondo che voleva considerare reale. Anche il momento estremo si colorò di una leggenda che venne amplificata dalla stampa: c’è chi scrisse che fosse stato avvelenato dalla gelosissima Natasha o da un’amante non corrisposta. Quando le sue condizioni si aggravarono si riunì fuori dell’ospedale una folla immensa e disperata, e la famiglia diede disposizione di preparare in segreto una statua di cera per la camera ardente. I fan venerarono senza saperlo l’idolo dell’idolo, e poi riempirono le strade per due funerali passati alla storia: se a New York la bara venne portata a spalla dal capo della Paramount Adolph Zukor, a Los Angeles l’onore toccò a Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks. Lasciò dietro di sé due vedove autentiche ed una infinità di aspiranti tali, tra cui una misteriosa donna vestita di nero che per molti anni portò fiori sulla sua tomba nell’anniversario della morte. Fu lo stesso Valentino a dare disposizione di lanciare delle rose da un aereo durante la cerimonia hollywoodiana per negare con il gesto spettacolare la realtà degli enormi debiti accumulati negli ultimi anni. Il mito era già immortale e non riuscì ad offuscarlo neanche la pubblicazione del testamento, nel quale lasciò alla moglie soltanto un dollaro di eredità. 36 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 Esce per la prima volta in italiano “Brother Ray”, l’autobiografia nella quale l’artista scomparso lo scorso giugno si racconta e si confessa. Un libro che svela episodi inediti e segreti della sua esistenza e di cui anticipiamo i brani più significativi. L’infanzia difficile, il dramma della cecità, gli eccessi, l’amore per le donne e quello, ancora più forte, per la musica: così “The Genius” ha voluto mettere nero su bianco la storia di una vita spesa con passione all’inseguimento di un sogno Così il bimbo del ghetto diventò il genio del soul te disgrazie, ha avuto la fortuna di possedere un talento unico: saper comunicare rima di cominciare, facon il mondo attraverso la musica. temi dire subito che soBrother Ray è un libro affascinante, dino un ragazzo di camvertente, in grado di offrire, a differenza di pagna. E guardate che molti altri libri biografici, un ritratto vero per campagna intendo e appassionato dell’uomo e della sua muuno di quei posti verdi sica. Ovvio? Non troppo, perché in linea alberati lontani da tutto!». Un ragazzo di di massima le autobiografie degli artisti campagna. Come se lui, il grande “frateltendono a dipingere ritratti non del tutto lo Ray”, l’uomo che ha scritveritieri, a glissare sulle vere to e cantato alcune delle più motivazioni che hanno belle pagine della storia delspinto verso alcune scelte IL MAESTRO la musica popolare del sepiuttosto che altre, tralasciaNat “King” Cole colo appena trascorso, che no i momenti di debolezza, i «Anche allora sapevo che Nat Cole era il più grande di era in grado di commuovefallimenti, gli errori, puntansempre», scrive Ray Charles nella sua autobiografia. «I re fino alle lacrime il proprio do a far aderire l’immagine bianchi sapevano accettarlo perché faceva roba che pubblico, o di travolgerlo del “divo” a quella idealizzacapivano, e la faceva con grande sentimento. È strano, nell’estasi del ritmo e della ta che ne hanno i fan. Ray ma in tutti quegli anni in cui lo copiavo non ci pensai mai passione, fosse davvero una Charles, invece ha provato a troppo, non mi sentii in colpa perché gli copiavo i trucchi» persona come tante. Eppuraccontare se stesso con il re inizia così Brother Ray, massimo possibile della l’autobiografia che Ray onestà. Non c’è tutto, ovviaCharles scrisse alla fine demente, ma c’è molto di gli anni Settanta con l’aiuto quanto ci dovrebbe essere, di David Ritz. Ed è con quedai matrimoni falliti all’esto tono, diretto, colloquiasperienza della droga, dagli le, che il grande musicista errori artistici e manageriali afroamericano racconta la a quelli personali: «Ho decisua vita, le vicende personaso di raccontare tutto», scrive li, la sua arte, l’inarrestabile Charles nell’introduzione. passione per la musica, gli «Guardando nel mio passato L’ALLIEVO amori, i drammi, i momenti non sono riuscito a trovare Joe Cocker bui e i grandi successi, in un niente che andasse censura«Oggi sento dei cantanti che secondo me mi volume che oggi viene proto. Non c’era motivo per non assomigliano», prosegue “The Genius” nel libro. «Joe posto, per la prima volta in essere franchi. Quello che è Cocker, per dirne uno. Diavolo, lo so che è un tipo che Italia, aggiornato fino agli fatto è fatto». Charles è a tratprobabilmente i miei dischi se li porta pure a letto. Ma non ultimi giorni della sua vita, ti autoindulgente, come si mi importa. Sono lusingato; e lo capisco. Io in fin dei conti dalla casa editrice Miniaddice a chi racconta se stesfacevo la stessa cosa» mum Fax. Una vita che, per so in un libro, ma allo stesso quanto “The Genius” si tempo, con sapienza, offre sforzi di ridurre tutto alla anche alcuni dei suoi lati semplicità dell’esistenza, non è stata peggiori, cercando di non nascondere davvero la vita di un qualsiasi “ragazzo di troppo i difetti (l’egocentrismo, l’infecampagna”, piuttosto la straordinaria deltà, l’amore per il denaro) che hanno avventura di un uomo che, al di là di molcontribuito, al pari dei pregi, a fare di lui uno dei personaggi più importanti della musica americana del Novecento. Il libro è, infatti, anche e soprattutto il racconto di un eccezionale cammino, quella di un musicista che ha contribuito in maniera determinante a definire la musica popolare moderna. È stato il primo a fondere gospel e rhythm’n’blues, è stato tra i padri del rock’n’roll, è stato tra gli “inventori” della soul music, ha predicato la lingua del countrye quella del pop, ha dimostrato che l’arte dell’interpretazione è una delle arti più difficili e personali del mondo. E, come hanno sottolineato molti dei suoi estimatori, ha dimostrato che la soul musicnon era necessariamente un genere ma un “modo” di interpretare la musica e la vita, una vera e propria predisposizione dagli esiti teoricamente illimitati. Chi lo ha visto suonare e cantare dal vivo almeno una volta ha avuto modo di comprendere che per Ray Charles quello della musica non era un mestiere ma, come diceva lui, “l’essenza”: se era sul palco di Sanremo a cantare una canzone di Toto Cutugno, come è accaduto davvero, era in grado di prendere quella melodia e donargli l’anima, trasformandola profondamente, facendola diventare un gioiello; se era assieme a qualche giovane rampollo della musica nera odierna era capace di dare lezioni non di musica ma di ERNESTO ASSANTE «P “Guardando nel mio passato non sono riuscito a trovare niente che andasse censurato. Non c’era motivo per non essere franchi. Quello che è fatto è fatto” stile, muovendo le mani sul pianoforte con la sicurezza di chi conosce non tanto la musica quanto la vita. Ed è la vita che esce forte e inarrestabile dalle pagine di questa autobiografia. Una vita fatta di tante piccole cose (le torte della Mamma, scritta sempre con la maiuscola, le monetine del signor Johnson che invece a comprare caramelle servivano ad alimentare il jukebox del bar, le liti con le fidanzate e le mogli) e di grandi momenti (l’incontro con Art Tatum, «non una di quelle cosette tipo il presidente di una nazione, o un primo ministro, o un attore di fama internazionale. Era Art Tatum», di canzoni indimenticabili e di momenti difficili, di donne («Molte di più di quanto sia in gra- DOMENICA 27 MARZO 2005 do di ricordare»), e di musicisti. Una vita che avrebbe schiacciato in terra molti, e che invece Ray Charles ha affrontato sempre a testa alta, rialzandosi dopo ogni caduta, salendo sempre un gradino più in su, senza mai fermarsi, nemmeno negli ultimi anni, quando la vecchiaia aveva tolto smalto e superbia al ragazzino d’un tempo, ma non aveva spento la passione per la musica. Brother Ray non è soltanto un autobiografia ma anche una fotografia, particolarissima, dell’America, con i suoi pregi e i suoi difetti, raccontata con semplicità, l’America degli anni Cinquanta e Sessanta soprattutto, vista con gli occhi di un afroamericano che doveva combattere ogni giorno contro il razzismo LA DOMENICA DI REPUBBLICA 37 («Non è che vada tanto a sbandierarlo in giro, ma sono stato uno dei primi artisti a beccarsi una denuncia per aver rifiutato di esibirsi compiacendo i bianchi»). Un’America nella quale si muove un ragazzino di straordinario talento che suona il pianoforte come un diavolo e canta come un dio. C’è tutto Ray Charles, insomma, in questo libro, c’è il racconto della cecità, a sei anni, a causa di un glaucoma, e quello degli esordi nel mondo della musica, alla fine degli anni Quaranta, quello della ribellione alle regole del sistema, quello del successo, arrivato all’inizio degli anni Cinquanta e cresciuto in maniera esponenziale fino a fare di Charles uno dei grandi divi della musi- ca nera, quello della dipendenza dalla droga, che lo porterà in prigione negli anni Sessanta e, addirittura, ad abbandonare le scene per più di un anno. Ci sono molte storie all’interno di questa affascinante storia, raccontata con il tono del dialogo tra amici, senza pretese letterarie, senza inutili abbellimenti, molti aneddoti divertenti e molti tragici, nei quali Charles si presenta spesso per quello che era, con molti limiti personali e grandi pregi artistici. David Ritz ha aggiornato il libro, portandolo fino alla fine con una necessaria appendice, per chiudere il cerchio e consentire a Ray di uscire di scena, come è stato per gran parte della sua vita, con un ultimo, scrosciante applauso. ‘‘ POVERO CON LA “P” MAIUSCOLA ‘‘ LA MUSICA DENTRO ‘‘ VERSO IL BUIO ‘‘ LA SCELTA DELLA DROGA ‘‘ AMORE E SESSO Avete presente quelli che dicono di essere poveri? Sentite me: quando dico che eravamo poveri, intendo poveri con la P maiuscola. Anche rispetto agli altri neri di Greensville noi eravamo sul primo piolo della scala e dovevamo guardare tutti dal basso. Sotto di noi c’era solo la terra. Per dire, ero già abbastanza grandicello quando ricevetti il mio primo paio di scarpe. Il bagno dentro casa, neanche ce lo sognavamo Sono nato con la musica dentro. È l’unica spiegazione che so darmi, visto che nessuno dei miei parenti sapeva né cantare né suonare uno strumento. La musica era una delle parti di cui ero composto. Come le costole, il fegato, i reni, il cuore. Come il sangue. [...] Era una necessità, come il cibo o l’acqua. E dal momento in cui appresi che sul pianoforte c’erano dei tasti che potevo pestare, cominciai a pestarli, cercando di fabbricare dei suoni a partire dalle mie emozioni Diventare ciechi. Suona come un destino peggiore della morte, no? Qualcosa che travolgerà un bimbo, lo spaventerà, lo lascerà mezzo pazzo e pieno di tristezza. Be’, non è andata così, almeno per me. Forse perché ci sono voluti due anni prima che perdessi la vista completamente. [...] E credo sia questo il motivo per cui non ho mai avuto troppa paura. [...] All’inizio riuscivo ancora a distinguere le forme più grandi, poi solamente i colori, e alla fine nient’altro che il giorno e la notte Per 16 o 17 anni ho fatto uso regolare di sostanze varie e non incoraggerei mai nessuno a fare il coglione con la droga. Eppure, forse qualcuno si stupirà, non ho nessun racconto dell’orrore da farvi. [...] Per cui non posso vendervi luoghi comuni. L’argomento è troppo importante. Posso solo dirvi quello che è successo a me e dirvelo chiaro e semplice. Non è colpa di nessuno. Sono stato io a decidere. [...] E poi, per quanto suoni folle, non ho rimpianti Sono sempre stato senza freni in fatto di donne, e solo ora riesco a capire come la mia lunga serie di avventure abbia finito per distruggere il mio matrimonio. Le donne sono la mia ancora. [...] Non dico di averne amate chissà quante. Amore è una parola speciale, e io la uso solo quando la sento davvero. [...] Ma il sesso è un’altra cosa . Non credo che di sesso se ne possa mai fare troppo. Per me è una delle tante esigenze quotidiane, come mangiare. Se sto senza per 24 ore di fila, mi viene fame DOMENICA 27 MARZO 2005 spettacoli Note politiche EDMONDO BERSELLI L a politica non canta più. Nei congressi di partito hanno preso in prestito qualche cantautore. Si sono ascoltate La canzone popolare di Ivano Fossati, che di politico non ha nulla, Viva l’Italia di Francesco De Gregori, addirittura Una vita da mediano di Luciano Ligabue, che dovrebbe evocare una misteriosa analogia fra Oriali e Prodi. Sono citazioni e allusioni più che inni, metafore invece che proclami cantati. Della vecchia musica politica rimane nella memoria collettiva solo qualche traccia convenzionale, Bandiera rossa e una strofa dell’Internazionale. Chissà chi ricorda più l’inno scelto dalla Dc, O biancofiore, composto nel 1907 da don Dario Flori, un seguace di Romolo Murri. Oggi suona paradossale che nei giorni politicamente bollenti della campagna elettorale del 1948, mentre quelli del Fronte popolare cantavano «Il 25 aprile / c’è nata una puttana / e le hanno messo nome / Democrazia cristiana», i democristiani potessero mobilitarsi cantando il grottesco aulico della loro strofa: «Udimmo una voce, corremmo all’appello. / Avanti la croce del re d’Israello! / Avanti cantiamo la nostra canzone: / estrema tenzone ci attende: corriam!». Per un tuffo in un repertorio generale dei canti politici è dunque utilissimo il nuovo libro di Stefano Pivato, Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia (pagg. XII-362, euro 18), un volume scritto in collaborazione con Amoreno Martellini che Laterza manda in libreria dal 14 aprile. Pivato insegna storia contemporanea a Urbino ed è avvezzo ad affrontare la vicenda italiana per via laterale: fra i suoi libri si può ricordare Il nome e la storia (1999), che trattava l’onomastica in relazione alle fedi politiche del LA DOMENICA DI REPUBBLICA 39 L’Ottocento e il Novecento sono secoli permeati da musiche di liberazione e disperazione, di rassegnazione e lotta. Prima la Marsigliese, poi i canti del risorgimento e delle guerre mondiali e infine Bella ciao. Un libro adesso riordina il pentagramma di una tradizione scomparsa Quando le canzoni facevano la Storia nostro paese; e La storia leggera (2002), un saggio dedicato all’uso pubblico della canzone, che costituisce l’antecedente diretto di questo nuovo lavoro. Oggi la politica non si fa canzone perché la retorica dei partiti ha trovato altri strumenti, e nell’epoca della politica “fredda”, del populismo elettronico, del riformismo spassionato, della postpolitica e del disincanto, il sentimento viene espunto dal circuito politico. Invece, quando la politica era calda, nel mondo incantato delle grandi religioni terrene, dalla Rivoluzione francese in poi, gli inni e le canzoni hanno fuso il sentimento di massa con le posizioni di parte. Facendo leva sulla matrice di ogni canto politico, La Marsigliese, l’Ottocento e buona parte del Novecento sono secoli canori, permeati da note di liberazione, di riscatto, di disperazione, di rassegnazione e di lotta. Pivato ha il merito e la capacità di mettere le mani in un sedimento culturale di una vastità impressionante, e di una varietà insidiosa. Perché è vero ad esempio che la rivoluzione nazionale e lo spirito risorgimentale si sono cristallizzati nei più popolari inni garibaldini, «Si scopron le tombe, si levano i morti», oppure nell’irredentismo esaltato di «Morte a Franz, viva Oberdan!». Ma in parallelo l’immaginario dell’Ottocento rispecchia anche l’inclinazione borbonica delle plebi meridionali, «Viva, viva BELLA CIAO Sulla canzone politica il nuovo libro di Stefano Pivato pubblicato da Laterza, “Bella ciao. Canto e politica nella storia d’Italia” Ferdinando, nostro padre, nostro re», fino agli exploit goliardici e reazionari che esaltano la revanche antifrancese all’epoca della Repubblica partenopea: «È venuto lu papa santu / ch’ha portato li cannoncini / p’ mazzà li giacobini / et voilà et voilà / caici in culu a li libbertà». Così come nella Sicilia subito dopo l’Unità, nel clima del Gattopardo, ecco una protesta contro l’amministrazione sabauda, «Governu ‘talianu è vero buttanu / ci suca lu sangu a lu povir’omu», in quanto «c’è tassa ppi tuttu: manciari e biviri, / vigghiari e durmiri, campari e muriri!». Insomma, anche nella politica cantata si manifestano linee diversissime, una classicamente di sinistra e altre a essa estranee se non opposte. La prima si esprime con gli inni del movimento operaio, «Su fratelli, su compagne / su venite in fitta schiera», e rievoca lo strazio degli anarchici cantato da Pietro Gori, «Addio, Lugano bella o dolce terra pia». Siamo nel 1895; poche stagioni dopo, nel maggio del 1898, la repressione cruenta operata a Milano dal generale Bava Beccaris originava un epicedio disperato: «Alle grida strazianti e dolenti / di una folla che pan domandava / il feroce monarchico Bava / gli affamati col piombo sfamò». Ma accanto agli inni “di classe”, ossia alle canzoni di filanda, ai canti delle mondine, ai lamenti dell’emigrazione, con la Belle Époque prendono l’aria anche i primi ritornelli nazionalisti: «Avvolta nella bandiera tricolore — racconta Pivato — la famosa chanteuse Gea della Garisenda infiamma gli animi degli spettatori dei teatri di varietà quando intona “Tripoli bel suol d’amore…”». Intorno alla Grande guerra è un fiorire di canti, ora eroici ora luttuosi, che evocano la parola patria: simboleggiati dal più famoso fra tutti, La leggenda del Piave di E. A. Mario, a cui si riferì Benito Mussolini parlando di «quel brivido sottile che percorre le membra quando si sentono le sue note». Sul fronte fascista c’è la «maschia gioventù», il «santo manganello», la «primavera di bellezza», la «bella morte» dei militi della Rsi. A sinistra i canti della Resistenza, Pietà l’è morta, Fischia il vento, infuria la bufera, le esecrazioni triviali della Badoglieide. Dopo L’attentato a Togliatti del cantastorie emiliano Marino Piazza, la canzone politica sarebbe transitata oltre la prima modernizzazione soprattutto con il Cantacronache di Fausto Amodei, Sergio Liberovici e Michele Straniero. Proprio Per i morti di Reggio Emilia di Amodei è forse l’ultima grande “canzone popolare”, una narrazione fissatasi nella memoria contemporanea (insieme a Contessa di Pietrangeli, ma con ben altra tensione epica). Dopo di allora, secondo Pivato, per cercare la politica in musica bisogna trovarne le tracce in certe suggestioni di Tenco, nelle allegorie di De Andrè e di De Gregori, a cui si deve il rilancio più progettuale della canzone politica, Il fischio del vapore, un disco realizzato con Giovanna Marini. Ma non è più la stessa musica. Anche se alla fine i movimenti chiudono il cerchio recuperando Bella ciao e trasformando la tradizione in un canto di protesta “globale”. 40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 i sapori Le ultime cifre Istat danno in crescita sia i consumi interni che le esportazioni. Ma il mercato globale è ricco di concorrenti. Così dal 7 all’11 aprile a Verona produttori, sommelier, degustatori e semplici curiosi si troveranno per capire dove va l’Italia delle vigne, delle cantine e dell’enoturismo Tempo di Vinitaly itinerari San Vigilio Uno dei luoghi più incantevoli del lago di Garda, con la passeggiata sul lungolago e il centro storico dominato dal colle della Rocca. Oltre la punta, da vedere la baia delle Sirene DORMIRE LOCANDA SAN VIGILIO (con cucina) Punta San Vigilio Tel. 045 7256688 Camera doppia da 120 euro, colazione inclusa Il veronese Giancarlo Perbellini è uno dei migliori chef di nuova generazione. Nella sua “offelleria”, a pochi km dal ristorante di Isola Rizza (www.perbellini.com), si preparano colombe, offelle e pandori di qualità eccezionale acquistabili on line Soave Valeggio sul Mincio Deve il nome ai suoi fondatori (Svevi). Circondata da una cinta muraria con 24 torrioni, è adagiata ai piedi di tre valli, dove le colture della vite e dell’ulivo hanno radici millenarie Imperdibili le fortificazioni medievali (castello Scaligero, ponte Visconteo) e il bellissimo Borghetto, antico villaggio di mulini sul fiume. E’ zona d’eccellenza per i tortellini DORMIRE DORMIRE CENTRO SAN FELICE (con cucina) Località San Giacometto Illasi. Tel. 045 6520586 Camera doppia da 70 euro, colazione inclusa AGRITURISMO CORTE Marzago Località Le Bugne Tel. 045 7945104 Camera doppia da 60 euro, colazione inclusa MANGIARE MANGIARE Il PORTICCIOLO Lungolago Marconi 22 Lazise Tel. 045 7580254 Chiuso il martedì, menù da 30 euro LA TERRAZZA Via Cesari 1 Montecchia di Crosara Tel. 045 7450940 Chiuso domenica sera e lunedì, menù da 50 euro BOTTEGA OSTERIA AL PONTE Via Michelangelo Buonarroti 24 Località Borghetto Tel. 045 6370074 Chiuso mercoledì, menù da 30 euro COMPRARE COMPRARE COMPRARE ENOTECA ALLA CALLE Via Calle Dei Sottoportici 5, Garda Tel. 045.7256485 CANTINA DI SOAVE viale Vittoria 100 Tel. 045 6139811 PASTIFICIO ARTIGIANO Via Sala 24 Tel. 045 7951630 MANGIARE Vino 9 mld Il settore vinicolo nel 2004 ha fatturato 9 miliardi di euro LICIA GRANELLO S iete tra quelli che se chiudono gli occhi faticano a distinguere un bianco da un rosso? Oppure avete allestito la vostra cantina come un piccolo santuario? Il trentanovesimo Vinitaly — in programma dal 7 all’11 aprile — fa comunque per voi. Perché non esiste fiera più trasversale, caotica, onnicompensiva, democraticamente divisa tra degustazioni pateticamente inutili e meravigliosamente imperdibili, tra affaristi trafficoni e produttori specchiati, tra piccole produzioni di alta qualità ed etichette da grandi numeri di mediocrità imbarazzante (a volte anche il contrario, ma è più difficile), capace di emozionare, annoiare, mettere in ansia, stupire i suoi frenetici, tantissimi visitatori. È la tipologia stessa del Vinitaly, ad attrarre irresistibilmente addetti ai lavori e curiosi, semplici appassionati e gente che col vino ci campa da generazioni. Esistono le fiere-bomboniera come il Merano Wine Festival di novembre — i produttori che servono personalmente i vini, le cene di gala, il cotè gastronomico in primo piano — o appuntamenti iperprofessionali come il Vinexpò, in programma a Bordeaux la terza settimana di giugno — * Sagrantino Montefalco 25 anni 2001 Arnaldo Caprai Un rosso di grande forza e ampiezza, ma senza sbavature. In enoteca a 60 euro Il Made in Italy tutto da bere stand di studiata bellezza, degustazioni eleganti, la Francia enologica al gran completo — entrambi pieni di meriti e di fascino. Ma il Vinitaly ci appartiene perché è cresciuto con noi: da occasione per trangugiare tutto quanto arraffabile sui banchi — quanti biglietti regalati ai bar per riempire gli stand… — a luogo di appuntamenti incrociati per ristoratori ed enotecari, vignaioli e agenti di vendita, dove le bottiglie diventano occasione e strumento per agguantare un pezzo di futuro economicamente più stabile. Tutti un poco più confortati, quest’anno, dalle ultime analisi Istat, che annunciano una risalita nei consumi familiari (otto milioni di bottiglie in più), dato rimarcato dal primato del vino nell’export agroalimentare. Ma come affrontare la fiera senza strapazzare troppo il fegato o far esplodere i palloncini misura-alcol * La Top Ten Qui sotto i migliori 10 vini italiani secondo il mensile di Milano Finanza "Gentleman", che ha reso omogenei e poi sommato i punteggi delle 5 principali guide di settore (Ais, Espresso, Gambero Rosso/Slow Food, Luca Maroni, Luigi Veronelli) Masseto 2001 Ornellaia Una bella conferma per il più prestigioso tra i Merlot italiani, fine e intenso. In enoteca a 130 euro Barbaresco Rabaja 2001 Bruno Rocca Un mirabile assemblaggio di frutti maturi, dagli accenti profondi e fragranti. In enoteca a 50 euro nel raggio di cinque miglia? Il decalogo del buon visitatore prevede che la giornata cominci con una colazione abbondante — gli esperti consigliano anche un paio di cucchiai d’olio per “foderare” le pareti dello stomaco. Nel caso, prima di entrare al Vinitaly, passare dagli stand del Sol — che ci si porti appresso una o più bottigliette d’acqua per stemperare la quantità d’alcol ingoiata, e che non si accettino tutti gli assaggi proposti. Se invece gli affollamenti vi inquietano, lasciatevi la Fiera alle spalle e godetevi una passeggiata nel cuore di Verona: al palazzo della Gran Guardia, ogni giorno dalle 17 alle 22, troverete centinaia di vini di fascia alta in degustazione (10 euro per tre assaggi di vini, uno di olio, guida e bicchiere compresi). Oppure spostatevi in piazza Zagata e godetevi il bel programma di Critical Wine-Terra e Libertà, la manifestazione di enologia etica creata da Luigi Veronelli, alla cui memoria verrà dedicata l’edizione di quest’anno. Scoprirete che la terra e il vino sono molto più inestricabilmente legati di quanto sembri bevendo certe bottiglie: tanto perfette e algide da somigliare più a un prodotto di catena di montaggio che a una creatura viva (come dovrebbe essere il vino). Bolgheri Rosso Superiore Ornellaia 2001 Vendemmia magica per uno dei Super Tuscans più famosi del mondo. In enoteca a 85 euro Barbaresco 2001 Gaja L’ennesimo Gran Rosso del vignaiolo che ha imposto il Barbaresco nel mondo. In enoteca a 120 euro DOMENICA 27 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 41 54 mln L’Italia nel 2004 ha prodotto 54 milioni di ettolitri di vino IL PREMIO “CARTA DEI VINI” Con uno sponsor astemio (un’acqua minerale) e il supporto Ardi, Associazione Internazionale ristoranti d’Italia, via al concorso “Migliore carta dei vini”, riservato ai ristoranti italiani di qualità all’estero. Diecimila gli invitati, segno che il mercato estero – qui filtrato dalla casa-madre Italia – è considerato un canale privilegiato per lo sviluppo dei consumi di bottiglie nazionali. Si premiano: miglior carta dei vini, scelta più creativa, migliore selezione italiana, servizio innovativo Come vincere la scommessa dell’export Mettete in bottiglia terra, storia e cultura ENZO VIZZARI I VINI ITALIANI & PIATTI EUROPEI I piatti dell’alta cucina europea abbinati alle etichette nazionali. Due gli appuntamenti quotidiani del “Wine&Food Paring”, per gustare le ricette-culto di 4 tra i migliori cuochi stranieri under 40, membri dell’associazione Jre, giovani ristoratori europei. Saranno gli stessi chef (il francese Jean-Jacques Daumy di La Cignette, Christian Franz del Belvedère in Lussemburgo, Ivan Louer dell’olandese De Eetkamer e Mario Holtzem del belga De Boote) a scegliere i vini 1.710 mln La spesa annua degli italiani per vini è di 1.710 mln di euro GLI ENOVIAGGI DI GULLIVER Non si vive di soli Chardonnay, Merlot e Cabernet. In linea con l’opera di salvaguardia dei vitigni autoctoni – a Napoli dal 3 al 5 giugno il primo salone nazionale a loro dedicato – il Vinitaly chiama a raccolta i produttori che in tutta Europa hanno privilegiato le tipologie più legate ai rispettivi territori. Ad affiancarli, un ventaglio di guru della sommellerie mondiale dal campione del mondo, l’italiano Enrico Bernardo, al greco Kostas Toloumtzis 50 litri In Italia è di 50 litri all’anno il consumo di vino pro capite I SAPORI DEL “SOL” Compratori e appassionati da 60 paesi invaderanno l’area della Fiera dedicata al Sol, Salone internazionale olio di qualità, per degustazioni comparate e mini corsi di tecnica di degustazione. Alla vigilia, il gruppo dei Verdi presenterà un pdl per obbligare i ristoranti a mettere in tavola solo bottiglie d’olio con etichetta. La sera, saranno annunciati i vincitori del concorso “Sol d’Oro”: 300 gli oli in gara, nelle tre categorie leggero, medio e intenso Aglianico del Vulture Basilisco 2001 Rosso di spiccata personalità mediterranea: speziato possente e verace. In enoteca a 36 euro Vino Nobile di Montepulciano Asinone 2001 Poliziano Un rapinoso vino di carattere, figlio del territorio. In enoteca a 35 euro Vino Nobile di Montepulciano Vigneto Antica Chiusina 2001 Fattoria del Cerro Altro rosso di “terroir”, dalle cadenze armoniose. In enoteca a 35 euro dentità, qualità e marketing, sembrano essere le parole d’ordine dei produttori italiani alla vigilia del Vinitaly, dove si cercherà di capire che cosa sta davvero succedendo nell’Italia e soprattutto nel mondo del vino. Corazzata salda ancorché afflitta da problemi strutturali e logistici, criticato da operatori e visitatori, il Vinitaly resta in realtà l’unico vero appuntamento irrinunciabile del mercato fieristico, cui nessuno che voglia fare affari nel vino in Italia e con l’Italia può sottrarsi. Tanto per cominciare, dopo fiumi di parole e di pianti spesi per denunciare la gravità non solo della crisi del mercato interno ma anche delle crescenti difficoltà nell’export, dal Vinitaly uscirà probabilmente una prima credibile sintesi fra le diverse valutazioni e sulle prospettive, che giorno sì e giorno no, i produttori esternano, contraddicendosi l’un l’altro. «Non si tratta di congiuntura negativa, stiamo vivendo una crisi strutturale dovuta a tre fattori: sovrapproduzione a livello mondiale, drastica caduta dei consumi interni, minor competitività sui mercati esteri», tuona Gianni Zonin. Proprio il contrario di quanto emerge dal sondaggio svolto poche settimane fa da Winenews.it, sito web tematico tra i più seri e documentati, tra cinquanta grandi imprese del settore, che al settanta per cento hanno dichiarato di aver aumentato il proprio fatturato nel 2004 e prevedono un 2005 ancora migliore. E di queste oltre un terzo ha segnalato una significativa crescita della vendita in Italia… D’accordo su tale valutazione, pur con diverse sfumature, Marco Caprai, Francesca Planeta, Michele Bernetti di Umani Ronchi, Martino De Rosa del Gruppo Wiish (Contadi Castaldi capofila), Enrico Viglierchio di Castello Banfi. Tutti concordi, comunque, sul fatto che il comparto stia attraversando una fase di riflessione nella quale ogni azienda, se non l’ha già fatto, deve ridefinire obiettivi, prodotti, strategie e riposizionarsi sul mercato. Secondo Angelo Gaia, «ha poco senso ragionare in termini di mercato domestico, perché, diciamolo francamente, per il vino l’Italia è e resterà un mercato povero, limitato. In una prospettiva mondiale la ricetta è che i produttori italiani alzino il tiro, cioè la qualità, dei propri vini, spostandosi con decisione dai “vini da tavola”, di prezzo sino a 4 euro a bottiglia, ai cosiddetti “premium wine”, categoria che nel lessico adottato dagli americani ricomprende i “popular premium” (da 4 a 12 euro), i “premium” veri e propri (da 12 a 50), i “super premium” (da 50 a 150) e gli “ultra premium” (oltre 150 euro)». E in effetti tutte le previsioni convergono sul fatto che da qui al 2008 cresceranno in misura maggiore le vendite di vini di prezzo superiore ai 4 euro che quelle di vini meno costosi. La scelta pare quindi obbligata, per tutti: fare più qualità e fare tanto marketing, molto più meditato e mirato che in passato. Valorizzando l’identità dei nostri vini, puntando sempre più sui vitigni autoctoni peculiari dei nostri terroir, lasciando perdere i modelli internazionali e omologati. E naturalmente dandosi una robusta regolata sui prezzi, nei quali quasi tutti i produttori nostrani hanno esagerato, salvo poi vedere anche marchi prestigiosi attuare spudoratamente politiche del tipo “prendi tre casse, ne paghi due” o addirittura “una cassa a prezzo pieno, una cassa regalata”. In ogni caso più aglianico e montepulciano d’Abruzzo, negroamaro e insolia, nebbiolo e ribolla, meno cabernet, merlot e chardonnay. Una cura particolare va poi dedicata ai mercati più vasti e a quelli emergenti. Che restano innanzitutto gli Stati Uniti, sbocco già fondamentale con spazi importanti di crescita, poi la Germania quando la sua economia riprenderà a tirare, e i nuovi clienti tutti da conquistare, cioè la Federazione russa, la Cina, l’India (dove i consumi di vino crescono del venticinque per cento l’anno), i paesi scandinavi. «Vinciamo se facciamo qualità, certo, dobbiamo però essere più efficaci nel vendere non solo le nostre bottiglie, ma la nostra storia, la nostra cultura, tutti i prodotti d’eccellenza della filiera agroalimentare, la nostra cucina che suscita nel mondo una richiesta impressionante di cuochi, formatori, operatori vari», riassume Enzo Ercolino di Feudi di San Gregorio. Bolgheri Sassicaia 2001 Elegante come non mai, il vino-culto del marchese Incisa della Rocchetta. In enoteca a 90 euro Barolo Vursù Vigneto Campè 2000 La Spinetta Interpretazione raffinata e seducente del cru orginario di Grinzane Cavour. In enoteca a 100 euro DOMENICA 27 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 43 gli stili Da sempre ci preoccupiamo di fabbricarci un’immagine capace di piacere agli altri e di assicurarci più potere. E recitiamo come attori sul “palcoscenico del mondo”. Adesso un libro in uscita, “Che figura”, ci spiega le emozioni che questo travestimento pubblico può dare e come può stimolarci a migliorare Usi sociali FOTO CORBIS La nostra vita in maschera CARLOTTA MISMETTI CAPUA Q ROMA uando la mattina scegliete un vestito, quando salutate qualcuno per strada, ogni volta che dite qualcosa in riunione o raccontate un aneddoto ad una cena tra amici, state facendo quel che si dice “impression management”. La formula, che oggi trovate sulla brochure di un qualunque corso per dirigenti d’azienda, l’inventò negli anni Sessanta Erwin Goffman, accreditato antropologo americano il quale, prendendo sul serio la battuta di Shakespeare in As You Like It — «tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne non recitano che una parte» — , si mise a studiare e misurare i meccanismi di questo mercanteggiare sociale, gli scopi e le sue tecniche. L’impression management, ovvero l’arte di mostrare agli altri la nostra immagine migliore o, per dire esattamente, quella utile all’uopo, è quanto racconta Cristiano Castelfranchi, cognitivista del Cnr e docente all’università di Siena, in Che figura, breve trattato di psicologia sociale pubblicato da Il Mulino. Quale che sia il nome di questa recita, tra le più incessanti, defatiganti e necessarie attività dell’uomo, Castelfranchi cerca di indagarne gli scopi: perché teniamo tanto a mostrarci migliori di quel che siamo (considerata la fatica che costa)? Ovvio, il nostro tornaconto: più considerazione, più opportunità e dunque più potere. E il libro spiega con molte 1 L’ammirazione L’invidia 3 La derisione È un attacco diretto all’immagine dell’altro, camuffato con l’ironia: un insieme di riso e di pena, spesso suscitati dallo stesso elemento. Per i Padri della Chiesa il riso era una manifestazione diabolica 4 La superbia La vergogna Nasce dallo sguardo dell’altro, che vede o dice cose che non avremmo voluto mostrare. Ci si vergogna anche davanti ad estranei, di cose di cui non avremmo ragione di vergognarci, come inciampare per strada La pena La pena, come la carità, è un sentimento socialmente fuori moda (oggi si preferisce il mutualismo della solidarietà). È legata ad uno stato d’inferiorità e per questo è dannosa alla nostra immagine 5 L’ammirazione è il giusto ed educato riconoscimento delle virtù dell’altro. È un sentimento costruttivo che favorisce l’attaccamento di chi si ammira e ci spinge all’emulazione È il più celato,o malcelato, dei sentimenti ma anche il più attuale. Scatta su un confronto di potere, è spesso gratuito, spesso ingiusto. La società lo condanna perché esprime un’inutile aggressività 2 complicate formule paralogiche le relazioni che intercorrono, con tragica prevedibilità, tra il potere che vogliamo e l’immagine che offriamo. Ma spiega anche — e qui la lettura si fa più leggera e anche più incoraggiante — che mostrare è dimostrare e dimostrare è migliorare. «Se l’altro riconosce un mio talento io mi sentirò motivato a coltivarlo e spenderlo: se sarò riconosciuto un buon capo sarò un capo migliore, se sarò valutato un buon padre sarò un padre migliore», spiega l’autore. Tra le funzioni più elementari della nostra faccia, o delle nostre molteplici maschere — non tutte le amministriamo, sia in pubblico che in privato alcune sono inconsapevoli e sono quelle a cui più siamo affezionati — ci sarebbe quindi anche quella primaria di stimarci. Alcune emozioni sono inevitabilmente legate a questa strategia perenne della nostra immagine. Sono quattro, e tutte negative, quelle di cui il libro racconta origini e meccanismi: l’invidia, la vergogna, la pena e la derisione. L’invidia è quella forse più interessante in questi tempi: pare esser diventata una moda, anzi quasi una misura sociale che ha sostituito il rispetto e l’ammirazione di un tempo. «Essere invidiati è diventato improvvisamente bello — spiega Castelfranchi — ed anche se le società generalmente condannano l’invidia in quanto sentimento anti-sociale, che sollecita le ostilità e boicotta la meritocrazia, oggi l’invidia sembra quasi essere diventata, nell’incertezza delle identità e delle ragioni che muovono le nostre vite, quasi una “griffe dell’anima”». Come difendere il fragile equilibrio tra come ci rappresentiamo e come siamo Essere o fare, il nuovo dilemma UMBERTO GALIMBERTI «T utto ciò che è profondo ama la maschera» diceva Nietzsche, e perciò: «Dammi ti prego una maschera ancora, una seconda maschera». Così parla il pudore che non vuole risolvere l’interiorità in esteriorità, che non vuole perdere l’anima nel rumore del mondo. Oggi noi viviamo nel mondo della rappresentazione e perciò siamo assetati di autenticità. Ma l’autenticità è davvero un valore quando viene identificata con la riservatezza del privato, su cui si buttano i giornali scandalistici secondo quelle derive della spudoratezza che oggi vengono contrabbandate per sincerità? Se vogliamo conservare la nostra anima per salvaguardarla dalla rapina del mondo e poterla preservare per gli eventi d’amore, nelle relazioni sociali dobbiamo offrire solo la nostra faccia che è poi la nostra maschera, perché la “faccia”, dal latino facere, la costruiamo noi. La faccia, infatti, è il vuoto del nostro corpo che io non vedo, ma gli altri vedono, per questo la chiamiamo anche “viso” che vuol dire «visto dagli altri». Un motivo questo che ritorna anche nell’espressione francese visage e in quella tedesca Gesicht. La nostra faccia è dunque quella che noi costruiamo a partire dallo sguardo degli altri, perché non si dà identità che non sia l’effetto del riconoscimento. Ma nelle relazioni sociali, attraverso quali vie passa il riconoscimento? Attraverso le nostre funzioni e prestazioni e, per restare nella metafora teatrale della maschera, attraverso il nostro “ruolo”, parola che fa riferimento al rotolo di pergamena sul quale l’attore di teatro nell’antichità leggeva la sua parte. E come nella rappresentazione teatrale interessante non è l’attore in quanto persona privata, ma il “personaggio”, la “maschera” che l’attore in virtù del suo ruolo rappresenta nel contesto drammatico, così nella società ciò che conta non è l’individuo nella sua specificità, ma il ruolo che svolge, che gli consente di entrare in relazione con gli altri, a loro volta rappresentati dai rispettivi ruoli. Se questo è vero, l’assunzione di un ruolo che è poi la maschera che garantisce la nostra identità sociale finisce col condizionare anche l’identità personale, che è data dalla coerenza fra i ruoli rivestiti nei diversi stadi della nostra biografia, di cui il curriculum traccia il profilo. Nella nostra epoca noi siamo dei curricula in cui so- no descritte in successione le nostre risposte alle richieste sociali che, opportunamente interiorizzate, costituiscono la trama profonda della nostra identità e lo spazio dischiuso alla nostra libertà, che è dunque libertà di ruolo vasta quanto l’articolazione curriculare. Mortificante? No, inevitabile. Già Aristotele avvertiva che l’individuo, preso singolarmente, non è riconoscibile direttamente e in se stesso, perché la sua leggibilità passa attraverso quella maschera (la funzione sociale) in cui si evidenzia la natura originariamente associativa dell’uomo (zoon politikon). Nella nostra epoca l’assunto aristotelico non solo rimane valido, ma l’aumento della complessità delle relazioni e dei criteri di leggibilità lo rende ancora più valido, perché se l’individuo dovesse proporre la sua identità personale al di là di quella sociale, in cui si esprime il mondo delle relazioni, apparirebbe folle, e se invece dovesse risolvere la sua identità personale nella funzionalità di quella sociale apparirebbe insignificante. Per evitare follia e insignificanza l’individuo deve giocare quel precario equilibrio che gli consente di rendere visibile la sua identità sociale unitamente alla consapevolezza del suo carattere fittizio, e insieme custodire la sua identità personale che gli permette di avere, nei confronti del suo ruolo, quella giusta distanza che gli consente di non identificarsi con la sua maschera e soprattutto di non confondere la sua maschera col suo vero volto. Questo delicato equilibrio, che è poi la fatica di essere uomo tra gli uomini, non è uno spregevole compromesso tra quel che veramente siamo e come ci rappresentiamo, ma è la salvaguardia del nostro spazio di libertà, perché se in ogni circostanza volessimo essere quel che davvero siamo non avremmo la libertà di divincolarci dalla nostra natura, così come se non riuscissimo ad essere altro dal ruolo che rivestiamo, oltre a dipendere da chi o dalle circostanze che ci assegnano il ruolo (finché ce lo concedono), avremmo semplicemente perso noi stessi. Per questo Nietzsche può dire: «Tutto ciò che è profondo ama la maschera». La maschera difende la nostra interiorità e tutela quello spazio tra il nostro fare e il nostro essere in cui è la radice della nostra libertà, preclusa tanto a chi si identifica col suo fare quanto a chi si perde nel suo essere. 6 Nasce dal bisogno di riconoscimento della propria identità e del proprio valore, può essere buona per chi la prova, ma anche ridicola e ostile agli occhi degli altri. Per i cristiani è un peccato capitale L’orgoglio 7 In giusta misura ci permette di difendere e costruire quello che siamo con dignità o di raggiungere i nostri obbiettivi. Quando travalica può trasformarsi in presunzione. Un tempo si chiamava amor proprio La vanità È l’illusione suprema, credere di poter apparire migliori di quello che siamo. “Vanità delle vanità e tutto è vanità” è detto al principio de l’Ecclesiaste: oggi è poco meno di un vizio e molto più di una moda 8 44 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 le tendenze Bellezza & business Nella generale flessione delle spese superflue, la cosmetica aumenta sensibilmente il fatturato Ecco i make-up sulla cresta dell’onda e quelli al tramonto, raccontati dagli addetti ai lavori alla vigilia del Cosmoprof di Bologna, il salone mondiale in calendario dall’1 al 4 aprile UN COLORE PER TUTTO Bohemian Chic è la linea di Ultima II, basata su toni coordinati, dal rossetto al gloss, all’ombretto, allo smalto da unghie ROSSO ASSOLUTO Idrata le labbra, le protegge dall’eccessiva aggressività del sole e le modella allo stesso tempo: il rossetto Le Rouge Absolu è l’ultima creazione messa sul mercato da Lancôme Trucco ORO E SETA Fra i suoi componenti ha anche oro e seta. The Lipstick di Kanebo, vanta un effetto antiinvecchiamento Facce lucenti contro la crisi LAURA LAURENZI R EFFETTO BAGNATO Un gloss lucidalabbra a effetto bagnato che non appiccica. Formula cremosa e idratante. Si applica attraverso un beccuccio con la punta obliqua. In dieci colorazioni, tutte prive di profumo, Colour Surge Impossibly Glossy di Clinique è un prodotto anallergico inunciamo a un vestito e a un paio di scarpe ma non al rossetto, non al mascara, non al fondotinta. La donna italiana si trucca, e spende per farlo. Cerca un look naturale, ma che è frutto di un laborioso e sapiente processo fatto di accostamenti e sfumature anche inedite, il risultato di un knowhow reso possibile da una gamma sempre più ampia di prodotti hi-tech, di ricerca, mirati verso il trucco su misura. Nella crisi generalizzata del superfluo, la cosmetica non soltanto tiene, ma aumenta il suo fatturato, che nel 2004 è cresciuto del 6 per cento rispetto all’anno precedente, e del 3,5 per cento per quanto riguarda il numero dei pezzi venduti. I dati verranno resi noti in ogni dettaglio al Cosmoprof, il salone mondiale della cosmetica che si terrà alla fiera di Bologna dall’1 al 4 aprile e cui partecipano 1.795 aziende, 900 delle quali internazionali. «Le italiane sono fra le donne che si truccano di più in Europa, hanno un modo di truccarsi più corretto e più consapevole, quella che potremmo definire la cultura del trucco, diffusa in tutto il Paese, là dove in Francia, per esempio, è limitata soltanto a Parigi», osserva Daniele Renica, make-up stylist. Varie sono le tendenze della moda, spesso in contrasto fra loro: «Una è il ritorno a un maquillage molto naturale, ma solo all’apparenza. In realtà è estremamente sofisticato, e si ottiene sovrapponendo diverse tonalità di fondotinta ottici che catturano la luce in modo multidirezionale. C’è poi la tendenza che potremmo definire “Vacanze anni Sessanta”, con il ripescaggio di colori pastello, ma anche di tonalità grintose e cariche su carnagioni dall’aspetto abbronzato, genere californiano». Cosa invece non sarà di moda? «L’eyeliner se troppo definito, le matite scure, i mascara troppo cupi», afferma Daniele Renica. «Sì invece ai kajal colorati o color carne, sì alle terre con una punta di glitterato, sì al mascara effetto bagnato, sì alle labbra satinate, sì alle sopracciglia dal colore contrastante rispetto a quello dei capelli». Riflessi cangianti, colori brillanti e vinilici rubati ai multipli pop di Andy Warhol, riflessi metallizzati, trasparenze specchiate. Estrema lucentezza, culto della luminosità, quasi della perlescenza: «Dopo tanto minimalismo reagiamo ai tempi bui nei quali siamo immersi con il desiderio di avere un po’ di allegria e un po’ di luce almeno in faccia», commenta Carla Volontè, responsabile comunicazione dell’italianissima Collistar, che nell’ultimo anno ha visto aumentare le vendite dei suoi cosmetici del 5,1 per cento. «La vera novità è il trucco su misura, sempre più sofisticato, modulato su ogni diverso tipo di pelle», spiega Carla Volontè. «Il fondotinta ad azione guidata, che si assorbe con differente densità nelle zone più grasse. Il mascara tecnico. Il rossetto personalizzabile, mai uguale a seconda dei diversi strati di gloss sovrapposti. Le matite multiuso, utilizzabili come kajal, come ombretto, o per le labbra». Entrare in una profumeria e comprare un fondotinta può risultare un’impresa, tante sono ormai le varianti, le possibilità e le opzioni che ogni prodotto rivendica. Un’importanza sempre maggiore — che incide sensibilmente sul prezzo — è quella del packaging, degli astucci, delle confezioni: non più soltanto dei profumi ma anche e soprattutto dei cosmetici. Racconta Vincent Ditrichstein, responsabile del design per Estée Lauder: «Le influenze più forti ci sono venute dal mondo dell’architettura, del design e della decorazione, forme e strutture pure, precise, ironiche. Abbiamo guardato e studiato i lavori degli architetti Frank Lloyd Wright, Le Coirbusier, Eileen Gray, per la loro sensibilità pionieristica e per l’uso avventuroso e non ortodosso dei materiali e degli abbinamenti. Infine abbiamo coltivato riferimenti dell’Art Deco, per la volumetria delle sue linee. E per i colori degli astucci abbiamo intervistato 17mila donne». Per un rossetto. ‘‘ Bette Davis Gli uomini diventano molto più attraenti quando cominciano a sembrare più vecchi. Ma per le donne non funziona così, sebbene noi abbiamo un vantaggio: il trucco LOOK NATURALE PRIMA DELLA TINTARELLA FONDOTINTA SPRAY Garantisce un effetto naturale Light! di Biotherm, un fondotinta impalpabile per sembrare non truccate Predispone la pelle all’abbronzatura proteggendola dal sole. Gel Eclat d’Eté di Yves Saint Laurent Addio spugnette: ora il fondotinta si nebulizza. Diorskin Airflash è spray e garantisce un effetto ultranaturale DOMENICA 27 MARZO 2005 LA DOMENICA DI REPUBBLICA 45 il rossetto Ogni donna possiede in media otto rossetti. Si tratta ancora oggi del cosmetico più venduto al mondo (oggi nella versione lipgloss, più naturale). Le tonalità più richieste vanno dai rosa beige ai rosa vivi fino ai rosa malva, ma il rosso scarlatto è la tinta che più di ogni altra resiste alle mode il mascara Le donne europee lo usano in media almeno cinque volte a settimana. È oggi sempre più tecnico, dotato di microscopiche fibre sintetiche che promettono il raddoppio delle ciglia, sia in foltezza sia in lunghezza, effetto extensions il fondotinta LABBRA AL CIOCCOLATO Oggi è come una seconda pelle, coprente e naturale insieme, leggero, ad assicurare una protezione dal sole e dallo smog. Soprattutto è a lunga durata (anche 16 ore) È al gusto oltre che al profumo di cioccolato il balsamo per labbra Lush: fra gli ingredienti anche miele, vaniglia, arancia, mandarino, burro di karitè, olio di germe di grano e olio di mandorle CIGLIA PIÙ FOLTE Acacia del Senegal, proteine della seta, pantenolo, olio di avocado e pigmenti micronizzati sono fra gli ingredienti di Fabulash Mascara di Revlon, che garantisce ciglia più folte e zero grumi. Spazzolino brevettato con setole differenziate DUE IN UNO Due prodotti in uno: è l’Eyeliner Duo di Collistar, uno stilo che da un lato è un eye-liner, dall’altro un ombretto. Gli abbinamenti sono nero più azzurro e nero più rosa l’ombretto I nuovi tipi variano se usati asciutti o bagnati. Nel primo caso hanno un effetto più naturale, nel secondo hanno un risultato più luminoso OMBRETTO HI-TECH Le polveri micronizzate garantiscono la massima adesività. In ogni astuccio quattro ombretti: è il Graphic Color Eyeshadow Quad, di Estée Lauder AL CARBONE Ultra-nero effetto ciglia finte agli estratti di carbone. Cil Architecte Midnight Black, di L’Oréal, è dotato di uno speciale applicatore a spirale che modella le ciglia dalla radice alla punta MASSIMO VOLUME Il mascara è, assieme al rossetto, il cosmetico più utilizzato dalle donne. Oggi è sempre più hi-tech, a lunga durata, volumizzante, come il Mascara Wonder Volume di Clarins Sui volti dipinti si specchiano fasi storiche e mode sociali FOTO ZEFA A I NASTRI DI COCO Ispirato ai nastri con cui Coco Chanel ornava abiti e cappelli, il nuovo fard/ombretto Ruban Perlé di Chanel nche le librerie più dotte hanno ormai un reparto impressionante che riguarda il trucco: pareva già esagerato che si parlasse di cultura della moda, adesso si sta diffondendo la cultura del makeup, seriamente. Si può scegliere tra montagne di saggi che vanno dall’archeologia del fondotinta alla storia della guerra attraverso la decorazione delle facce bellicose, sino agli studi spericolati, magari legati come Body Visions, a cura del sociologo Francesco Morace, proprio al Cosmoprof, in cui si sostiene che sono il corpo, il suo benessere, la sua bellezza e quindi la sua cura e valorizzazione a dirigere il futuro del pianeta. Quanto ai manuali pratici su come truccarsi, molto richiesti, ce ne sono montagne e il più venduto al mondo si intitola Face forward, autore il celebre inventore di facce Kevyn Aucoin, prematuramente defunto. Opera terrorizzante sin dalle prime pagine, ove mostra una quantità enorme di utensili necessari per raggiungere, dopo ore e ore di impegno, un risultato si spera soddisfacente. Per cominciare, almeno undici pennelli di diverso spessore e morbidezza e una tavolozza con un centinaio di cremine e polveri e liquidi e paste di vario colore, più matite e altri aggeggi, con cui lavorare accanitamente su una faccia per trasformarla in un’altra. Una faticaccia che solo le martiri della bellezza finta, con molto tempo a loro disposizione, possono affrontare. A meno di rivolgersi a un professionista eccellente, che un tempo si chiamava truccatore e oggi viene venerato come make-up artist: indispensabile figura, appunto di artista, per ogni servizio di moda o di pubblicità, in grado di prendere come materia prima una faccia grigia e insipida o assonnata o fatta (purché giovanissima), e di lavorarci su come un miniaturista, per farne un’opera Sopracciglia perdute da Mina a Costantino NATALIA ASPESI d’arte, la raffigurazione di uno stereotipo femminile magari fantasma ma ancora vivo nell’immaginario dei nostalgici, nelle soap opera e nei talk show: fatalona o innocente, seduttrice o sedotta, dominatrice o fiammiferaia; oppure, nel genere preferito dalle riviste più chic: pazza, ninfomane, drogata, stuprata, annegata, ecc. Da sempre le donne, ma anche gli uomini, hanno rifiutato la loro faccia, anche la più bella, desiderosi di nascondersi dietro una facciata che esprimesse o negasse l’edificio retrostante, cioè il segreto di sé. Con il trucco, con matite, pennelli, colori, si cancella e si riscrive la propria pagina, non potendo però sfuggire alle imposizioni del contesto sociopolitico. E se negli anni ‘60 i grandi truccatori dipingevano fiori o ali di farfalla sul volto della meravigliosa Twiggy, creando una facciata giocosa che parafrasava lo slogan «mettete fiori nei vostri cannoni», oggi in tempi di inquietudine e di guerra, il make-up serve alle donne per nascondere ogni eventuale debolezza e preparare al combattimento nella vita: facce dure, aggressive, cattive, per intimidire, che nelle esagerazioni delle riviste (decine di pagine sui prodotti di bellezza ad ogni numero) possono diventare spaventevoli, con gran battimani degli appassionati dei turbinosi trend. Quirino Conti, autore del bestseller Mai il mondo saprà, saggio irresi- stibile sulla moda, ricorda come il grande costumista Pietro Gherardi (quello di 8 ½ di Fellini) negli anni ‘60, quando la televisione era rispettabile, durante il varietà Linea contro linea depilò improvvisamente le sopracciglia di Mina. Togliendole un elemento legato all’espressività dell’ira, del corruccio, fece di questa ragazza già famosa, dal volto comune, un’astrazione, una icona impassibile sottomessa alla sua vocalità, una persona indimenticabile. Il trucco è tornato anche nella vita degli uomini che usano la propria immagine come potere. Infatti, se la telestar Costantino non fosse levigato come una statuetta di cera, e non avesse gli occhi blu esaltati da ombretti e mascara e la pelle color mattone per artifici sapienti, forse non avrebbe sedotto il popolo ambosessi mediasettizzato: perché non basta oggi che un giovane uomo non abbia nulla da dire e non sappia far altro che stare seduto, sorridere, portare jeans stracciati e mostrare muscoloni tatuati, prestandosi a finti litigi e falsi innamoramenti, per diventare un mito mediatico. Bisogna che su di lui cali una maschera che non gli appartiene, inventata con cupa sapienza dai manipolatori di immagini. Massimo intervento di trasformazione dalla natura all’incultura, è su di lui e sugli altri giovani maschi inventati dalle mode, non tanto il trucco quanto la depila- zione del corpo e soprattutto (in ricordo del gesto di Gherardi) delle sopracciglia, che priva definitivamente un uomo di ogni aggressività e quindi mascolinità. L’espressione melensa che ne deriva, non per niente promossa da trasmissioni televisive familiari nascostamente perverse, rende desiderabile la tipologia dell’uomo docile e mercificabile, asessuato e passivo, fintamente arrendevole. Non è una novità: si depilavano i giovani di età elisabettiana prima di accedere sottomessi nei letti principeschi, si depilavano i maschi nell’antica Atene per cancellare dal loro corpo ogni animalità. Si truccavano monarchi e damerini settecenteschi (e se ne sono visti meraviglie e orrori nel magnifico film di Kubrick Barry Lyndon) per esprimere grazia, si truccavano i guerrieri barbari per apparire più feroci. Buona parte degli eroi omerici si massaggiava con oli profumati e si depilava prima di affrontare sanguinosi scontri, e già che c’erano, nella promiscuità solo virile, giacevano tra di loro. Il viso innaturale, trasfigurato, non più umano ma quasi divino, poteva avere il potere di incantare le folle: e infatti Mosè torna dal monte Sinai raggiante per il suo incontro con Dio, e quando quella luce si spegne, si copre con un velo per non deludere il popolo di Israele. La convinzione di essere in contatto con Dio, unto dal Signore se non addirittura il Signore stesso, l’idea che il potere lo si esercita anche nell’immutabilità divina che non conosce la condanna alla decrepitezza umana, ha consentito al nostro attuale premier la crescita miracolosa dei capelli, il negromantico distendersi di rughe e flaccidità, il trucco continuo, sia davanti alle telecamere che nella quotidianità, perché il popolo non debba mai conoscere il vero volto di chi lo tiene in pugno. 46 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 27 MARZO 2005 l’incontro Miti dello schermo L’infanzia misera, la madre sempre troppo stanca per un gesto d’affetto, la scuola lasciata a tredici anni, il successo come attore col marchio di “007”, l’amore e le mogli, il nazionalismo scozzese e la nomina a baronetto da parte della regina dell’odiata Inghilterra. L’“uomo più sexy del mondo” ha cominciato un doloroso viaggio nella memoria per un’autobiografia che sarà pronta a giugno. “Per la prima volta credo di essere vicino a conoscere me stesso” Sean Connery ean Connery alla ricerca di Sean Connery. È un percorso nella memoria quello che da mesi impegna il «più grande scozzese contemporaneo» ovvero «il pensionato più sexy del mondo», che per rispettare il contratto con la Harper Collins dovrà consegnare le bozze dell’autobiografia entro la fine di giugno. Una bella impresa mettersi lì a ricostruire 75 anni di vita vissuti intensamente solo attraverso i ricordi. «Perché io non conservo nulla del passato, niente diari, niente lettere, niente appunti. Ho un animo da zingaro, mi piace viaggiare leggero, senza bagagli pesanti. Per fortuna ci sono le date dei film a dare una cadenza ai momenti essenziali della carriera», dice Connery. Il segno dei 75 anni — il prossimo 25 agosto — c’è: nella calvizie, nella barba tutta bianca, nel portamento un po’ meno eretto, nell’ombra di stanchezza che affiora a tratti nella sua inconfondibile voce dall’accento fieramente scozzese. Ma è bello comunque. Il fisico, sia pure leggermente appesantito, è ancora agile, forte, elegante, grazie all’altezza (un metro e 91), allo sport e ad una attenzione al corpo che viene da lontano (nel ‘50 il ragazzo Connery, ancora Thomas, fu terzo a Mr Universo). E il sorriso, tenero o malandrino, è sempre seduzione. Ancora quattro anni fa nell’inchiesta della rivista Peoplefu scelto come «l’uomo più sexy vivente». «Avete mai visto un morto più sexy di me?», commentò allora. L’ironia c’è sempre quando parla del fascino personale e delle donne. «Anni fa pensavo che le donne fossero attratte non da me ma da Bond, vissuto come un’icona, imperturbabile, sexy, intelligente, un vincitore, un uomo ideale a cui tutti, magari in segreto, vorremmo somigliare. Oggi che il mio Bond potrebbe agire solo su una sedia a rotelle, penso che le donne una nuvola di distrazione. Credo che il tempo modifichi le persone, le aiuti a crescere, a conoscere la vita. Io ho l’impressione di essere rimasto com’ero quando avevo 14 anni. Forse perché a 14 anni la vita la conoscevo già». C’è una commozione sincera nella voce di Sean Connery che ricorda l’infanzia povera di Edimburgo. «Mio padre lavorava solo saltuariamente, era mia madre che portava avanti la famiglia e io preferivo guadagnare qualcosa consegnando il latte la mattina piuttosto che andare a scuola, detestavo lo studio. Però non sento tristezza al pensiero del freddo e dei disagi di allora, era così e basta, i poveri non hanno tempo per gli stati d’animo, per sentirsi allegri o depressi. Ricordo solo la felicità dei momenti liberi passati a giocare a pallone. A 13 anni ho lasciato definitivamente la scuola e ho fatto mille lavori con in testa una sola idea, forse comune ai bambini di allora: andare in guerra. Sono entrato in Marina a 16 anni, a guerra finita. La mia carriera militare è durata tre anni, stroncata da un’ulcera che mi costrinse Mi piacciono le donne, quelle belle subito e quelle da scoprire, mi piace la femminilità da scovare in un gesto. Però amo anche gli uomini, non tutti e non allo stesso modo FOTO GAMMA/CONTRASTO S ROMA mi amino con senso materno, con il gusto un po’ perverso di proteggermi in vecchiaia». Del resto l’amore è ricambiato: «Mi piacciono le donne, quelle belle subito e quelle da scoprire, mi piace la femminilità da scovare in un gesto, in uno sguardo, nel modo di prendere in mano un bicchiere. Però amo anche gli uomini, non tutti e non alla stessa maniera». È facile prevedere che nell’autobiografia il capitolo sulle donne sarà tutt’altro che piccante e scandaloso, visto che l’attore anche nel momento di massima gloria è sempre riuscito a proteggere la sua privacy. Da trent’anni è felicemente sposato con la pittrice francese di origine tunisina Micheline Roquebrune che, dice, «non si preoccupa finché le donne che mi girano intorno sono tante. Comincerebbe a preoccuparsi se fosse una sola». Nel passato l’unico spunto da cronaca pettegola fu uno schiaffo alla prima moglie, Diane Cilento, madre del suo unico figlio Jason; e ci fu un’esplosione di femminismo indignato per le sue affermazioni maschiliste («non è violenza, uno schiaffo è l’unica cosa che placa certi momenti isterici o capricciosi di una donna») in seguito ritrattate: «Sono parole che avrebbe detto Bond, allora mi divertiva esprimermi come il personaggio, un grande seduttore, ma non certo un tipo capace di dolcezza o di grande amore». La decisione di scrivere della sua vita ha sorpreso molti. «Ha sorpreso anche me, avevo sempre detto che non lo avrei mai fatto e adesso capisco perché. Non solo per non ferire qualche persona ma perché è un’esperienza durissima, forse terapeutica ma molto dolorosa, che mi costringe a un’indagine nel passato e nella memoria. E talvolta affiorano ricordi che non avrei voluto ritrovare. Lo faccio per amore della verità. Ci sono almeno dieci biografie non autorizzate che mi riguardano. Non ne ho letto nessuna, ma nelle recensioni dei libri ho visto inesattezze, errori, bugie al limite della calunnia. Volevo chiedere rettifiche, ne ho parlato con l’avvocato. “Dovrei fare dieci denunce, ti costerei troppo. Meglio se scrivi tu la verità su te stesso. Puoi anche guadagnarci qualcosa”, mi ha risposto». Per la cronaca «qualcosa» sono due milioni di sterline del contratto con la Harper Collins. Tra i ricordi che Connery non avrebbe voluto ritrovare «ci sono volti di persone che sono uscite dalla mia vita senza che avessi il modo di dire loro le parole giuste, l’affetto o la stima che provavo, le scuse non espresse, le scelte inopportune, gli errori stupidamente ripetuti, le assenze da chi aveva bisogno di me. Non so se il libro farà scoprire agli altri qualcosa di nuovo di me, ma la vera scoperta l’ho fatta io. Per la prima volta credo di avvicinarmi alla conoscenza di me stesso, mi rendo conto di aver dedicato più tempo ad approfondire i personaggi e a identificarmi con loro piuttosto che a capire chi ero. Come se avessi vissuto dentro a una lunga degenza in ospedale». Ci sono due tatuaggi sulle spalle di Sean Connery, che riflettono i suoi valori di allora: Mum and Dad e Scotland forever. Valori semplici mai rinnegati, ed è forse nella forza di questo legame con le radici l’impressione di freschezza e di spontaneità che resta da un incontro con lui. Connery svela l’imbarazzo di chi non ha studiato: «La mia scuola è stata la vita». Ricorda senza falsi pudori suo padre «che non è mai venuto a trovarmi in ospedale, non aveva tempo né soldi, ma so che mi voleva bene, l’ho capito quando è mancato, è stata una delle poche volte in cui ho pensato seriamente di lasciare il cinema». Oppure sua madre: «Mi sono reso conto solo adesso che non mi ha mai abbracciato, mai un gesto affettuoso. Un po’ per carattere un po’ perché era sempre troppo stanca. Chissà, forse questo ha influenzato la mia vita affettiva e il mio rapporto con le donne». Scotland forever. Il nazionalismo di Sean Connery non ha mai avuto cedimenti. Anzi, di sir Sean Connery, un titolo che lo inorgoglisce, è il segno di un percorso trionfale, dalla povertà di Edimburgo al successo nel mondo, ma è anche un onore attribuito dalla regina di quell’Inghilterra che «opprime» la Scozia. «Quando me l’hanno proposto ho chiesto una settimana per riflettere. Poiché non mi hanno imposto di modificare nessuna delle mie opinioni, né artistiche né politiche, alla fine ho accettato il titolo. E nessuno, finora, me lo ha tolto, anche se continuo a dire quello che penso». E quello che pensa è che «non tornerò a vivere in Scozia finché non sarà indipendente. Finché anche il suo nuovo Parlamento — sono andato all’inaugurazione, ed ero felice di esserci — viene deciso da Downing Street». Non significa che in Scozia non sia presente: «Ci sono con la fondazione che si occupa di aiuto ai disabili, di scuole per i bambini bisognosi, con il progetto di una scuola di cinema. E insieme all’autobiografia sto collaborando alla stesura di una storia della Scozia in 14 volumi, che in parte diventeranno una serie televisiva della Bbc scozzese. Ma non posso vivere nel paese, il mio paese, in cui i media sono i più feroci nei miei confronti, perché tutti i media sono nelle mani di stranieri, di Rudolph Murdoch soprattutto». «Perché uno che non paga le tasse e non vive in Scozia deve dire agli scozzesi per chi votare?»: è uno degli slogan più perfidi diffusi dai media. «Ho un appartamento a New York ma sono felice solo quando sto nella casa delle Bahamas, dove trovo la pace di cui ho bisogno, leggo, gioco a golf, un’ora di piscina, guardo il tramonto. Non sopporto più la follia delle grandi città. Ma le mie tasse le pago, agli Stati Uniti e all’Inghilterra. Datemi la Scozia libera e non mi muovo da Edimburgo». La stessa passione nei toni di Connery c’è solo quando parla del golf che per lui «è più che una metafora della vita, talvolta è più reale della vita reale, ma solo chi lo gioca può capire. Anche se si fa un ottimo punteggio, si continua a pensare agli errori, ai colpi imprecisi. Come nelle opportunità che ti offre la vita. Ma se si è intelligenti bisogna dimenticare le cose cattive o le occasioni perdute e tenere a mente le cose belle. Solo così si va avanti. La mia vita è un misto di casualità e di fortuna». La fortuna per esempio è che Broccoli e Saltzman, produttori storici della serie di Bond, non furono d’accordo con Ian Fleming che come interprete del suo eroe voleva Cary Grant o David Niven. Ma dopo i primi minuti di 007 licenza di uccidere, alle parole ormai mitiche: «Mi chiamo Bond, James Bond», lo scrittore si ricredette, anzi diede al suo eroe la nazionalità scozzese. «Sono legato da odio e amore per Bond. Gli devo tanto, tutto, ed è bello sapere che una persona su quattro nel mondo mi conosca per lui. Ma mi addolora pensare che, avendo fatto oltre quaranta film — e alcuni mi sono più cari di altri, come Il nome della rosa o L’uomo che volle farsi re o Indiana Jones — sarò ricordato solo per 007». È anche vero che «Bond ha significato per me la scoperta del cinema, prima il mio sogno era di fare il calciatore, avrei giocato nel Manchester United se non avessi avuto uno strappo muscolare. Nella memoria infantile c’è solo un film: non ricordo il titolo, ma c’era un padre, un bambino e un cane; il padre era severo, voleva educare il cane all’obbedienza, il bambino voleva solo giocarci, uscii dalla sala odiando il padre. Ho imparato ad amare il cinema da adulto. Ma con moderazione. Seguo l’insegnamento di Hitchcock, che pur lavorando con pignola professionalità, alla fine della giornata salutava con: «Ricordiamoci che è solo un film». Amore moderato, ma non ancora spento: «Ogni tanto dico che sto per dare l’addio al cinema, anche di recente. Ma poi sono sempre felice di smentirmi. Datemi un bel copione, un’offerta che non posso rifiutare, e sono pronto a ricominciare». ‘‘ MARIA PIA FUSCO
Scarica