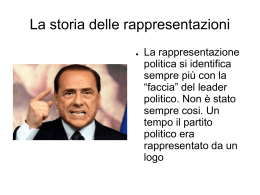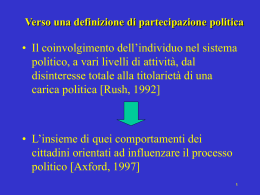SOMMARIO RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 1 Culture Economie e Territori Rivista Quadrimestrale Numero Diciannove, 2007 Borderline Pag. 03 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana di Antonino Scalone Passaggio a NordEst Pag. 23 Consenso, declino, mutamento di un modello identitario. Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano di Lino Scalco Viaggiando tra le costellazioni del sapere Pag. 57 Antonio Gramsci dal ribellismo sardista alla "Repubblica federale degli operai e dei contadini" di Elio Franzin Pag. 68 Immagini del tempo in Giordano Bruno di Lucia Vianello Il Faro Pag. 73 Di chi è il corpo di questa donna? di Mariarosa Dalla Costa Pag. 83 Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura delle nuove emergenze di Mariarosa Dalla Costa Il Sestante Pag. 97 Da Le origini del totalitarismo a Vita activa: viaggio nel pensiero di Hannah Arendt di Silvia Bedin LibriLibriLibri Pag. 115 Recensioni 1 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 n.19 / 2007 2 17-01-2008 9:03 Pagina 2 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 3 Antonino Scalone Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana Borderline I La vicenda del parlamentarismo in Germania non è priva di aspetti paradossali. Durante tutto il periodo successivo all’unificazione, fino alla rivoluzione di novembre, esso viene ritenuto inadatto per il paese e inconciliabile con l’assetto istituzionale vigente. Tale assetto si articola, secondo la tipologia offerta da Böckenförde, intorno a cinque elementi: il principio monarchico, ovvero il fatto che “portatore del potere statuale non è la nazione sovrana, e nemmeno re e popolo insieme, ma il re soltanto” (Böckenförde 1976, p. 115); il carattere octroyée della costituzione (Böckenförde 1976, p. 117); la specifica “organizzazione del potere legislativo” che “era esercitato in comune dal re e dalla rappresentanza popolare [Volksvertretung]” (Böckenförde 1976, p. 118); l’idea che “governo e amministrazione, diversamente dal potere legislativo, erano riserva esclusiva della monarchia” (Böckenförde 1976, p. 119); il controllo esclusivo dell’esercito da parte del re: “L’esercito della monarchia costituzionale era esercito del re, non esercito del parlamento” (Böckenförde 1976, p. 121). Ancora nel 1911 Otto Hintze poteva contrapporre questo assetto istituzionale a quello parlamentare di stampo anglosassone e poteva indicarlo “come il sistema tipicamente tedesco-prussiano” (Hintze 1980 [1911], p. 27). Sono le condizioni storiche differenti – a giudizio di Hintze - che spiegano la diversa storia costituzionale inglese e tedesca: “Le colonne storiche su cui posa il costituzionalismo monarchico continentale – assolutismo, militarismo, burocrazia - non si sono mai consolidate in Inghilterra, poiché non vi era alcuna esigenza politica a spingere in tale direzione quell’isola-Stato, militarmente relativamente sicura e politicamente precocemente centralizzata” (Hintze 1980 [1911], p. 31). Sono invece le condizioni specifiche della Germania, non ultima la sua vocazione militare, a produrre quella “forma costituzionale di specie particolare, che riposa proprio su una prosecuzione dell’assolutismo e che è sorta dall’innesto di istituzioni costituzionalistiche sul tronco monarchico ed ha dunque un retroterra storico-politico completamente diverso da quello del sistema parlamentare” (Hintze 1980 [1911], p. 31). Il sistema parlamentare, infatti, corrisponde ad uno Stato di tipo industriale, mentre il sistema incentrato sul principio monarchico “riposa sulla specificità del tipo di Stato guerriero che domina nel Continente” (Hintze 1980 [1911], p. 31). Il primo a individuare la specificità del principio monarchico – 3 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 4 n.19 / 2007 1 Il riferimento è a E. Kaufmann, Bismarks Erde in der Reichsverfassung, Berlin, 1917, pp. 1-9 e 100-106. 2 Scrive Rosenberg 1928, p. 183: “Hertling, che era assai superiore ai suoi predecessori per intelligenza politica, sapeva che non poteva essere più mantenuto il sistema di governo d’anteguerra, fondato sul predominio dell’aristocrazia militare prussiana, ma non desiderava neppure una parlamentarizzazione”. 3 Sulla base di queste leggi il cancelliere necessita della fiducia parlamentare per poter governare e il Kaiser non ha più il potere di dichiarare guerra e di stipulare trattati. 4 ricorda Hintze - fu F.J. Stahl: “Egli distinse con grande rigore ciò che in Germania si chiamava principio monarchico dalla sovranità monarchica puramente formale, che anche l’Inghilterra parlamentare certamente riconosceva; ed egli separò d’altra parte il concetto di costituzione costituzionale dalla concezione della forma di governo parlamentare” (Hintze 1980 [1911], p. 34). Un sistema parlamentare e un fondamento parlamentare del governo erano stati possibili in Inghilterra perché Whig e Tories costituivano l’espressione di una società politicamente omogenea: “Erano entrambi partiti aristocratici, che si basavano sostanzialmente sugli stessi principi politici, sociali ed ecclesiastici e che si distinguevano solo per sfumature relativamente di second’ordine” (Hintze 1980 [1911], p. 41). Tutt’affatto diversa la situazione in Germania, ove “i partiti non sono tanto costruzioni politiche, quanto piuttosto economico-sociali o religioso-confessionali” e dove “l’incommensurabile distanza, quanto a politica e a concezione del mondo, che si ha ad esempio fra il Centro e la Socialdemocrazia, esclude assolutamente la possibilità di un governo di partito fondato sulla rotazione” (Hintze 1980 [1911], p. 41). A giudizio di Hintze, “forse la progressiva democratizzazione della vita statale è un destino inevitabile nel mondo moderno, ma non è una fortuna e un obiettivo a cui mirare, soprattutto se essa si compie secondo un «tempo» troppo veloce” (Hintze 1980 [1911], p. 41). In ogni caso, la forte contiguità fra compagine statale imperial-prussiana e principio monarchico rende assai difficile e sommamente pericolosa per gli equilibri complessivi del sistema una trasformazione in senso compiutamente parlamentare. Scrive con accenti involontariamente profetici Hintze: “Il principio monarchico è cresciuto in modo così stretto con la struttura complessiva dell’esperienza statale prussiana e imperiale da non poter essere sostituito dal principio del governo parlamentare se non attraverso una completa trasformazione di quella struttura stessa, come potrebbe avvenire solo con una rivoluzione” (Hintze 1980 [1911], p. 42). Questo modo di pensare era così diffuso che, come scrive Böckenförde, “ancora nel 1917 a Erich Kaufmann, e non solo a lui, la prima guerra mondiale apparve al tempo stesso come una guerra costituzionale fra la forma costituzionale nazional-autoritaria del Reich di Bismarck e il democraticismo anglosassone, la cui accettazione in Germania avrebbe significato una sciagura e uno snaturamento dell’essenza nazionale” (Böckenförde 1976, p. 113)1. Ma anche in campo progressista l’introduzione del sistema parlamentare e il superamento del sistema costituzionale vengono visti con molta cautela e sempre all’interno della specificità tedesca. Tale cautela durerà anche durante la guerra, fino quasi alla vigilia dell’armistizio e della caduta dell’Impero. Lo stesso Hugo Preuss nel suo noto progetto di riforma costituzionale del 1917, pur fissando l’obbligatorietà delle dimissioni per il Cancelliere sfiduciato dal Reichstag, attribuisce comunque ancora la sua scelta e la sua nomina alla competenza dell’imperatore (cfr. Mezzadra 1999, pp. 234-5 e Lanchester 1985, pp. 146-149). Il governo Hertling, che pure accoglie nelle sue fila come vicecancelliere il capo del partito progressista von Payer, non si configura come un governo parlamentare – cosa alla quale peraltro il cancelliere era personalmente contrario2 - ma mirava a “mantenere l’intervento della maggioranza parlamentare nell’ambito di un Einfluß che non rivoluzionasse le basi tradizionali del sistema costituzionale” (Lanchester 1985, p. 178). Quando, il 28 ottobre 1918, vengono approvate due leggi che emendano in senso parlamentare la costituzione imperiale3, la rivoluzione è ormai alle porte e rispetto alla nuova situazione il parlamentarismo, RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 5 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana senza essere mai stato effettivamente operante4, appare per molti versi ormai obsoleto. In questo sta la paradossalità della sua vicenda tedesca, secondo quanto accennato all’inizio. E con il parlamentarismo appaiono obsoleti i partiti, nella misura in cui il governo parlamentare era stato fino a quel momento inteso e avversato in quanto Parteiregierung. Questa situazione si ripercuoterà nel nuovo assetto repubblicano. Se si prende in considerazione il testo costituzionale della repubblica di Weimar, la limitata fiducia nel parlamento e la diffidenza nei confronti dei partiti appaiono da due circostanze. La prima è che il processo di formazione della volontà politica non è limitato al parlamento: accanto ad esso sono previsti due potenti strumenti di democrazia cosiddetta plebiscitaria: il presidente del Reich che non solo è eletto direttamente dal popolo, ma, sulla base dell’art. 48, gode in caso d’emergenza di ampi poteri discrezionali d’intervento, e gli istituti del referendum e della legge d’iniziativa popolare, la quale ultima, a determinate condizioni, può anche essere approvata per via referendaria senza passare attraverso il parlamento. In un sistema strutturato in questo modo – nota Stolleis - “la legittimazione democratica dell’ordinamento giuridico era fin dall’inizio spaccata e indebolita. Innanzitutto al parlamento era sottratta la fonte più importante di legittimazione” (Stolleis 1999, p. 103). La seconda circostanza è che i partiti vengono citati una volta sola nel testo costituzionale, all’art. 130, e in termini negativi5. A cosa si deve tale atteggiamento? Non vi è una spiegazione univoca, ma piuttosto una serie di ragioni fra loro variamente intrecciate. Innanzitutto vi sono ragioni di tipo storico. Dice ancora Stolleis: “Chi fra il 1919 e il 1933 si pronunciava sui partiti, si riallacciava innanzitutto alle esperienze del periodo prebellico (…) «Partiti» (Parteiwesen) era la parola simbolo per la frustrazione dei buoni propositi del governo, per dissidi interiori, impotenza e interessi politici egoistici. Per chi intendeva lo Stato come centro di volontà, come organismo, come reale personalità sociale o come processo spirituale di integrazione, i partiti erano la divisione e la frattura organizzata della nazione” (Stolleis 1999, p. 107)6. Vi sono poi ragioni di tipo più teorico: nel sistema fondato sul principio monarchico l’unità era, per così dire, già rappresentata dal sovrano, al quale si collegavano con un vincolo indissolubile amministrazione ed esercito e il parlamento costituiva semplicemente un’istanza rappresentativa della società che al più collaborava, in funzione integrativa, al Willensbildungsprozeß. In questo quadro i partiti svolgevano la funzione di “organizzazione tecnica della procedura di voto” ed erano presenti in parlamento nella forma di “gruppi parlamentari” (Stolleis 1999, p. 102). Ma nel momento in cui l’istituto monarchico viene a mancare e si passa ad un ordinamento repubblicano, si pone la duplice necessità da un lato di immaginare un’istanza che possa in qualche modo svolgere la funzione dell’imperatore (il presidente del Reich eletto plebiscitariamente) e dall’altro di sterilizzare il parlamento dai suoi elementi parziali e partitici, sia sottolineando la sostanziale estraneità dei partiti rispetto alla Staatslehre, sia enfatizzando la libertà del mandato parlamentare (art. 21). Come vedremo, cautele e diffidenze nei confronti dei partiti sono presenti anche nel pensiero di coloro che esplicitamente accettano o sostengono tanto il sistema parlamentare quanto la presenza dei partiti nella sfera pubblica. Sintomatico è che – come nota sempre Stolleis - il capitolo dedicato ai partiti politici dell’ Handbuch des deutschen Staatsrechts curato da Anschütz e Thoma sia affidato non ad un giurista di diritto pubblico, ma ad un “filosofo del diritto, penalista e uomo politico” (Stolleis 1999, p. 105) come Gustav Radbruch. 4 Wehler 1981, p. 221 scrive: “La monarchia parlamentare durò in Germania solo tre giorni”. 5 Recita l’art. 130: “Gli impiegati sono al servizio della collettività, non di un partito. Ad essi sono assicurati la libertà del pensiero politico e quella di riunione. Altre leggi del Reich garantiranno agli impiegati speciali rappresentanze professionali”. 6 Cfr. sull’argomento Gusy 1993 che nota come i partiti tradizionali non risultino dotati di particolare appeal perché incapaci di interpretare la nuova realtà e di integrare nuovi strati sociali (circostanza confermata dalla nascita del KPD alla sinistra della SPD, p. 61). Insomma, i partiti anteguerra restano tradizionalmente “Interessen- und Milieuparteien” (p. 61). Viceversa, il successo del partito nazionalsocialista, secondo Gusy, è dovuto in primo luogo alla sua capacità di farsi Volkspartei e di presentarsi come partito sostanzialmente nuovo rispetto a quelli anteguerra. 5 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 6 n.19 / 2007 II 7 Le teorie elitistiche, soprattutto nella declinazione weberiana, costituiscono, anche se non sempre in modo esplicito, uno dei riferimenti più significativi della riflessione della Staatslehre sul tema dei partiti. Lo stesso Kelsen, che pure nei suoi scritti attribuisce ai partiti un ruolo costituzionale assolutamente centrale come strumento essenziale per la realizzazione del principio democratico, riconosce che la vita politica nei grandi Parteienstaaten contemporanei è caratterizzata necessariamente dal principio del piccolo numero e dal rapporto di sopra e sott’ordinazione. “L’idea di libertà della democrazia, l’assenza di dominio e quindi di capi – si legge in Sociologia della democrazia – non è nemmeno approssimativamente realizzabile. La realtà sociale, infatti, non è altro che dominio e comando. Qui, perciò, può trattarsi solo di come viene formata la volontà dominante, di come viene creato il capo” (Kelsen 1991 [1926], p. 33). 8 Gusy 1993, p. 71 nota, a proposito del riconoscimento del ruolo dei partiti da parte di Thoma:“Con ciò viene soltanto detto che i partiti hanno il loro posto nella costituzione della repubblica democratica, ma non dove sia questo posto (…) Solo sporadicamente [e in nota rimanda a Radbruch e Kelsen] si trova l’opinione che essi vadano intesi come ciò che già da lungo tempo erano: cioè «organi della formazione della volontà popolare» [Kelsen]”. 6 a. L’Handbuch di Anschütz e Thoma è un buon punto di osservazione per cogliere l’atteggiamento della Staatslehre nei confronti dei partiti e in particolare l’atteggiamento dei giuristi più inclini a riconoscerne il ruolo costituzionale. A questo proposito faremo riferimento a due contributi: quello già citato di Radbruch e quello di Richard Thoma, intitolato Das Reich als Demokratie. Qui Thoma sostiene con grande chiarezza la cesura fra la repubblica di Weimar e l’ordinamento politico precedente: la proclamazione della Repubblica, così come la convocazione di un’assemblea costituente (cfr. Thoma 1930, p. 193) significano infatti la negazione di ogni principio monarchico-ereditario. Al tempo stesso, la repubblica trova la propria unità nel fatto di essere una Gemeinschft nella quale “ogni potere è al servizio dei membri e ogni membro al servizio del tutto” (Thoma 1930, p. 186). E’ appena il caso di notare come in Thoma il distacco dalla tradizione guglielmina sia realizzato al prezzo di ribadire immediatamente il carattere comunitario dell’unità politica – carattere che pertanto eccede la dimensione meramente giuridica e appare fortemente wertorientiert - e di sottolineare la subordinazione del singolo alla sfera politica di cui è parte. In ogni caso secondo Thoma l’espressione “democrazia o Stato popolare indica una contrapposizione assoluta a quello che Hugo Preuß ha chiamato «Obrigkeitsstaat», per cui uno Stato con autorità (Obrigkeit) stabile e inamovibile è detto «autocratic government» in contrapposizione al «responsible government»” (Thoma 1930, p. 190). La differenza fra un ordinamento democratico ed uno autoritario non consiste peraltro nel fatto che nel secondo governano tutti e nel primo solo pochi: “Possono governare sempre e solo delle élite”, scrive Thoma (Thoma 1930, p. 191). La differenza sta piuttosto nel modo in cui tali élite vengono scelte: da un gruppo ristretto di persone nell’autocrazia, dalla maggioranza degli elettori prima e dei deputati poi nella democrazia (Thoma 1930, cfr. pp. 190-191)7. L’Autore distingue inoltre fra “democratismo radicale”, che è “egualitario” e “democratismo liberale” che è “antiegualitario” (Thoma 1930, p. 191). Tanto alla democrazia liberale, quanto a quella radicale è necessariamente collegata l’esistenza dei partiti: “Una costituzione che faccia derivare tutti i titolari del supremo potere legislativo e di governo dal voto popolare (…) non può nascere né essere mantenuta in vita se dalla società non si formano liberamente svariati gruppi che presentino i loro capi come candidati per le varie cariche elettive (membro del parlamento, presidente, ministro ecc.), cosicché ogni Stato di «responsible government» è necessariamente e sistematicamente Stato dei partiti (in un’accezione del termine generale e priva di ogni accento valutativo” (Thoma 1930, p. 190)8. Ma questo esplicito riconoscimento del carattere necessariamente partitocratico della democrazia conosce subito una limitazione. Thoma infatti afferma che l’ordinamento weimariano appartiene al secondo tipo di democrazia, quella liberale, con un’importante concessione, però, alla democrazia radicale: gli istituti del referendum e delle leggi di iniziativa popolare (Thoma 1930, cfr. p. 193). Qual è la loro funzione? Essi devono valere “come correttivo contro l’unilaterale potere del parlamento e dei partiti” (Thoma 1930, p. 196). Gli istituti plebiscitari vengono così fatti giocare in funzione antipartitica e antiparlamentare: essi devono correggere delle tendenze degenerative che di per sé parlamento e partiti sembrano comportare necessariamente. b. Veniamo al contributo di Radbruch, dedicato esplicitamente al ruolo costitu- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 7 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana zionale dei partiti. Radbruch distingue innanzitutto fra un approccio sociologico, uno ideologico ed uno giuridico: “Mentre infatti l’ideologia democratica nega il problema dello Stato dei partiti – scrive - la sociologia palesemente risponde in modo affermativo, il diritto dello Stato della democrazia assume una posizione intermedia fra sì e no” (Radbruch 1930, pp. 285-6). Riguardo all’ideologia democratica, Radbruch riprende le considerazioni schmittiane di Die geistesgeschichtliche Lage der heutigen Parlamentarismus, secondo le quali la democrazia si baserebbe sull’”identità fra governati e governanti” (Radbruch 1930, p. 286; cfr. Schmitt 2004 [1926], p. 35 sgg.). Ma, diversamente da Schmitt, collega all’idea di democrazia quella della del “popolo come una somma di singoli uomini liberi e eguali” i quali esprimono liberamente un voto, in conseguenza del quale si formano maggioranze e minoranze. Anche i deputati eletti esprimono liberamente il loro voto e “sono sottoposti solo alla loro coscienza e non sono vincolati da mandati. La decisione tanto nel voto quanto in parlamento è il risultato della discussione, dell’autoconvincimento tramite discorsi e repliche – si è definito la democrazia come «governo attraverso discussione». Il fondamento di questa concezione è la dottrina liberale del libero gioco delle forze” (Radbruch 1930, p. 286). Come si vede, Radbruch – pur riferendosi esplicitamente a Die Lage - mette insieme ciò che Schmitt separa: infatti Schmitt attribuisce l’identità fra governati e governanti al pensiero democratico e il libero convincimento, l’indipendenza del deputato e la centralità della discussione al pensiero liberale e parlamentare9. “Da tali considerazioni liberali – conclude comunque Radbruch - anche il democratico Rousseau deriva il rifiuto dei partiti in democrazia, giacché essi significano una falsificazione «della volontà generale» (Contrat social, II,3)” (Radbruch 1930, p. 286). Se quello testé descritto è il concetto ideologico di democrazia, invece “la sociologia della democrazia offre un’immagine del tutto diversa, contrapposta. Infatti il popolo sovrano non è una costruzione in mattoni fatta di meri singoli liberi ed eguali, ma una costruzione in pietra di gruppi di ineguale grandezza – di partiti. Infatti la sovranità del popolo non è sovranità di tutti su tutti, ma il potere dei più forti sui più deboli, certo mitigata attraverso la ripercussione dei partiti più deboli sui più forti (…) Gli elettori non sono liberi, non singole personalità, ma membri di partito o simpatizzanti, non eguali, ma caratterizzati dalla più estesa ineguaglianza” (Radbruch 1930, p. 286). Lo Stato dei partiti non è per nulla fondato sulla discussione, ma piuttosto sull’accordo di potere: non vi è in esso lotta di opinioni, ma lotta di potere. Nonostante i suoi difetti, questa realtà sociologica non può essere mutata: “Questo sviluppo dello Stato popolare in Stato dei partiti è però inevitabile. In ogni grande cerchia di persone, una formazione collettiva di volontà e di opinione senza formazioni organizzative intermedie fra i singoli e la totalità è una cosa sociologicamente impossibile” (Radbruch 1930, p. 287). Certo, negli Stati moderni vi sono dei contrappesi al potere dei partiti, come le forme di democrazia diretta – plebisciti e leggi di iniziativa popolare - ma “l’introduzione e l’organizzazione di un plebiscito nello Stato dei partiti può derivare essenzialmente solo dai partiti” (Radbruch 1930, p. 287.). Nemmeno il federalismo, il filtro della struttura burocratica o un’eventuale organizzazione corporativa sembrano in grado – a giudizio di Radbruch - di mutare sostanzialmente la situazione. “Così, guardando la realtà sociologica della vita del nostro Stato, non rimane altro che riconoscere che esso è uno Stato dei partiti e nonostante tutti i tentativi di riforma resterà uno Stato dei partiti” (Radbruch 1930, p. 288). 9 Schmitt 2004 [1926], p. 11: “La fiducia nel parlamentarismo, in un government by discussion, è propria del pensiero del liberalismo. Essa non appartiene alla democrazia. E’ necessario che liberalismo e democrazia vengano separati “. 7 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 8 n.19 / 2007 10 In nota, Radbruch ricorda che il primo nella dottrina dello Stato tedesca a riconoscere i partiti come “staatsbildende Kräfte” è stato R. Schmidt, Allgemeine Staatslehre I, 1901, p. 253 sgg. 8 Rispetto alla realtà sociologica del Parteienstaat, la dottrina dello Stato sconta un certo ritardo: “Ma anche il diritto dello Stato della democrazia finora non si è pienamente adattato alla realtà sociologica dello Stato dei partiti” (Radbruch 1930, p. 288)10. Ci si aspetterebbe che nella costituzione i partiti fossero citati in almeno tre luoghi: dove si parla dell’origine del potere dello Stato, dove si parla dei deputati e dove si parla del governo. Ma le cose non stanno così: nell’art. 1 si parla del popolo, da cui tutto il potere proviene, senza far cenno alle sue partizioni; nell’art. 21 si parla dei deputati come rappresentanti dell’intero popolo, sottoposti solo alla propria coscienza; nell’art. 130 degli impiegati, ai quali sono assimilabili i membri del governo, come persone “al servizio della collettività, non di un partito” (e questo, come si è detto, è l’unico luogo della costituzione ove i partiti siano espressamente citati) (Radbruch 1930, p. 289). “Questa ignoranza dei partiti nella costituzione del Reich ha la sua radice meno nell’ideologia democratica che nell’ideologia dello Stato autoritario, tramandata e anche nel nuovo Stato incoerentemente mantenuta ferma” (Radbruch 1930, p. 289). Naturalmente “la sovrapartiticità del governo” vantata dai sostenitori del principio monarchico “era precisamente la leggenda, la vitale bugia dello Stato autoritario”. In realtà, ciò che distingueva quel tipo di governo da quello attuale era solo che “i suoi sostegni partitici non erano visibili agli occhi dell’opinione pubblica, bensì erano oggetto di una diplomazia segreta di politica interna” (Radbruch 1930, p. 289). Ora, dato che “presupposto del pensiero democratico” è il “relativismo”, la pretesa ideologica – tipica dello Stato autoritario - che vi sia una verità sovrapartitica e unitaria costituisce oggi “una contraddizione e un pericolo” (Radbruch 1930, p. 289). Di fatto, nella Staatslehre e nel diritto pubblico ai partiti viene riconosciuta un’attenzione subordinata e reticente (“Grüß mich nicht Unter den Linden!”). Tuttavia, anche se la costituzione descrive un popolo unitario, l’adozione del sistema proporzionale significa in ultima analisi il riconoscimento dei partiti, giacché quel sistema ne presuppone l’esistenza: “Le liste dei candidati devono «essere provviste di una parola di riconoscimento o qualcosa di analogo che indichi l’appartenenza partitica del candidato». Esse hanno bisogno di un numero minore di firme se sono presentate da quei partiti che erano già rappresentati nell’ultimo Landtag” (Radbruch 1930, p. 290). Ma vi sono molti altri esempi in questo senso e da tutto ciò si può ben concludere che “i gruppi elettorali che fanno liste elettorali e di conseguenza anche i partiti rappresentati attraverso di essi sono «Kreationsorgane» nel senso di Georg Jellinek” (Radbruch 1930, p. 289), vale a dire organi dello Stato (in questo senso – ricorda in nota Radbruch - si esprime anche Triepel). Le conseguenze di questa circostanza sono di estrema importanza: “Se quindi il deputato è scelto non più come personalità individuale, ma come membro del suo partito, ne consegue che il suo mandato dovrebbe finire insieme con la sua appartenenza ad un partito” (Radbruch 1930, p. 289). Ora, “questa naturalis obligatio finora ha avuto nella legislazione solo un riconoscimento sporadico” (Radbruch 1930, p. 291), come ad esempio nella legge del Land del Wüttemberg del 4 aprile 1924 che prevede la perdita del seggio nel caso in cui un deputato transiti da un raggruppamento ad un altro (cfr. Radbruch 1930, p. 291). Lo stesso regolamento interno del parlamento prevede, esplicitamente o implicitamente, la presenza dei gruppi parlamentari. Conclusione: “Si può perciò affermare senza dubbio che i gruppi parlamentari dei partiti «sono accolti nel diritto pub- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 9 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana blico» come «partizioni organiche del parlamento»”, secondo le parole di Anschütz (Radbruch 1930, p. 292). Certo, il contenuto dell’art. 21 sembra comunque in contraddizione con la presenza di partiti. E’ questo l’argomento principe degli avversari dello Stato dei partiti. A ciò Radbruch oppone due argomentazioni. La prima è che non necessariamente da considerazioni sociologiche si debbano trarre conseguenze giuridiche: “Si può essere senz’altro dell’opinione che nello Stato dei partiti il «mandato imperativo» sia diventato una realtà sociologica, senza dover trarre da ciò la conseguenza di una sanzione giuridica di questo fatto. Il problema del mandato libero o imperativo non può essere deciso solo per mezzo di deduzioni logiche dal concetto di Stato dei partiti, ma prevalentemente sulla base di considerazioni tecniche – della considerazione già impiegata da Montesquieu (1. XI, cap. VI) che il mandato imperativo «jetteroit dans des longueurs infinies»” (Radbruch 1930, pp. 292-3)11. La seconda argomentazione è più strettamente giuridica: “L’art. 21 può ben essere interpretato in maniera diversa dal punto di vista dello Stato dei partiti che dal punto di vista di una democrazia pensata in modo individualistico. Il deputato resta anche in questo caso rappresentante dell’intero popolo, se egli agisce conformemente alla sua posizione partitica; perché la posizione di un partito non è nient’altro che una certo indimostrabile, ma anche inconfutabile convinzione di rappresentare il bene del popolo intero. Anche se il deputato nel caso specifico sacrifica alla disciplina di partito la propria convinzione, agisce pur sempre «sottoposto unicamente alla propria coscienza e non vincolato da alcun mandato» se il suo agire non è motivato dal mandato del suo partito, ma dal dovere di coscienza di volere il compito complessivo del partito e di accettare un piccolo danno per il rafforzamento di esso in funzione del compito complessivo” (Radbruch 1930, p. 293). In questa concezione idealizzata dell’agire e della funzione del partito, l’art. 21 non perde allora il suo valore: esso costituisce “un mezzo di lotta pieno di valore, certamente solo ideale, contro partiti che aspirano non al bene della totalità del popolo, ma di un gruppo all’interno del popolo” (Radbruch 1930, p. 293). Ma è nei confronti dell’influenza partitica sui governi che si è manifestata la maggiore diffidenza: “Finora la legislazione si è rapportata nella maniera più reticente con la questione del fondamento partitico e del compito (Aufgabe) dei governi parlamentari, anche se in un caso singolo non ha potuto evitare la propria attenzione: in quella legge di autorizzazione del 1923 che limitava espressamente la propria validità alla durata della «composizione partitica del governo del Reich» di allora” (Radbruch 1930, p. 293). La difficoltà di riconoscere la realtà sociologica dell’influenza dei partiti sul governo deriva dall’art. 130 della Costituzione, ma soprattutto dalla diffusa “deutsche Parteiprüderie” (Radbruch 1930, p. 293). La radice di questo atteggiamento sta ancora una volta nell’ “oscurità delle relazioni fra governo e Beamtenschaft, tramandata dallo Stato autoritario, che già Max Weber aveva individuato nella non osservanza della distinzione essenziale fra governo come attività politica e amministrazione come attività burocratica (beamtlicher)” (Radbruch 1930, p. 293). In realtà il ministro non può essere ridotto a impiegato, proprio a causa della responsabilità politica inerente al suo ufficio. Ne consegue che “l’ulteriore sviluppo del parlamentarismo” dovrà necessariamente comportare la sempre minore vincolatività dell’art. 130 rispetto ai ministri. In ogni caso, come già per l’art. 21, anche per il 130 è possibile un’interpretazione che non contrasti con la realtà sociologica dello Stato dei parti- 11 Ecco il passo di Montesquieu, Lo spirito delle leggi, trad. it. Milano, Rizzoli 1989, vol. I, p. 313: “Non è necessario che i rappresentanti, che hanno ricevuto da chi li ha scelti un’istruzione generale, ne ricevano una particolare su ciascun affare, come si pratica nelle diete della Germania. E’ vero che, in tal modo, la parola dei deputati sarebbe più diretta espressione della voce nazionale; ma farebbe incappare in lungaggini infinite, renderebbe ogni deputato padrone di tutti gli altri, e, nei casi più urgenti, tutta la forza della nazione potrebbe essere arrestata da un capriccio”. 9 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 10 n.19 / 2007 12 Sulla riflessione kelseniana a proposito del tema del partiti e delle “parti”, ci permettiamo di rimandare a Scalone 1996, pp. 90-109. Non solo la posizione di Kelsen, con la sua valorizzazione del ruolo dei partiti e con la sua critica radicale ai concetti di bene comune, interesse generale, rappresentanza, appare minoritaria all’interno della dottrina weimariana: essa risulta essere anche l’oggetto di un attacco concentrico che accomuna – in nome di una concezione del nesso diritto-politica orientata alla valorizzazione della dimensione concreta e della decisione – giuristi di vario orientamento e varia formazione, da Schmitt a Smend, a Leibholz, a Kaufmann, al socialdemocratico Heller. Tale attacco raggiunge talora anche toni apertamente diffamatori, come in alcuni passaggi del saggio di Alexander Hold-Ferneck Der Staat als Übermensch (1926), trad. it. in H. Kelsen – A. Hold-Ferneck, Lo Stato come superuomo. Un dibattito a Vienna, Torino, Giappichelli 2002. 13 Sull’argomento, cfr. Stolleis 1999, p. 106. 14 10 Cfr. Stolleis 1999, p. 173. ti: “Il ministro, che agisce in base all’opinione della sua posizione di partito, resta tuttavia servitore della totalità e non diventa servitore del suo partito solo se questo stesso partito è «puro», incline non all’interesse di una parte del popolo, ma al bene della totalità (così come esso lo intende)” (Radbruch 1930, pp. 293-4). In questo modo, però, il partito sembra perdere la sua caratteristica essenziale di essere parte e non tutto. Inoltre, quella indicata da Radbruch è una circostanza non verificabile: chi stabilisce se effettivamente il ministro rispecchi nel suo agire la posizione del partito di appartenenza? In secondo luogo: chi verifica se questi sia puro (il che sembra significare: non-partito) cioè se miri effettivamente al bene comune e non al vantaggio particolare di uno strato sociale? Tutto ciò, inoltre, sembra escludere dal novero dei partiti quelli che mirano espressamente a dar voce a interessi particolari (partito dei contadini, dei pensionati ecc.). In ogni caso, avanzando la distinzione fra partito puro, orientato al Gemeinwohl, e partito meramente interessato a fini determinati, Radbruch riproduce in termini sostanzialmente inalterati quella Parteienprüderie che pure respinge. Il problema è che, salvo qualche eccezione, la più significativa delle quali è probabilmente costituita da Kelsen (nella misura in cui la riflessione del giurista praghese può essere ricondotta entro questo ambito spaziale e temporale)12, la dottrina dello Stato weimariana – e non soltanto quella di orientamento conservatore – non appare adeguatamente attrezzata sul piano concettuale per comprendere la realtà dei partiti a cagione del permanente utilizzo delle categorie tipiche dell’epoca guglielmina13. III a. Fra coloro che manifestano riserve più o meno forti nei confronti del ruolo costituzionale dei partiti e che ne segnalano i pericoli per la tenuta dell’unità politico-statuale, merita di essere ricordato Otto Koellreutter e in particolare un suo contributo del 1927, Der deutsche Staat als Bundesstaat und als Parteienstaat. In questo scritto la presa di distanza nei confronti del fenomeno non si è ancora tradotta – come invece avverrà negli anni immediatamente successivi - in una deriva verso destra che porterà il giurista ad una precoce adesione al nazionalsocialismo14. Uno dei motivi di interesse di questo contributo è il fatto che in esso Koellreutter incrocia fra di loro due tematiche cruciali per la situazione costituzionale weimariana: quella riguardante i partiti e quella riguardante l’assetto federale. Con una procedura argomentativa che si ritrova in giuristi di diverso orientamento, Koellreutter esordisce sottolineando, oltre e attraverso la rottura rivoluzionaria del novembre 1919, gli elementi di continuità di tipo esistenziale ed ideale che caratterizzano la compagine statuale tedesca. Egli si chiede infatti che cosa significhi l’espressione “Stato tedesco” di fronte all’evento rivoluzionario. Certo, “la fraseologia rivoluzionaria vuol vedere solo il nuovo (Koellreutter 1927, p. 7), ma, a ben guardare, quando si parla di “nuovo Stato” in contrapposizione al vecchio si fa riferimento solo all’”organizzazione statale” (Koellreutter 1927, p. 7), cioè al suo aspetto puramente esteriore (è appena il caso di ricordare che questa distinzione fra un aspetto esteriore, formale ed uno interiore, sostanziale, autentico dello Stato costituisce uno degli obiettivi polemici più ricorrenti della riflessione kelseniana nei confronti di quella che il giurista praghese chiama “dottrina dominante”). Ora, sostiene Koellreutter, “lo Stato non è soltanto RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 11 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana mera forma, non è solo pura organizzazione, bensì è essenziale per il concetto di Stato il suo contenuto come realtà storica, come grandezza esistenziale storica” (Koellreutter 1927, p. 7). Questo Stato non rappresenta il frutto della rivoluzione di novembre, ma è un’entità già esistente e che nel presente si perpetua sotto una nuova veste: “Perciò la rivoluzione di novembre non ha creato alcuno Stato nuovo, ma ha solo chiamato in vita nuove forme organizzative della nazione tedesca” (Koellreutter 1927, p. 8). Se si prende in considerazione la storia costituzionale tedesca – interpretata dunque come un continuum - è possibile individuare al suo interno due tendenze fondamentali in lotta perenne fra loro: la prima, orientata all’unità e la seconda orientata alla salvaguardia del particolare. All’interno di questa seconda tendenza occorre fare un’ulteriore distinzione fra particolarismo e federalismo. Secondo Koellreutter esiste una profonda differenza fra il particolarismo, che “ha giocato un ruolo nefasto nella storia costituzionale tedesca” in quanto essenzialmente distruttore dell’unità politica, e il federalismo “che non ha alcuna opposizione assoluta nei confronti dell’unitarismo (…) Esso riconosce la necessità dell’unità statuale e trae da ciò la conseguenza della necessaria sovraordinazione del Reich rispetto ai singoli Stati” (Koellreutter 1927, p. 10). In questo quadro si spiega l’elogio nei confronti di Bismarck, il quale ha saputo costruire una compagine imperiale unitaria, ma federalistica, salvaguardando la specificità tedesca dovuta al ruolo preponderante della Prussia (cfr. Koellreutter 1927, p. 11). Anche la repubblica di Weimar ha sostanzialmente proseguito questa linea, affermando il proprio carattere unitario, ma dandosi una struttura federale. Il fatto è – nota Koellreutter - che il nuovo Stato non ha la medesima “legittimazione storica” della creazione di Bismarck e ci si può chiedere se sia effettivamente riuscito a dare risposta ai problemi complessi di equilibrio istituzionale connessi ad un ordinamento federale e, ancora una volta, alla presenza di un Land come la Prussia per dimensioni, tradizioni, unità interna e potenza economica assolutamente sovraordinato rispetto agli altri (cfr. Koellreutter 1927, p. 14). Koellreutter ricorda come per risolvere questo problema e garantire alla Germania un assetto complessivamente più equilibrato, Hugo Preuß abbia proposto lo smembramento della Prussia. Si tratta però di una proposta non condivisibile perché contraddice la storia costituzionale della Germania: è infatti solo con questa Prussia, che l’unità della Germania si è potuta infine realizzare e dunque un elemento così decisivo dell’unità politica tedesca non può essere impunemente scomposto. Non procederemo oltre nei vari passaggi dell’analisi dedicata al problema del federalismo perché non è indispensabile ai fini del nostro ragionamento. Ci limitiamo a dire che riguardo al problema la posizione di Koellreutter – pur nel rispetto della tradizione federalistica e della specificità storico-costituzionale della Germania, a cominciare, come si è visto, dal ruolo della Prussica - è favorevole ad un processo di accentramento e omogeneizzazione amministrativa. Egli è consapevole che i crescenti problemi di organizzazione economica eccedono largamente i confini dei Länder più piccoli e meno ricchi e che il loro apparato amministrativo risulta spesso eccessivo rispetto alle dimensioni territoriali e alle risorse locali (cfr. Koellreutter 1927, p. 21). E’ a questo punto e in questo contesto argomentativo che viene introdotto il tema dei partiti: “Ma ciò che è interessante per l’economia è il funzionamento il più possibile semplice ed efficace dell’apparato della legislazione e dell’amministrazione. E qui il problema della divisione del Reich compatibile con l’unità statale sfocia nel secondo ordine di pro- 11 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 12 n.19 / 2007 blemi, quello della struttura del Reich e dei Länder tedeschi come Stato di partiti. Infatti qui si pone il problema se Länder con infelice divisione politica interna e le corrispondenti difficoltà di formazione del governo, Länder il cui apparato amministrativo, commisurato a quello di grandi Stati, è spropositatamente grosso e oneroso, possano permettersi alla lunga un proprio apparato statale. Ma per poter valutare giustamente questo problema deve essere innanzitutto esaminata l’odierna forma di governo del Reich e dei Länder” (Koellreutter 1927, p. 21). La considerazione di partenza è il riconoscimento della realtà partitica tanto del governo centrale quanto dei governi locali. Questa circostanza è a giudizio di Koellreutter la conseguenza diretta dell’adozione di un sistema politico compiutamente parlamentare; non vi può essere a suo avviso, almeno al presente, sistema parlamentare a prescindere dai partiti organizzati: “Infatti il sistema parlamentare non è pensabile senza la presenza dei partiti politici, perché esso presuppone un parlamento diviso in maggioranze politiche. Con «fiducia del parlamento», da cui, secondo il principio fondamentale del parlamento, dipende il governo, s’intende la maggioranza del parlamento, che di nuovo, per parte sua, deriva la propria articolazione dai partiti politici. Perciò in uno stato parlamentare la forma e la tecnica dei partiti politici sono determinanti in modo essenziale per il funzionamento del parlamentarismo” (Koellreutter 1927, pp. 21-22). Il sistema parlamentare inglese, articolato su due grandi partiti e fondato sul maggioritario, risulta stabile ed efficace. Il contrario avviene in Germania ove, in conseguenza dell’introduzione del sistema proporzionale, si è verificata un’eccessiva Parteizersplitterung (cfr. Koellreutter 1927, p. 22). Non solo il proporzionale – rendendo necessari governi di coalizione - produce instabilità, ma, garantendo la rappresentanza parlamentare a piccoli partiti, fa sì che essi, nonostante siano presenti in parlamento, proprio per le loro dimensioni non vadano appunto oltre la semplice presenza e “non esercitino alcun influsso politico” (Koellreutter 1927, p. 25). E questo contraddice il senso stesso di questo sistema di voto. Inoltre il proporzionale, facendo dipendere le fortune elettorali del candidato prima e del deputato poi dalla lista di appartenenza, lo rende assai dipendente dalla disciplina di partito e finisce con l’enfatizzare il ruolo di istanze extraparlamentari quali la struttura e la burocrazia di partito. Se a livello centrale il problema dell’instabilità dei governi può trovare un contrappeso nel ruolo del presidente del Reich (cfr. Koellreutter 1927, p. 28), nei singoli Länder non esiste una figura analoga. Né Koellreutter condivide la posizione di chi è favorevole al cosiddetto Beamtenkabinett: un tale governo contraddirebbe l’essenza del parlamentarismo fondata sullo stretto legame fra parlamento e governo (cfr. Koellreutter 1927, p. 33). In realtà, sia a livello centrale che a livello regionale, il problema non pare risolvibile puramente e semplicemente in termini d’ingegneria costituzionale: “Infatti le forme costituzionali non sono mai fini a se stesse e funzionano solo se sono espressione di una struttura politica adeguata allo scopo” (Koellreutter 1927, p. 31). Il sostanziale “unitarismo”, o federalismo moderato di Koellreutter appare là dove egli ricorda che paradossalmente Napoleone – pur mirando al male della Germania - inconsapevolmente le causò un bene durevole eliminando per decreto 112 piccoli Stati (cfr. Koellreutter 1927, p. 34). La soluzione dell’Autore al complesso di problemi affrontati si concreta infine in quattro proposte: 1) restituzione alla Prussia di un ruolo preminente – in questo Koellreutter si ricollega esplicitamente all’esperienza del secondo Reich - magari “attraverso un capo dello 12 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 13 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana Stato comune per il Reich e la Prussia” (Koellreutter 1927, p. 36); 2) accentuazione del carattere amministrativo dei Länder a discapito di quello politico (cfr. Koellreutter 1927, p. 36); 3) limitazione del Parlamentsabsolutismus tramite una più forte sottolineatura dell’autonomia del governo rispetto al parlamento (cfr. Koellreutter 1927, pp. 36-37)15; 4) valorizzazione dello spirito unitario del funzionariato tedesco, per sua natura e formazione orientato “al bene della totalità del popolo tedesco” (Koellreutter 1927, p. 37) e fattore di continuità fra vecchie e nuove istituzioni anche nei giorni della rivoluzione. Come si vede, pur in un quadro di sostanziale accettazione del nuovo sistema, del parlamentarismo e del ruolo dei partiti, Koellreutter non manca di sottolineare la necessità, ai fini della stabilità del sistema, di un’unità pre-data di tipo esistenziale e pregiuridico, rispetto alla quale parlamento e partiti costituiscono, almeno potenzialmente, un elemento di pericolo, allo stesso titolo di un particolarismo troppo accentuato. Al pericolo di una frammentazione territoriale, infatti, fa da contraltare quello della Zersplitterung partitica; rispetto a tutto ciò e in funzione di “neutralizzazione” dell’esperienza rivoluzionaria, Koellreutter – confermando la scarsa attitudine della Staatslehre weimariana a elaborare categorie interpretative originali e all’altezza del presente - ripiega esplicitamente sull’esperienza guglielmina, rifacendosi alla “geniale soluzione bismarckiana” (Koellreutter 1927, p. 35) dei rapporti fra centro e periferia e alla continuità rappresentata dal ceto burocratico. 15 “Il parlamento – scrive Koellreutter - non può mai esercitare anche l’esecuzione, ma al massimo assumere delle deliberazioni orientative (richtungggebende Beschlüsse) per il governo e anche questo solo nel proprio ambito”, p. 36. Si tratta però di una posizione che non appare del tutto conciliabile con quanto espresso poco prima a proposito del Beamtenkabinett. b. Ancor più significativo – innanzitutto per l’autorevolezza dell’autore - dell’atteggiamento perlomeno diffidente nei confronti del fenomeno partitico e, nella misura in cui si interseca con esso, nei confronti del parlamentarismo, è un contributo di Heinrich Triepel, intitolato Die Staatsverfassung und die politischen Parteien. Si tratta del discorso di rettorato tenuto all’Università di Berlino il 3 agosto 1927 e naturalmente il tono dell’esposizione risente dell’occasione per la quale è stato concepito. Interessante è comunque la strategia argomentativa attraverso la quale si giunge al tema centrale. Triepel esordisce ricordando Federico Guglielmo III, fondatore dell’Università nel 1810: “Inestinguibile è anche il nostro ringraziamento per il fatto – giacché era un fatto - che in un tempo caratterizzato dalla più gravosa delle emergenze per la patria abbia creato le basi e la cornice per uno dei più importanti luoghi di formazione della nazione” (Triepel 1928, p. 7). Indi ricorda lo scritto che Humboldt indirizzò al sovrano chiedendo la fondazione dell’Università: “Noi uomini d’oggi ammiriamo in tali parole non solo in primo luogo la profondità dello sguardo e la capacità profetica dell’uomo di Stato, ma innanzitutto la schietta sicurezza in cui poteva esprimere la fede dei patrioti prussiani nell’indistruttibilità delle forze morali del proprio Stato. In questa ferma speranza, però, il re era concorde col suo ministro. Fortunato il popolo i cui capi non solo sono forti nel volere, ma che anche vengono sostenuti dalla fede vivente e operante nel futuro della nazione e dello Stato nazionale!” (Triepel 1928, p. 8). Il medesimo compito di rigenerazione spirituale si è posto all’indomani del “crollo” del 1918 e, anche se “le università tedesche” hanno tuttora “un grande numero di desideri insoddisfatti”, pur tuttavia non mancano le ragioni di riconoscenza per quello che le istituzioni centrali e regionali hanno fatto per la cultura (cfr. Triepel 1928, p. 8). Triepel ricorda come per Humboldt l’erigenda università non avrebbe dovuto trarre il proprio sostentamento “dalle casse reali, ma da determinati beni demaniali da rimettere 13 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 14 n.19 / 2007 16 La radicale inconciliabilità fra istituzioni culturali e partiti è sottolineata anche da R. Smend, Hochschule und Parteien (1930), in Id., Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, Berlin, Duncker & Humblot 19682, p. 277, ove si legge: “Parteien und Parteipolitik stehen mit dem Wesen der Hochschule in Widerspruch”. 14 ad essa in proprietà” (Triepel 1928, p. 9). Humboldt, infatti, “ha insegnato che la nazione stessa sarebbe stata illuminata e moralizzata se avesse collaborato attivamente ad istituire l’illuminazione e la moralizzazione della generazione che cresceva; essa avrebbe preso maggior interesse alla scuola se questa fosse stata anche dal punto di vista pecuniario opera e proprietà sua” (Triepel 1928, p. 9). Triepel dubita che l’auspicio di Humboldt avrebbe prodotto i risultati sperati: “Se la sua pretesa non fosse stata subito sventata dal suo successore Schuckmann, ma fosse stata soddisfatta, questo fatto per sé solo difficilmente avrebbe portato l’Università in una relazione più stretta con la nazione”(Triepel 1928, p. 9). A differenza di cento anni fa, oggi, in conseguenza delle trasformazioni sociali intervenute nel frattempo (Triepel 1928, cfr. 9-10) questo sostegno da parte della società alla cultura è possibile e si attua, ma si tratta di un fatto non scevro di pericoli: “Non ogni fondazione a favore della scienza si verifica per puro amore per la pura scienza. Molti di quelli che danno qualcosa, vogliono anche avere qualcosa per questo” (Triepel 1928, p. 10). Se ciò non suscita alcun problema per le scienze applicate, ne suscita invece per le Geisteswissenschaften. Triepel ricorda le “ciniche parole” di Schuckmann: “Chi ha il potere sugli stomaci la spunterà anche sulle teste”. E continua: “Gli istituti di formazione, questa era l’opinione, dovevano stare soltanto sotto il potere dello Stato, quindi anche in immediata dipendenza economica dallo Stato. Questo era l’esatto contrario delle idee di Humboldt, il cui ultimo piano mirava precisamente a sciogliere l’intero sistema dell’istruzione dall’abbraccio con lo Stato e, come egli scrisse una volta, a «far pagare solo dalla nazione» tutte le scuole”. Ma ciò era possibile solo con un determinato concetto di nazione, che non ha nulla a che vedere con quello presente: “In generale, Humbolt con «nazione» pensava a qualcosa d’altro e di indiviso rispetto alla società spaccata dal conflitto fra gruppi d’interesse frammentati. E avrebbe provato orrore se si fosse immaginato che il «pagamento» delle scuole al posto dello Stato dovesse essere sbrigato da molteplici organizzazioni d’interesse, forse da quelle che si nascondono nei partiti politici o sono strettamente unite ad essi” (Triepel 1928, p. 11). Così i partiti politici appaiono nel ragionamento di Triepel in un contesto fortemente negativo: una società divisa, campo di battaglia di fazioni che si contendono ogni settore della sfera pubblica, anche quello dell’istruzione e della formazione che, per sua natura dovrebbe essere neutrale16. Ma questo è solo il primo passo per un attacco ulteriore: infatti, se il moderno Stato è Parteienstaat, nemmeno l’attribuzione allo Stato del controllo e del finanziamento dell’istruzione può assicurarne l’indipendenza: “Saremo tutti d’accordo – scrive Triepel - sul fatto che la scienza perderebbe la propria nobiltà se finisse in reale dipendenza dai partiti politici. Perciò incalza la paurosa questione se nel presente tale dipendenza non sia divenuta quasi inevitabile” (Triepel 1928, p. 11). E’ dunque un’esigenza di tipo squisitamente culturale, la necessità di salvaguardare l’autonomia delle scienze dello spirito a porre con urgenza il problema dei rapporti fra Stato e partiti e della subordinazione del primo ai secondi: “E così si dovrebbe rispondere alla questione posta, che per noi è una questione fatale, in modo affermativo se risultasse che lo Stato moderno, e in particolare quello tedesco, avesse preso il carattere di uno Stato dei partiti, come suona la più recente espressione, cioè di uno Stato che i partiti politici incorporano così saldamente nella loro organizzazione che il volere e l’agire statali nelle questioni decisive si fonda sul volere e sull’agire di comunità partitiche. Questo è giusto? Io vorrei oggi cercare solo una risposta a quest’ultima, se RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 15 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana così posso dire, domanda pregiudiziale e lasciare agli ascoltatori di trarre in silenzio le conseguenze importanti per noi. Il mio tema è dunque: la relazione fra Stato e partito, o più precisamente fra costituzione dello Stato e partito politico” (Triepel 1928, pp. 11-12). Dal punto di vista storico, a giudizio di Triepel è possibile distinguere alcune fasi nel rapporto fra Stato e partiti. Si è passati dalla fase della lotta, a quella dell’ignoranza, a quella del riconoscimento e della legalizzazione e infine a quella dell’”incorporazione costituzionale” (Triepel 1928, p. 12). Tutto ciò in un periodo relativamente breve, giacché i partiti politici così come li intendiamo oggi hanno suppergiù un secolo di vita. I partiti così intesi sono “un risultato della costituzione rappresentativa moderna. Il partito politico presuppone una rappresentanza popolare come campo di battaglia e un diritto di voto parlamentare come mezzo di lotta” (Triepel 1928, p 13). I partiti sono altresì espressione e conseguenza di una rottura rivoluzionaria: così in Inghilterra con la Gloriosa Rivoluzione, negli Stati Uniti con la promulgazione della costituzione di quel paese, nel continente europeo con la rivoluzione francese. Ma allora perché lo Stato costituzionale, e in primo luogo quello tedesco, si contrappone ai partiti? In realtà,“formazione di partiti e potere partitico si connettono solo con una concezione e una versione del tutto determinata del sistema di rappresentanza popolare e non con tutte” (Triepel 1928, p.13). Vi sono sistemi elettorali che non prevedono partiti; d’altronde “il cittadino tedesco dell’epoca Biedermeier considerava i partiti come un pericolo per la quiete dello Stato anche se non era propenso a vedere il partito come un traviamento morale. Ed era un democratico, cosicché si poteva richiamare al classico della dottrina democratica, a Jean Jacques Rousseau, che aveva considerato i partiti come un’intrusione estranea fra la massa dei cittadini e la sua totalità, come un mezzo per falsare la volontà generale” (Triepel 1928, p.14). La dottrina liberale nega il mandato imperativo e svincola il deputato da ogni controllo partitico: “Egli è signore della sua propria opinione” ricorda Triepel citando l’”opinione dominante in Inghilterra nel 18. secolo”, Sieyès, Mounier e Talleyrand (cfr. Triepel 1928, p. 15) e facendo infine riferimento a Die geistesgeschichtliche Lage der heutigen Parlamentarismus (cfr. Triepel 1928, pp. 15-6) e, per il suo tramite, a Burke, Bentham, John Stuart Mill, Guizot e Constant (cfr. Triepel 1928, p. 16). Né mancano “i mezzi tecnici” per “ostacolare o paralizzare, o perlomeno non rendere visibile la formazione di partiti nella rappresentanza popolare” (Triepel 1928, p. 16). Triepel ricorda come in Baviera e nel Sachsen la distribuzione dei posti nel parlamento sia sorteggiata. Una tale distribuzione, secondo Robert Mohl, favoriva la moderazione della passionalità rispetto alla contrapposizione fra gruppi parlamentari compatti e rendeva più agevole al deputato sostenere le proprie posizioni anche in disaccordo dal proprio gruppo (cfr. Triepel 1928, pp. 16-7). In questa direzione va anche il divieto di leggere i discorsi: ciò che il deputato ha da dire dev’essere il risultato dell’andamento della discussione complessiva, non di quanto già stabilito “in un locale del gruppo parlamentare” (Triepel 1928, p. 17). A differenza di quanto sostenuto ad esempio da Koellreutter, che interpreta il rapporto parlamento/partiti come qualcosa di non patologico, Triepel - in accordo con quanto gia sostenuto da Schmitt e in sostanziale sintonia con le posizioni pressoché coeve espresse da Leibholz in Das Wesen der Repräsentation - considera tutto questo come una sorta di snaturamento rispetto al parlamentarismo bene inteso: “Lo sviluppo del parlamentarismo si è gradualmente allontanato dai 15 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 16 n.19 / 2007 17 Sottolineiamo il fatto che di questa democrazia si tratta e non della democrazia in generale perché poche pagine prima – come si è visto - Triepel attribuisce a Rousseau una concezione della democrazia che esclude la presenza dei partiti. 18 Per alcuni autori il passo successivo sarà, come vedremo, la liquidazione del parlamentarismo in nome di una democrazia pretesa vera e l’eliminazione del pluralismo partitico a favore del partito unico in nome della salvaguardia dell’unità politica. 16 suoi fondamentali punti di partenza. Il sempre crescente rafforzamento del pensiero democratico ha diminuito e quasi eliminato l’autonomia del parlamento, l’originalità delle sue deliberazioni nate in discussioni e dibattiti, l’indipendenza dei deputati dagli influssi extraparlamentari, la libertà da controlli dei gruppi parlamentari. L’organizzazione partitica attacca il parlamento dall’esterno e dall’interno” (Triepel 1928, p. 18). E poco più avanti: “La discussione nel plenum, spesso perfino nelle commissioni, diventa vuota forma. La deliberazione parlamentare, se il parlamento ha una maggioranza omogenea, è una deliberazione partitica, se vi è frammentazione partitica, è un compromesso fra partiti. E il deputato non è più un rappresentante del popolo, ma un rappresentante del suo partito, egli si sente e agisce come tale” (Triepel 1928, p. 18). Il parlamentarismo e la democrazia – o perlomeno questo tipo di democrazia17, incentrata sui moderni partiti di massa - appaiono dunque sostanzialmente disomogenei18. Anche per Triepel esiste una discrasia fra la realtà sociologica – caratterizzata dal dominio dei partiti e dalla democrazia di massa - e la sua registrazione in termini giuridici: “La circostanza particolare è però che il diritto scritto ha per il momento ignorato del tutto questo sviluppo”, tant’è vero che “l’espressione «partito» non si trova in alcuna costituzione, in alcuna legge” (Triepel 1928, p. 19). Questo vale innanzitutto per gli Stati Uniti (“Il Congresso degli Stati Uniti non conosce ancor oggi alcun gruppo parlamentare”, Triepel 1928, p. 20), ma la situazione non è diversa in Europa: “In Francia e Germania i gruppi parlamentari, sebbene da lungo tempo fossero sviluppati, lavorassero alacremente e tenessero gelosamente alla parità nella composizione delle commissioni, rimasero tuttavia fino a non molto tempo fa un concetto sconosciuto” (Triepel 1928, p. 20). Solo di recente si è assistito ad un adeguamento del diritto alla realtà effettuale: “Sotto la pressione delle condizioni questo atteggiamento dello Stato ufficiale da breve tempo è essenzialmente cambiato. Leggi, ordinanze, regolamenti interni iniziano a riconoscere formalmente il partito e l’organizzazione partitica, extra e interparlamentare” (Triepel 1928, p. 20). Particolarmente significativa è a questo proposito l’affermazione negli Stati Uniti del meccanismo delle “primarie”. E’ questo un sistema partitico di selezione del candidato presidenziale che però ha diretta influenza politica sulla sfera propriamente pubblica e che è puntigliosamente regolamentato nel suo funzionamento da leggi dello Stato, nonostante questo fatto all’inizio avesse suscitato qualche perplessità in chi vedeva in ciò una limitazione del diritto costituzionale di associazione (cfr. Triepel 1928, p. 23): “Oggi solo qualcuno negli Stati Uniti dubita ancora che lo Stato abbia il diritto di influire nel modo più profondo con le sue leggi sull’autonomia dei partiti” (Triepel 1928, p. 23). Cambiamenti sostanziosi sono intervenuti anche in Germania, ove “lo Stato non è lontano dalla legalizzazione dei partiti” (Triepel 1928, p. 24). Tale riconoscimento è correlativo all’adozione del sistema proporzionale: “Infatti l’intero sistema si fonda sul fatto che partiti organizzati lottano per la vittoria elettorale” (Triepel 1928, p. 25). Decisiva è la lista elettorale partitica, in conseguenza della quale “i partiti riguardo al voto diventano infine tutto, il singolo elettore per contro una nullità. Anche il candidato di partito diventa semplice comparsa. Oggi, secondo molte leggi elettorali non c’è nemmeno bisogno che il suo nome appaia sulla scheda elettorale” (Triepel 1928, p. 25). Vi è solo un punto che oppone ancora resistenza alla legalizzazione dei partiti ed è la formazione del governo, se si esclude la costituzione austriaca (cfr. p. 26). RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 17 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana Triepel ricorda la legge di autorizzazione tedesca del 1923 che parla di “parteipolitischen Zusammensetzung” del governo del Reich, ma ne fornisce un’interpretazione affatto diversa da quella già ricordata di Radbruch: egli infatti la qualifica come Eintagsfliege (Triepel 1928, p. 27), mosca effimera. “Per il resto – continua - non si trova né in Inghilterra, patria del governo partitico parlamentare, né nel continente, una costituzione o una legge che con parole esplicite abbia accordato al partito il ruolo di elemento nel punto centrale dell’organismo dello Stato” (Triepel 1928, p. 27). E qui Triepel non manca di ricordare che l’unico luogo della costituzione di Weimar in cui ricorre la parola partito è l’art. 130: “La clausola si presenta come una chiara presa di posizione contro il concetto di Stato dei partiti” (Triepel 1928, p. 28). . Eppure i partiti sono sempre più presenti nella vita costituzionale: Triepel ricorda le opinioni di von Wieser (“La costituzione partitica è una parte essenziale della costituzione dello Stato”), di Thoma, Radbruch, Koelreutter (“Lo Stato tedesco dei partiti è diventato oggi realtà in modo conforme alla costituzione”, nel contributo dianzi analizzato) e si chiede se tale concezione sia giusta. “A tale problema non si può, come io penso, rispondere con un semplice sì o no. Come molto spesso, qui dipende se si vogliono giudicare le cose dal punto di vista (Standpunkt) del diritto formale o dal punto di vista (Gesichtpunkt) della dinamica politica” (Triepel 1928, p. 29). Dal primo punto di vista, non si può riconoscere al partito lo statuto di organo dello Stato: “Solo il bolscevismo e il fascismo hanno realmente edificato lo Stato sui partiti” (Triepel 1928, p. 30). D’altronde, disconoscere la presenza reale dei partiti nella vita pubblica e nella vita dello Stato “significherebbe “nascondere la testa sotto la sabbia (…) Di fatto e in verità è ai partiti politici che va ricondotto il governo dello Stato” (Triepel 1928, p. 31). Sono essi, inoltre, che esercitano un notevole influsso sull’amministrazione (Ämterpatronage). “Questi fatti – continua Triepel - non sono nulla di arbitrario o di casuale. Qui si è piuttosto compiuto un processo del tutto naturale. Esso costituisce la quasi logica conseguenza di una concezione dello Stato che ha dato la propria impronta alla sviluppo degli ultimi tempi. L’atomismo individualistico domina l’evoluzione della democrazia moderna. Se in ultima analisi il potere pubblico viene collocato nella massa frazionata individualisticamente, allora questa, che come massa non può volere né agire, si crea le organizzazioni attraverso cui può produrre una volontà. Se in particolare il diritto di voto per la rappresentanza popolare è strutturato in modo puramente individualistico, la massa non può esercitare il proprio diritto senza dividersi in qualche modo in gruppi (…) Il sistema politico dei partito è l’autoorganizzazione che la democrazia di massa si è creata” (Triepel 1928, pp. 32-3). Va da sé che questo tipo di organizzazione contrasta con “il diritto formato secondo i principi liberali” (Triepel 1928, p. 33). Dunque secondo Triepel nella moderna società, atomistica e di massa, non è possibile un accesso im-mediato alla sfera pubblica: i partiti costituiscono pertanto una conseguenza necessaria della democrazia in quanto sono il medio necessario per la partecipazione delle grandi masse alla vita politica Questo però confligge con i principi liberali che stanno alla base del parlamentarismo classico: ancora una volta parlamentarismo e democrazia sembrano percorrere due sentieri divergenti e al declino del primo sembra poter corrispondere un ulteriore sviluppo della seconda. Infatti Triepel scrive: “Le vecchie idee liberali dell’essenza dello Stato rappresen- 17 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 18 n.19 / 2007 tativo difficilmente si affermeranno di nuovo, per quanto forti siano i valori morali contenuti in esse. Perciò un allontanamento dallo Stato dei partiti può accadere solo attraverso uno sviluppo della democrazia di massa o attraverso il suo superamento. E’ possibile e molti lo vedono già in divenire, che si compia un raffinamento della democrazia «egualitaria» attraverso la su conversione in un’oligarchia di capi, cosicché al posto delle organizzazioni di partito prive di responsabilità e degli ancora più irresponsabili molteplici poteri anonimi che si nascondono sotto di esse, subentrino statisti indipendenti e pertanto responsabili. Il partito non sarebbe più allora un puro organo dello Stato, ma – come Georg Jellinek aveva detto - sarebbe ridotto a ruolo di un semplice «organo di creazione» (Triepel 1928, p. 34). Il problema è che proprio la visione del mondo che sta alla base della democrazia sembra ostacolare una statalizzazione dei partiti, una loro trasformazione in organi dello Stato responsabili e orientati al bene dell’intero. In realtà, “un baluardo contro la penetrazione dello Stato dei partiti” – cioè contro la minaccia della divisione partitica e del conseguente indebolimento dello Stato - può essere eretto solo con l’avvento di una concezione politica tutt’affatto diversa, solo se, insomma, “la concezione dello Stato atomistico-individualistica, da cui esso è nato, è stata superata e sostituita attraverso una di tipo organico” (Triepel 1928, p. 36). Si tratta naturalmente di un processo lungo, il cui fine è la realizzazione di quella “unità nella molteplicità” che a Triepel non appare come “un’illusione romantica”: “Io penso del resto che non siano affatto figure fiabesche e fantasmatiche, ma sostanze in carne ed ossa che si accingono a strutturare dalla società meccanica del presente delle forme organiche. Se si riesce a costringere le forze che si combattono con violenza elementare nel seno del popolo all’interno di una nuova amministrazione autonoma, riccamente articolata nel personale e nel territorio, di tipo economico e spirituale al servizio dello Stato, che attraverso di esse non deve essere distrutto, ma tenuto unito, se lo Stato non sarà demolito, ma al contrario costruito dal basso, allora saremo diventati un puro organismo” (Triepel 1928, pp. 36-7). Triepel coglie dunque in modo lucido la sostanza del problema, ovvero la crescente precarietà dell’unità politica, dovuta alla difficoltà di costruire effettivamente lo Stato von unten. Egli però opera, per così dire, una scorciatoia argomentativa particolarmente debole pretendendo di ritornare indietro rispetto a quello Stato dei partiti che pure ha poc’anzi riconosciuto come espressione dei tempi in favore di una concezione organicistica dello Stato della quale – con riferimento al periodo in cui tale proposta viene avanzata - il meno che si può dire è che appare politicamente poco effettuale. IV Se il parlamentarismo appare incapace di produrre stabile unità politica, se è succube dello strapotere dei grandi partiti, rafforzati dal sistema proporzionale, se risulta inadeguato rispetto alla nuova realtà della democrazia di massa, occorre allora pensare di abbandonarlo in favore di forme di produzione della volontà politica più adeguate ai tempi. In questa direzione va l’analisi di coloro i quali oppongono al principio rappresentativo – cui si rifà l’ideologia parlamentare - il principio di identità, a loro avviso tipico dell’epoca presente e della democrazia di massa. E’ questo il caso del già ricordato contributo di Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, ove, appunto, la demo- 18 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 19 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana crazia, radicalmente opposta al parlamentarismo, è caratterizzata dal fatto di essere fondata su una serie di identità e su un’omogeneità prepolitica di tipo esistenziale, tale da escludere il diverso19 e fonte di energia politica. Tale posizione conosce negli anni di Weimar larga fortuna e spesso il saggio viene citato nei contributi degli altri giuristi; per molti versi analoga è l’analisi di Leibholz che in Das Wesen der Repräsentation fornisce un’interpretazione della democrazia di massa come forma politica fondata sul principio di identità. Non ci diffonderemo qui sulla questione se tale identità sia effettivamente qualcosa di immediato o se non sia in realtà identificazione, ovvero il frutto di un processo alla fine del quale e non prima - dunque in modo mediato - l’identità e la forma politica che su di essa si basa vengono prodotte. L’ipotesi che ci sembra possa essere plausibilmente avanzata è appunto che non d’identità immediata si tratti, ma di una procedura nella quale risultano all’opera tutti gli elementi caratterizzanti la rappresentazione. E’ d’altronde lo stesso Schmitt a ricordare nella Verfassungslehre che non c’è forma politica senza rappresentazione e che la democrazia diretta e immediata presuppone sempre necessariamente un’istanza che dia forma, anche solo convocando il popolo sovrano e ponendo la domanda alla quale esso deve rispondere (peraltro, solo con un sì o con un no)20. Proprio il riferimento a Schmitt e l’esempio da lui addotto ci mostrano come il problema della democrazia diretta sia indisgiungibile da quello della Führung: si può invocare la “vera” democrazia, espressione della sostanza autentica del popolo, in contrapposizione alla Zersplitterung partitica, anticamera della guerra civile, ma essa appare impensabile senza la presenza di un capo carismatico capace di dar forma alla moltitudine. In tutti coloro che, specialmente nella seconda metà degli anni venti, invocano un superamento, o perlomeno una riforma dell’ordinamento costituzionale capace di uscire dalla paralisi del Parteienstaat, ritorna prepotentemente, accanto all’idea del popolo come “vera” unità, la figura di un capo(popolo). Se il popolo autenticamente inteso costituisce una “comunità di valore” (Gusy, 1993, p. 80), se ”lo Stato consiste in una pluralità di uomini, la cui condotta è rivolta attraverso una legalità normativa a scopi unitari” (Horneffer, 1933, p. 104), tale unità politica caratterizzata da finalità e valori condivisi si produce là dove vi è un capo autentico che le dà voce e presenza reale. Come scrive Spengler, con significativo paragone fra ambito militare e ambito politico: “Il coraggio di una truppa dipende dalla fiducia nella Führung; fiducia, cioè spontanea rinuncia alla critica. L’ufficiale è colui che fa di un codardo un eroe e di un eroe un codardo. Questo vale per eserciti, popolo, ceti, come anche per i partiti. La capacità politica di una moltitudine non è altro che fiducia nella Führung” (Spengler, 1980 [1923], p. 1111). Nella stessa direzione va il già citato Hornheffer, in un saggio nel quale sottopone a critica radicale la concezione kelseniana della democrazia, (Horneffer, 1926, p. 49): “Quello che possiamo con ciò indicare come volontà popolare - scrive significativamente - è soltanto l’unione degli inconsapevoli bisogni delle masse con la consapevole volontà del Führer”21. Ora, per quanto questi autori e tutti gli altri che si pongono in tale prospettiva enfatizzino l’elemento della comunità prepolitica ed esistenziale che accomuna e affratella ab origine i membri della erigenda comunità politica, nonché l’immediatezza della relazione fra capo e seguito, pur tuttavia rimane sempre il problema della produzione della Führung e del suo riconoscimento da parte della massa (solo riconoscendosi nel capo, infatti, la massa prende coscienza di sé 19 Schmitt 19262, p. 11: “Ogni vera democrazia si fonda sul fatto che non solo l’uguale viene trattato in modo uguale, ma – conseguenza inevitabile – il disuguale in modo disuguale. Proprio della democrazia è, dunque, innanzitutto l’omogeneità e secondariamente – all’occorrenza – l’eliminazione o l’annientamento dell’eterogeneo”. 20 Sull’argomento ci permettiamo di rimandare a Scalone 1999, pp. 409-428. 21 Sulla Führung in Spengler e Horneffer, cfr. Gusy, 1993, p. 81. 19 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 20 n.19 / 2007 22 O. Koellreutter, Festgabe Schmidt, vol. II, 1932, p.134. 23 Schmitt 1935, pp. 175176: “Anche per l’annientamento del nemico dello Stato e del popolo, del partito comunista, non si poteva stare ad attendere l’autorizzazione di un sistema che per la sua propria debolezza e neutralità non era in grado di distinguere neppure un nemico mortale del popolo tedesco”. 24 pp. 226-227: “Sulla eguaglianza di stirpe è fondato tanto il continuo e infallibile contatto tra capo e seguito quanto la loro fedeltà reciproca (…) Uguaglianza di stirpe del popolo tedesco in sé unito è dunque il presupposto e la base più indispensabile per il concetto della direzione politica del popolo tedesco”. 20 come popolo e diventa una grandezza autenticamente capace di decisione politica, sia pure solo nella forma dell’acclamazione). A tale fine risponde la teoria del partito unico, ovvero di quel partito che, innervando la comunità, la organizza, la indirizza allo scopo, prepara le condizioni per il riconoscimento e l’acclamazione del capo. Il partito unico è il tramite necessario fra popolo e capo. A differenza della pluralità dei partiti, orientati ciascuno alla realizzazione egoistica dei propri interessi di parte e contrapposti per questo al bene comune e alle finalità dello Stato, il partito unico è per sua natura orientato all’unità. Esso, scrive un Koellreutter ormai prossimo all’adesione al partito nazionalsocialista, costituisce un «elemento della totalità del popolo» e deve «essere visto come rappresentante dell’unità politica»22. Il partito unico, è stato notato, “viene pensato come il legame fra Führer e seguito, il quale deve comunicare al Führer la volontà del popolo e in pari tempo far valere nel popolo la volontà del Führer” (Gusy 1993, p. 83). Ancora una volta, questa posizione teorica viene compendiata al meglio da Carl Schmitt, nelle pagine di uno dei suoi saggi più sbilanciati in favore del regime nazionalsocialista: Stato, movimento e popolo. In questo saggio egli da un lato enfatizza la soluzione di continuità rispetto alla costituzione di Weimar, dall’altro si richiama alla tradizione di pensiero tedesca precedente. In questo senso si spiegano i ripetuti riferimenti ai Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel (cfr. Schmitt 1935, p. 187: “La costruzione a tre membra […] corrisponde anche alla grande tradizione, fondata da Hegel, della dottrina statale tedesca”; p. 207; pp. 211-212) e allo Stato dei funzionari tedesco (cfr. Schmitt 1935, p. 209), contrapposti polemicamente allo Stato pluralistico dei partiti della repubblica di Weimar e alla dottrina giuridica liberale, identificata col pensiero di Kelsen (cfr. Schmitt 1935, p. 190). Per Schmitt, dunque, la nuova forma istituzionale tedesca è una sorta di unità tripartita: “L’unità politica dello Stato presente è l’unità di tre membra: Stato, movimento, popolo” (Schmitt 1935, p. 184). Ciò che è interessante ai fini del nostro ragionamento è che nonostante l’enfatizzazione dell’elemento unitario, fondato sia sulla comunità di stirpe (cfr. ad es. Schmitt 1935, pp. 191192), che sull’omogeneità e sull’eliminazione di ciò che è estraneo politicamente23 e razzialmente, pur tuttavia è necessario ancora pensare l’unità politica come articolata in tre momenti diversi. Nonostante il ruolo assolutamente predominante del capo (cfr. Schmitt 1935, p. 182), nonostante l’identità razziale col popolo – fonte di riconoscimento reciproco e di reciproca fedeltà24 - è tuttavia necessaria la presenza di un medio, il movimento, superiore rispetto a popolo e Stato, capace di connettere fra di loro le membra del nuovo (preteso) organismo e di subordinarle al capo. Il movimento, dunque, “sorregge lo Stato e il popolo, penetra e conduce le due altre” (Schmitt 1935, p. 184). Certo, Schmitt considera una sofisticheria, riconducibile alle aborrite “separazioni liberali” la pretesa di contrapporre “e far giocare Stato contro Movimento e Movimento contro Stato e Stato contro Popolo, Popolo contro Movimento o Movimento contro Popolo” (Schmitt 1935, p. 185). Ma questa tripartizione, e il ruolo di supremazia che al suo interno gioca il movimento, mostrano la non-immediatezza dell’unità politica, l’impossibilità di una pura e semplice identità fra gli elementi inevitabilmente eterogenei che lo costituiscono: in particolare fra il capo e il popolo da un lato e fra quest’ultimo e l’apparato statale e amministrativo dall’altro. La complessa articolazione costituzionale proposta da uno Schmitt pure assolutamente engagé sembra dunque rivelare infine una difficoltà di ordine teorico. Anche nel RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Antonino Scalone 17-01-2008 9:03 Pagina 21 Aspetti del dibattito sui partiti nella dottrina dello Stato weimariana “nuovo” Stato nazionalsocialista, omogeneo, totale, razzialmente puro, l’unità politica è sempre prodotta: essa è l’instabile composto frutto della forza carismatica del capo e della capacità organizzativa e pervasiva del movimento. Bibliografia E.W. Böckenförde (1976), Der deutsche Typ der konstitutionellen Monarchie, in Id., Staat, Gesellschaft, Freiheit, Frankfurt a.M., Suhrkamp 1976, pp. 112-145. C. Gusy (1993), Die Lehre vom Parteienstaat in der weimarer Republik, „Der Staat“, a. XXXII (1993), n. 1, pp. 57-86. O. Hintze (1980 [1911]), Il principio monarchico e il regime costituzionale, trad. it. in Id., Stato e società, Bologna, Zanichelli 1980, pp. 27-49. R. Horneffer (1926), Hans Kelsens Lehre von der Demokratie, Erfurt, Stenger 1926. R. Horneffer (1933), Die Entstehung des Staates. Eine staatsteoretische Untersuchung, Tübingen, Mohr, 1933. O. Koellreutter (1927), Der deutsche Staat als Bundesstaat und als Parteienstaat, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1927. H. Kelsen (1991 [1926]), Sociologia della democrazia, trad. it. Napoli, Esi 1991. F. Lanchester (1985), Alle origini di Weimar, Milano, Giuffré 1985. S. Mezzadra (1999), La costituzione del sociale. Il pensiero politico e giuridico di Hugo Preuß, Bologna, Il Mulino 1999. G. Radbruch (1930), Die politischen Parteien im System des deutschen Verfassungsrechts, in G. Anschütz-R. Thoma (Hrsg.), Handbuch des deutschen Staatsrechts, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1930, vol. II, pp. 285-294. A. Rosenberg (1928), Origini della repubblica di Weimar (1928), trad. it. Firenze, Sansoni 1972. A. Scalone (1999), Diritto, decisione, rappresentanza: il potere in Carl Schmitt, in G. Duso (a cura di), Il potere. Per la storia della filosofia politica moderna, Roma, Carocci 1999, pp. 409-428. A. Scalone (1996), Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi, Milano, Angeli 1996. C. Schmitt (2004 [1926]), La condizione storico-spirituale dell’odierno prlamentarismo (1926), trad. it. Torino, Giappichelli 2004. C. Schmitt (1935), Stato, movimento, popolo, trad. it. in Id., Principi politici del Nazionalsocialismo, Firenze, Sansoni 1935. O. Spengler (1980 [1923]), Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, München, C. H. Beck 1980 (prima ed. 1923). M. Stolleis (1999), Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland. Weimarer Republik und Nationalsozialismus, München, C.H. Beck 1999. R. Thoma (1929), Das Reich als Demokratie, in G. Anschütz-R. Thoma (Hrsg.), Handbuch des deutschen Staatsrechts, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1929, vol. I, pp. 98-126. H. Triepel (1928), Die Staatsverfassung und die politischen Parteien, Berlin, Liebmann 1928. H.U. Wehler (1981 [1977]), L’impero guglielmino. 1871-1918 (1977), trad. it. Bari, De Donato 1981. 21 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 n.19 / 2007 22 17-01-2008 9:03 Pagina 22 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 23 Lino Scalco Consenso, declino, mutamento di un modello identitario. Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano Passaggio a NordEst 1. Una filigrana secolare e complessa Nello scenario padovano, la pista d’indagine sul nesso società-religione-politica non è stata battuta a sufficienza perché si è ritenuto che nel Veneto la politica, riassunta nel binomio Chiesa-D.C., non avesse storia (Allum-Andrighetto, 1982). Se ciò vale per il Veneto, a maggior ragione dovrebbe esserlo per Cittadella e il Cittadellese: un Comune e un’area dell’Alto padovano inseriti a pieno titolo all’interno della subcultura “bianca”, dove l’identità culturale, veicolata da un fortissimo reticolo associativo cattolico, ha condizionato fortemente il quadro delle relazioni tra società, partiti e sistema politico locale. In questo contesto, le vicende politiche e in esse il ruolo svolto dalla società e dalle componenti cattoliche, sono state riassunte in termini di integrazione e continuità, attribuendo quasi automaticamente a tali caratteri il valore di indicatori di stagnazione e di uniformità. Le relazioni fra mondo cattolico, politica e società sono state considerate prevalentemente sotto il profilo istituzionale e, attraverso la riduzione del complesso di situazioni in tale ambito, a due sostanziali poli di riferimento: la Chiesa e la Democrazia Cristiana. Salvo poi, di fronte a eventi di natura traumatica, come l’accrescere della mobilità del voto negli anni Ottanta, o al più recente “terremoto” del 5-6 aprile 1992, interrogarsi sulle ragioni e scoprire che si trattava di processi e di cambiamenti più profondi. che si manifestano con modalità vistose solo più tardi (Diamanti, 2004). In altre parole, è lecito chiedersi se la continuità degli orientamenti e dei comportamenti politici espressi dalla D.C. siano davvero legati esclusivamente a basi “confessionali”, ad una appartenenza indiscussa e tramandata riconducibile ad una identità culturale di tipo religioso, o se, tra le pieghe di questo consenso, vi siano anche elementi di razionalità e consapevolezza della società nel rapportarsi alla Chiesa e, in forma mediata, al sistema politico. Questo studio fa luce su questo cono d’ombra, delineando il quadro delle relazioni fra società, religione e politica a Cittadella e nel suo territorio, dell’evoluzione del mondo cattolico e del sistema politico, cioè della dimensione culturale di base e del modello organizzativo del partito dominante. Più precisamente, l’oggetto dell’indagine è l’esplorazione della genesi, trasformazione e crisi di un modello identitario che ha portato al declino del “sistema democristiano”, indi- 23 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 24 n.19 / 2007 viduando i fattori del mutamento nella cultura politica che in quell’area si è manifestata in un processo evolutivo durato circa un secolo. Intendendo per cultura politica non un ventaglio di credenze, bensì una struttura di significazione della realtà, un codice simbolico che acquista senso in un contesto e fornisce identità ai soggetti individuali e collettivi, essa non è solo manifestazione di opinioni e di atteggiamenti, ma “(…) si sostanzia di idee e valori, simboli e norme, riti e miti, comportamenti concreti e iterati che non solo elaborano e trasmettono messaggi, ma riproducono la cultura stessa e condizionano individui e generazioni. Questa complessa miscela va riferita a collettività e collocata in un contesto storico di lunga o almeno media durata e in un territorio che non è mero spazio fisico, ma il prodotto dell’opera delle popolazioni che quello spazio fisico hanno trasformato e trasformano (…)” (Caciagli, 1988). In questo senso, la subcultura politica territoriale si può considerare come un “(…) particolare sistema politico locale, caratterizzato da un elevato grado di consenso per una determinata forza e da una elevata capacità di aggregazione e mediazione dei diversi interessi a livello locale. Questo presuppone l’esistenza di una fitta rete istituzionale coordinata dalla forza dominante, che controlla anche il governo locale e tiene i rapporti con il sistema politico centrale. Attraverso questa, non solo si riproduce un’ identità politica particolare, ma si contribuisce anche all’accordo locale tra i diversi interessi” (Trigilia, 1986). La metodologia utilizzata, lo “studio del caso”, è appropriata per approfondimenti qualitativi in contesti circoscritti (Bartolini, 1986) - si distingue dallo studio di comunità in quanto quest’ultimo tende a studiare l’insieme dei rapporti sociali utilizzando la comunità come una sorta di laboratorio per ricostruire alcune caratteristiche essenziali della società e del suo mutamento (Collins-Makowsky, 1980) - e consente di esplorare meglio le interdipendenze tra fenomeni diversi attraverso l’uso combinato di varie tecniche di ricerca: dall’analisi dei documenti provenienti dagli archivi parrocchiali, comunali e prefettizi allo spoglio della stampa locale, dalla raccolta di elaborazioni di dati socio-economici e politici alle interviste, dalle foto storiche di manifestazioni politiche e religiose ai filmati di più recente produzione, introducendo una dimensione dinamica nei fenomeni studiati, poiché l’obiettivo è quello di valutare il mutamento della subcultura politica locale e le trasformazioni del partito democristiano. Il “caso” studiato si riferisce alla genesi e alle trasformazioni del modello d’identità espresso dalla subcultura cattolica a Cittadella e dintorni, al suo formarsi e mutare nel dinamico rapporto tra società, politica e religione, al suo configurarsi e trasformarsi nella delega politica espressa al partito della Democrazia Cristiana. L’attenzione è pertanto rivolta essenzialmente alle condizioni endogene, alle strutture socio-culturali e politiche dell’area, al confine tra società, politica e religione, assumendo quale luogo privilegiato di osservazione gli atteggiamenti e le scelte della dimensione culturale di base, con l’obiettivo di riannodare in un’unica trama le conoscenze e i dati più significativi, isolando i problemi di maggior rilievo e le variabili di maggior significato, rimanendo invece sullo sfondo i macro processi politici, sociali ed economici assunti come un dato. L’intento è quello di individuare la presenza di una filigrana sottostante a quel complesso di interazioni tra Democrazia Cristiana, religione e società che percorre la cultura politica di Cittadella e che promuove e stabilizza il consenso alla D.C. anche in tempi in cui viene meno la risorsa religione. Dall’analisi delle origini della subcultura politica territoriale tra la fine dell’Ottocento e i primi anni 24 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 25 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano del Novecento, emerge il lento delinearsi di una dialettica politica, il formarsi di orientamenti e schieramenti politici via via più riconoscibili, la nascita del movimento cattolico con le sue strutture sociali che creano consenso attorno alla Chiesa perché essa ha soddisfatto bisogni cui nessun altro aveva posto mano. Il successivo consolidarsi e cristallizzarsi non intaccano il forte spirito religioso, dando vita sul piano programmatico a maggioranze e minoranze ben definite, in un rapporto d’intesa tra clero e amministratori locali. Nel primo Novecento, davanti alla minaccia rivolta alle basi sociali della Chiesa, il movimento cattolico si fa portatore di una “richiesta protezionistica”, dove passa in secondo piano la discriminazione politico-ideologica relativa ai rapporti tra Stato e cattolici e si afferma la necessità di intensificare l’intervento sul piano economico-sociale e un maggior inserimento nel gioco politico. Si tratta di ricomporre l’unità organica del mondo contadino, vista come la base sociale più confacente al rafforzamento del cattolicesimo contro la politica liberale e l’avanzata dei socialisti (Scalco, 2001)1. Dal sostrato delle prime congregazioni e unioni e dall’attitudine mentale alla vita associativa sorgono e si diffondono nuove forme di associazionismo e sindacalismo cattolico con l’appoggio del clero diocesano. La parrocchia - e in essa il parroco - è sempre più la dimensione cruciale nel rapporto tra società civile e politica perché al suo interno nascono nuove istituzioni che operano nell’ambito dell’educazione e dell’assistenza, della cultura e della politica. Sono associazioni cattoliche la cassa rurale, la cooperativa, il circolo giovanile, il sindacato agricolo, la lega bianca, il comitato elettorale, la “buona stampa”, l’oratorio festivo, la rete assistenziale, ecc. (Isnenghi, 1973; Lazzarini, 1978). La parrocchia estende così la sua sfera d’azione in tutti i settori della vita sociale entrando nel gioco delle vicende politiche, perseguendo un programma di “contadinizzazione” che bene si sintonizza con la sensibilità e la visione sociale del clero curato, che ha in mente il modello di una società rurale tradizionalmente ordinata, stabile e armonica. L’intervento del clero padovano nelle lotte sociali va in questa direzione e si traduce in un apporto concreto dove le condizioni strutturali rendono praticabile il programma cattolico del frazionamento della terra nelle aree, come il Cittadellese, dove prevale la piccola azienda familiare - fittavoli, mezzadri, piccoli proprietari - (Scalco, 2001)2. Dal 1909 al 1923, l’arciprete di Cittadella è promotore, in un certo senso arbitro della vita politica locale e ispiratore delle scelte dell’Amministrazione comunale. Invitato dal vescovo ad esercitare nella popolazione, anche in fatto di questioni amministrative, quello stesso ascendente che essa gli riconosce in cose religiose, non manca di farlo iscrivendo i cattolici in possesso dei requisiti di legge nelle liste elettorali e scegliendo i candidati al Consiglio comunale (Lazzarini, 1978; Scalco, 2007). Il controllo del governo locale serve come garanzia contro l’estromissione della religione dalla scuola, contro i maestri atei e l’ingerenza del Comune nella gestione delle opere pie e degli istituti di beneficenza. Ma anche come garanzia contro una politica di espansione delle spese comunali che si risolva in un aumento della pressione fiscale, o che vada nella gestione di servizi di pubblico interesse rispetto ai quali si preferisce la gestione privata. Il riemergere del fenomeno della subcultura politica cattolica nel secondo dopoguerra e il suo assestamento lungo gli anni Cinquanta delineano il quadro delle relazioni fra società, religione e politica. La continuità istituzionale della subcultura non viene rotta dal fascismo, perché attorno alla Chiesa sopravvivono for- 1 Alfiere di questa concezione era Gavino Sabadin; sul personaggio e il suo tempo, SCALCO LINO (2001). 2 È Gavino Sabadin, presidente dell’Unione del lavoro di Padova, l’organizzazione sindacale dei cattolici, a lanciare nel 1919 il piano per il frazionamento della terra: ogni azienda agricola a conduzione salariale avrebbe dovuto mettere a disposizione fino al venti per cento della superficie terriera per essere assegnata in affittanza a braccianti agricoli. Per approfondimenti, SCALCO LINO (2001, pp. 207-209). 25 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 26 n.19 / 2007 3 È quanto si apprende da una lettera di mons. Emilio Basso, arciprete di Cittadella, al commissario prefettizio di Cittadella, riportata da BORGHI MARCO, in SCALCO LINO (2007, pp. 868-869). 4 Sulle caratteristiche della Resistenza nel Cittadellese, SCALCO LINO (2000) e CECCATO EGIDIO (1999). 26 mazioni sociali che, seppure ridimensionate sul piano politico, assicurano una continuità e un rafforzamento della subcultura consentendone la successiva riemergenza. La rilevante forza della Chiesa in quest’area sposta a suo favore gli equilibri del potere limitando le pretese totalitarie del regime. Il fascismo viene tollerato e riconosciuto dalla Chiesa: in cambio vengono garantite la sopravvivenza e l’autonomia della rete istituzionale cattolica. La convergenza è maggiore sul terreno generale della politica interna e di quella coloniale, appoggiate dal clero locale. La prova che nel ventennio fascista la rete subculturale sia sopravvissuta, si sia ristrutturata e rafforzata sul piano della socializzazione e delle attività di assistenza è la seguente: alle prime elezioni amministrative del marzo 1946 la nuova forza della Democrazia Cristiana raccoglie un così vasto consenso tale da esprimere un chiaro segno di continuità con la subcultura costituitasi già prima del fascismo. Nel vuoto istituzionale che si determina dopo l’8 settembre 1943, il clero locale mantiene un atteggiamento prudente, riproponendosi come punto di riferimento essenziale per la difesa della società locale dalle minacce e dalle tensioni. Durante la guerra di Liberazione, l’egemonia della Chiesa nella società civile si riflette con due facce: da un lato allineandosi alle autorità della Repubblica Sociale Italiana e all’occupante tedesco contro le formazioni partigiane (Borghi, 2007)3; dall’altro, controllando l’influenza dei gruppi laici, socialisti e comunisti sulla società rurale, ostacolando la saldatura tra le componenti più radicali dell’antifascismo e la popolazione delle campagne. È in questo periodo che la Chiesa e il nascente partito della Democrazia Cristiana confermano la centralità della loro posizione tra fascismo e comunismo, operando sapienti correzioni tali da non stravolgere la linea individuata dalla Resistenza, ma attenuandola, ammorbidendola sì che fosse accettabile a tutti i moderati, acquisendo una forte connotazione interclassista. Uomini come Gavino Sabadin esalteranno la Resistenza dei cattolici proprio per i suoi contenuti di moderazione, prendendo le distanze da altre forme che la guerra partigiana aveva assunto, mettendone in luce i costi umani per le popolazioni e i fatti sanguinosi cui esse a volte avevano condotto. Così, dopo la Liberazione, nella Giunta comunale provvisoria di Cittadella che assume i poteri nel maggio 1945, la carica di sindaco è affidata a persona politicamente moderata ed estranea alla Resistenza armata. E nel Consiglio comunale eletto nel marzo 1946 la componente partigiana non ha rilevanza né numerica né politica (Scalco, 2000; Ceccato, 1999)4. La struttura di classe rimane centrata sull’agricoltura, con larga prevalenza della piccola proprietà e della piccola affittanza, caratterizzate da un’organizzazione del lavoro di tipo familiare, con un forte legame alle vecchie consuetudini rurali strutturate attorno alla famiglia patriarcale e alle pratiche religiose. Lungo gli anni Cinquanta del Novecento permane dunque, senza forti cambiamenti, quella situazione di ridotta proletarizzazione e di scarsa polarizzazione della struttura di classe, che costituisce una componente essenziale della subcultura territoriale, con la centralità culturale e istituzionale della Chiesa e la sostanziale persistenza di un quadro economico e sociale che ne favorisce l’influenza sulla società. Con queste coordinate si afferma, sul terreno politico, la Democrazia Cristiana, che a Cittadella come altrove nel Veneto nasce come partito cattolico (Sabadin, 1944; Romanato, 2001). I risultati ottenuti a Cittadella alle politiche nel 1919 dal Partito Popolare Italiano e dalla Democrazia Cristiana per l’Assemblea Costituente nel 1946 fanno emer- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 27 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano gere la corrispondenza tra l’area subculturale cattolica formatasi nel primo dopoguerra e quella di più forte presenza democristiana nel 1946. Il rapporto tra clero, ceto politico e società civile fondato sull’appartenenza religiosa e un certo paternalismo che funge da ammortizzatore delle tensioni nella soluzione dei conflitti hanno contribuito a difendere Cittadella dalle pressioni esterne derivanti dai nuovi modi di pensare e dai comportamenti provenienti dalle aree più evolute, realizzando così un’efficace mediazione tra gli elementi tradizionali, le relazioni sociali che su di essi si fondano e il mercato capitalistico. Nel rafforzarsi della subcultura cattolica tra gli anni Sessanta e Settanta, le basi sociali che così si costituiscono hanno carattere territoriale e non di classe, con forti legami interclassisti e coagulate da robuste risorse di identità diffuse date dal clero e dalla Chiesa. L’elevazione dei lavoratori deve avvenire in modo pacifico ricusando atti violenti, con cautela e moderazione. L’attività del sindacato è ispirata al principio della collaborazione di classe, senza tuttavia accettare l’organizzazione mista di contadini e proprietari (Vedovato, 1997). Rispetto alla trasformazione negli anni Ottanta, le parrocchie funzionano ancora come centri di promozione e di organizzazione, ma il loro carattere confessionale comporta che bisogna essere cattolici e rispettare i doveri religiosi per poter essere accettati come soci. Certo, le loro possibilità di funzionamento sono condizionate dai rapporti con le banche cattoliche per il fabbisogno creditizio. La stampa cattolica, cui le famiglie si abbonano attraverso le strutture parrocchiali, oltre ad essere uno strumento di divulgazione del pensiero della Chiesa, rappresenta un potenziale veicolo per combattere la penetrazione delle idee ostili alla religione e ai “buoni” costumi. Da questa analisi emerge un dato di fondo, che ci consente di collocare l’intervento sociale e culturale del clero cittadellese nelle sue giuste dimensioni e di comprendere i caratteri che gli sono propri. Il clero è nella sostanza estraneo alla pratica sindacale e politica, muovendosi ed operando entro un orizzonte culturale diverso, entro una gamma di preoccupazioni e istanze di tipo confessionale e religioso-pastorale. Gli strumenti propri del sindacalismo non sono accettati; anzi, sono valutati come pesanti fattori di turbamento sociale e religioso e fenomeni dannosi per la vita parrocchiale. Il problema che più sta a cuore ai parroci e che guida la loro interpretazione della situazione è quello dei comportamenti delle popolazioni e delle modificazioni negative da essi riscontrate nella pratica religiosa, nella condotta morale, negli atteggiamenti verso la Chiesa cattolica. Ecco allora la consapevolezza che le guerre, i conflitti sociali, lo Stato laico, il pensiero comunista abbiano indotto mutamenti profondi nella società e nella coscienza stessa delle masse cattoliche, come è dimostrato dalla mobilità del voto lungo gli anni Ottanta del Novecento. È qui che si aprono gli interrogativi sulla direzione del mutamento. Il clero interviene ancora in una prospettiva di più ampie proporzioni, per dare una risposta alle mutate condizioni storiche, sociali e politiche, aggiornandosi nei criteri e nei mezzi ai bisogni dei tempi, mirando a rafforzare o a ripristinare, dove è stato messo in discussione, il consenso popolare alla Chiesa e il suo agire in conformità ad essa. È dunque la risposta di un clero consapevole che la restaurazione cristiana della società richiede, negli anni Ottanta del Novecento, l’adozione di nuovi metodi “pastorali” (Brunetta-Longo, 1991). Per spiegare le origini e le conseguenze della formazione, nel Cittadellese, di una subcultura politica territoriale, si sono analizzati degli indicatori socio-economi- 27 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 28 n.19 / 2007 5 Tema controverso, quello dell’identità cattolica, come traspare dalle interviste a sociologi, filosofi, sindacalisti, imprenditori e parlamentari contenute nel citato volume di BRUNETTA GIUSEPPE e LONGO ANTONIO (1991). 6 Nell’Alto padovano vince alla grande la monarchia, con percentuali altissime a Santa Giustina in Colle (87,51%), Villa del Conte (84,85%), Trebaseleghe (84,60%), Camposampiero (83,79%), Loreggia (78,86%), Tombolo (77,73%), Gazzo Padovano (77,39%), San Giorgio in Bosco (76,25%), Villafranca Padovana (75,88%), San Martino di Lupari (74,71%), ecc. Un quadro completo di tutti i comuni padovani in SCALCO LINO (1996). 28 ci a partire dai rapporti di produzione nelle campagne, con l’ impatto che viene a determinarsi tra questi e il mercato capitalistico in una situazione in cui lo sviluppo industriale è quasi completamente assente, con una prevalenza di tipo “autonomo” - mezzadria, piccolo affitto, piccola proprietà contadina -. Tutto ciò, da un lato fornisce risorse di resistenza relativamente maggiori di fronte agli effetti disgreganti del mercato; dall’altro, costituisce delle basi sociali favorevoli per l’affermarsi di una mobilitazione con caratteri territoriali, più che di classe in senso stretto. Ma questo esito non ci sarebbe stato senza l’apporto di identità diffuse. Questo chiama in causa le tradizioni ideologiche e le risorse istituzionali e associative che fanno da catalizzatore del processo di mobilitazione. Una struttura di classe caratterizzata dalla piccola proprietà, fortemente influenzata dal clero, combinandosi con un’identità urbana anch’essa influenzata dalla Chiesa, favorisce lo sviluppo del movimento cattolico. E la crisi agraria di fine Ottocento, destabilizzando gli equilibri sociali tradizionali, attiva la mobilitazione che si consolida in una subcultura territoriale rafforzando l’identità locale, per effetto dei rapporti conflittuali con lo Stato nazionale. Questo processo di identificazione politica caratterizza sia le basi sociali che il fondamento della delega. Dalla politica ci si attende la difesa dell’ordine tradizionale e in particolare una difesa del ruolo della Chiesa in campo educativo-economico-sociale. La politica deve garantire e sostenere l’autonomia della società civile, piuttosto che intervenire in essa per modificarla. Una delega politica è fondata sì sull’identità cattolica (Brunetta-Longo, 1991)5, ma anche sulla capacità della subcultura di trovare localmente risposte concrete alle tensioni indotte dal mercato. Di qui l’importanza di guardare alla subcultura come ad un sistema politico locale attraverso il quale non solo si riproduce una particolare identità, ma si sviluppa anche una mediazione localistica degli interessi. La subcultura non implica solo l’affermarsi di particolari orientamenti politici, ma comporta pure una complessa attività sul piano economico-sociale, il cui fine ultimo è la mediazione locale tra il mercato capitalistico e i rapporti sociali tradizionali, che sono di tipo interclassista, legati alla rete istituzionale della Chiesa e rappresentati dal partito democristiano, tenendo conto del mutamento di identità politica rispetto alla struttura politica di origine. 2. Riemergenza e consolidamento della subcultura politica cattolica nel secondo dopoguerra: continuità e varianti del modello identitario La corrispondenza tra l’area subculturale cattolica formatasi all’inizio del Novecento e quella di più forte presenza democristiana nel secondo dopoguerra è confermata dai consensi raccolti dallo scudo crociato, maggiori di quelli ottenuti alle elezioni politiche del 1919 dal Partito Popolare Italiano. Questi dati segnalano non solo la continuità della subcultura costituitasi prima del fascismo, ma anche un rafforzamento elettorale della D.C. che si richiama alla medesima matrice politico-religiosa e la conferma di Cittadella come territorio dell’Alto padovano a pieno titolo inserito all’interno della subcultura bianca, che è la cartina di tornasole per capire il risultato del referendum istituzionale del 2 giugno 1946: nella città murata vince la monarchia con 3.644 voti pari al 53,49% contro i 3.169 alla repubblica con il 46,51% (Scalco, 1996)6. RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 29 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano Delineiamo ora il quadro delle relazioni tra società, religione e politica in questa fase di riemergenza e assestamento della subcultura territoriale dall’immediato dopoguerra a tutti gli anni Cinquanta. Innanzitutto il fattore religioso, che svolge un ruolo cruciale nei processi di cambiamento-conservazione della società cittadellese, per la sua capacità di aderire, attraverso la mediazione decisiva della Chiesa, agli orientamenti dell’identità sociale, dello sviluppo economico e del consenso politico. Per lungo tempo e per tutti gli anni Cinquanta, la dimensione simbolica e organizzativa della Chiesa costituisce l’intelaiatura all’interno della quale si realizzano non solo la coesione e il controllo sociale, ma anche la regolazione e la soddisfazione delle domande individuali e collettive. Come dire che la religione si impone come il campo all’interno del quale si scambiano non solo beni simbolici e normativi, ma anche benefici concreti e prestazioni materiali: il fattore religioso va riferito ad un sistema simbolico normativo e istituzionale unitario e compatto, interpretato dalla Chiesa sia sul piano pastorale che su quello organizzativo (Ventura, 1989). Dunque, rispetto alla società locale, la Chiesa esprime una funzione sostanziale di produzione di senso e di identità, fornendo un sistema di significati, un universo normativo e di valori sostanzialmente coerente con le aspettative e le istanze del contesto nel quale è inserita. In particolare, per quanto riguarda la società rurale, questo aspetto ha ottenuto numerose verifiche, come osservava Gustavo Guizzardi: “La Chiesa svolge un ruolo di intellettuale organico dei contadini. Essa in effetti è l’unica agenzia intellettuale che si occupi dei contadini, che sappia loro offrire una interpretazione della loro vita quotidiana, che li colloca entro un quadro di riferimento in cui il loro esistere acquista significato al di sopra dei puri fenomeni contingenti e congiunturali (…)” (Guizzardi, 1978). La società rurale fa riferimento alla religione attraverso la mediazione della Chiesa e così può disporre di un quadro di significati da attribuire alle azioni soggettive, agli eventi, alle situazioni concrete. Così la religione si propone come centro di produzione del “senso comune” e ad essa si riconnette gran parte del sistema di socializzazione secondaria del contesto locale. L’esperienza dell’aggregazione e della comunicazione interpersonale viene realizzata, in misura prevalente, all’interno dell’associazionismo cattolico, fitta rete di organizzazioni costituitasi e sviluppatasi attorno alle parrocchie. I dati raccolti nella tab. 1, anche se incompleti, sono sufficienti a dare la dimostrazione del fenomeno, senza trascurare che la frequenza alla messa festiva conserva il suo carattere di massa anche nel secondo dopoguerra. Tenendo conto della bassa scolarizzazione nel 1951, che l’unico mezzo di comunicazione di massa era la stampa ed un abbonamento era considerato un lusso, si ha una chiara immagine dell’influenza culturale e sociale esercitata dalla Chiesa. Attorno alla struttura ecclesiale si costituiscono sedi e luoghi di rappresentanza e organizzazione degli interessi categoriali e sociali, che tutelano e promuovono le condizioni materiali e di status, più ancora di quelle etiche, dei propri aderenti: i lavoratori dei campi, gli operai, i giovani che affrontano l’esodo dalle campagne e apprendono un nuovo mestiere, gli studenti, gli insegnanti. Il fattore religioso fornisce quindi risorse importanti anche sul piano “materiale” e la rete dei servizi e delle strutture assistenziali delinea un complesso di condizioni favorevoli all’industrializzazione diffusa e allo sviluppo del terziario. Lo “sviluppo senza fratture”, cioè il processo che conduce questa realtà territoriale ad avere nel 1983, accanto ad un 50% di occupati nel secondario (compreso l’arti- 29 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 30 n.19 / 2007 gianato di produzione), il 35% della popolazione attiva nel terziario - sanità, istruzione, pubblica amministrazione, servizi privati e pubblici, commercio (Associazione degli industriali della Provincia di Padova, 1984) - senza che di ciò giunga adeguata rappresentazione e percezione presso la cittadinanza, ottiene dal fattore religioso più di qualche sostegno. L’omogeneità e la coesione culturale che sostengono la stabilizzazione sociale circoscrivono le tensioni e il conflitto. Tra le pieghe della società è inarrestabile l’attività del Patronato Pio X, delle opere pie, dell’asilo, dell’Ospedale civile, della Casa di riposo, dell’Istituto Farina e del cinema parrocchiale: tutti servizi che sorgono per iniziativa dell’ambiente religioso ed ecclesiale, al cui interno vengono mantenuti controllo e gestione. Ma il ruolo del “fattore religioso” costituisce la dimensione cruciale, a Cittadella, lungo tutti gli anni Cinquanta e fino alla prima metà degli anni Sessanta, anche nel rapporto tra società e politica. L’adesione all’insegnamento e la tutela degli interessi della Chiesa rappresentano il parametro su cui gran parte della popolazione regola il proprio atteggiamento, costruisce le proprie valutazioni e le proprie scelte nei confronti dei partiti. Tab. 1 – L’associazionismo di matrice cattolica a Cittadella a metà degli anni Cinquanta nome dell’organizzazione iscritti M F totale Azione cattolica* 760 389 371 760 Confraternite** 450 195 255 450 S. Vincenzo De’ Paoli 47 22 25 47 Volontari della sofferenza — — — — Frequentanti il patronato Pio X 289 289 — 289 Dottrina cristiana — — — — ACLI — — — — Corsi professionali organizzati dalle ACLI*** — — — — Alunni all’Istituto Farina 241 115 126 241 Associati alla Coldiretti — — — — Scouts — — — — Studenti universitari cattolici (FUCI) — — — — Missionari all’estero — 35 28 63 Terz’ordine francescano 38 17 21 38 Catechisti 30 12 18 30 Associazione italiana maestri cattolici (AIMC) 25 11 14 25 Scuola cantorum — — — — Abbonati alla stampa cattolica**** — — — 55 Fonte, ARCHIVIO PARROCCHIA DEL DUOMO, CITADELLA, “Il giornaletto di Cittadella”, anni 1950-1955. * Comprendeva i fanciulli cattolici, gli aspiranti, i giovani, gli uomini cattolici, le beniamine, le donne cattoliche. ** Del SS. Sacramento, Madri e spose cristiane, Figlie di Maria, Confraternita del Carmine. *** Sono i corsi ENAIP. **** Al settimanale diocesano “La difesa del popolo”, al mensile “Famiglia cristiana”, ai quotidiani “L’Avvenire d’Italia” e “Il Gazzettino”, a “Il vittorioso” e “Primavera”. 30 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 31 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano La delega della società cittadellese si rivolge alla Democrazia Cristiana in termini “difensivi” in quanto riconosciuta strumento di tutela dell’identità e dell’organizzazione ecclesiale e dunque di quella sociale. Non solo, ma si muove parallelalemte contro gli altri partiti in quanto percepiti come minaccia nei confronti del “fattore religioso”, del campo di elementi simbolici e normativi, del sistema di servizi concreti ad esso sottesi. Potremmo definire questa fase come “idealtipica”, che ci consente di cogliere e descrivere le premesse e i caratteri del rapporto Chiesa-società e la natura della delega, integralmente beneficiata dalla D.C. 3. La domanda politica e le dinamiche elettorali dal 1946 al 1963 Uno sguardo alle connotazioni del voto ci aiuta a definire e precisare le premesse e i caratteri del rapporto tra Chiesa e società e la natura della delega maggioritariamente beneficiata dalla D.C. Nel periodo considerato risulta esplicito il legame del contesto locale e del comportamento elettorale con la dimensione religiosa, con la presenza, il radicamento e la diffusione dell’organizzazione e dell’adesione al mondo cattolico. Rispetto a questo fattore discriminante, mentre la D.C. mostra correlazione stretta e positiva, la sinistra si presenta in modo ambivalente: da una parte P.C.I. e P.S.I. esprimono antitesi e opposizione associandosi ai segni di una pratica e di una cultura laica e anticlericale; dall’altra il P.S.D.I., unico partito a non essere demonizzato dalla Chiesa. La destra, raccolta soprattutto attorno al partito monarchico, assume atteggiamenti reazionari e conservatori e comunque non in sintonia con gli interessi della Chiesa. Osservando analiticamente i risultati elettorali sintetizzati nella tab. 2, si colgono i processi in atto. La predominanza nettissima della D.C. si manifesta sin dal 1946 e la sua forza si conferma in tutte le consultazioni politiche successive, mantenendosi fino al 1963 al di sopra del 77% dei voti validi. Il restante elettorato viene ripartito tra le varie formazioni di destra e di sinistra con peso pressoché analogo. Il P.C.I., in tutto questo periodo non supera mai l’8% dei suffragi rimanendo al di sopra della soglia minima di sopravvivenza, il 5%. Il P.S.I., fatta salva la consultazione del 1946 dove raggiunge il 10,1% dei voti, per tutti gli anni successivi fino al 1963 non supera il 5,2%. Questo debole insediamento della sinistra nel Cittadellese è dovuto ad una composizione sociale caratterizzata quasi esclusivamente dalla piccola proprietà coltivatrice, dalla piccola affittanza, dall’assenza del tessuto industriale e dalla forte opposizione del clero che si può definire come ossessione anticomunista, tenuta in vita a dispetto dell’insignificante peso elettorale del partito comunista, che nelle zone rurali raggiunge minimi insignificanti. I tentativi di penetrazione dei comunisti nel Cittadellese non hanno successo e il clero ne prende atto con soddisfazione. La paura del “peccato mortale” viene agitata non solo contro gli elettori dei partiti marxisti - dal luglio 1949 sugli iscritti ed elettori del P.C.I. pesa la scomunica del S. Uffizio -, ma anche nei confronti dei votanti le formazioni di destra. Una tale presa di posizione, che etichetta gli stessi monarchici come “anticattolici”, non è ininfluente ai fini della mancata costituzione a Cittadella di una solida formazione di destra. Elementi interessanti si ricavano pure analizzando l’andamento elettorale nelle consultazioni amministrative dal 1946 al 1964, dove la D.C. mantiene il suo elevatissimo consenso. Alle elezioni del marzo-aprile 1946 conquista il governo di 31 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 32 n.19 / 2007 Tab. 2 - I risultati percentuali delle consultazioni politiche nel Comune di Cittadella dal 1946 al 1963 partiti 19461 19482 19533 19584 19635 D.C. 72,0 83,0 75,0 81,0 77,0 P.C.I. 8,8 — 7,0 3,9 4,2 P.S.I. 10,1 — 3,5 5,2 5,2 Fronte Democratico Popolare — 12,0 — — — P.S.D.I. — — 3,0 3,1 4,3 P.R.I. 0,6 0,2 0,1 0,7 0,2 P.L.I. — — 5,0 3,8 5,1 P.D.I.U.M. — 0,4 3,0 1,1 0,5 M.S.I.-D.N. — 0,8 1,2 1,3 1,1 Uomo Qualunque 1,8 — — — — Unione Socialista Indipendenti — — 0,3 — — Partito Federalista — — 0,01 — — Alleanza Democratica Italiana — — 0,1 — — Partito Esistenzialista — — — — — Partito di Unità Popolare — — 0,8 — — Partito Radicale Socialista — — 0,1 — — Fonte, ARCHIVIO STORICO COMUNE DI CITTADELLA, nostra elaborazione dei dati elettorali del 1946, 1948, 1953, 1958 e 1963. 1 Elezioni del 2-3 giugno per l’Assemblea Costituente e referendarie. All’ appuntamento del 18 aprile 1948, un elemento determinante dei comportamenti elettorali fu la paura del comunismo. Per l’alto indice di instabilità e al tempo stesso per la capacità di mobilitazione degli elettori, quelle elezioni hanno segnato uno spartiacque nella politica italiana, avviando la fase della stabilizzazione che caratterizzerà gli anni Cinquanta e Sessanta. A Cittadella, alla Camera dei deputati la Democrazia Cristiana sfiora l’83% dei voti, una percentuale mai più raggiunta. Il Fronte Democratico Popolare e Unità socialista superano di poco il 12% delle preferenze. La destra sembra abbandonare provvisoriamente le proprie formazioni per confluire, in funzione anticomunista, nella D.C. Quello del 18 aprile 1948 non fu solo un voto cattolico, ma anche conservatore perché alimentato da una cultura genericamente nazionalista. All’altissima percentuale di votanti fa riscontro il bassissimo l’indice delle defezioni. Accompagnati da suore o parenti, alle urne si sono recati pure i moribondi, i paralitici, i ciechi, gli arteriosclerotici con tremore, gli affetti da “marasma senile”, come si legge nei certificati medici presentati ai presidenti dei seggi elettorali. Percentuali così elevate non hanno paragoni con tutte le altre consultazioni politiche precedenti di epoca pre-fascista e ricordano i plebisciti fascisti (Dal Lago, 1999). 3 Alla Camera dei deputati la D.C. ottenne 5.913 voti, il P.C.I. 485, il P.L.I. 370, il P.S.I. 257, il Partito Nazionale Monarchico 209, il P.S.D.I. 198, il M.S.I. 96, il Partito di Unità Popolare 53, l’Unione Socialista indipendenti 24, il Partito Radicale Socialista 15, l’Alleanza Democratica Nazionale 11, il P.R.I. 6, il Partito Federalista Italiano 1, il Partito Esistenzialista Universale 0. Al Senato alla D.C. furono attribuiti 5.285 voti, al P.C.I 432, al P.L.I. 244, ai monarchici 216, ai socialdemocratici 208, ai socialisti 206, ai fascisti 95, ad un’altra lista socialista 61, all’Alleanza Democratica Italiana 8, ai repubblicani 7. 4 Alle elezioni politiche del 25 maggio 1958, Camera dei deputati, alla D.C. vanno 6.365 voti, 409 ai socialisti, 308 ai comunisti, 299 ai liberali, 247 ai socialdemocratici, 101 ai fascisti, 89 ai monarchici, 66 ai repubblicani alleati con i radicali, 33 alla lista monarchica+combattenti+nazionalisti, 10 al Movimento Autonomia Regionale. Al Senato della Repubblica, 5.581 voti vanno al candidato della D.C., 395 a quello liberale, 338 a quello socialista, 283 a quello comunista, 242 a quello socialdemocratico, 108 a quello monarchico, 50 al candidato della lista monarchici-combattenti-nazionalisti. 5 Alle elezioni politiche del 28 aprile 1963, alla Camera dei deputati 6.675 voti vanno alla D.C., 458 ai socialisti, 439 ai liberali, 381 ai socialdemocratici, 363 ai comunisti, 97 ai fascisti, 51 ai monarchici, 24 al Papi, 18 ai repubblicani. Al Senato 5.917 voti vanno al candidato democristiano, 393 a quello socialdemocratico, 364 a quello comunista, 363 a quello socialista, 121 a quello fascista. 2 32 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Lino Scalco 9:03 Pagina 33 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano 76 Comuni su 105; 29 vanno alla sinistra. A quelle del 27 maggio 1951 alla D.C. vanno 96 Comuni, la sinistra ne perde 20 rimanendo con 9. Alle amministrative del 27 maggio 1956 essa raggiunge la sua punta massima conquistando 98 Comuni, alla sinistra ne rimangono 7. A Cittadella, con una popolazione di 13.913 abitanti, si vota in 13 sezioni; gli elettori iscritti sono 8.163; 115 sono quelli residenti all’estero - Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Congo Belga, Stati Uniti d’America, Venezuela, Indocina, Francia, Svizzera, Belgio, Uruguay -, cui vengono spediti i certificati elettorali. Alle amministrative del 6 novembre 1960 sono interessati 104 Comuni: 96 vanno alla D.C., 2 a liste indipendenti, 6 alla sinistra. A quelle del 22 novembre 1964 si vota in 104 Comuni: 96 vengono conquistati dalla D.C., 2 da liste civiche e solo 4 dalla sinistra (Scalco, 2007). Aumentano le defezioni rispetto alle elezioni politiche e precisamente, più che gli astenuti, le schede bianche e quelle nulle: sono malumori di una parte dell’elettorato che non si riconosce nella D.C., ma anche la riprova del minor carattere politico delle consultazioni amministrative, con una conseguente sdrammatizzazione del loro contenuto ideologico. Nei primi anni del dopoguerra, l’immagine che emerge della D.C. è quella di un partito organizzativamente debole, “sponsorizzato” esternamente dalla Chiesa, nel quale prevale lo spirito moderato e conservatore, come dimostra il già ricordato esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Dai dati emersi, si può affermare che al differente atteggiamento rispetto alla dimensione religiosa, si associano anche differenti assetti della struttura sociale e territoriale di riferimento. Così, mentre l’elettorato democristiano - e prima ancora, nel periodo pre-fascista, quello popolare - associa ad un elevato grado di adesione al mondo cattolico i tratti del contesto rurale, l’elettorato di sinistra rivela atteggiamenti di contrapposizione e di estraneità all’ambito cattolico, con riferimenti sociali e territoriali tipici del contesto cittadino e industriale. Identità religiosa, appartenenza al mondo cattolico e al suo sistema rituale e organizzativo, appaiono dunque presupposti cruciali nell’improntare orientamenti e scelte nella sfera politica, ma non risolutivi. Solo in combinazione e miscelandosi con altri fattori, ben più concreti e di natura strumentale, connessi al contesto territoriale e all’ambiente sociale, essi risultano esprimere compiutamente la propria influenza. Il fattore religione si propone quindi come dimensione determinante in quanto luogo di interscambio tra contenuti ed elementi di segno molteplice e non solo normativo e di identità. Ad esso si riconnettono un’appartenenza sociale e territoriale ben precisa, l’adesione o la contrapposizione, nel concreto e nell’esperienza, ad un contesto, ad una struttura, ad una condizione. 4. Le caratteristiche e la natura della delega Questa pragmatica e localistica cultura della partecipazione, non scalfisce, né ostacola i processi di identificazione e consenso quando si passa a verificare l’orientamento della delega all’interno del sistema politico complessivo. Il senso di appartenenza che permea l’atteggiamento della società cittadellese rispetto al sistema politico si rispecchia nel consistente grado di concentrazione delle scelte espresse nei confronti della D.C., così che il grado di legittimazione che connota la delega della società locale a questo partito appare elevatissimo, come altrettanto elevato risulta essere il grado della sua matrice religiosa. È il fattore religioso a fungere da selettore e da discriminante nei confronti del- 33 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 34 n.19 / 2007 7 Questa preoccupazione è ben presente in SABADIN GAVINO (1968). 34 l’intero ambito dei partiti, valutati sul metro della distanza e dell’affinità rispetto a tale dimensione e sulla percentuale di religiosità e di fedeltà alla Chiesa. Il binomio religione-Chiesa costituisce il presupposto e il perno attorno a cui ruotano, a Cittadella negli anni Cinquanta, atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi. Il consenso espresso dalla società civile e dalla preponderante componente dei cattolici al sistema politico si alimenta di risorse esterne ad esso, con una fitta rete di interessi che si sono coagulati attorno alla D.C., spiegandone il successo nel collegio elettorale quanto e più ancora del fattore religioso. Basti pensare al sistema creditizio, ai nuovi ceti produttivi - l’imprenditoria di prima generazione -, al Consorzio agrario, all’Ospedale Civile, alla Casa di ricovero, alla Coldiretti, al Centro ENAIP, all’Unione artigiani: cioè tutti i centri di potere della D.C. Cittadellese (Scalco, 2007). La D.C. delle origini si presenta come un partito di debole istituzionalizzazione, il cui sviluppo avviene per diffusione territoriale più ad opera di personaggi come Gavino Sabadin che per coordinamento centrale. Nello stesso tempo, si affaccia sulla scena politica come il prodotto del massimo impegno da parte della Chiesa nella fase di transizione che segna la caduta del fascismo, per precostituire una soluzione dell’assetto politico italiano in sintonia con i propri interessi istituzionali (Sabadin, 1968)7. Prevalenza e centralità della D.C. nelle relazioni fra società locale e sistema politico implicano un atteggiamento di delega ispirato e indotto dalla religiosità e dalla Chiesa: un atteggiamento che fa convivere identificazione e al tempo stesso distacco, schieramento attivo e scarso impegno personale. Lo spazio della politica tende ad essere limitato e connotato essenzialmente in negativo. Da essa ci si aspetta soprattutto la difesa dell’ordine morale e delle istituzioni tradizionali come la famiglia, la Chiesa, la comunità locale, contro i pericoli derivanti dalla promiscuità dei sessi nei luoghi di lavoro e, soprattutto, considerando l’agricoltura il settore economico centrale, quasi a dire che finchè l’uomo rimane attaccato alla terra e vive a contatto con la natura, conserva le sue tradizioni e le virtù fondamentali: la fede in Dio, la probità, la parsimonia, il rispetto dell’autorità, l’amore per la famiglia. Uscito da questo mondo, è destinato a mutare in peggio (Associazione veneta di studi regionali, 1971). Il fondamento della delega ha quindi delle conseguenze rilevanti sui caratteri del consenso e della domanda politica: a) fondandosi su un sistema di valori condiviso, il consenso tende ad essere generale, stabile e maggiormente sganciato dal soddisfacimento immediato di richieste particolari; b) i rappresentanti sono valutati e individuati sulla base dell’appartenenza culturale, prima che sulla base delle loro proposte e della loro azione concreta; c) in generale, la delega tradizionale tende a ridurre la domanda e quindi il carico per il sistema politico; forti dell’ampio consenso e delle scarse possibilità di controllo, gli amministratori possono spesso eludere le richieste meno gradite e meno opportune senza gravi danni. Una lettura più attenta delle preferenze elettorali ci consente di scorgere elementi di consapevolezza e razionalità nelle scelte e nelle valutazioni fondati su basi concrete. Se gli aspetti legati alla religione risultano determinanti, affiora in modo evidente una domanda di diverso segno che possiamo ricondurre al variegato mondo del lavoro - le filandiere sindacalizzate reclamano condizioni di lavoro più umane, l’escavazione selvaggia nel Brenta, approvata dalle amministrazioni comunali rivierasche tutte rette dalla D.C., pregiudica la sicurezza idraulica del territorio -, non facilmente risolvibile all’interno del sistema locale e fa emergere RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 35 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano l’impossibilità per i partiti di fondare la propria legittimazione semplicemente su risorse di tipo simbolico, su una mera offerta di identità, su una base puramente difensiva (Scalco, 2007)8. Alla dimensione religiosa, la cui tutela costituisce il fondamento della delega, sono inscindibilmente connessi gli aspetti dell’organizzazione e della struttura ecclesiale e del mondo cattolico. Un’organizzazione e una struttura che non agiscono solo su un piano pastorale e di religiosità, ma che operano anche come organizzazione e struttura della società locale, come centri di produzione di senso, socializzazione, soddisfazione e supporto alle domande del contesto locale. Un modello municipalisticamente imperniato sulla parrocchia, attorno alla quale si dipana una rete di associazioni, strutture e iniziative che si insinuano nei settori dell’esistenza individuale e collettiva per rispondere a tutti i bisogni della società. Così nuove associazioni vengono fondate quando nuovi bisogni si fanno sentire. Attorno all’associazionismo di matrice cattolica si coagulano lavoratori dipendenti e autonomi, contadini e professionisti, insegnanti e studenti formando ed alimentando amministratori locali, sindacalisti, esponenti di partito, tessuto economico e ceto dirigente. Pertanto, quando nell’immediato dopoguerra la domanda di qualificazione professionale dei giovani lavoratori che progressivamente si staccano dalle campagne alimenta una forte richiesta di corsi di addestramento per falegnami, muratori, carpentieri, ecc., è la sezione delle ACLI a promuoverli e a gestirli in un apposito edificio costruito su terreno della parrocchia del duomo. Alla dimensione religiosa, sulla cui difesa e tutela reggono delega e consenso alla D.C., sono sottesi non solamente valori e simboli di un ambito di fede, ma più estesamente convergono le premesse e i caratteri dell’organizzazione socio-economico locale. Significativo è anche un altro aspetto: il privilegiare le forme e gli strumenti di partecipazione politica centrati sul proprio paese, manifestando un distacco per le forme legate all’ambito statuale. Atteggiamento, questo, che è indice di un precario processo di integrazione della società locale con gli ambiti istituzionali più generali, segno di un irrisolto rapporto centro-periferia. L’incrocio tra la questione centro-periferia e quella del fondamento religioso della delega riconduce i caratteri dell’atteggiamento politico dei cattolici cittadellesi negli anni Cinquanta e Sessanta ad un modello interpretativo che supera i rischi di una lettura improntata alla “tradizione” e alla “confessionalità”. In questo periodo storico, il rapporto tra società e politica va riconnesso al ruolo e alla funzione che la religione svolge sul piano di fede e organizzativo. Da un lato essa fonda il consenso della società cittadellese nei confronti della D.C., fornendo al partito ideologia e struttura; dall’altro, si legittima verso la società locale acquisendone direzione e controllo, non solamente per ragioni di fede o rituali, ma perché in grado di rispondere a necessità concrete sul piano interno nei confronti del contesto sociale e su quello esterno rappresentando il contesto locale rispetto allo Stato. Lungo gli anni Cinquanta e Sessanta, l’appartenenza al mondo cattolico implica una appartenenza al sistema locale nel suo complesso e l’accesso ad un’articolata e complessa trama di prestazioni e risorse simboliche e materiali erogate al suo interno. Non è azzardato affermare che la Chiesa funga da “mediatrice” verso l’esterno della società locale, nei confronti delle pressioni dello Stato e delle tensioni del mercato. Al riguardo, efficace e suggestiva è l’immagine fornitaci da 8 SCALCO LINO (2007). In più occasioni il tema delle escavazioni di inerti nel Brenta è stato oggetto di interrogazioni in Consiglio provinciale e in Parlamento. E quando si prospettavano licenziamenti, la CISL di Cittadella faceva intervenire personalmente il ministro del Lavoro Luigi Gui. 35 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 36 n.19 / 2007 Parisi di un “mondo cattolico” (Parisi, 1979) disperso in politica. La delega alla D.C. non è pertanto il risultato di fattori puramente tradizionali, ma esprime buoni margini di consapevolezza e razionalità in quanto è il risultato di relazioni che vedono la società locale non semplicemente in condizioni di subalternità, ma di negoziato. Una conclusione può essere la seguente. Negli anni Cinquanta e Sessanta il fattore religioso incide sul piano spirituale e morale, sull’aggregazione e sull’identità sociale, ma anche sull’aspetto materiale e operativo dell’organizzazione, della rappresentanza e della soddisfazione della domanda sociale. Alla religione attingono, in forma mediata e talora in forma diretta, risorse consistenti la società locale, il sistema economico e quello politico. 5. Oltre l’appartenenza, fine della “Grande Ideologia”. Società, religione e politica negli anni Settanta 9 Per approfondimenti, rinvio a BRUNETTA GIUSEPPE e LONGO ANTONIO (1991). 36 Per ripercorrere le interazioni fra società, religione e politica lungo gli anni Settanta e Ottanta del Novecento, occorre raffrontare le connotazioni, le dinamiche e le condizioni di questa fase con quella degli anni Cinquanta e Sessanta per rilevare e analizzare gli aspetti di continuità e, soprattutto, di differenza e divergenza, per configurare i termini e i meccanismi che si pongono fra queste realtà sociali e come influenzano l’atteggiamento politico dei cattolici cittadellesi. Dalla metà degli anni Sessanta a buona parte degli anni Settanta del Novecento, a Cittadella si assiste, come del resto in tutt’Italia, a smobilitazioni massicce di gloriose associazioni cattoliche e ad una progressiva autonomia dell’azione politica, delle scelte di appartenenza di fede. Sono gli anni in cui si consuma, in forma quasi drammatica, l’esperienza delle ACLI, sconfessate dall’autorità ecclesiastica e obbligate all’autocritica anche a Padova (Marangon, 1998). L’Azione cattolica subisce un forte calo di iscritti e i rapporti tra la Democrazia Cristiana e la Chiesa non sono più diretti, ma tendono a divenire relazioni di autonomia relativa. Si può parlare di una crisi di autorevolezza nel “carisma d’ufficio”, che si trova a dover fare i conti con una pluralità di istanze, esperienze, sensibilità contraddittorie di preti e laici, di persone aggregate o di individui isolati. Il risultato di tutto ciò è il venir meno della pre-condizione sostanziale per il funzionamento del modello precedente: l’identificazione di società e cultura locale con il mondo cattolico, l’intreccio profondo fra l’ambiente sociale di Cittadella da un lato, la struttura organizzativa e la funzione pastorale della Chiesa dall’altro. In altre parole, quest’ultima e il mondo cattolico rappresentano sempre meno la società cittadellese, certo non la rappresentano più tutta. I caratteri e le motivazioni di questa sensibile ridefinizione si possono ricondurre a tre differenti versanti di mutamento. Il primo ci riporta al piano della cultura e dei comportamenti della società locale, dove si è verificato un lento processo di laicizzazione di indubbia entità (Brunetta-Longo, 1991)9; il declino dell’adesione alle pratiche e ai riti dell’osservanza religiosa ne costituisce solo la più appariscente, ma non la più importante, fra le manifestazioni. Se ancora nel periodo che dal 1951 al 1964 la partecipazione alla messa festiva conservava il suo carattere di fenomeno di massa, nel 1991 la percentuale è scesa notevolmente. Ma gli aspetti maggiormente qualificanti l’appartenenza religiosa spingono oltre questa lettura e ci propongono l’immagine, suggerita da Guizzardi, di un “cattolicesimo senza Chiesa” (Guizzardi, 1981), nel quale comportamenti extra-istituzionali, l’etica personale intesa come amore RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 37 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano per il prossimo e onestà, l’adesione ai riti e ai princìpi di base - il battesimo, l’esistenza di Dio - sopravanzano i riferimenti alla funzione ecclesiale: il credere alla Chiesa, ai suoi rappresentanti, frequentarne i luoghi istituzionali, ecc. Ridimensionata, se non assente, appare la funzione di “guida” della Chiesa nei problemi relativi alla politica, prefigurando una delimitazione di compiti, piani e responsabilità tra dimensione personale, sociale e politica da un lato e dimensione religiosa e formativa dall’altro. Mutamenti sensibili hanno caratterizzato anche l’orientamento e lo stesso modello organizzativo di Chiesa e mondo cattolico. Le opzioni espresse nel Concilio Vaticano II e in successivi documenti della gerarchia ecclesiale costituiscono premesse importanti per l’autonomia delle scelte dei cattolici nell’ambito politico e sociale (Marangon, 1998)10. Il secondo versante ci porta a indagare le tensioni interne ed esterne alla Chiesa - il “dissenso cattolico”, che sfocerà in una scelta riformista o di classe, invocando la fine del collateralismo, dell’unità politica dei cattolici e la liberalizzazione del voto - che hanno favorito sia il declino della base associativa e istituzionale ad essa connessa, che il sorgere e l’espandersi di esperienze esterne. Non si tratta di un semplice declino quantitativo, bensì della disgregazione dell’organica architettura istituzionale e del tessuto associativo. In ultima istanza, del venir meno dei nervi e dello scheletro del rapporto Chiesa-società, che lascia intravedere il declinare di un altro livello di identificazione tra piani: dopo quello fra mondo cattolico e società, quello fra mondo cattolico e Chiesa. Se l’ambiente sociale non si identifica più pienamente nel mondo cattolico, questo non si esaurisce più nell’ambito ecclesiale (Marangon, 1998)11. Un terzo versante di mutamento spiega come, a sgretolare l’universo coeso che l’interazione fra società locale e mondo cattolico aveva delineato, abbia concorso l’emergere di questioni, problemi e contraddizioni di carattere sociale e soprattutto economico non risolvibili né mediabili su un piano “interno” all’ambiente locale e alle sue strutture. In particolare l’”autunno caldo”, allorquando il movimento operaio comincia ad interrogarsi più a fondo sul suo futuro, constatando che il sistema capitalistico mortifica l’intelligenza dentro la più rigida e gerarchica divisione tayloristica del lavoro, in un quadro organizzativo nel quale la partecipazione è tenuta al minimo indispensabile per la coesione dei processi produttivi (Rullani-Romano, 1998)12. Questi tre versanti di mutamento ci portano ad affermare che il quadro di una società in relazione stretta con la religione e di una religione in connessione profonda con la Chiesa, fino alla quasi coincidenza fra i piani, subisce una ridefinizione sensibile a partire dagli anni Settanta. Se prima il sistema di comunicazione religione-Chiesa assicurava una identità fortemente affermata nel sociale, nel politico e nella cultura, dalla fine degli anni Sessanta questo referente si dissolve. Per dirla con il sociologo Enzo Pace, cadeva la “Grande Ideologia” (Pace, 1984), con inevitabili riflessi sulla politica. Dapprima con il costituirsi di liste civiche nelle varie tornate elettorali amministrative dal 1964 al 1995, poi con la perdita della maggioranza assoluta della D.C. alle elezioni regionali del 6 maggio 1990, scendendo per la prima volta nella sua storia al di sotto del 50% dei voti, evidenziando che il sistema politico sopravviveva non tanto sulla capacità propulsiva del partito democristiano, quanto piuttosto sul forte grado di frammentazione altrui. Alle politiche del 5 aprile 1992 la D.C. a Padova scende dal 47% al 34,5% dei suffragi. Ma il partito non si scuote, continuando la politica del giorno per giorno, rimanendo sempre più inefficaci 10 MARANGON VITTORIO (1998, parte II, 76). Era stato il Concilio Vaticano II ad affermare a chiare lettere l’autonomia, la laicità dell’agire politico e la legittimità del pluralismo all’interno dell’unica fede. 11 MARANGON VITTORIO (1998). Al X congresso delle ACLI (Roma, 3-6 novembre 1966), il presidente nazionale Livio Labor aveva rilevato come, nonostante l’apertura ai socialisti, i livelli di partecipazione fossero del tutto insufficienti. In sede congressuale, l’intervento di Mariano Rumor, allora segretario della D.C., fu fischiato: era l’inizio di un processo di distacco dalla D.C. che trovò la sua sanzione ufficiale con l’XI congresso. Le ACLI padovane, anche se strette tra Coldiretti e CISL, nella prima metà degli anni Sessanta avevano raggiunto una rilevante consistenza associativa contando nel 1963 su 172 circoli con 12.590 iscritti. Gestivano cinque Centri di formazione professionale a Padova, Cittadella, Piazzola sul Brenta, Conselve e Villa Estense. 12 RULLANI ENZO e ROMANO LUCA (1998). Nel secondo dopoguerra il taylorismo è parso superato per la maggiore qualificazione della manodopera, per la tendenza ad aumentare la flessibilità degli apparati produttivi di fronte all’instabilità dei mercati di acquisizione delle risorse e di sbocco dei prodotti, oltre che per l’esplodere di conflitti sociali. 37 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 38 n.19 / 2007 13 SCALCO LINO (2007) Numerosi i casi di crumiraggio nelle industrie cittadellesi: durante gli scioperi diversi lavoratori accettavano di sostituire gli scioperanti. A Galliera Veneta, gruppi di operai delle “Officine Pavan” scioperarono e manifestarono per le vie del paese a favore del padrone. 38 gli appelli dei vescovi all’unità. Infine, alle elezioni del 24 aprile e 7 maggio 1995 - si vota con la nuova legge maggioritaria a doppio turno -, quando i cedimenti diventano frana: i Comuni padovani che rinnovano i loro Consigli alla scadenza normale sono solo 78 su 105. L’immagine dello smarrimento è il segnale delle difficoltà a capire i cambiamenti in atto e ad accettarli. Non è la catechesi per adulti in forma di dialogo la risposta adeguata, né le prediche dal pulpito bastano a chiarire stati d’animo di incertezza o dubbi che tanti cittadini portano dentro il proprio spirito. La Chiesa dovrà accettare e riconoscere l’esistenza della differenziazione, del fatto che essa non riesce più a mediare posizioni sociali e culturali diverse: nel frattempo una parte di laicato appoggia le lotte sindacali, un’altra continua ad essere estranea ed indifferente, un’altra ancora le avversa in modo ostile (Scalco, 2007)13, ma c’è anche chi si ripiega su se stesso e pratica la “fuga dal mondo” attraverso l’esperienza mistica e via dicendo. Va da sé che questi vari pezzi rendono la società religiosa un soggetto altamente complesso. Pur tuttavia, la forte smobilitazione che si avverte, a Cittadella non crea fratture perché la presenza della rete organizzativa cattolica ha continuato e continua ad essere consistente. Gestisce o è presente in servizi importanti quali le scuole materne, la Casa di riposo, l’Ospedale Civile, l’Istituto Farina, l’Istituto Bertollo dando così significato alla sua presenza nel sociale. Ancora nel 1991 la Chiesa cittadellese è presente sul territorio comunale con sacerdoti diocesani, religiosi e religiose, con un rapporto tra una figura religiosa e abitanti più elevato di quello della media nazionale che è di 1 a 292 (Garelli, 1991). Certo, se confrontata con le caratteristiche e il significato che essa aveva assunto negli anni Cinquanta, questa rete organizzativa si è assotigliata per numero di uomini, si è ridimensionata per apporto di idee con il rischio di ridursi a mero movimento di strutture e servizi. Se da un lato ha consentito alla Chiesa locale di reggere all’ondata lunga di crisi, dall’altro l’ha messa in condizione di capire come ci si trovasse di fronte ad un insieme di opere, ad un certo capitale materiale e simbolico che però non riusciva più ad investire in termini reali, capaci cioè di suscitare interesse, consenso, attenzione, aggregazione. Da qui, due effetti di grande interesse per comprendere cosa stesse accadendo nella Chiesa cittadellese a partire dagli anni Settanta: la scoperta che le “opere” senza una profezia finiscono per inaridirsi, la presa d’atto di non essere più Chiesa “di tutti” e che la società si veniva progressivamente secolarizzando. Nelle parti più attente e critiche del clero e del laicato si comprende che occorre riscoprire la “profezia”, anche se questa può non far più comodo a chi crede ancora ad una visione irenica e organicistica della società propria degli anni Cinquanta. In altre parole, la riscoperta di un’attitudine pastorale e profetica che scarti ogni antica velleità di temporalismi più o meno recenti, che impone delle scelte ed una ricerca di nuovi modelli aggregativi. Ricerca difficile, questa, perché condotta in una società fortemente informata dal pluralismo e dalla differenziazione socio-culturale, in una situazione ecclesiale in cui la caduta dei modelli preesistenti lascia spazio a nuove forme di ridefinizione del rapporto Chiesa-mondo cattolico. L’identità cattolica che emerge da questo processo di differenziazione del campo religioso si presenta così: venuta a mancare la “Grande Ideologia”, il messaggio culturale cattolico resta scarnificato. Da un lato ciò consente di esplorare sempre di più la possibilità di dialogare con altre culture, dall’altro di tollerare all’interno della realtà ecclesiale una pluralità RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 39 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano di posizioni (Cuminetti, 1983). Differenziazione, fine dell’ideologia che si impone, annuncio, conversione da struttura che tutto risolve e spiega a flessibile, mobile confine capace di offrirsi a chi crede, a chi è impegnato comunque per una maggiore giustizia sociale: sono questi i caratteri peculiari del mutamento dell’identità cattolica nel corso degli anni Settanta in cui convivono due anime: l’una aperta al nuovo, l’altra integralista e preoccupata di riaffermare il modello identitario delle origini che si ritiene minacciato o perduto (Scalco, 2007)14. In questo contesto, la parrocchia si presenta come una mediazione fra gruppi che, se da una parte non paga più in termini di pieno consenso, dall’altra rende possibile la liberazione di energie vive del mondo cattolico, che permette di procedere più spediti verso una laicizzazione culturale e l’applicazione coerente con gli insegnamenti conciliari del principio del rispetto dell’autonomia della sfera profana. Un discorso a parte è quello che investe la crisi della D.C. e delle sue correnti in rapporto alla crescita economica, che cambia il rapporto della politica con l’economia a partire dal 1983, quando i processi di ridefinizione del rapporto tra società, istituzioni e politica divengono appariscenti e il voto penalizza pesantemente il baricentro del Veneto bianco. Si apre una stagione di instabilità, tanto ampia quanto costante, originata dalle stesse premesse che in precedenza avevano garantito la stabilità (Diamanti, 2004). 14 SCALCO LINO (2007). Esempi di comportamenti integralisti si sono visti massicciamente tra gli insegnanti, ostili al sindacato confederale, alle rivendicazioni, agli scioperi, alla nuova didattica e perfino all’antifascismo. 6. L’associazionismo cattolico cittadellese negli anni Ottanta 6.1 Una rete distesa su società e territorio Negli anni Ottanta, l’associazionismo cattolico cittadellese si presenta come una rete fitta, distesa su società e territorio, in continua evoluzione e difficile da definire perché molti fili e molti nodi sfuggono all’osservazione. Gran parte delle associazioni d’impronta giovanile sorgono alle soglie del decennio. Alcune, pur di piccole dimensioni, sono capaci di un’area estesa di contatti sociali, organizzate in singoli nuclei tendenzialmente autonomi. Si tratta di aspetti che rispecchiano modelli di azione e organizzazione specifici, di forme di aggregazione emergenti tra i giovani in questo periodo, che sono l’ambito di riferimento privilegiato in quanto soggetti e militanti, oppure utenti e destinatari. L’elevato grado di spessore sociale dell’associazionismo cattolico cittadellese, il cui radicamento nella società locale è dato dal fatto che le associazioni operano in direzioni e settori assai diversificati, esprimendo nei confronti della società e dell’universo giovanile un’offerta articolata per qualità e contenuto, segue questi indirizzi prevalenti: a) socio-assistenziale, radicato nella tradizione socio-culturale veneta e in connessione con l’organizzazione del mondo cattolico, che ha assunto modalità e significati nuovi; l’offerta associativa è rivolta ai bisogni primari delle fasce sociali più marginali, quali la terza e la quarta età, i disabili, l’accoglienza degli extracomunitari, ecc. b) culturale-ricreativo-sportivo; sono associazioni che producono beni culturali, o ne favoriscono e organizzano la diffusione in ambito sociale; si tratta di gruppi sportivi, musicali, corsi di studio, attività per il quartiere, seminari, ecc.; c) educativo-partecipativo; sono i gruppi che intendono promuovere interesse, formazione, mobilitazione nei confronti delle questioni che investono l’uomo, la società, l’ambiente; l’area è assai differenziata perché agiscono gruppi giovanili 39 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 40 n.19 / 2007 operanti all’interno di un partito, associazioni educativo-religiose, aggregazioni laiche che perseguono una formazione politica, come Polis 2000 a Camposampiero; d) solidale-relazionale; sono i gruppi cosiddetti “comunitari”; e) cooperazione internazionale, con le O.N.G. (Organizzazioni non governative). Questo associazionismo si pone nei confronti del contesto sociale in un rapporto che si può definire di “adattamento attivo” (Diamanti, 1989) alle domande e ai problemi che attraversano la realtà sociale, inserendosi all’interno delle contraddizioni emergenti. E non è raro scorgere, in questo tessuto associativo, esperienze che promuovono indirizzi e forme di intervento particolari in risposta a problemi di tipo socio-assistenziale; si tratta di servizi spesso di carattere primario ai quali non vi è alternativa, sia nel settore pubblico che in quello privato. Dietro a questo associazionismo non è difficile scorgere, in filigrana, l’incidenza della tradizione sociale e culturale cattolica veneta, vera risorsa territoriale piuttosto che generazionale. Certo, rispetto al passato le relazioni fra i soggetti appaiono profondamente cambiate, ma l’ambito ecclesiale rimane un riferimento importante, in quanto risorsa organizzativa, fonte di identità, luogo di comunicazione e di collegamento. Come tutti i fenomeni sociali, anche l’associazionismo religioso-ecclesiale di Cittadella nel corso degli anni Ottanta del Novecento ha subìto dei mutamenti, cogliere i quali significa dar conto e ragione delle dinamiche, delle linee di tendenza, dei tratti predominanti dei gruppi emergenti, del profilo socio-culturale dei loro appartenenti. Sono questi gruppi quelli che più sono stati interessati dai processi di mutamento e che hanno reagito con maggior consapevolezza al modificarsi delle situazioni, contestualmente alla permanenza-prevalenza di un orientamento tradizionalista. Già alla fine degli anni Settanta vi è una ripresa dei movimenti del laicato all’interno della Chiesa. Una crescita, se guardiamo i cosiddetti gruppi emergenti, che quantitativamente è sempre stata costante per tutti gli anni Ottanta, assumendo significati sociali sicuramente rilevanti, rappresentando nella città murata la prima realtà per capacità di coinvolgimento. Quanto ai suoi contenuti e alle sue forme, le caratteristiche del nuovo associazionismo sono sostanzialmente diverse da quello degli anni Cinquanta, solo se si considerano gli appartenenti rispetto alle classi di età, alla loro professione e provenienza territoriale: le associazioni religiose avvicinano una grande quantità di bambini dai 6 ai 10 anni e di ragazzi dagli 11 ai 18; una caduta riguarda la fascia dai 19 ai 30, con un’ulteriore diminuzione con l’età adulta. Inoltre, i componenti appartengono prevalentemente al ceto medio, o sono espressione di condizioni sociali avvantaggiate. Se confrontiamo questi dati con le caratteristiche che aveva la base sociale dell’associazionismo degli anni Cinquanta, constatiamo che la situazione è completamente capovolta. Mentre allora l’Azione cattolica era composta nella maggioranza da adulti provenienti quasi esclusivamente dal mondo rurale, negli anni Ottanta di contadini non vi è traccia e scarsa è pure la presenza della classe operaia; prevale il ceto medio con fasce d’età in maggioranza giovani. 6.2 Linee di tendenza dell’associazionismo cattolico Analizzate la consistenza e la composizione sociale dell’associazionismo religioso-ecclesiale degli anni Ottanta, occupiamoci ora, in estrema sintesi, delle linee di mutamento e di tendenza lungo le quali si è mosso per dar ragione degli 40 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 41 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano aspetti peculiari di un così significativo successo. In una prima tendenza, rispetto al passato, si scorge la presenza di una vasta articolazione di movimenti e associazioni religiose con identità ed esperienze distinte. Sono realtà con un elevato grado di autonomia e che, rispetto al passato, non sembrano trarre la loro legittimazione in base al semplice grado di prossimità ad un modello di religiosità ufficiale. Più semplicemente, l’associazionismo degli anni Ottanta si presenta differenziato e senza egemonie; rimane pur sempre l’assistenza religiosa del sacerdote (Diamanti, 1989). Nella seconda tendenza caratterizzante di questo periodo, si riscontra la ricerca di rapporti “significativi”, vale a dire adeguati ad avviare a soluzione le esigenze di identificazione sociale e religiosa dei soggetti. È un’istanza che non interessa in modo omogeneo tutte le realtà associative e che risulta più accentuata nei gruppi ecclesiali “emergenti”, quelli di più recente costituzione, in cui il ricambio generazionale e il processo di ridefinizione del modello associativo sono risultati più marcati. In una parola, sono le realtà associative più di altre chiamate a confrontarsi con le condizioni storiche e culturali contingenti, in cui sono forti le domande di appartenenza e di riferimento, che segnalano il diverso modo di interpretare l’adesione associativa a seconda dell’età media e della condizione di vita dei soggetti che compongono il gruppo. Una domanda di appartenenza, espressa soprattutto dai gruppi ecclesiali giovanili di A. C. e AGESCI, che indica l’esigenza dei membri di ritrovare all’interno delle realtà associative una risposta ai problemi di identificazione sociale, un luogo di ricomposizione delle tensioni a cui si è esposti nelle ordinarie dinamiche della vita. È la ricerca di ambienti rassicuranti, l’esigenza di rapporti e di esperienze significativi. Il gruppo viene così vissuto dai suoi membri come totalizzante e fortemente impegnativo, in grado di dare senso all’esperienza personale e sociale e di far maturare un’identità socio-religiosa. Al contrario, le proposte educative e religiose appariranno ai giovani eccessivamente distanti dalla loro sensibilità e insignificanti per la loro condizione di vita. In questa capacità di mediazione tra le esigenze della persona e l’impegno propositivo è individuabile uno dei fattori del successo aggregativo dei gruppi-movimenti religiosi giovanili. In termini più maturi e riflessivi - quando si ha a che fare con realtà associative emergenti costituite prevalentemente da adulti -, l’esigenza di appartenenza si compone, o lascia lo spazio ad una forte domanda di riferimento religioso prevalentemente rivolta al confronto e alla verifica dei valori e degli orientamenti che ispirano la realtà associativa. Il “gruppo di riferimento” si distingue dal “gruppo di appartenenza” per un minore potere di coinvolgimento della vita dei soggetti: l’adesione ad esso è centrata più su aspetti secondari che primari, più sulla condivisione di orientamenti e valori che sull’esigenza affettiva e relazionale. Tutto questo sembra esprimere la consapevolezza che il modo di vivere l’identità religiosa nel tempo presente si diversifica sensibilmente da quello di 30-40 anni orsono. La situazione dei gruppi emergenti giovanili degli anni Ottanta è sostanzialmente nuova: la loro è una generazione senza ricordi, senza una salda tradizione alle spalle; né il Concilio, né le tensioni sociali e politiche rappresentano punti di riferimento significativi di ridefinizione dell’identità socio-religiosa (Brunetta-Longo, 1991)15. Accostarsi ad una prospettiva di fede in un’epoca di crisi, di complessità e di differenziazione sociale comporta l’urgenza di ancorare questa dimensione 15 BRUNETTA GIUSEPPELONGO ANTONIO (1991). La ridefinizione dell’identità socio-religiosa non è cosa semplice proprio per la profonda articolazione interna del cattolicesimo italiano, per il suo polimorfismo, soprattutto dopo le rotture degli anni Settanta, dopo il cosiddetto “dissenso cattolico”, senza dimenticare le forme di neointegralismo. 41 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 42 n.19 / 2007 al bisogno di identità, alla necessità dell’appartenenza, alla consapevolezza della diversità: da un lato per rispondere alle esigenze dell’uomo contemporaneo, dall’altro per evitare che l’attuale clima di pluralismo culturale abbia a stemperare le specifiche identità. Una terza tendenza ritiene che il clero sia pervenuto alla convinzione che sia giunto il momento di collocarsi con il proprio specifico patrimonio cristiano dentro la storia, lasciando ad altri il dovere di cercare soluzioni adeguate a problemi politici che sappiano coniugare insieme valori cristiani e scelte pratiche concrete. In un contesto di modernità, ogni istituzione o gruppo sociale è impossibilitato a svolgere una funzione totalizzante nel sistema sociale, avviandosi sempre più ad operare scelte parziali che rispondono a specifiche competenze nel rispetto dell’intervento altrui. Questa riduzione dell’ambito di competenza, questa assunzione di scelte particolari appare necessaria soprattutto per le realtà che mirano ad essere propositive nell’attuale società e depositarie di un messaggio da riattualizzare nel tempo presente. Questa terza tendenza distintiva ha assunto diverse configurazioni, che possono essere considerate condizioni alla base della loro tenuta e del loro successo associativo. Una prima condizione è che i gruppi-movimenti religiosi siano in possesso di una identità religiosa originale, di una sensibilità religiosa specifica capace di informare una spiritualità e una visione del mondo particolari. In questo caso, il richiamo è “all’idea originaria” da cui è sorto il gruppo-movimento. L’identità di un gruppo è il condensato di una memoria storica che racchiude l’insieme delle scelte compiute dalla realtà associativa e da quanti hanno appartenuto ad essa nel tempo. Tanto più queste scelte sono state significative, tanto più l’identità del gruppo risulta forte e definita, adeguata ad essere riproposta al tempo presente. Un gruppo-movimento radicato su una identità specifica e fondante e che può contare su una ricca memoria storica, ha grandi possibilità di affermarsi positivamente nel tempo presente e di rappresentare un punto di riferimento nelle dinamiche contemporanee. Una seconda condizione è rappresentata dalla capacità di attualizzare l’identità originaria, per raccordare “l’idea fondante” alle condizioni di vita e al contesto socio-culturale in cui si vive. Infatti, molte realtà associative hanno chiuso con la storia perché non sono state in grado di reinterpretare in un’ottica particolare l’idea fondante, la memoria storica che le caratterizzava. È sempre presente il rischio che un patrimonio di proposte vada disperso per le difficoltà di renderlo significativo nelle condizioni sociali di un determinato periodo storico. La terza condizione di successo dei gruppi-movimento religiosi è data dalla necessità di operare in una particolare area sociale: ogni realtà associativa deve avere un proprio ambito culturale e sociale di riferimento, uno spazio in cui poter effettuare la propria proposta e precisare una specifica funzione. L’ultima condizione di successo è individuabile nella capacità di essere portatori nel tempo presente di una proposta associativa forte e controcorrente, capace di affermarsi in quanto è in grado di interpellare i possibili destinatari, di rappresentare un’adeguata istanza di richiamo in una situazione caratterizzata dall’eccedenza di proposte culturali. Questo implica che i gruppi-movimenti devono affinare la propria capacità propositiva, operando una sorta di semplificazione del messaggio di cui sono portatori, sottolineando il carattere controcorrente rispetto alla cultura prevalente 42 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 43 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano della proposta che li contraddistingue. L’obiettivo è preciso: dare evidenza sociale ad una proposta che rischia altrimenti di disperdersi tra i molteplici mercati di significato della società contemporanea (Brunetta-Longo, 1991). Ci sembra che il radicamento su una particolare idea religiosa, abbinata alla capacità di attualizzarla attraverso una forte propositività, sia individuabile nell’AGESCI, nella sua istanza educativa che viene riproposta in un periodo, dalla contestazione studentesca ad oggi, in cui risultano in crisi tutte le proposte educative. Ma anche nella Caritas, per il suo saper coniugare l’istanza religiosa con quella sociale ponendosi dalla parte degli “ultimi”; e nell’O.N.G., con l’idea che la Chiesa è chiamata ad autodissolversi nel mondo per fermentarlo dall’interno. Queste, in sintesi, le condizioni di successo dell’associazionismo cattolico in una società secolarizzata, che dipendono, oltre che dai princìpi ispiratori, dal fatto che esso ha operato e continua ad operare in uno spazio che registra un’assenza pressoché totale di iniziative pubbliche volte alla promozione di attività socializzanti e formative per i bambini e i ragazzi in età scolare. 6.3 Un modello d’identità religiosa da ridefinire Abbozziamo ora un modello che, ridefinendo l’identità religiosa negli anni Ottanta, rappresenti l’esito più recente del grande travaglio vissuto dal cattolicesimo cittadellese negli ultimi settanta anni e che ha visto sia la faticosa uscita dalla crisi che l’aveva colpito, che la ridefinizione di una nuova strategia di ricerca di consenso. Questo modello, che potremmo definire della “scelta religiosa”, si differenzia rispetto all’associazionismo del passato anzitutto per un diverso atteggiamento nei confronti della realtà complessiva e per una diversa interpretazione dei cattolici nella società (Brunelli, 1997). Il mondo non viene più considerato antagonista e concorrenziale alla Chiesa, né la Chiesa sembra considerare lo Stato e la società civile come spazi di possibile conquista, abbandonando l’idea di ridisegnare una situazione di cristianità tipica degli anni Cinquanta. Infatti, la Chiesa ha di fronte a sé una realtà secolarizzata, che però lascia trasparire anche una possibile funzione di rivalutazione della sua presenza sociale circostanziata, perché la realtà sociale nel suo complesso è attraversata da tensioni e problematiche che attendono risposta. Da qui la necessità ad un richiamo etico e religioso che i credenti e la Chiesa possono interpretare e nel contempo rivendicare quali testimoni di un orizzonte più ampio, aperto alla trascendenza, carico di appello ai valori. Ecco allora l’esigenza di tradurre in termini non confessionali, quindi condivisibili da tutti, la risposta agli interrogativi di fondo che il nostro tempo pone sul piano della razionalità, della cultura e della vita sociale e politica. Ma anche, per non correre il rischio di fermarsi alla sola dimensione etica, l’impegno di operare una scelta religiosa esplicita. Una implicazione immediata di questi mutamenti è riscontrabile nella differente logica insita nei rapporti fra società e politica, nel ridotto ruolo riconosciuto alla Chiesa e al mondo cattolico organizzato. Il declino dell’identificazione non significa tanto lacerazione del rapporto fra società e mondo cattolico, ma più semplicemente relativizzazione degli ambiti e delle sfere in cui si verificano organiche interazioni. Come hanno dimostrato Bagnasco e Trigilia nella loro ricerca sulle trasformazioni sociali, economiche e politiche delle aree ad economia diffusa nel Veneto (Bagnasco-Trigilia, 1983), gli stessi princìpi regolatori dell’esistenza individuale e collettiva degli individui attingono al fondamento della “coscienza per- 43 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 44 n.19 / 2007 16 Ricordo che il Partito Popolare Italiano era nato come partito non cattolico, aconfessionale, a forte contenuto democratico ispirandosi alle idealità cristiane. Don Luigi Sturzo aveva chiaro che il cattolicesimo è una religione e che il partito è sinonimo di politica, di divisione; STURZO LUIGI (1956). 44 sonale” e della “necessità familiare”, prima ancora che al fondamento delle “verità religiose”. Se questo vale anche per Cittadella, allora non sono più mondo cattolico e Chiesa a mediare, a orientare l’atteggiamento sociale rispetto al sistema politico, bensì motivi di valutazione e di necessità personale e familiare: ciò sottende che la relazione società-politica è divenuta diretta e quantomeno più intensa del passato. Più esplicitamente, non sono più il fattore religioso e la tutela del principio organizzativo, culturale e di identità della comunità locale a prefigurare e plasmare i comportamenti e gli atteggiamenti rispetto alla politica. La rete dell’associazionismo e la struttura della subcultura cattolica non assolvono più ai compiti della formazione e della trasmissione della domanda sociale. Il rapporto pare improntato, piuttosto, a più marcati presupposti di “scambio” concreto e di valutazione su scelte e programmi. In tal modo, il Comune, l’ente locale si pone al vertice delle preferenze tra le sedi pubbliche e istituzionali. I luoghi di formazione delle idee e di socializzazione alla politica, seppur sottratti all’ambito ecclesiale e al mondo cattolico, non si sono trasferiti in quello del sistema politico. Piuttosto, in analogia con il passato, si sono riproposti all’interno dei microcosmi privati, familiari e locali. Altri segni chiari di mutamento, coerenti con gli aspetti sin qui delineati, compaiono sul versante della delega e dell’identificazione con le articolazioni del sistema politico. L’atteggiamento di piena adesione al sistema e al suo “polo” privilegiato rappresentato dalla D.C., tipico degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, negli anni Ottanta è radicalmente rovesciato: in particolare, i giovani dimostrano di subire maggiormente il declino delle antiche appartenenze, delle antiche certezze manifestando disinteresse per l’attività politica e per i partiti, ricercando una soluzione dei problemi in chiave personale e privata (Diamanti, 1989), sia che si tratti della timidezza, dell’insicurezza, dell’ansietà, del senso di inferiorità, della solitudine. Di fronte ai problemi sociali si avverte uno stato di disagio, ma senza la capacità di vedere la necessità di una loro soluzione politica. Se ne possono trarre le seguenti considerazioni. Un ritorno dal politico al privato, l’assenza di casi clamorosi di contestazione o di rifiuto netto dell’ambiente in cui si è inseriti, quanto piuttosto il desiderio di vederlo animato da valori più autentici; un sintomo preoccupante che chiamiamo solitudine e che provoca il desiderio dei giovani di parlare con qualcuno con cui confrontarsi. La politica suscita indifferenza o avversione. Del resto, è difficile negare che i partiti abbiano avuto verso i giovani, qui come altrove, un interesse puramente strumentale, per carpirne i voti con promesse spesso non mantenute. Così come, dati alla mano, questo associazionismo cattolico è collocabile prevalentemente su un piano politicamente moderato. Tralasciando la vexata quaestio se la D.C. dovesse essere partito “dei” cattolici o “di” cattolici (Sturzo, 1956)16, essere cattolici costituiva sicuramente, per la delega alla D.C., una premessa necessaria, ma non sarà più sufficiente perché sono i contenuti ulteriori a fondare il consenso, sono le “cose” che concretamente e materialmente la D.C. riesce ad offrire che ne determinano la delega. E mentre la religione non vede più cumulati l’identità e gli aspetti strumentali e la Chiesa non costituisce più il riferimento negoziale per lo scambio di senso e consenso, di benefici e autorità, la società ed in essa anche il segmento cattolico si pongono in relazione diretta con il partito in situazione parimenti negoziale. La D.C., per contro, si è attrezzata a fronteggiare il progressivo distacco dalla RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 45 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano tutela della Chiesa sostituendo, all’erosione delle basi di identità religiosa, le risorse crescenti ad essa rese disponibili grazie al rapido accesso al governo centrale, regionale e alle amministrazioni locali. Da partito di identità religiosa essa è sempre di più diventata partito di interessi di gruppo; da partito sponsorizzato dalla Chiesa, la D.C. si è progressivamente trasformata in partito sponsorizzato dallo Stato (Diamanti, 1984). In questo modo, la leadership politica tende a mutare di sembianze, sostituendo alla lealtà socio-confessionale l’abilità imprenditoriale e la capacità di muoversi come imprenditore politico, canalizzando risorse dal centro verso la periferia e favorendo, a questo livello, il soddisfacimento degli interessi delle categorie più rilevanti. I canali e luoghi di reclutamento, pur mantenendo nella struttura del mondo cattolico radici profonde, attingono sempre di più ad altre sedi. Rispetto all’interazione fra società, mondo cattolico e politica, si può affermare che il fattore religioso non è più il collante culturale e organizzativo di un ambiente nel quale l’autorità della Chiesa è, anche, frutto delle funzioni e prestazioni da essa erogate e garantite all’ambiente sociale. E non è più il legame tra società e mondo cattolico a legittimare e sostenere il sistema politico imperniato sulla D.C. Così la Chiesa, indotta dalla progressiva secolarizzazione e complessità sociale, si ridefinisce attorno alla “scelta religiosa” (Diamanti, 1984)17. Il mondo cattolico, il sistema di istituzioni, le esperienze associative, i gruppi ben distesi negli anni Cinquanta attorno alla Chiesa non si presentano più come un “sistema”. L’associazionismo degli anni Ottanta si mostra differenziato e senza egemonie. Guardando al voto politico e amministrativo emergono altri due aspetti. In primo luogo, il pluralismo delle scelte fra i cattolici non determina una contromigrazione rispetto alla fase precedente, non assume orientamenti alternativi. In secondo luogo, l’associazionismo religioso degli anni Ottanta appare esprimere una cultura e una prassi di impegno sociale orientate a mutare le situazioni esistenti, a riequilibrare determinati rapporti sociali, ad operare a vantaggio delle molteplici condizioni di emarginazione presenti nel contesto sociale. Tutto questo sembra deporre per una denuncia dei rapporti prevalenti nel sistema sociale e per una concreta modifica delle condizioni date. Ciò nondimeno, i dati complessivi ci portano a dire che si tratta di un impegno di volontariato e solidarietà che, pur dando adito ad una domanda di cambiamento del sistema sociale, non prefigura almeno finora uno scollamento dei soggetti nei confronti degli equilibri politici dominanti. Dunque, soggetti moderati negli orientamenti politici e ideologici, ma progressisti nelle dinamiche di vita e nell’impegno quotidiano. La matrice culturale cattolica sembra predisporre i soggetti all’impegno e alla dedizione in molti settori della società civile, ma appare per certi versi refrattaria alla modifica degli equilibri politici esistenti. Le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992 hanno evidenziato un mondo cattolico in movimento, che denunciava una caduta di valori etici e morali nella politica e che faticava ad identificarsi con quella D.C., lasciando trasparire incertezza sul fatto che il comportamento dei cattolici, all’interno di queste mutate ragioni, si sarebbe orientato ancora, per il futuro, verso il partito dello scudo crociato (Diamanti, 2004). Un comportamento impensabile solo trent’anni prima, nella fase di consolidamento della subcultura cattolica, via via coinvolta in processi di cambiamento annunciati, per esempio, dai risultati del referendum abrogativo della legge sul divorzio Fortuna-Baslini del 12-13 maggio 1974 - ma a Cittadella, su 10.406 iscritti, i votanti sono 10.378 e l’altissima percentuale del sì (73%) è l’in- 17 “Scelta religiosa” che presenta due anime: l’uno nel solco della tradizione secolare del cattolicesimo, l’altra aperta alle istanze provenienti dalla società civile. 45 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 46 n.19 / 2007 18 Nel corso degli anni Settanta anche a Cittadella esisteva una Comunità cristiana di base, collegata con la Comunità dell’Isolotto di Firenze e altri centri studi. 19 Come nel Cittadellese, nel Bassanese, nella pedemontana. dice inconfutabile della non avvenuta secolarizzazione -, dalla laicizzazione delle basi dell’identità sociale con il progressivo declino delle pratiche religiose, dall’accresciuta mobilità del voto nel decennio 1970-1980, dall’estendersi di esperienze e aggregazioni esterne all’apparato e spesso in bilico fra ascesi e mistica (Scalco, 2007)18, dal crollo delle adesioni alla D.C. preceduto dalla crisi dell’identità religiosa del partito, dal complicarsi dell’impianto elettorale che evidenziava crescenti differenziazioni in corso nel rapporto territorio-società-politica, mettendo a nudo un’accelerata instabilità nelle aree a matrice urbano-terziaria e artigianale-industriale (Diamanti, 2004)19. È evidente che i mutamenti della struttura sociale hanno contribuito ad erodere le subculture politiche tradizionali, contraendo l’area dell’elettorato di appartenenza e declinando le forti identificazioni di partito. È così che si determinano fasce sempre più ampie di elettorato potenzialmente mobile, più indipendente dal partito, che condizionano la propria adesione non tanto all’identità, quanto alla tutela di un proprio interesse (Trigilia, 1986), aumentando così la potenziale instabilità delle turbolente arene elettorali. Certamente il partito professionale-elettorale crea anche un vuoto di identità collettive. L’elettore diventa sì più indipendente, più autonomo, ma anche inevitabilmente più solo e disorientato. Il microcosmo cittadellese ne è una chiara dimostrazione. 7. I fattori del mutamento del modello identitario: verso la secolarizzazione 20 46 Valga per tutti il curricu- Riassumiamo ora le indicazioni emerse evidenziando le caratteristiche salienti. Si è spiegato come il processo di stabilizzazione e consolidamento dell’egemonia D.C. sul sistema politico locale si rifacesse all’intreccio profondo che a Cittadella si era articolato fra economia, società e cultura. Questa singolare “congruenza di piani” (Bagnasco-Pini, 1981) era possibile ed era sostenuta grazie alle risorse di integrazione e consenso fornite da una forte e condivisa identità e da una rete associativa e istituzionale capillare. Così si era delineata quella subcultura territoriale (Trigilia, 1981) che tanta parte ha avuto nel determinare coesione e stabilizzazione sociale e politica. Rispetto alla definizione del modello identitario, anni cruciali sono stati quelli compresi tra l’ultimo decennio dell’Ottocento e il primo del Novecento. Si è evidenziato quanto importante sia stato il rapporto tra struttura di classe e particolari risorse di identità per dare un volto alla subcultura territoriale cattolica nel Cittadellese, dove la struttura di classe non polarizzata era centrata su lavoratori agricoli di tipo prevalentemente autonomo - mezzadri, piccoli affittuari - per i quali la famiglia conservava una funzione produttiva importante. In questo contesto, la destabilizzazione dell’assetto sociale tradizionale, indotta dalla penetrazione del mercato e dalla crisi agraria di fine Ottocento, era maggiormente ammortizzata dalla struttura di classe agricola. Al tempo stesso, le risorse di identità e di organizzazione fornivano un supporto essenziale per forme collettive di risposta ai problemi emergenti. Da questo punto di vista, la subcultura territoriale operava anche in direzione di una difesa della società locale dai mutamenti indotti dal mercato e dallo Stato nazionale, cercando di limitare la disgregazione sociale. Si veniva così a sedimentare uno specifico stile di mediazione degli interessi di tipo localistico, tale da caratterizzare le basi sociali e il fondamento della delega. RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 47 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano Più precisamente, dalla politica ci si aspettava la difesa dell’ordine tradizionale e in particolare del ruolo della Chiesa in campo educativo-assistenziale-economico. La politica doveva garantire e sostenere l’autonomia della società civile, piuttosto che intervenire in essa per modificarla. Di fatto, era una delega politica fondata sull’identità cattolica, ma anche sulla capacità della subcultura di trovare localmente risposte concrete alle tensioni indotte dall’esterno. La dimensione “religiosa”, nella fase di affermazione dello sviluppo locale, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del nuovo secolo, come in quella tumultuosa e acuta della più recente ondata degli anni Cinquanta e Sessanta, non esprimeva semplicemente un’opzione di fede. Più estesamente, essa riassumeva le premesse e le linee dell’organizzazione sociale, i tratti più significativi del contesto culturale di appartenenza. In primo luogo, la Chiesa dimostrava la capacità di governare e di produrre un sistema culturale, più propriamente un “senso” imperniato nella vita quotidiana, fornendo agli individui e al contesto sociale, organizzato nel passato ancora attorno agli schemi della comunità rurale, una concezione del mondo e uno strato di significati che “(…) illuminano per l’individuo la routine della vita quotidiana ed infondono un senso alla mera fattualità delle crisi della vita. Sia la routine sia le crisi della vita individuale sono posti, grazie alle rappresentazioni religiose interiorizzate, in un contesto trascendente di significato e trovano una legittimazione nella logica del cosmo sacro” (Luckmann, 1969). Alla religione e alla Chiesa i soggetti ricorrevano per “situarsi” dentro la realtà, per regolare le proprie scelte, per rapportarsi con gli altri, per ricondurre le proprie azioni e gli eventi ad un complesso di “fini ultimi”. Morale individuale, etica sociale, dimensione teologica erano domande soddisfatte dalla Chiesa e la religione costituiva, allora, una discriminante cruciale nelle scelte della popolazione perché cruciale era il ruolo da essa svolto per la società locale. Una ragione ulteriore per cui la Chiesa era ritenuta una dimensione decisiva nelle scelte della popolazione risiedeva nel fatto che l’interazione fra essa e la società non aveva solo, come posta, benefici simbolici e d’identità, ma anche risorse organizzative e beni materiali. Pertanto, oltre al “senso” entravano in gioco l’assistenza sociale, il sostegno economico, l’organizzazione territoriale: tutti beni di cui la Chiesa alimentava e regolava il circuito. In tale contesto, negli anni Cinquanta l’alternativa fra D.C. e altre formazioni politiche sembrava porsi tra questo o un altro modello di sviluppo, con una ripercussione assai rilevante sia sotto il profilo della delega e del consenso, che del modello di partito che ne conseguiva (Diamanti-Riccamboni, 1992). Sotto il profilo della delega, si delineava un rapporto con la politica all’insegna della stabilità e della appartenenza, ottenendo la D.C. un consenso esteso, ma in una proiezione difensiva e riflessa. Se il grado di legittimazione che connotava la delega della società locale nei confronti della D.C. appariva elevatissimo, altrettanto elevato appariva il suo fondamento nella matrice religiosa. In altre parole, alla D.C. veniva attribuita la delega in quanto riconosciuta strumento di difesa e di tutela dell’identità e dell’organizzazione ecclesiale, in quanto garante dell’offerta di prestazioni di segno non meramente normativo, ma anche organizzativo e concreto garantita dalla Chiesa. Ciò si collega bene al modello interpretativo delinato da S. Rokkan (Rokkan, 1982), per il quale comportamenti elettorali e sistemi di partito originano in Occidente da alcune fratture profonde che hanno segnato l’era moderna: la frat- 47 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 48 n.19 / 2007 lum di Gavino Sabadin, per il quale rinvio a SCALCO LINO (2001). 21 48 BACCARIN CLAUDIO tura “territoriale” fra centro e periferia, fra le tendenze centralizzanti dello Stato nazionale e le resistenze delle realtà periferiche; la frattura religiosa fra Stato e Chiesa; la frattura fra città e campagna; la frattura di classe. A Cittadella sono le prime tre a rivelarsi particolarmente cruciali, mentre il conflitto di classe ha trovato molteplici forme di mediazione e compensazione a livello sociale, senza riprodursi appieno in termini partitico-elettorali. In particolare, è stata la frattura religiosa a manifestare un’importanza prioritaria, proprio perché capace di riassumere le altre, quella territoriale anzitutto. In quest’ottica, la D.C. veniva concepita come garanzia e parte del sistema locale, del complesso di relazioni, strutture e valori sul quale esso si reggeva. Di conseguenza, il voto era un modo per accoglierne la logica, oppure per opporsi ad esso, optando per una diversa identità e per un diverso modello socio-culturale di riferimento (Diamanti-Riccamboni, 1992). In sintesi, sembra plausibile ricondurre l’orientamento e la stabilità del comportamento elettorale all’esistenza di una radicata subcultura politica territoriale: tradizione politico-culturale diffusa e organizzata, territorialmente radicata e, in qualche misura, dotata di autonomia e distacco rispetto allo Stato. La scelta del voto in questo contesto esprimeva appartenenza, era il riflesso di una fedeltà preesistente, di un’identificazione comunitaria. Nel corso di questa ricerca si sono individuati una filigrana culturale, un sistema di valori e di opzioni cumulato e coagulato dalla dimensione religiosa, ma ad essa in parte preesistente, che non si dissolve, né muta di segno al venir meno della risorsa religione. Il filo della continuità che ha percorso la cultura politica a Cittadella, anche in tempi successivi, promuovendo e stabilizzando il consenso alla D.C., sembra proprio questa “filigrana bianca”, questa subcultura territoriale intrisa in primo luogo di fiducia nel mercato e nella via individuale al benessere economico. In secondo luogo, di un moderatismo che, particolarmente timoroso di ogni elemento di emanazione socialista, è incoraggiato e sostenuto da convenienze reciproche con le tradizionali istituzioni politiche e religiose (Diamanti, 1986). Queste prerogative si sono riflettute e riversate sul modello organizzativo e sulla struttura sociale della D.C. che, nella fase di avvio, si caratterizzava come partito di identità cattolica, forza politica a bassa autonomia rispetto all’ambiente in quanto “sponsorizzata” dall’esterno dalla Chiesa locale, che con le sue articolazioni era la reale struttura organizzativa del partito, a conferma di una dipendenza dalle forze cattoliche non solo sul piano identitario, ma anche organizzativo. L’intervento diretto del clero e dei dirigenti delle organizzazioni cattoliche “prestati” al partito, o operanti come agenti elettorali, è stato l’indice di questo condizionamento, di questa dipendenza (Scalco, 2001)20. Nella fase iniziale, la D.C. si è strutturata come organizzazione eminentemente elettorale, dai fragili ed incerti confini con l’esterno e la Chiesa, oltre a legittimare il partito in via di costituzione, gli ha fornito le risorse organizzative fondamentali: la rete delle organizzazioni cattoliche e il personale politico da cui è emersa la classe dirigente democristiana. Negli anni Cinquanta e Sessanta, mentre si andava consolidando la subcultura cattolica, il partito democristiano ricerca una maggiore istituzionalizzazione e una maggiore autonomia dall’ambiente esterno. Ma le attese di partecipazione alla vita politica suscitate dagli ideali della Resistenza e dall’estensione del suffragio trovano poco spazio nel partito, anche se non improntato esclusivamente alla mobilitazione elettorale, in una struttura organizzata via via in modo perma- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 49 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano nente che dovrebbe divenire il tramite continuo tra elettori ed eletti. Ma il progetto di fare della D.C. un partito di massa riesce solo in parte. Negli anni Sessanta l’organizzazione si è sicuramente irrobustita, rispetto alla fase precedente le iscrizioni hanno conosciuto un forte incremento, ma corrisponde al modello di istituzione debole: la partecipazione diretta dei Comitati civici e del clero locale nelle campagne elettorali porta i leaders del partito ad avere uno scarso interesse a rafforzare l’organizzazione. Egemonia della D.C. e marginalità delle forze di destra e di sinistra hanno costituito le costanti di un aspetto, il voto, che rifletteva non solamente gli atteggiamenti e le culture della società, ma anche il profilo e la struttura del sistema politico nel quale il ruolo egemonico della D.C. e la debolezza degli altri partiti concorrevano a suggerire una sorta di “monopartitismo imperfetto” (Allum, 1976). Negli anni Settanta, annunciato dai risultati del referendum abrogativo della legge sul divorzio, a Cittadella si verifica un progressivo mutamento nelle dinamiche del quadro politico. È un orientamento il cui impatto sull’ambiente risulta meno violento e vistoso che altrove a causa del ben delineato assetto dei rapporti di forza del sistema politico, oltre che della capacità di decompressione e di filtro espressa dalla società locale. Queste trasformazioni maturano e iniziano a produrre i loro effetti nel decennio 1970-1980, mostrandosi in modo via via più evidente negli anni successivi e delineando uno scenario ben più articolato e complesso di quanto ci si attendeva, fluido e in continua ridefinizione (DiamantiRiccamboni, 1992). Il mutamento più significativo è avvenuto all’interno dello snodo cruciale tra sistema politico locale e ambiente sociale, ovvero nel fattore religioso che vedeva erosa la propria peculiarità di collante culturale e organizzativo del contesto sociale, determinando un progressivo prosciugamento del serbatoio di consenso e legittimazione cui attingevano lo sviluppo e il sistema politico stesso. La Chiesa e il mondo cattolico non rappresentano più la società locale, certamente non la rappresentano più tutta. E d’altra parte, il secondo non si esaurisce più in ambito ecclesiale. Questi processi riflettono altri importanti mutamenti che percorrono il contesto locale. Anzitutto la laicizzazione, di cui il declino dell’adesione alle pratiche religiose costituisce solo la più appariscente, ma certo non la più importante fra le manifestazioni. Il calo della base associativa e istituzionale della Chiesa, l’estendersi di esperienze e aggregazioni esterne all’apparato, come un certo “associazionismo invisibile” (Quaranta, 1982) spesso in bilico tra ascesi e mistica e gli orientamenti maturati all’interno della Chiesa stessa a partire dal Concilio Vaticano II, in direzione di una maggiore autonomia nelle scelte dei cattolici in ambito politico e sociale. Il complesso di queste trasformazioni e il loro impatto sul fattore religioso non potevano non determinare effetti di rilievo sulla politica. La relazione dell’ambiente sociale con la D.C., in primo luogo, appare meno pervasa di elementi di appartenenza e identità e maggiormente svolta sul piano dello scambio strumentale. Ciò che entra in crisi è l’identità religiosa del partito, che non è più condizione sufficiente nella delega alla D.C. in quanto viene attribuita importanza crescente agli aspetti concreti, legati all’interesse, ai problemi del tessuto economico-sociale: alle forze politiche si chiede di agire da sostegno allo sviluppo locale e viene “premiato” chi dà prova in tal senso (Baccarin, 2000)21. L’atteggiamento di concretezza e di assoggettamento della scelta e del comportamento politico a bisogni concreti da soddisfare si immette direttamen- (2000). Premiato, cioè votato, anche nei casi in cui il candidato è un esterno al collegio elettorale e come tale viene imposto dalla Direzione nazionale della DC, come è successo per Nicolò Lipari il 26 giugno 1983, alla IX legislatura. 49 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 50 n.19 / 2007 te in circolo, nel processo di partecipazione politica, in quello della delega. In questa situazione, che non vede più nel fattore religioso sintetizzati aspetti normativi e strumentali, che non vede più nella Chiesa il riferimento negoziale privilegiato, sono le “cose” che la D.C. concretamente riesce ad offrire che divengono determinanti per la delega. Più esplicitamente, il partito sostituisce all’erosione delle basi di identità religiosa le risorse crescenti di cui dispone trovandosi al governo del Paese e nelle amministrazioni locali. Il peso del fattore “territoriale”, di rilievo cruciale nel radicamento e nell’organizzazione della struttura ecclesiale, risulta determinante in questa per la legittimazione della D.C.. Proponendosi come partito di mediazione degli interessi territoriali, piuttosto che interprete di identità e fratture di valori, la D.C. ha alimentato il processo di laicizzazione della società in ambito politico e ha accentuato l’incidenza sociale di atteggiamenti verso la politica di tipo pragmatico e strumentale. Così, la leadership democristiana tendeva a mutare di profilo, sostituendo alla lealtà “socio-confessionale” l’abilità imprenditoriale, la capacità di muoversi e agire come “imprenditore politico” (Baccarin, 2000), tutelando e garantendo gli interessi dell’area e delle categorie più rilevanti nei confronti del “centro”, Stato o Regione Veneto che fosse. Uno sguardo agli indicatori di segno organizzativo conferma l’immagine di un processo che ha visto la D.C. svincolarsi dalla struttura ecclesiale, ma senza condurla alla sua completa autonomia dall’ambiente, alla sua definizione di partito a istituzionalizzazione forte, “macchina amministrativa” che nel corso del tempo si è progressivamente plasmato in funzione di sostegno e gestione dell’attività del governo locale. Comportamento elettorale, atteggiamento sociale, sistema politico, caratteri socio-organizzativi della D.C. forniscono pertanto un disegno tutt’altro che stabile e definito: gli elementi di fluidità e complessità prevalgono nettamente su quelli di linearità e consolidamento e un nuovo modello, diverso da quello che aveva presieduto al sorgere dei partiti di massa, orienta la trasformazione dei partiti. In questo nuovo contesto, ai partiti conviene formulare domande il più possibile generiche nei loro programmi e trasmettere ogni domanda particolaristica all’attività quotidiana, intensificando i contatti con i gruppi di interesse e competendo gli uni contro gli altri per una clientela potenzialmente comune, diventando “partiti prendi-tutto”. Sul finire degli anni Settanta, si può ritenere che le componenti della popolazione che si pongono in modo disincantato di fronte ai partiti, scegliendo e votando su basi pragmatiche o, comunque, razionali piuttosto che di identificazione, siano consistenti e in progressivo aumento, anche se gli esiti di questa tendenza non sono chiaramente percettibili in quanto, pur con motivazioni diverse, gli elettori continuano nella gran parte a votare come prima. Tuttavia, se il “monopartitismo imperfetto” della fase precedente ancora non sembra superato, è certo che dalla metà degli anni Ottanta le basi su cui si fonda risultano di natura diversa e senza dubbio meno stabile del passato. Lungo quel decennio profondi mutamenti si colgono in ambito ecclesiale. L’associazionismo cattolico si presenta come soggetto di rilevante spessore sociale, con una vasta rete di movimenti e associazioni che non traggono la loro legittimazione, come in passato, in base al grado di prossimità ad un modello di religiosità ufficiale, manifestandosi in modo differenziato, senza egemonie: un modello di identità che si definisce attorno alla “scelta religiosa”. Senza il cemento dell’identità religiosa, i temi della domanda politica si frammentano e si parti- 50 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 51 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano colarizzano, saldandosi con specifici orientamenti della delega. Le tradizionali fratture, anzitutto quella religiosa, non riescono più a sintetizzare le rivendicazioni vecchie e nuove che emergono in ambito sociale e queste, in sede elettorale, trovano sbocco in specifiche proposte politiche, fra cui in primis le leghe autonomiste e le liste ecologiste. Così la rappresentanza “territoriale”, in precedenza messa tra parentesi e subordinata ad altre dimensioni, diventa elemento specifico e autosufficiente. Le relazioni fra centro e periferia, i rapporti con lo Stato e le istituzioni si trasformano progressivamente in contrasto e frattura. La legittimità sociale dei partiti tradizionali subisce un rapido degrado che si manifesta anche nel crescente numero di consenso verso formazioni politiche al di fuori del continuum destra e sinistra e che hanno allargato l’area di quello che viene definito “voto difforme” (Caciagli-Spreafico, 1990). Anche nel nostro sistema, negli ultimi anni, lo spazio politico ha preso a trasformarsi in multidimensionale: alla distinzione sinistra-destra si è aggiunta la distinzione establishmentantiestablishment, che separa le classi dirigenti dei partiti tradizionali da settori sempre più consistenti di cittadini. In essa hanno affondato le loro radici comportamenti di voto anticonvenzionali, che presentano i segni evidenti delle tensioni che una realtà in rapida trasformazione e densa di contraddizioni scarica sui partiti tradizionali accusati di scarsa democraticità, di pratiche spartitorie, di poco senso di responsabilità, di spreco delle risorse pubbliche ad ogni livello, di incapacità di rappresentare le domande della società civile. Per tutte queste ragioni, è possibile sostenere che a Cittadella la D.C. già alla fine degli anni Settanta fosse profondamente minata alla sua base e logorata nelle stesse premesse che ne avevano fondato l’affermazione e il consolidamento. In quest’ottica, le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992 costituiscono non tanto una svolta, quanto piuttosto un risultato ampiamente annunciato, l’ulteriore segno di una trasformazione profonda iniziata molto tempo prima. Per la prima volta nella storia politica cittadellese si assiste a un declino vistoso dello scudo crociato, sceso al di sotto del 50% dei voti, con il concomitante decollo delle Leghe, principale espressione del voto “esterno” al sistema partitico tradizionale: sono fenomeni, questi, emersi da oltre un decennio e con radici ancor più profonde perché, dal 1983, avevano dimostrato consistenza crescente, assumendo per l’occasione proporzioni appariscenti in un’area “bianca” (Diamanti, 2004). Tuttavia, le novità insorte potrebbero suggerire che non di “despecificazione” in assoluto si debba parlare, ma piuttosto di perdita della specificità tradizionale identificabile con il colore bianco, che fino al 1987 ha segnato il fondale politico di Cittadella. Il risultato del 5-6 aprile 1992 lascia intuire che a quella tradizionale stava subentrando una nuova specificità, riconducibile al voto difforme e in particolar modo alla componente autonomista, che nel richiamo al territorio e al conflitto con le istituzioni centrali e con i partiti ha la propria matrice. È emblematico, a questo riguardo, che il successo del voto autonomista ripercorra nel Veneto le medesime tracce del voto bianco (Diamanti-Riccamboni, 1992). Il che ci induce ad un interrogativo: se a Cittadella la crisi del consenso alla D.C. significhi la fine dello specifico territoriale, oppure una sua ridefinizione in forme nuove. Queste mutate condizioni hanno inciso anche sul modello organizzativo della D.C., che particolarmente nell’ultimo decennio aveva visto affermarsi il modello di partito professionale-elettorale. E mentre le preferenze raccolte dallo scudo crociato alle scadenze elettorali erano in costante calo, le 51 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 52 n.19 / 2007 tessere di iscrizione al partito al contrario erano in continua crescita. Le ragioni? Il rafforzamento delle correnti e il conseguente acuirsi delle tensioni soprattutto in prossimità delle scadenze elettorali interne ed esterne. Non vi è dubbio che i mutamenti della struttura sociale hanno contribuito ad erodere le subculture politiche tradizionali, contraendo l’area dell’elettorato di appartenenza e declinando le forti identificazioni di partito. È così che si determinano fasce sempre più ampie di elettorato potenzialmente mobile, più indipendente dal partito, che condizionano la propria adesione non tanto all’identità, quanto alla tutela di un proprio interesse, aumentando la potenziale instabilità delle arene elettorali. Scrive Angelo Panebianco: “(…) L’affermazione del partito professionale-elettorale crea infatti più problemi di quanti non ne risolva. Esso è certamente il prodotto della modernizzazione, dell’aumento dei livelli di istruzione, del forte miglioramento delle condizioni di vita di interi gruppi e classi in precedenza socialmente e politicamente penalizzati. Però il partito professionale-elettorale crea un vuoto di identità collettive. L’elettore diventa più indipendente, più autonomo, ma anche inevitabilmente più solo e disorientato (…)” (Panebianco, 1982). Con particolare riferimento alla D.C., tra gli esiti di sviluppo più verosimili non sembra esservi stato un ritorno di fiamma ideologico, né un tentativo del partito a tornare a svolgere la tradizionale funzione espressiva mediante un recupero di identità antiche. In altre parole, non vi è stato alcun tentativo di innovazione politica all’interno del partito capace di reagire alle sfide ambientali. Dunque, nessuna rivalutazione delle ragioni territoriali, nessun avvicinamento alle fonti dell’identità democristiana, alla Chiesa e al mondo associativo religioso, che non era più quello degli anni Cinquanta. Può essere che il vecchio parroco sia stato sostituito dalla figura dell’imprenditore politico. Ma mentre il primo, oltre a produrre senso e identità, riusciva egregiamente a svolgere funzioni di imprenditoria politica, non è certo che il nuovo leader D.C. sia in grado di manovrare altrettanto bene le leve manageriali e quelle dell’identità, cioè a legittimarsi per la quantità e la qualità dei valori e degli obiettivi espressi. L’altra possibilità sarebbe stata l’innovazione politica vera e propria, le cui forme e modalità erano imprevedibili nel 1992. Ma, si sa, l’innovazione difficilmente parte dall’interno di un sistema politico, raramente è espressa dalle organizzazioni già consolidate. Essa entra invece, per lo più, dall’esterno ed è condotta nel sistema da nuove organizzazioni, da nuovi imprenditori politici che entrano in concorrenza con le organizzazioni insediate. Certo è che il vuoto di identità collettive che il decadimento della funzione integrativo-espressiva dei partiti ha contribuito a creare, ha aperto il campo a formazioni e movimenti politici le cui caratteristiche sono ancora oggetto di analisi per ora ci appaiono con poche analogie con le organizzazioni storiche -, anche se sembra difficile ammettere che l’attuale sistema dei partiti possa ricevere da loro linfa vitale, mediante processi di adattamento-trasformazione suscitati da nuovi imprenditori politici (Lanaro, 1992; Diamanti, 1993; Cafagna, 1993). Bibliografia ALLUM PERCY, Anatomia di una Repubblica. Milano, 1976. ALLUM PERCY-ANDRIGHETTO T., Elezioni ed elettorato a Vicenza nel dopo- 52 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 53 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano guerra,in “Quaderni di sociologia”, n. 2-3-4, 1982. ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA. DELEGAZIONE DI CITTADELLA, Il Cittadellese nel Veneto: un’area di vitalità economica. Firenze, 1984. ASSOCIAZIONE VENETA DI STUDI REGIONALI, Sviluppo del Cittadellese. Atti del convegno di studi. Cittadella, Teatro Sociale, 16 gennaio 1971, in “Bollettino dell’Associazione veneta di studi regionali”, a. I, n. 5, maggio 1971. BACCARIN CLAUDIO, Che fine ha fatto la DC? La diaspora democristiana a Padova e in Veneto. Padova, Gregoriana, 2000. BAGNASCO ARNALDO-PINI R., Sviluppo economico e trasformazioni sociopolitiche dei sistemi territoriali ad economia diffusa. Economia e struttura sociale, in “Quaderni della Fondazione Feltrinelli”, 14, 1981. BAGNASCO ARNALDO-TRIGILIA CARLO, Società e politica nelle aree di piccola impresa. Il caso di Bassano. Venezia, Arsenale, 1983, p. 315. BARTOLINI S., Metodologia della ricerca storica politica, in PASQUINO GIANFRANCO (a cura di), Manuale di scienza della politica. Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 73-76. BRUNELLI GIANFRANCO, Nel sistema bipolare. Ricostruire il mondo cattolico, in Chiesa in Italia, Annale de “Il Regno”, 1997, pp. 151-156. BORGHI MARCO, 8 settembre 1943-29 aprile 1945, in SCALCO LINO (a cura di), Storia di Cittadella. Tempi, spazi, gerarchie sociali, istituzioni, cit., pp. 868-869. BRUNETTA GIUSEPPE-LONGO ANTONIO (a cura di), Italia cattolica. Fede e pratica religiosa negli anni Novanta. Firenze, Vallecchi, 1991. CACIAGLI M., Approssimazione alle culture politiche locali. Problemi di analisi ed esperienze di ricerca, in “Il Politico”, n. 2, 1988, pp. 269-292. CACIAGLI M.-SPREAFICO A., Vent’anni di elezioni in Italia: 1968-1987. Padova, Liviana, 1990. CAFAGNA LUCIANO, La grande slavina. L’Italia verso la crisi della democrazia. Venezia, Marsilio, 1993. CECCATO EGIDIO, Resistenza e normalizzazione nell’Alta padovana (19431948). Il caso Verzotto, le stragi naziste, epurazione ed amnistie, la crociata anticomunista. Padova, Centro studi Ettore Luccini, 1999. COLLINS RANDALL-MAKOWSKY MICHAEL, La scoperta del mondo comune: Thomas Park e la Scuola di Chicago, in Storia delle teorie sociologiche. Bologna, Zanichelli, 1980. CUMINETTI MARIO, Il dissenso cattolico in Italia. Milano, Rizzoli, 1983. DAL LAGO PAOLA, Verso il regime totalitario: il plebiscito fascista del 1929. Padova, Cleup, 1999. DIAMANTI ILVO, Associazioni giovani e istituzioni locali. Indagine sull’area padovana. Milano, Angeli, 1989, p. 17. DIAMANTI ILVO, Elezioni e partiti nel secondo dopoguerra, in FUMIAN CARLOVENTURA ANGELO (a cura di), Storia del Veneto. 2, Dal Seicento a oggi. RomaBari, Laterza, 2004, pp. 205-208. DIAMANTI ILVO, La filigrana bianca della comunità. Senso comune, consenso politico, appartenenza religiosa nel Veneto degli anni ’50, in “Venetica”, n. 6, 1986, pp. 55-81. DIAMANTI ILVO, Società, religione e politica nel Veneto del secondo dopoguerra, in FONDAZIONE CORAZZIN, “Quaderni”, 4, 1984, Cattolici e movimento operaio nel Veneto, pp. 53-72. 53 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 54 n.19 / 2007 DIAMANTI ILVO, La Lega. Geografia, storia e sociologia di un nuovo soggetto politico. Roma, Donzelli, 1993. DIAMANTI ILVO-RICCAMBONI GIANNI, La parabola del voto bianco. Elezioni e società in Veneto (1946-1992). Vicenza, Neri Pozza, 1992. GARELLI F., Religione e Chiesa in Italia. Bologna, Il Mulino, 1991, p. 160. GUIZZARDI GUSTAVO, Potere ideologico, organizzazioni e classi sociali, in ISNENGHI MARIO-LANARO SILVIO (a cura di), La Democrazia Cristiana dal fascismo al 18 aprile. Venezia, Marsilio, 1978, pp. 345-405. GUIZZARDI GUSTAVO, Verso una religione senza Chiesa? Qualche dato da una ricerca nel Veneto, in GUIZZARDI GUSTAVO-STERPI S., La società italiana. Crisi di un sistema. Milano, Angeli, 1981. ISNENGHI MARIO, Stampa di parrocchi nel Veneto. Padova, Marsilio, 1973. LANARO SILVIO, Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta. Venezia, Marsilio, 1992. LAZZARINI ANTONIO, Vita sociale e religiosa nel padovano agli inizi del Novecento. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura-Istituto per le ricerche di storia sociale e di storia religiosa, 1978. LUCKMANN T., La religione invisibile. Bologna, Il Mulino, 1969. MARANGON VITTORIO, Il movimento cattolico padovano, parte II (19461995). Padova, Centro studi Ettore Luccini, 1998, pp. 73-78. PACE ENZO, Associazioni cattoliche e mondo del lavoro nel Veneto. Ipotesi di ricerca sulla dinamica dell’ultimo ventennio, in FONDAZIONE CORAZZIN, “Quaderni”, n. 4, 1984, Cattolici e movimento operaio nel Veneto, pp. 7-42. PANEBIANCO ANGELO, Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici. Bologna, Il Mulino, 1982, p. 499. PARISI ARTURO, I democristiani. Bologna. Il Mulino, 1979. QUARANTA GUIDO, L’associazionismo invisibile. Firenze, Sansoni, 1982. ROMANATO GIANPAOLO, Le origini e l’essenza della Democrazia Cristiana in un opuscolo di Gavino Sabadin del 1944, in SCALCO LINO (a cura di), Gavino Sabadin (1890-1980) nel Veneto del Novecento tra società, politica e amministrazione. Atti della giornata di studio. Padova, Cleup, 2001, pp. 95-104. ROKKAN S., Cittadini, elezioni, partiti. Bologna, Il Mulino, 1982. RULLANI ENZO-ROMANO LUCA (a cura di), Il postfordimso. Idee per il capitalismo prossimo venturo. Milano, Etas libri, 1998. SABADIN GAVINO, Essenza e programma della Democrazia Cristiana. Vicenza, Gualandi, 1944. SABADIN GAVINO, Memorie dalla nascita alla lotta per la libertà. Cittadella, 1968, inedito. SCALCO LINO, Volontari della libertà, I patrioti cittadellesi per l’indipendenza e l’unità nazionale (1848-1945). Cittadella, Biblioteca Cominiana, 2000, pp.139-204. SCALCO LINO, Gavino Sabadin (1890-1980) nel Veneto del Novecento tra società, politica e amministrazione, in SCALCO LINO (a cura di), Gavio Sabadin (1890-1980) nel Veneto del Novecento tra società, politica e amministrazione. Atti della giornata di studio. Padova, Cleup, 2001, pp. 197-221. SCALCO LINO, La rottura di un equilibrio di potere. Il risveglio sociale dei cattolici, in SCALCO LINO (a cura di), Storia di Cittadella. Tempi, spazi, gerarchie sociali, istituzioni. 2. Comune di Cittadella, 2007, pp. 673-692. SCALCO LINO, La ricostruzione tra moderatismo, ruralismo e industrializzazione diffusa, in SCALCO LINO (a cura di), Storia di Cittadella. Tempi, spazi, 54 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Lino Scalco 17-01-2008 9:03 Pagina 55 Il “sistema democristiano” nell’Alto padovano gerarchie sociali, istituzioni, 2. Comune di Cittadella, 2007, pp. 909-955. SCALCO LINO (a cura di), Tra liberazione e ricostruzione. Padova, 8 settembre 1943 - 2 giugno 1946. Padova, Editoriale Programma 1996. STURZO LUIGI, Il Partito Popolare Italiano, vol. I, 1919-1922. Bologna, Zanichelli, 1956. TRIGILIA CARLO, Grandi partiti, piccole imprese. Comunisti e democristiani nelle regioni ad economia diffusa. Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 47-48. TRIGILIA CARLO, Sviluppo economico e trasformazioni socio-politiche dei sistemi territoriali a economia diffusa. Le subculture politiche territoriali, in “Quaderni della Fondazione Feltrinelli”, 16, 1981. VEDOVATO GIUSEPPE, Il “sindacato nuovo” di Padova alla prova dell’antagonismo. Testimonianze, documenti e una chiave di lettura storica (19501985). Abbazia Pisani, Bertato, 1997. VENTURA ANGELO, Padova. Roma-Bari, Laterza, 1989. 55 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 n.19 / 2007 56 17-01-2008 9:03 Pagina 56 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 57 Elio Franzin Antonio Gramsci dal ribellismo sardista alla "Repubblica federale degli operai e dei contadini" Viaggiando tra le costellazioni del sapere Il 12 settembre 1923 Antonio Gramsci scrisse da Mosca una lettera al Comitato esecutivo del PCI, l’organismo di direzione del partito composto da cinque membri, in cui affrontò, come direttore designato dall’Internazionale comunista, la questione del personale giornalistico e della linea politica del nuovo quotidiano operaio di sinistra, aperto anche agli anarchici, ai repubblicani e ai sindacalisti, che, con il nome di “Unità”, stava per essere fondato. Nella lettera Gramsci scrisse che la parola d’ordine del governo operaio e contadino doveva essere adattata in Italia così: “Repubblica federale degli operai e dei contadini”. Nei mesi precedenti, come Gramsci stesso ha riferito in una sua lettera a Julia Schucht del 10 gennaio 1923, l’Internazionale comunista aveva deciso, in previsione dell’unificazione dei due partiti socialista e comunista poi non verificatasi, che Gramsci sarebbe diventato redattore dell’“Avanti” con Giacinto Menotti Serrati co-redattore. Ma poi Serrati si era rimangiato con un pretesto risibile la sua accettazione della decisione; la partenza di Gramsci per l’Italia fu rimandata (Gramsci, 1992, 105). La decisione successiva del Presidium dell’Internazionale comunista di fondare un nuovo giornale era stata comunicata sia al PCI che al consiglio direttivo dei socialisti detti “terzini”, favorevoli all’unificazione con il PCI con una lettera di Otto Kuusinen che portava la data del 5 settembre 1923 (Spriano, 1967, 297 n.). Nel settembre 1923 il ruolo ne “L’Unità” affidato a Gramsci rispetto a quello di Serrati è ormai radicalmente diverso; egli è stato nominato direttore del quotidiano che sta per uscire. In nessun altro suo scritto, dopo il settembre 1923, Gramsci ha indicato, con altrettanta chiarezza, l’obbiettivo politico della repubblica federale degli operai e dei contadini. È utile tentare di individuare le ragioni per le quali Gramsci soltanto nel settembre 1923 è giunto a tale formulazione, e per quali motivi successivamente essa è stata attenuata anche se riconfermata. È ovvio ricordare che Gramsci, prima dell’arresto (6 novembre 1926), è un dirigente di partito, un uomo politico, che subisce tutti i condizionamenti della situazione specifica in cui opera, sia quella politica nazionale sia quella interna del suo partito e dell’Internazionale comunista; egli non è un pensatore staccato dalla contingenza politica come, per certi aspetti, è diventato obbligatoriamente durante il periodo carcerario e la stesura dei Quaderni del carcere. La lettera del 12 settembre 1923 è divisa in due parti. Nella prima parte Gramsci ribadisce tutte le sue riserve nei confronti di Giacinto Menotti Serrati e di Fabrizio Maffi, esponenti dei socialisti massimalisti che avevano accettato la proposta della fusione dei due partiti socialista e comunista, o meglio di quella parte dei socialisti che si erano dichiarati favorevoli ad essa. Gramsci nella lettera regola severamente la collaborazione di Serrati al nuovo quotidiano e prevede perfino delle “polemiche di principio” contro “lo spirito socialista di Serrati, Maffi ecc.” in previsione della fusione dei due partiti, indicata dall’Internazionale comunista, che egli, almeno formalmente, in questo momento accetta dopo averla contrastata nei mesi precedenti. Non intendo affrontare, data la sua complessità, la 57 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 58 n.19 / 2007 ricostruzione dei rapporti fra Gramsci e Serrati, fra Gramsci e il socialismo massimalista. Gramsci ha espresso la sua valutazione più completa su Serrati nell’articolo scritto in occasione della sua morte avvenuta il 19 maggio 1926 nel quale ammise che forse i giovani dell’“Ordine nuovo” avevano oltrepassato la misura nei ripetuti e aspri attacchi al vecchio dirigente massimalista. E ne ha riconosciuto il ruolo e la grandezza soprattutto durante la prima guerra mondiale. Ben diverso era stato il suo giudizio sul ruolo di Serrati dopo la fine della prima guerra mondiale. Mi limito pertanto ad analizzare la seconda parte della lettera nella quale Gramsci motiva le ragioni della parola d’ordine della Repubblica federale degli operai e dei contadini come adattamento italiano dell’obiettivo indicato dall’Internazionale comunista, del governo operaio e contadino nel suo IV Congresso (Mosca, 5 novembre – 5 dicembre 1922). L’obiettivo del governo operaio e contadino, e non della dittatura del proletariato, alla quale Gramsci si riferisce nella lettera del 12 settembre, era stato lanciato a Mosca dall’Internazionale comunista su ispirazione di Lenin in una situazione internazionale caratterizzata dal riflusso rivoluzionario. Con tale parola d’ordine veniva lanciata la linea di collaborazione con la socialdemocrazia. Ma essa aveva trovato, fra l’altro, una netta opposizione da parte della maggioranza dei comunisti italiani diretti ancora da Amadeo Bordiga, il vero fondatore del PCI, ad eccezione di Angelo Tasca e Antonio Graziadei. Ancora nel giugno 1923 a Mosca, durante la riunione del Comitato esecutivo allargato dell’Internazionale comunista, Gramsci aveva espresso non soltanto tutta la sua ostilità nei confronti dei socialisti massimalisti e quindi alla fusione dei due partiti, ma anche alcuni suoi interrogativi, simili a delle riserve, sulla applicazione della tattica del fronte unico da parte dei partiti dell’Internazionale comunista. Gramsci appare sostanzialmente ancora allineato con Bordiga, benché nei mesi precedenti avesse espresso delle critiche nei confronti della sua linea politica e fosse già stata individuato da alcuni inviati dell’Internazionale comunista come un dirigente alternativo a Bordiga. (Gramsci, 1971, 449-457). Successivamente Gramsci ha dovuto più volte giustificare e motivare, su richiesta dei suoi compagni, 58 le posizioni sostanzialmente antifusioniste espresse durante l’Esecutivo allargato dell’Internazionale comunista del giugno 1923 (Togliatti, 1962, passim). Il 1923 fu un anno nero per il PCI che vide numerosi dei suoi dirigenti nazionali incarcerati in varie riprese. Ma Gramsci scrive la lettera del settembre tenendo conto soprattutto della situazione nella quale opera a Mosca, dove egli ha caratterizzato i suoi interventi con la ribadita volontà, diversamente da Amadeo Bordiga, di seguire la nuova strategia dell’Internazionale comunista. Gramsci ancora non pensa affatto di poter sostituire il prestigioso dirigente, il vero fondatore del PCI, ma certamente nella sua nuova qualità di direttore del nuovo quotidiano esprime una linea politica e strategica nuova, omogenea con quella enunciata dall’Internazionale comunista, a parte il suo atteggiamento nei confronti di Serrati e di Maffi. L’unità degli operai e dei contadini La proposta gramsciana del nome del nuovo giornale “L’Unità” non è casuale. L’11 novembre 1922, intervenendo al IV Congresso dell’internazionale comunista, Bucharin aveva affermato, fra l’altro, “Guardate la situazione italiana: tutto chiama, esige, l’unità e Bordiga non ne dice verbo” (Spriano, 1976, 248). L’unità alla quale Bucharin si riferisce, in polemica particolarmente con Bordiga, viene interpretata da Gramsci soprattutto come unità fra gli operai del Nord e i contadini del Sud; egli nega che la borghesia italiana sia stata capace di assolvere una funzione nazionale in modo unitario. Ma l’unità degli operai con i contadini era l’obiettivo che Gramsci aveva indicato, sull’esempio bolscevico. anche in uno dei primi articoli pubblicati su “L’Ordine nuovo” il 2 agosto 1919. Nel settembre 1923 egli afferma che per realizzare in Italia l’obiettivo del governo operaio e contadino è necessario individuare i caratteri specifici del rapporto fra gli operai e i contadini, che non è soltanto un rapporto fra classi sociali diverse, ma si pone come problema di un territorio, il Sud, “uno degli aspetti della questione nazionale”. Per questione nazionale Gramsci intende i problemi posti dalle modalità dell’unificazione statale della nazione. Non intendo ricostruire l’evoluzione del pensiero di Gramsci in materia di politica agraria, un aspetto importante della sua analisi della società italiana RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Elio Franzin 17-01-2008 9:03 Pagina 59 "Repubblica federale degli operai e dei contadini" e della sua critica al PSI ed anche al PCI di Bordiga, ma semplicemente constatare che nel settembre 1923 egli vede come cardine della rivoluzione e della opposizione al fascismo l’alleanza fra operai e contadini, che in Italia si configura “anche e specialmente come problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale”. Il 29 marzo 1923 Gramsci aveva già rivolto la sua attenzione all’autonomismo meridionale scrivendo: “Noi crediamo che anche in questa situazione avrà in Italia nuova vita la tendenza all’autonomia di intere regioni (Sardegna, Sicilia ed Italia Meridionale), che potrà offrire una base amplissima di lotta contro il fascismo e per la dissoluzione dello stato borghese” (Gramsci, 1992, 521). Nella lettera del 12 settembre 1923 Gramsci afferma che per realizzare in Italia l’obiettivo del governo operaio e contadino è necessario individuare il carattere nazionale specifico del rapporto fra gli operai e i contadini, il quale non è soltanto un rapporto fra classi sociali diverse, ma si pone anche come un problema di due territori, il Nord industriale e il Sud contadino, uno degli aspetti della questione nazionale prima malamente risolta dalla borghesia con un “centralismo bestiale” e poi gestita sfruttando ferocemente le isole e il Meridione mediante il protezionismo. Gli strati di sinistra dei popolari e dei democratici rappresentanti il Sud hanno sempre avuto nel loro programma, secondo Gramsci, gli obiettivi dell’autonomia locale e del decentramento. Gramsci è consapevole che vi possono essere degli usi reazionari degli autonomismi meridionali, ad esempio da parte dei proprietari terrieri siciliani, ma ritiene che l’accentramento politico degli operai e contadini nel PCI consenta di gestire la “decentralizzazione amministrativa e la sua colorizzazione locale”. Egli stabilisce quindi una netta distinzione fra il centralismo politico del PCI e il federalismo o il decentramento statale. Nei mesi successivi al settembre 1923 il contrasto fra Bordiga e l’Internazionale comunista diventò sempre più acuto e Gramsci, anche per rispondere alle iniziative di Bordiga, fu costretto ad affrontare il problema di una nuova linea politica e di un nuovo gruppo dirigente del PCI. Nell’ambito di questa difficile e complessa operazione politica e organizzativa Gramsci criticò non la scissione dal PSI operata dai comunisti a Livorno il 21 gennaio 1921, ma certamente le sue modalità, ossia “il distacco della maggioranza del proletariato italiano dalla Internazionale comunista”, e in esso vide “il più grande trionfo della reazione” (Togliatti, 1962, 102). Secondo Gramsci, il trionfo della reazione era dipeso anche dai comunisti che a Livorno non si erano mossi sulla base dei fatti italiani ed avevano presentato la scissione come una conseguenza necessaria del II Congresso dell’Internazionale comunista. Essi non avevano saputo spiegare il significato degli avvenimenti italiani del biennio 1919-1920, e successivamente non avevano saputo conquistare la maggioranza degli operai. In questa valutazione critica della scissione di Livorno era implicito un ridimensionamento politico radicale di coloro che erano stati i protagonisti della scissione di Livorno rispetto all’Internazionale comunista. Non a caso il loro dirigente riconosciuto era stato Bordiga. Dopo la lettera “federalista” del 12 settembre 1923 In tre lettere successive a quella del 12 settembre, il 10 gennaio, il 9 febbraio e il 1 marzo 1924, Gramsci ribadì il carattere territoriale dell’opposizione antifascista ma anche antistatale che si era delineata nel Meridione, senza che esso fosse stato riconosciuto dal PCI. Il carattere territoriale è una caratteristica dell’originalità italiana dei rapporti fra città e campagna che provoca la nascita dei partiti autonomisti meridionali. Il 10 gennaio 1924 Gramsci scrive in una lettera a Zino Zini: “Il Mezzogiorno è in fermento e tende a darsi una figura di opposizione nazionale territoriale, mettendo in grave pericolo l’unità” (Gramsci, 1992, 173). Uno dei temi costanti di Gramsci, fin dall’articolo “Tradizione monarchica” ( 14 marzo 1920) è stata la critica e la denuncia del tipo di unità nazionale raggiunta dalla monarchia. È evidente che Gramsci con la frase citata vuole sottolineare l’ampiezza del contrasto che è esploso nel Sud nei confronti del fascismo, e non esprime affatto una sua presunta preoccupazione a favore dello stato centralista anche se è consapevole del carattere regressivo della possibile divisione dell’Italia. (È molto difficile capire le ragioni dell’affermazione di Carla Petraccone sul carattere strumentale del federalismo in Gramsci testimoniato dalla sua 59 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 60 n.19 / 2007 preoccupazione unitarista (C. Petraccone, Federalismo e autonomia in Italia dall’Unità ad oggi, Bari 1995, 217-218)). Il 9 febbraio Gramsci, che finalmente espone la piattaforma politica sulla quale intende formare un nuovo gruppo dirigente del PCI, critica la dirigenza bordighista, la quale nei mesi precedenti alla marcia su Roma non ha saputo valutare la pericolosità del fenomeno fascista e “ora nuovamente non si tiene conto della emergente opposizione della borghesia industriale e specialmente di quella che si delinea nel Mezzogiorno con carattere più recisamente territoriale e quindi affacciando alcuni aspetti della questione nazionale”. Quali sono questi aspetti della questione nazionale? La rimessa in discussione del processo di unificazione egemonizzato dalla borghesia. Nella successiva lettera del 1 marzo 1924 Gramsci, dopo aver ribadito che ”la questione dei rapporti fra città e campagna si pone in Italia, per la questione meridionale, su una base territoriale netta, determinando la nascita dei partiti autonomisti o di partiti come la democrazia sociale di tipo originale”, propone lo “studio della possibilità di fare concessioni di carattere politico a queste popolazioni (le popolazioni agricole meridionali, ndr) con la formulazione di Repubblica federativa degli operai e dei contadini invece di governo operaio e contadino” (Togliatti, 1962, 199-200, 223, 225). Il termine concessione deriva chiaramente da qualcuno dei numerosi scritti di Lenin successivi alla adozione della politica della NEP (marzo 1921) in Russia, in cui insisteva sulla politica delle concessioni ai fini di potenziare l’alleanza fra gli operai e i contadini. In particolare Lenin afferma la necessità di concessioni alle nazionalità non russe nella seconda parte delle sue note su La questione delle nazionalità o dell’autonomia (30-31 dicembre 1922). Lo scritto fa parte di quelli dedicati da Lenin alla critica delle posizioni grandi-russe e antifederaliste di Stalin, ormai diventato un oppositore frontale, aperto, del federalismo di Lenin. Gramsci quindi corregge, sviluppa la formulazione canonica dell’Internazionale comunista relativa al governo operaio e contadino, che accetta senza riserve diversamente dagli altri dirigenti bordighisti o exbordighisti del suo partito ma anche del suo gruppo. 60 La Repubblica federale degli operai e dei contadini di Gramsci e i dirigenti del PCI Quali furono le reazioni del gruppo politico che egli stava formando a questa specifica formulazione? Se confrontiamo la motivazione e la formulazione gramsciana, espresse nella corrispondenza politica, relative alla repubblica federale con le Tesi di Lione, presentate al III congresso del partito (gennaio 1926), ispirate da Gramsci e scritte anche da Togliatti, constatiamo una notevole diversità. Contrariamente a quanto più volte affermato da Gramsci, nelle Tesi si afferma che i partiti democratici o regionali del Sud orientando le popolazioni “verso soluzioni democratiche regionali” spezzano l’unità del processo di liberazione delle popolazioni. Gramsci aveva scritto ben diversamente, che essi mettevano in discussione l’unità centralistica statale degli industriali e dei proprietari terrieri. Nelle Tesi di Lione appare la formulazione più categorica della funzione unificante della classe operaia: “Di fronte a questa eterogeneità il proletariato si presenta come l’unico elemento che per sua natura ha una funzione unificatrice e coordinatrice di tutta la società. Il suo programma di classe è il solo programma unitario, cioè il solo la cui attuazione non porta ad approfondire i contrasti tra i diversi elementi della economia e della società e non porta a spezzare la unità dello Stato.” Togliatti, ma anche la nuova maggioranza congressuale, non condivisero la posizione federalista di Gramsci. La stessa accettazione della parola d’ordine dell’Internazionale comunista del “governo operaio e contadino” nelle Tesi è condizionata dal rifiuto di riconoscere in esso “una fase reale dello sviluppo storico”; è soltanto una formula di agitazione. L’unico obiettivo rimane sempre e soltanto quello della dittatura del proletariato. Nella stesura delle Tesi di Lione, Togliatti è coerente con le posizioni espresse nel suo articolo “Irlande italiane”, apparso l’11 dicembre 1921 su “L’Ordine Nuovo”. In esso si sostiene che tutte le regioni italiane sono sottoposte all’oppressione statale e che il regionalismo è una demagogia dei partiti regionali identica a quella dei partiti dal fascista al socialdemocratico (Togliatti, 1967, 307-309). Manca qualsiasi percezione delle diversità fra Nord e Sud. La stessa riserva nei confronti dei partiti regionalisti è espressa da Ruggero Grieco, un RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Elio Franzin 17-01-2008 9:03 Pagina 61 "Repubblica federale degli operai e dei contadini" comunista che ha lavorato intensamente nel Meridione sotto la direzione di Gramsci. Grieco nelle sue “Tesi sul lavoro contadino nel Mezzogiorno” (agosto 1926) rifiuta le tesi regionalista e federativa della Concentrazione repubblicana contrapponendole l’obiettivo della terra ai contadini. (Grieco, 1966, 206-207). Nelle “Tesi “ di Grieco appare, per la prima volta in un documento del PCI, la nozione di “blocco rivoluzionario operaio-contadino”. Egli si è spostato decisamente su posizioni federaliste soltanto dopo il IV Congresso del PCI (aprile 1931) ed anche in conseguenza di ciò ha sviluppato i suoi rapporti con il federalista veneto Silvio Trentin (Verri, 2006, 95-120). Stabilita quindi la diversità della posizione dei più diretti collaboratori nei confronti del federalismo, rispetto a quella affermata più volte da Gramsci, si può cercare di individuare le matrici culturali e politiche del federalismo gramsciano. Esso è una conseguenza diretta della sua analisi del Mezzogiorno, la quale è il risultato di una esperienza personale (la Sardegna), di una lunga elaborazione ed anche di alcune iniziative politiche fra le quali quella verso il Partito d’azione sardo e in particolare verso Emilio Lussu. Gramsci entra nella vita politica sulla base di un forte sentimento di ribellione che ha la sua motivazione nelle condizioni dei contadini della Sardegna, come ha scritto in una lettera a Julka del 6 marzo 1924 (Gramsci, 1992, 271). Il suo sardismo radicale è di ispirazione contadina e si contrappone a quello retorico e piccolo borghese (Gramsci, 1965, 432). Gramsci ha ricordato la sua simpatia giovanile per i banditi sardi, la sua adesione alla parola d’ordine “i continentali al mare”. Il sardismo lo portò ad aderire il 28 settembre 1913 al Gruppo sardo della Lega antiprotezionista di Alfredo Defennu (Maiorca, 2007, p. 60). Qualche giorno dopo, il 9 ottobre, apparve la sua adesione al gruppo antiprotezionista sul numero 41 de “La Voce”. (Fiori,1966, p. 989). (Gramsci nel 1913 ha ormai 22 anni). La questione doganale era stata indicata da “La Voce” come problema centrale della vita politica nazionale già sul numero 1 del 2 gennaio 1913 in polemica con i nazionalisti. Nello stesso anno la rivista pubblica un lungo articolo a puntate di Enrico Ruta sulla questione meridionale che si richiama a Giustino Fortunato. Sul numero 18 dell’1 maggio 1913 compaiono la circolare del Comitato provvisorio costitutivo della Lega antiprotezionista e lo statuto. La Lega antiprotezionista nasce come associazione trasversale ai partiti. Oltre a “La Voce” appoggiano l’iniziativa la “Riforma sociale”, “L’Unità” di Gaetano Salvemini, l”Iniziativa”. Dal numero 28 del 10 luglio 1913 “La Voce” inizia la pubblicazione delle adesioni individuali alle varie sezioni locali e annuncia la pubblicazione dell’opuscolo sul protezionismo di Gino Borgata. Nei numeri successivi “La Voce” fa la pubblicità di un pacco di quattro libri antiprotezionisti che comprende: E. Giretti, I trivellatori della nazione, G. Borgata, Che cos’è e cosa costa il protezionismo in Italia. Manualetto antiprotezionista, l’opuscolo de “L’Unità” di Salvemini sul protezionismo, A. De Viti De Marco Il protezionismo e la questione meridionale. Gramsci nella prima fase (preleninista) del suo sardismo o meridionalismo individua nel protezionismo adottato nel 1887 da Francesco Crispi la causa più recente della crisi meridionale e si schiera con gli antiprotezionisti. Il pensatore di riferimento è soprattutto Gaetano Salvemini e gli altri sostenitori del liberismo (G. Vacca, 199, 125143). Ma apparentemente Gramsci ne ignora la battaglia federalista; Salvemini aveva pubblicato già nel luglio-agosto 1900 su “Critica sociale” il suo saggio su La questione meridionale e il federalismo. (Su Francesco Crispi rimane insuperato il saggio di Emilio Sereni “Il nodo della politica granaria” in Capitalismo e mercato nazionale, Roma 1966.) È sorprendente come in uno dei primi articoli su “Il Grido del popolo”, quello del 10 aprile 1916, siano presenti alcuni degli elementi fondamentali dell’interpretazione gramsciana dei rapporti fra Nord e Sud. Nell’articolo “Il Mezzogiorno e la guerra” Gramsci, in relazione ad un intervento di Arturo Labriola sulla politica economica del governo Calandra, attribuisce a Francesco Coletti “un economista serio e poco amante dei paradossi” la tesi delle conseguenze disastrose per il Mezzogiorno del regime accentratore imposto dall’unificazione. Coletti era autore di vari studi dedicati alla Sardegna. (Si tratta di un ricordo impreciso. Nell’articolo citato da Gramsci “Le zone del progresso e le zone della stazionarietà” (“Rivista italiana di sociologia”, sett.-ott. 1914) non c’è nessun riferimento specifico alla conseguenze dell’unificazione sul 61 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 62 n.19 / 2007 Mezzogiorno.) Il deputato interventista Arturo Labriola il 18 marzo 1916 intervenne alla Camera dei deputati nel dibattito sulla politica economica del governo illustrando un suo ordine del giorno, ed affermando che la guerra aveva provocato uno spostamento “territoriale” della ricchezza dal Sud verso le industrie metallurgiche, chimiche e tessili del Nord. (Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, sessione 1913-16, vol.IX,2584). Secondo Gramsci, Labriola fu l’unico a sollevare il problema. Territoriale è l’aggettivo usato da Labriola che Gramsci continuerà a ripetere nelle sue analisi dei contrasti fra Nord e Sud. Egli traccia anche una breve storia di lunga durata dei due tronconi della penisola, il Settentrione che ha ricevuto l’impulso “speciale” dai Comuni, e il Meridione dominato dalle monarchie che si sono succedute ed hanno impedito la formazione della borghesia. Anche Giustino Fortunato nel suo articolo “Le due Italie”, apparso sul numero monografico dedicato al Meridione de “La Voce” del marzo 1911, aveva sottolineato come l’autonomia del Municipio costituisse l’elemento fondamentale dell’omogeneità del Nord davanti al Sud sempre organizzato feudalmente. Anche nelle Tesi sul lavoro contadino di Grieco è presente il riferimento della lotta dei Comuni contro l’ordinamento feudale. (In linea con l’interpretazione del ruolo dei Comuni come fattore di differenziazione fra il Nord e il Sud si colloca R. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Milano 1993)). Con l’unificazione si è imposto un “accentramento bestiale”, afferma Gramsci, il quale chiede per il Mezzogiorno una nuova politica generale, esterna ed interna, dello stato italiano. La politica doganale protezionista nell’analisi gramsciana dei vari gruppi della classe dirigente italiana è l’elemento fondamentale della loro unificazione e del loro carattere anticontadino e antipopolare. Successivamente in un articolo apparso su “Il Grido del popolo” del 18 maggio 1918, egli aggrava le affermazioni contenute nell’articolo del 1916, definisce lo stato italiano “dispotico” e aggiunge che esiste in Italia “un regime burocratico centralista”. Gramsci è stato largamente influenzato dalla sua esperienza diretta di sardo, dalla propaganda sardista e dalla campagna antiprotezionista a favore del Meridione de “La Voce” e de “L’Unità”. 62 Nell’articolo “Uomini, idee, giornali e quattrini” (“Avanti”, ediz. Piemontese, 23 ottobre 1918) ha ricordato i vecchi pastori sardi che indicavano la distruzione subita dai pascoli e dai monti della Sardegna, venduti agli speculatori dagli agricoltori impoveriti dall’infame politica di Crispi documentata per la Sardegna dall’inchiesta di Francesco Pais-Serra. Anche in questo articolo analizza i vari gruppi della borghesia rispetto alla politica doganale da un punto di vista liberista. Il 12 gennaio 1918, in un articolo su “Il Grido del popolo” scritto contro i socialisti riformisti, Gramsci ricorda che Turati e Treves durante le elezioni del 1913 scrissero sulla “Critica sociale” due articoli a favore del protezionismo. La seconda fase del meridionalismo gramsciano è quella dell’antiprotezionismo liberista al quale si aggiunge l’obiettivo dell’unità degli operai del Nord e dei contadini del Sud. Il meridionalismo gramsciano è precedente alla sua adesione al leninismo. La sua rielaborazione critica è stata particolarmente intensa anche e sopratutto nel periodo successivo all’assassinio di Giacomo Matteotti, quando Gramsci ritenne che fosse possibile abbattere il fascismo anche con una insurrezione armata che partisse dal Sud. È inevitabile che durante il suo soggiorno a Mosca Gramsci abbia seguito con molta attenzione i lavori del I Congresso dei Soviet (30 dicembre 1922) e del XII Congresso del partito comunista russo nel corso del quale (23 aprile 1923) fu affermato il carattere federale dello stato sovietico ( Stalin, 1949, 197- 256). Ovviamente egli ignorò la durissima lotta che si era aperta fra Lenin e Stalin proprio su tale carattere dello stato sovietico, in particolare dopo che era esplosa la questione della Georgia nel gennaio 1923 (Lewin, 1967). Come abbiamo visto, il 1923 è l’anno di quella che possiamo definire la terza fase del meridionalismo di Gramsci, che aggiunge alla tesi dell’alleanza fra gli opera del Nord e i contadini del Sud la concessione della Repubblica federale. Nel marzo 1924 Pietro Sraffa espone a Gramsci la sua interpretazione molto riduttiva del ruolo del PCI nella lotta antifascista. E Gramsci pubblica la lettera nell’“Ordine nuovo”. Ma più importante della risposta è la sua lettera del 21 marzo ai dirigenti del suo gruppo in cui, sulla base della lettera di Sraffa, ammette che il PCI “non ha un programma immediato che si fondi sulle prospettive delle soluzioni RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Elio Franzin 17-01-2008 9:03 Pagina 63 "Repubblica federale degli operai e dei contadini" probabili che l’attuale situazione può avere”, e aggiunge: “Noi siamo per un governo operaio e contadino, ma cosa significa ciò concretamente in Italia?”. Nel giugno del 1924 Gramsci che sta operando la complessa e difficile sostituzione del gruppo dirigente e della linea politica bordighista; egli deve affrontare la drammatica situazione politica apertasi come conseguenza del delitto di Giacomo Matteotti. Deve decidere quali proposte e controproposte politiche e non soltanto propagandistiche rivolgere all’Aventino, quale atteggiamento assumere nei confronti del Parlamento. Con il discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925 e i provvedimenti successivi il fascismo da governo inizia la sua trasformazione in regime. L’alternativa al regime è l’insurrezione armata. Gli unici alleati del PCI sono il sindacalista agricolo, cattolico, Guido Miglioli ed Emilio Lussu del Partito sardo d’azione, come Gramsci rileva nella sua relazione al Comitato centrale del 6 febbraio 1925. L’assemblea repubblicana sulla base dei comitati operai e contadini Nel giugno 1925 il PCI propone ai partiti dei lavoratori, e quindi non a tutto l’Aventino, tre obbiettivi: l’Assemblea repubblicana sulla base dei comitati operai e contadini; il controllo operaio dell’industria; la terra ai contadini. Il federalismo è accantonato. La proposta federalista avrebbe ostacolato ulteriormente la collaborazione, che era già molto difficile, fra il PCI e gli altri partiti antifascisti fra i quali era diffuso l’orientamento mazziniano e unitarista. Nel settembre 1925 si svolge a Macomer il congresso del Partito sardo d’azione. I dirigenti dell’associazione di massa dei contadini (Giuseppe Di Vittorio, Guido Miglioli, Ruggero Grieco) rivolgono un appello in cui si indica il modello federale dell’URSS e si inneggia alla Repubblica sarda degli operai e dei contadini nella Federazione soviettista italiana! Dunque, dato l’orientamento del Partito sardo d’azione, si ritiene di poter indicare ai sardi l’obiettivo del federalismo. Nell’intervento al Comitato centrale del novembre dello stesso anno Gramsci nega che sia possibile la formazione di un Partito di azione meridionale. Nel Meridione si manifesta invece un “migliorismo” meridionale come possibile alleato contro il fascismo; in pratica un movimento dei contadini per la conquista della terra. Nel gennaio 1926 le Tesi di Lione confermano la parola d’ordine dell’Assemblea repubblicana sulla base dei comitati operai e contadini. Il 15 febbraio 1926 nel suo bilancio di Cinque anni di vita del partito, Gramsci scrive: “Nel quadro della società nazionale questi rapporti sono aggravati e radicalizzati dal fatto che economicamente e politicamente tutta la zona meridionale e delle isole funziona come una immensa campagna di fronte all’Italia del Nord, che funziona come una immensa città. Una tale situazione determina nell’Italia meridionale il formarsi e lo svilupparsi di determinati aspetti di una questione nazionale, se pure immediatamente essi non assumano una forma esplicita di tale questione nel suo complesso, ma solo di una vivacissima lotta a carattere regionalistico e di profonde correnti verso il decentramento e le autonomie locali.” Nel luglio 1926 Gramsci invia a Lussu un questionario in cui gli chiede se l’oppressione fascista in Sardegna “ha obbiettivamente portato a rendere più acuto il problema regionalistico e a porre la questione dell’autonomia su un terreno più radicale di rivendicazione di tipo nazionale”. Lussu risponde che “il federalismo è indubbiamente la forma statale rispondente alle nostre aspirazioni.” Nell’agosto del 1926 Gramsci nella sua relazione richiama il partito alla necessità di intensificare la sua azione nel Meridione e a definire la sua tattica nei confronti del Partito sardo d’azione che sta per avere il suo congresso. È evidente che la Sardegna ha un ruolo particolare nella strategia politica gramsciana; è la regione dove la rivendicazione federalista è più matura. Gramsci ha sviluppato alcune iniziative politiche, accompagnate da vari articoli, nei confronti dei sardi residenti a Torino e nei confronti della Brigata Sassari, negli anni precedenti alla scissione di Livorno. Lo ricorda nell’ultimo suo saggio Alcuni temi della questione meridionale. In esso ritorna la denuncia dell’accentramento statale come “espressione del dominio borghese sui contadini, specialmente del Mezzogiorno e delle Isole”. Si indica l’obiettivo della organizzazione delle masse dei contadini poveri “in formazioni autonome ed indipendenti”. La posizione di Gramsci sul federalismo, prima del carcere, è organica alla sua analisi del Meridione. 63 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 64 n.19 / 2007 Ne è la conclusione ma già negli anni precedenti al carcere è organica alla sua analisi del Meridione; ne è la conclusione politica ma è condizionata da una situazione politica in cui l’obbiettivo fondamentale, l’unità delle forze politiche nemiche del regime fascista, impone la parola d’ordine dell’assemblea repubblicana sulla base dei comitati operai e contadini. Il federalismo di Gramsci non è stato ancora rilevato sul piano storiografico per varie ragioni, ivi comprese quelle di carattere archivistico. Soltanto nel 1963 Stefano Merli ha pubblicato la lettera del 12 settembre 1923 (“Rivista storica del socialismo”, 18, gennaio-aprile 1963). Tuttavia i riferimenti al federalismo presenti nel carteggio compreso nel volume di Palmiro Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del partito comunista, pubblicato nel 1962, avrebbero potuto richiamare l’attenzione sulla rivendicazione federalista che è organica al meridionalismo gramsciano. L’indicazione dell’obiettivo della Repubblica federale nella lettera del 12 settembre 1923 consente inoltre di leggere meglio alcune lettere dal carcere e alcuni passaggi dei “Quaderni del carcere”. Gramsci termina la sua attività di scrittore politico libero con il aggio Alcuni temi della questione meridionale. Dalle tesi sostenute in tale saggio ricominciano, agli inizi del 1927, i suoi studi carcerari (Gramsci, 1965, 58) su quattro argoment unificati dallo “spirito creativo”, secondo la formula del linguista Matteo Giulio Bartoli. Ma a ben leggere la nota 43 del primo Quaderno, che contiene uno dei primi riferimenti che ricostruiscono il ruolo del federalismo nella storia italiana, da Gioberti fino al pronunciamento eparatista degli agrari siciliani nel 1920, si constata come Gramsci riprenda un’affermazione contenuta nel paragrafo sulla questione agraria contenuta nell’articolo Cinque anni di vita del partito (Gramsci, 1971, 107). La riflessione carceraria intende trovare argomentazioni a molte tesi sostenute negli anni dell’azione politica. Bibliografia Sonetti P. (1999), Gramsci e il liberalismo italiano del Novecento, Gramsci e il Novecento, a cura di G. Vacca, Carocci editore, Roma. Fiori G. (1966), Vita di Antonio Gramsci, Bari, Editori Laterza. 64 Gramsci A. (1965), Lettere dal carcere, Torino, Einaudi editore. Gramsci A. (1992), Lettere, Tonno, Einaudi editore. Lewin M. (1967), L’ultima battaglia di Lenin, Bari, Editori Laterza. Maiorca B. (2007), a cura di, Gramsci sardo. Antologia e bibliografia 1903-2006, Istituto Gramsci della Sardegna, Cagliari. Spriaano P. (1976), Storia del Partito comunista italiano. Da Bordiga a Gramsci, Torino, Einaudi. Stalin J. (1949), II marxismo e la questione nazionale, Torino, Einaudi. Togliatti P. (1962), La formazione del gruppo dirigente de/partito comunista italiano, Roma, Editori Riuniti. Togliatti P. (1967), Opere, a cura di E. Ragionieri, Roma, Editori Riuniti. Verri C. (2006), Trentin-Grieco, Un carteggio nel mezzo della guerra d’Etiopia, “Italiacontemporanea”, 242, marzo 2006. Appendice Lettera “federalista” di Antonio Gramsci a cura di Elio Franzin Pubblichiamo la lettera che Antonio Gramsci scrisse l’11 settembre 1923 da Mosca esponendo la linea politica del niovo quotidiano, l’Unità, di cui er stato appena nominato direttore dall’Internazionale comunista. La lettera è stata ritrovata all’Archivio centrale di Roma, che è apparsa sulla “Rivista storica del socialismo”, n.18, gennaio-aprile 1963, pp.115-116, con un commento di Stefano Merli. Un brano di essa è stato riprodotto nella prefazione al volume di Gramsci La costruzione del Partito comunista 1923-1926 del 1971. Infine è stata pubblicata integralmente nelle Lettere 1908-1926 raccolte a cura di Antonio A. Cantucci nel 1992. Questa lettera, rivolta al Comitato esecutivo del PCI, l’organismo dirigente del partito, segna una nuova fase della biografia politica di Gramsci, che nel nuovo ruolo affidatogli, quello di direttore del “L’Unità”, delinea una linea politica radicalmente contrapposta a quella di Amedeo Bordiga, il primo segretario del PCI. E’ una linea politica diversa anche da quelle enunciata da Lenin nel marzo 1919 nel suo saggio “Tesi e rapporto sulla democrazia RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Elio Franzin 17-01-2008 9:03 Pagina 65 "Repubblica federale degli operai e dei contadini" borghese e sulla dittatura del proletariato” sulla inesistenza di qualsiasi “soluzione intermedia” fra la dittatura della borghesia e la dittatura del proletariato. Questi tesi fu radicalmente corretta al III Congresso dell’Internazionale comunista (Mosca, 22 giugno – 12 luglio 1921) quando ormai era apparso evidente che l’ondata rivoluzionaria in Europa era caduta. Gramsci scrive la lettera da Mosca mentre esiste in Italia una situazione politica generale caratterizzata dalla ascesa al potere del fascismo e dalla successiva manovra di Benito Mussolini di ulteriore legittimazione del suo governo mediante l’approvazione di una nuova legge antiproporzionale e maggioritaria che, approvata dal Senato il 13 novembre 1923, prenderà il nome di legge Acerbo. Nell’aprile si era svolto a Torino il quarto congresso del Partito popolare italiano nel corso del quale la maggioranza dei delegati si schierò con don Luigi Sturzo contro il governo fascista. Ma Sturzo nel luglio fu costretto a dare le dimissioni da segretario del partito lasciando così via libera alla destra del gruppo parlamentare favorevole alla legge Acerbo. Nei mesi precedenti la pressione di Mussolini sul Vaticano e sul partito popolare era stata pesantissima. Dal maggio 1922 Gramsci, ammalato, si trovava a Mosca dove era arrivato per la riunione del II Esecutivo allargato, l’organismo che dirigeva l’Internazionale comunista (giugno 1923). Egli stava subendo fortissime pressioni affinché si distaccasse da Amadeo Bordiga il primo dirigente del Partito comunista italiano le cui posizioni teoriche e politiche furono sempre molto diverse da quelle di Lenin e dell’Internazionale comunista. Nell’ottobre 1922 si svolse a Roma il Congresso del Partito socialista nel quale fu decisa l’espulsione dei riformisti come richiesto dall’Internazionale comunista e questo rimise in discussione il modo con il quale si era verificata l’uscita dei comunisti dal Partito socialista a Livorno (gennaio 1921) e la fondazione del Partito comunista italiano come partito assolutamente minoritario. La divisione tra i socialisti massimalisti e i comunisti non aveva più nessuna ragione di essere, almeno dal punto di vista dei dirigenti dell’Internazionale comunista. Ma al IV Congresso dell’internazionale comunista (5 novembre-5 dicembre 1922) la delegazione italiana di cui Gramsci faceva parte era rimasta su posizioni bordighiane di rifiuto della decisione dell’organismo internazionale di unificare il Partito socialista italiano e quello comunista sulla base di un documento articolato in quattordici punti. Gramsci ha accettato che il PCI fosse diretto da Bordiga al 1921 fino al 1923 sia per ragioni organizzative che per ragioni politiche. La frazione di Bordiga prima della scissione di Livorno era organizzata su base nazionale contrariamente al gruppo del “L’Ordine nuovo” che era rimasto un gruppo soltanto piemontese. Sia Bordiga che Gramsci giudicavano negativamente tutta l’esperienza e l’eredità del Partito socialista, dei suoi dirigenti e delle sue organizzazioni. E’ comprensibile che la storiografia di ispirazione comunista abbia rimosso le profonde ragioni della alleanza di Gramsci con Bordiga nel periodo dal 1921 al 1923 e il peso che ha avuto l’Internazionale comunista nel determinare il faticosissimo superamento di esse da parte di Gramsci. Al IV Congresso dell’Internazionale comunista Lenin, ormai ammalato, presentò un sintetico bilancio sui cinque anni della rivoluzione russa e sulle prospettive della rivoluzione mondiale e un giudizio molto critico sui partiti comunisti. Secondo Lenin, la gravissima crisi economica russa doveva essere affrontata arretrando dalle misure socialiste alla creazione del capitalismo di stato. A proposito dell’Italia, egli pronunciò la seguente frase: ”I compagni stranieri debbono digerire un buon pezzo dell’esperienza russa. Come questo avverrà non lo so. Forse i fascisti in Italia, per esempio, ci renderanno grandi servizi mostrando agli italiani che non sono ancora abbastanza istruiti, che il loro paese non è garantito contro i cento neri”. Che cosa intendeva Lenin con questa frase decisamente sarcastica ? L’esperienza russa alla quale si riferisce è quella della rivoluzione democratica del 1905 contro lo zarismo nel corso della quale Lenin aveva pubblicato Le due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica, affermando la necessità della classe operaia e dei socialdemocratici rivoluzionari di dirigere, di egemonizzare la rivoluzione democratica. Bordiga, colui che dopo la nascita del Partito comunista a Livorno ne aveva assunto la direzione, era arrivato a negare nelle tesi per il II Congresso del 65 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 66 n.19 / 2007 PCI (Roma, marzo 1922) la possibilità di un colpo di stato di destra in Italia ricevendo una dura smentita dalla marcia su Roma dei fascisti dell’ottobre 1922. L’affermazione era stata subito contestata da Gramsci. Nel 1923 il conflitto apertosi fra il PCI e l’Internazionale comunista e la repressione fascista misero in pericolo la stessa esistenza del PCI. Soltanto nel maggio 1923 Gramsci, guarito, inizia un carteggio, in particolare con Palmiro Togliatti, nel quale esprime delle critiche aperte alla linea politica di Bordiga. La lettera a Togliatti del 23 maggio 1923 (P. Togliatti, La formazione del gruppo dirigente del partito comunista italiano, Roma 1962) contiene il riconoscimento del radicamento del Partito socialista fra le masse popolari italiane. Togliatti nell’aprile del 1923 pubblica su “Il Lavoratore” un articolo su un convegno nazionale del PSI svoltosi a Milano che Gramsci critica con durezza. Finalmente Gramsci ritiene sbagliato porsi in una situazione di antitesi insuperabile con la massa degli iscritti al Partito socialista come aveva fatto il PCI fino a quel momento, perdendo del tempo prezioso al fine della lotta unitaria contro il fascismo Ma soltanto quattro mesi dopo, nel settembre, con la sua lettera per la fondazione del “L’Unità” Gramsci propone all’organo dirigente del suo partito una nuova strategia politica, alternativa a quella di Bordiga, che è la traduzione originale di quella del fronte unico adottata dall’Internazionale comunista su indicazione di Lenin già al terzo Congresso dell’Internazionale comunista. È la lettera di una svolta politica anche se Gramsci non si pone ancora il problema della formazione di un suo gruppo dentro il partito. Nella affermazione della necessità di dare allo stato italiano una struttura federalista si fondono la sua esperienza di “sardista” che lo rendeva molto sensibile alla comprensione della struttura che stava assumendo, sotto l’impulso di Lenin, l’Unione sovietica e quella di dirigente dell’Internazionale comunista. È evidente che la sua posizione federalista del settembre 1923 e poi la lettera dell’ottobre 1926 sul conflitto apertosi all’interno del Partito comunista sovietico impongono oggi una ben diversa lettura di Gramsci come dirigente politico prima e poi come autore dei Quaderni del carcere. Si tratta di due posizioni nelle quali si è storica- 66 mente verificata la massima distanza fra le posizioni di Gramsci e quelle di Palmiro Togliate, il suo successore alla direzione del PCI Togliatti infatti nel 1926 inizia il suo allineamento sulle posizioni di Stalin e poi nel 1945 si dichiara antifederalista accettando, ai fini della Ricostruzione, il centralismo dello stato italiano. Lettera di Antonio Gramsci 12 settembre 1923 Al C. E. del PCI Cari compagni, Nella sua ultima seduta il Pres. ha deciso che in Italia sia pubblicato un quotidiano operaio redatto dal CE. al quale possano dare la loro collaborazione politica i terzinternazionalisti esclusi dal P.S. Voglio comunicarvi le mie impressioni e le mie opinioni a questo proposito. Credo che sia molto utile e necessario, data la situazione attuale italiana, che il giornale sia compilato in modo da assicurare la sua esistenza legale per il più lungo tempo possibile. Non solo quindi il giornale non dovrà avere alcuna indicazione di partito, ma esso dovrà essere redatto in modo che la sua dipendenza di fatto dal nostro partito non appaia troppo chiaramente. Dovrà essere un giornale di sinistra, della sinistra operaia, rimasta fedele al programma e alla tattica della lotta di classe, che pubblicherà gli atti e le discussioni del nostro partito, come farà possibilmente anche per gli atti e le discussioni degli anarchici, dei repubblicani, dei sindacalisti e dirà il suo giudizio con un tono disinteressato, come se avesse una posizione superiore alla lotta e si ponesse da un punto di vista “scientifico”. Capisco che non è molto facile fissare tutto ciò in un programma scritto; ma l’importanza non è di fissare un programma scritto, è piuttosto nell’assicurare al partito stesso, che nel campo delle sinistre operaie ha storicamente una posizione dominante, una tribuna legale che permetta di giungere alle più larghe masse con continuità e sistematicamente. I comunisti e i serratiani collaboreranno al giornale, manifestamente, cioè firmando gli articoli con nomi di elementi in vista, secondo un piano politico, che tenga conto mese per mese, e, direi, settimana per settimana, della situazione generale del paese e dei rapporti che si sviluppano tra le RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Elio Franzin 17-01-2008 9:03 Pagina 67 "Repubblica federale degli operai e dei contadini" forze sociali italiane. Bisognerà stare attenti ai serratiani che tenderanno a trasformare il giornale in un organo di frazione nella lotta contro la Direzione del P.S., Bisognerà essere severissimi in ciò e impedire ogni degenerazione. La polemica si farà necessariamente, ma con spirito politico, non di setta ed entro certi limiti. Bisognerà stare in guardia contro i tentativi per creare una situazione “economica” a Serrati, che è disoccupato e sarà dai suoi compagni proposto, molto probabilmente, come redattore ordinario. Serrati collaborerà firmando e non firmando; i suoi articoli firmati dovranno però essere fissati in una certa misura e quelli non firmati dovranno essere accettati dal C.E. nostro. Sarà necessario fare coi socialisti o meglio con lo spirito socialista di Serrati, Maffi ecc. delle polemiche di principio che saranno utili per rinsaldare la coscienza comunista delle masse e per preparare quella unità e omogeneità di Partito che sarà necessaria dopo la fusione per evitare una ricaduta nella caotica situazione del 1920. Io propongo come titolo “L’Unità” puro e semplice, che sarà un significato per gli operai e avrà un significato più generale, perché credo che dopo la decisione dell’Esec.[utivo] All.[argato] sul governo operaio e contadino, noi dobbiamo dare importanza specialmente alla questione meridionale, cioè alla questione in cui il problema dei rapporti tra operai e contadini si pone non solo come un problema di rapporto di classe, ma anche e specialmente come un problema territoriale, cioè come uno degli aspetti della questione nazionale. Personalmente io credo che la parola d’ordine “governo operaio e contadino” debba essere adattata in Italia così: “Repubblica federale degli operai e contadini”. Non so se il momento attuale sia favorevole a ciò, credo però che la situazione che il fascismo va creando e la politica corporativa e protezionistica dei confederali porterà il nostro partito a questa parola d’ordine. A questo proposito sto preparando una relazione per voi che discuterete ed esaminerete. Se sarà utile, dopo qualche numero, si potrà nel giornale iniziare una polemica con pseudonimi e vedere quali ripercussioni essa avrà nel paese e negli strati di sinistra dei popolari e dei democratici che rappresentano le tendenze reali della classe contadina e hanno sempre avuto nel loro programma la parola d’ordine dell’autonomia locale e del decentramento. Se voi accettate la proposta del titolo: “L’Unità” lascerete il campo libero per la soluzione di questi problemi e il titolo sarà una garanzia contro le degenerazioni autonomistiche e contro i tentativi reazionari di dare interpretazioni tendenziose e poliziesche alle campagne che si potranno fare: io d’altronde credo che il regime dei Soviets, con il suo accentramento politico dato dal Partito comunista e con la sua decentralizzazione amministrativa e la sua colorizzazione delle forze popolari locali, trovi un’ottima preparazione ideologica nella parola d’ordine: Repubbica federale degli operai e contar Saluti comunisti Gramsci 67 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 68 Lucia Vianello Immagini del tempo in Giordano Bruno Viaggiando tra le costellazioni del sapere La “nuova primavera” vissuta dagli studi bruniani negli ultimi decenni testimonia che il pensiero del filosofo nolano non ha ancora esaurito la sua intima forza, la sua capacità di liberare le menti, di innovare in ogni campo del sapere. La filosofia di Bruno si situa alle origini del mondo moderno, e rappresenta una particolare concezione di “modernità”, di rinnovamento della civiltà dell’uomo, ancora oggi attuale. Un nuovo/antico senso dello spazio, ma soprattutto del tempo, è l’essenza più profonda della rivoluzionaria visione bruniana di un universo senza più confini. Numerosi sono gli studi che hanno esplorato, da diversi punti di vista, i molteplici aspetti e accenti che questo motivo assume in Bruno divenendo la stessa trama nascosta dei suoi testi. La riflessione sul tempo è tema centrale, struttura portante in Bruno. A partire da questo nodo centrale l’indagine bruniana si svolge e si approfondisce in molteplici direzioni. Non vi sono fratture, o bruschi cambiamenti di rotta, su questo tema fondamentale, perché è la fonte da cui germinano le diverse prospettive da cui il Nolano osserva la realtà. E’ un punto di riferimento costante, che getta luce sull’intero percorso – dal Candelaio, ai dialoghi italiani, alle opere latine – assicurandone organicità e coerenza. La coscienza di trovarsi al tramonto di un’epoca è unita in Bruno all’esigenza di interpretare i segni del tempo, nel loro ambivalente carattere di morte e vita. C’è un tempo che sommerge la verità nei fiumi dell’oblio, e un tempo in cui la verità riaffiora. Il tempo porta a maturazione, disvela le cose, ricuce le ferite, fa rinascere la filosofia. Al senso 68 della fugacità e inconsistenza di tutte le cose, si accompagna la certezza che al di là del loro continuo mutarsi e svanire “la veritade sola con l’absoluta virtude è inmutabile ed immortale: e se tal volta casca e si sommerge, medesima necessariamente al suo tempo risorge” (Bruno 1985a, 592). Lo stesso tempo che cancella necessariamente riporta alla luce. Se struttura fondamentale del divenire è la ruota delle vicissitudini, per la quale tutte le cose “è necessario dal male vegnano al bene, dal bene al male, dalla bassezza a l’altezza, da l’altezza alla bassezza, da le oscuritadi al splendore, dal splendor alle oscuritadi” (Bruno 1985b, 1075), occorre cogliere i punti di passaggio, di trasformazione di un contrario nell’altro. Apprendere a navigare nel tempo, sapere in quale punto dell’orizzonte spazio-temporale ci si trova: “Quello dunque, al che doviamo fissar l’occhio de la considerazione, è si noi siamo nel giorno, e la luce de la verità è sopra il nostro orizonte, overo in quello degli aversarii nostri antipodi; si siamo noi in tenebre, over essi: ed in conclusione, si noi, che damo principio a rinovar l’antica filosofia, siamo ne la mattina per dar fine a la notte, o pur ne la sera per donar fine al giorno” (Bruno 1985c, 43). Leggere oltre la corrente del tempo, ricercare al di là della transitorietà e mutevolezza delle forme, dell’alternarsi ciclico di vita e morte, il principio che persevera sempre uno e immutabile: ciò che non può essere travolto dall’impetuoso fiume del tempo, quell’unità e stabilità in cui l’anima trova le sue radici. Il “furioso” ha un punto di riferimento, un punto di equilibrio, il suo divino oggetto: “si vanta il furioso RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Lucia Vianello d’aver forza e robustezza, come la rovere”. Come la quercia, non si oppone al tempo, non cerca di frenarne la corsa, ma trova nuove vie per sopravvivere, saldandosi alla terra, e così resiste agli assalti del vento del tempo: “e per ciò cossì rimaner constante e fermo contra gli Aquiloni e tempestosi inverni per la fermezza ch’ha nel suo astro in cui è piantato con l’affetto ed intenzione, come la detta radicosa pianta tiene intessute le sue radici con le vene de la terra” (Bruno 1985b, 1052). Il tempo distruttore “Cossì il sapiente ha tutte le cose mutabili come cose che non sono, ed afferma quelle non esser altro che vanità ed un niente; perché il tempo a l’eternità ha proporzione come il punto a la linea” (Bruno 1985b, 976). La ruota del tempo procede girando come il vento, si susseguono i giorni alle notti, ogni cosa nasce e muore, tutto incessantemente ritorna. In questo perenne e ciclico divenire, la breve esistenza dell’uomo trascorre come un’ombra fugace, di cui non rimarrà traccia. Il tempo precipita tutte le cose, logora, invecchia, demolisce, distrugge: ogni cosa si chiude con la morte, è destinata a scomparire nel vento, a perdersi negli abissi dell’oblio. Il movimento vorticoso del tempo tutto annienta e divora, in un’opera instancabile. Inutilmente l’uomo si affatica: cosa resta dopo l’opera di distruzione del vento? A che serve costruire case, accumulare ricchezze e potere, se tutto cadrà, verrà meno, inghiottito nel vortice del tempo? Il sapiente ricerca ciò che ha valore e significato, oltre l’apparenza, l’effimero, il vano inseguire il vento dell’uomo. Non si può raddrizzare ciò che è curvo, è vano tentare di frenare la corsa del tempo, pretendere di sovvertirlo. Occorre sapersi adeguare ai ritmi delle cose, ai tempi lunghi della natura, accettare gli eventi senza dismettersi d’animo, saper cogliere il giusto tempo. La percezione della vanità e caducità di tutte le cose si tramuta in profonda saggezza di vita. C’è un tempo per ogni cosa: “C’è un tempo per nascere e un tempo per morire/un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante/un tempo per uccidere e un tempo per guarire/un tempo per demolire e un tempo per costruire” (Qo 3,1-3). L’immagine ambivalente del tempo che, nel suo eterno circuire, tutto distrugge e tutto rinnova, ritorna nel sonetto Al tempo di Bruno: “O vecchio, 9:03 Pagina 69 Immagini del tempo in Giordano Bruno lento e celere, che chiudi e riapri, dovremo dirti un bene o un male? Sei largo insieme e tenace; i doni, che porgi, ritogli; quel che fai nascere, uccidi, e quel che dal tuo ventre generi nel tuo ventre divori, tu cui è lecito consumar colle fauci il frutto del tuo seno. Tutto crei e tutto distruggi: non potrei dunque chiamarti un bene e chiamarti un male?” “Lente senex, idemque celer, claudensque relaxans,/Anne bonum qui te dixerit, anne malum?/Largus es, esque tenax: quae munera porrigis, aufers;/Quique parens aderas, ipse peremptor ades;/Visceribusque educta tuis in viscera condis,/Tu cui prompta sinu carpere fauce licet./Omnia cumque facis cumque omnia destruis, hinc te/Nonne bonum posse dicere, nonne malum?” - (Bruno 1985d, 189). Il senso acuto del tempo che pervade l’Ecclesiaste, dell’inevitabile dissolversi di ogni cosa, risuona in varie forme nei testi bruniani, assumendo nuovi accenti. Bruno attinge a fonti diverse, utilizza i linguaggi della tradizione, ma nel contempo rielabora, rinnova, traduce nel suo linguaggio, partendo da un particolare punto di vista, quello del filosofo che esplora l’universo e la natura. L’esperienza della vanità e apparenza di tutte le cose, si approfondisce in molteplici direzioni, arricchendosi di nuovi sensi nel quadro della concezione bruniana di un universo infinito. La rinascita Copernico ha recuperato i frammenti degli antichi, che sostenevano la centralità del sole e il moto della terra, i resti sopravvissuti alle ingiurie del tempo: “ripigliando quelli abietti e rugginosi fragmenti ch’ha possuto aver per le mani da l’antiquità, le ha ripoliti, accozzati e risaldati”, li ha ricomposti in un intero, saldando una frattura avvenuta nella memoria. La sua opera di rinnovamento è “come un’aurora, che dovea precedere l’uscita di questo sole dell’antiqua vera filosofia” (Bruno 1985e, 28-9). La visione aristotelico-tolemaica del cosmo, che rinchiude il cielo in una gabbia di sfere di cristallo, non è che un’impalcatura immaginaria, che si è sovrapposta al vero volto della natura: “questa imaginazione – compreso che sarà il moto di questo astro mondano in cui siamo, che, senza essere affisso ad orbe alcuno, per il generale e spacioso campo essagitato dall’intrinseco principio, propria anima e natura, discorre circa il sole e si versa circa 69 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 70 n.19 / 2007 il proprio centro – averrà che sia tolta: e s’aprirà la porta de l’intelligenza de gli principii veri di cose naturali ed a gran passi potremo discorrere per il camino della verità. La quale, ascosa sotto il velame di tante sordide e bestiale imaginazioni, sino al presente è stata occolta per l’ingiuria del tempo e vicissitudine de le cose dopo che al giorno de gli antichi sapienti succese la caliginosa notte di temerari sofisti” (Bruno 1985f, 434). La caduta di un universo di sfere, la rovina del mondo, è rovina di un mondo fittizio. Al di là delle costruzioni teoriche dei vani matematici e dei filosofi volgari, la natura è sempre rimasta la stessa, solo l’immagine che l’uomo ha di essa è mutata. Una falsa immagine si è sostituita alla realtà: tale fantasia alimenta timori senza fondamento, primo tra tutti il terrore della morte. Vano timore, che può essere dissipato dallo studio e dall’osservazione della natura. Rinchiusi in un mondo di ombre, i fisici aristotelici sono simili a fanciulli che si spaventano per fantasmi che sono solo il prodotto della loro immaginazione. Nell’universo vivente e dinamico di Bruno, discordia divisione e morte sono solo apparenti. Considerato nella sua globalità, l’universo è immobile, perché non ha fuori di sé luogo dove trasferirsi, ma al suo interno ogni mondo è soggetto ad una eterna vicissitudine. Ogni cosa si trasforma, non è mai identica all’istante precedente, ogni essere è in comunicazione con gli altri esseri e con il tutto. Ma in questo movimento incessante il principio vitale persevera sempre uno e medesimo, la sostanza non subisce alterazione, conservandosi identica: “Ma mentre consideramo più profondamente l’essere e sustanza di quello in cui siamo inmutabili, trovaremo non esser morte, non solo per noi, ma né per veruna sustanza; mentre nulla sustanzialmente si sminuisce, ma tutto, per infinito spacio discorrendo, cangia il volto” (Bruno 1985f, 360). L’universo è un unico immenso organismo in perenne trasformazione. La diversità e contrapposizione presenti nell’universo sono momenti dell’esplicarsi dell’Uno necessari allo svolgersi della vicenda vitale cosmica: “Dalla qual diversità e contrarietà depende l’ordine, la simmetria, la complessione, la pace, la concordia, la composizione, la vita” (Bruno 1985f, 464). La riscoperta del vero volto della natura cancella il timore della morte: “Ogni produzione, di qualsivoglia sorte che la sia, è una alterazione, rimanendo 70 la sustanza sempre medesima; perché non è che una, uno ente divino, immortale. Questo lo ha possuto intendere Pitagora, che non teme la morte, ma aspetta la mutazione. L’hanno possuto intendere tutti filosofi, chiamati volgarmente fisici, che niente dicono generarsi secondo sustanza né corrompersi, se non vogliamo nominar in questo modo la alterazione. Questo lo ha inteso Salomone, che dice “non esser cosa nova sotto il sole, ma quel che è fu già prima”. (…) Ecco come non doviamo travagliarci il spirto, ecco come cosa non è, per cui sgomentarne doviamo. Perché questa unità è sola e stabile, e sempre rimane; questo uno è eterno; ogni volto, ogni faccia, ogni altra cosa è vanità, è come nulla, anzi è nulla tutto lo che fuor questo uno” (Bruno 1985g, 324). Il versetto dell’Ecclesiaste, così caro a Bruno da porlo come motto accanto alla sua firma, è spesso citato nelle sue opere. La struttura del tempo Il tempo tesse e disfa la tela della vita, l’immagine del movimento ciclico del tempo è l’immagine stessa del pulsare del cosmo. Ed è il senso del tempo che struttura il linguaggio, intesse i telai del pensiero: recuperando la memoria degli antichi filosofi, si ritrova una continuità con il passato, un senso dello spazio e del tempo dal quale emergono nuove parole e nuove immagini. Nel quadro di un universo infinito e unitario i comuni punti di riferimento non hanno più senso. Le coordinate spazio-temporali risultano enormemente dilatate, e si aprono allo sguardo prospettive che eguagliano quelle dell’abisso. Superando il proprio punto di vista, parziale e limitato, l’occhio della mente abbraccia simultaneamente l’alto e il basso, il passato, il presente e il futuro. Destro e sinistro, alto e basso sono riferimenti che hanno significato solo in relazione ad un determinato punto di vista. Non vi è proporzione alcuna tra finito e infinito, tempo ed eternità: “ne l’infinita durazione non differisce la ora dal giorno, il giorno da l’anno, l’anno dal secolo, il secolo dal momento; perché non son più gli momenti e le ore che gli secoli, e non hanno minor proporzione quelli che questi a l’eternità. Similmente ne l’immenso non è differente il palmo dal stadio, il stadio da la parasanga; perché alla proporzione de la inmensitudine non più si accosta per le parasanghe che per i palmi. Dunque infinite ore non son più che infini- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Lucia Vianello ti secoli, ed infiniti palmi non son di maggior numero che infinite parasanghe. Alla proporzione, similitudine, unione ed identità de l’infinito non più ti accosti con essere uomo che formica, una stella che un uomo; perché a quello essere non più ti avicini con esser sole, luna, che un uomo o una formica; e però nell’infinito queste cose sono indifferenti” (Bruno 1985g, 320). Questo aprirsi ed affacciarsi della mente sugli abissi spazio-temporali è riattingere alla fonte da cui tutti i tempi e ritmi delle cose traggono origine. Risalendo il corso del fiume necessariamente si giunge alla sua sorgente, così ripercorrendo le vie lungo le quali la divinità discende comunicandosi, si ritrova quell’unità che è fonte di ogni vita. Nel De la Causa Bruno ricerca quell’Uno che persevera immutabile, al di là del continuo trasmutarsi delle forme sul dorso della materia, oltre la vanità e caducità delle cose. Procedendo dall’esterno all’interno, dalle forme sensibili all’intima struttura delle cose, mediante una spoliazione progressiva, togliendo tutto ciò che è accidente, numero e figura, si tenta di raggiungere la sostanza, il “centro de ciò che ha l’essere, uno in tutto e per cui tutto è uno” (Bruno 1985g, 322). Nel De Minimo Bruno traduce nel linguaggio della geometria il linguaggio della vita. L’itinerario della conoscenza imita e rispecchia i modi e le forme del linguaggio naturale, risale dai tempi e ritmi che si osservano in natura all’unità da cui tutti provengono. Il linguaggio geometrico del De Minimo diviene uno strumento per esprimere e rendere evidente la metafisica che fonda l’unità dell’universo infinito. Come dall’unità si generano infiniti numeri e infiniti ordini, così la monade divina è la fonte dell’infinita molteplicità e varietà di specie e generi di esseri viventi. Bruno distingue tra minimo metafisico, fisico e razionale. Il minimo metafisico è lo stesso Uno, di cui l’intero universo è esplicazione: l’Uno si riflette in una molteplicità di minimi, fonti di vita. Il minimo fisico è l’atomo, la parte ultima della materia (non è possibile infatti la suddivisione all’infinito: la scomposizione naturale rimanda all’atomo come all’ultimo ente indivisibile), che non è il minimo sensibile, ma è straordinariamente “contratto” al di sotto del minimo sensibile. Minimo matematico è il punto, che è circolo, circolo razionale, non si danno veri circoli in natura. L’Uno, scandendosi numericamente, dà origini agli infiniti ritmi e tempi delle cose. Il minimo è la base di ogni suc- 9:03 Pagina 71 Immagini del tempo in Giordano Bruno cessione numerica: ogni grandezza deriva dal minimo e nel minimo si risolve. La natura presenta in ogni specie un massimo e un minimo relativi alla specie in questione: l’unità di misura non va reperita all’esterno della cosa, ma al suo interno. Tale unità di misura è il minimo, principio generatore che determina il ritmo della progressione numerica, che fissa e delimita l’arco dell’esistenza di ciascun essere. Ogni specie ha il suo minimo, il suo ritmo, il suo tempo. I minimi si toccano non completamente, né attraverso qualche loro parte (poiché, essendo indivisibili, non hanno parti), ma attraverso il loro termine, estremità che li separa gli uni dagli altri in modo che non coincidano. Esistono nodi, punti che strutturano il tempo secondo ritmi, ne spezzano il fluire: nodi nelle trasmutazioni circolari, punti da cui procedono i contrari e si trasformano l’uno nell’altro, punti estremi, che fissano e delimitano, e punti dai quali fluisce e defluisce la vita. Il tempo lascia le sue impronte nelle cose, per cui è possibile rinvenire nelle forme naturali la struttura del tempo. Risalire dai tempi e ritmi che scandiscono i movimenti che osserviamo in natura, alla sorgente della vita da cui tutti scaturiscono. Tempo e strutture della conoscenza Dalla dissoluzione di catene immaginarie emerge una nuova visione unitaria, dinamica, policentrica dell’universo. Svaniscono le gabbie teoriche in cui i fisici aristotelici hanno imprigionato la natura e rinchiuso la loro mente. Lo sguardo può ora spaziare liberamente negli spazi cosmici e nell’universo della conoscenza, e scoprire zone inesplorate. E’ la vera immagine del cosmo, il vero volto della natura, a lungo dimenticato, che riaffiora. Occorre superare le intercapedini culturali, dissolvere i falsi confini, per recuperare la memoria di quel volto. Occorre riattingere all’esperienza da cui hanno avuto origine le parole degli antichi sapienti, ritornare in quel punto in cui essi si trovavano, al di là della frattura tra parole e cose, realtà e rappresentazione. Dagli abissi della memoria emerge un luogo a lungo occultato: l’immagine del tempo che racchiude tutti i tempi, l’immagine della sfera della vita, in cui passato, presente e futuro si comprimono al centro, per poi svolgersi nuovamente, dando origine agli infiniti tempi e movimenti che si osservano in natura. Il tempo diventa spazio e lo spazio diventa tempo. 71 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 72 n.19 / 2007 E’ questo senso del tempo la fonte comune da cui sono nate le diverse visioni filosofiche e cosmologiche degli antichi. Gli antichi filosofi, a partire da punti di vista diversi, indagarono alla ricerca dell’Uno e lo chiamarono con diversi nomi. Bruno può interpretare i frammenti degli antichi, ricomporli in un intero, perché rivede ciò che essi hanno visto. La caduta di un universo di sfere conduce a contemplare un nuovo cielo, antecedente alla teoria dei cieli aristotelico-tolemaica, il cielo che già gli antichi filosofi contemplarono. Come lo spazio cosmico non è il nulla, ma infinita possibilità di vita, mare sterminato, così allo spaziare libero dell’occhio della mente si aprono nuovi orizzonti, nuove prospettive. Un universo infinito e in perenne trasformazione richiede nuove procedure di conoscenza. La ragione appronta modelli che imitano la struttura interna delle cose, per avvicinarsi a quel centro che precede tutte le opposizioni e tutte le genera. Solamente una visione globale, unitaria, consente di ricucire la trama dei significati. Le linee, i fili di questa trama sono le coordinate spazio-temporali della memoria, in base alle quali vengono organizzati i contenuti della conoscenza. Ma tra strutture della conoscenza e strutture del reale deve esserci corrispondenza, a rischio di costruire tessiture puramente fantastiche che hanno perduto il loro referente reale, prodotti di un punto di vista soggettivo che si ritiene l’unico valido. In analogia alla visione unitaria e al tempo stesso policentrica dell’universo infinito, nell’universo della conoscenza diversità, molteplicità, opposizioni vanno compresi nell’ordine del tutto. La perdita dei riferimenti spazio-temporali ordinari non si risolve nel relativismo di una molteplicità di prospettive soggettive chiuse in se stesse. Se spazio e tempo sono le grandi coordinate che costituiscono la matrice, il telaio del pensiero, la sospensione del senso comune dello spazio e del tempo produce nuove strutture di conoscenza, quelle che Bruno mette in opera nel De la Causa. L’esperienza della vanità e il nuovo senso del tempo che l’accompagna si configurano come struttura portante dell’intero percorso di conoscenza di Bruno: è questo il cuore a cui la riflessione filosofica bruniana sempre ritorna e trae nuova vita, in un duplice movimento di espansione e contrazione, di distruzione e di edificazione che imita 72 nel suo procedere i ritmi naturali. L’unità dell’universo infinito è la chiave, offerta nel De la Causa, che apre alla contemplazione del vero volto della natura. Riferimenti bibliografici Badaloni, Nicola (1991), “L’impulso del negativo: la vanitas in Giordano Bruno”, in Filosofia e Cultura. Per Eugenio Garin, a cura di Michele Ciliberto e Cesare Vasoli, Roma, Editori Riuniti, pp. 309-326 Bruno, Giordano (2002), Opere italiane, Utet, Torino Bruno, Giordano (1980), Opere latine, trad. a cura di Carlo Monti, Utet, Torino Bruno, Giordano (1985), Dialoghi italiani, nuovamente ristampati con note da Giovanni Gentile, terza ed. a cura di G. Aquilecchia, seconda rist. Sansoni, Firenze Bruno, Giordano (1985a), Spaccio de la Bestia Trionfante, in Bruno (1985) Bruno, Giordano (1985b), De gli Eroici Furori, in Bruno (1985) Bruno, Giordano (1985c), La Cena de le Ceneri, in Bruno (1985) Bruno, Giordano (1985d), De la Causa, principio et uno, in Bruno (1985) Bruno, Giordano (1985e), Cena, in Bruno (1985) Bruno, Giordano (1985f), De l’infinito, universo e mondi, in Bruno (1985) Bruno, Giordano (1985g), De la Causa, in Bruno (1985) Ciliberto, Michele (1999), Umbra profunda. Studi su Giordano Bruno, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma Mancini, Sandro (2000), La sfera infinita. Identità e differenza nel pensiero di Giordano Bruno, Mimesis, Milano Montano, Aniello (2003), “Aspetti di una storia della filosofia non dialettica e non continuista”, Rivista di storia della filosofia, anno LVIII, n. 3, pp. 437-457. Ordine, Nuccio (1987), La soglia dell’ombra, Marsilio, Venezia 2003; La cabala dell’asino, Liguori, Napoli Ruggiu, Luigi (2002), La ripresa dell’antico in Giordano Bruno, in Destino e Verità, a cura di Daniele Goldoni e Luigi Ruggiu, Marsilio, Venezia, pp. 185-219. RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 73 Mariarosa Dalla Costa Di chi è il corpo di questa donna?* Il Faro Mi è sembrato opportuno focalizzare le considerazioni che svolgerò oggi su un fatto che ritengo propedeutico a qualunque altra problematica sull’autonomia della donna. E cioè che per la donna costruzione di autonomia ha voluto dire, in qualunque regione del mondo anzitutto reimpadronirsi del proprio corpo, poter disporre di quel corpo femminile che è sempre stato la posta in gioco del rapporto fra i sessi. Questo era vero per noi agli anni inizi degli anni ’70 in Italia, era vero per le donne Maya quando cominciarono a stendere la loro legge agli inizi degli anni ’90 in Chiapas. Riportare e confrontare qui alcuni aspetti delle nostre problematiche e delle lotte su questo terreno penso possa essere utile in una battaglia che per noi come per loro, come per molte altre in vari paesi, ha segnato delle tappe importanti ma è lontana dall’essere conclusa. Quando lessi la Carta Rivoluzionaria delle Donne Maya mi colpì l’estrema corrispondenza tra le rivendicazioni espresse in quella Carta, unitamente alle altre che mano a mano venivano elaborate, e le nostre rivendicazioni un quarto di secolo prima, agli albori degli anni ’70. Per riuscire noi come loro a venir fuori dalla sofferenza e dall’impotenza avevamo dovuto unirci come donne e dar vita a un movimento. L’impotenza era il grande problema che avevamo visto nella vita delle nostre madri. L’impotenza della mancanza di denaro che impedisce qualunque scelta, anche di fuggire da mariti o padri violenti, l’impotenza di una non conoscenza della sessualità che fa fallire il matrimonio ma non si sa come rimediare dovendosi rapportare comunque a comportamenti maschili ignari della sessualità femminile1, l’impotenza della non comunicazione perché era tabù parlare con altre donne di cose troppo intime, l’impotenza derivante dalla stigmatizzazione di una scelta di vita che non fosse il matrimonio per cui le nostre madri erano obbligate molto giovani a passare dalla casa del padre a quella del marito senza aver mai potuto chiedersi chi erano e cosa volevano, l’impotenza di trovarsi madri a nove mesi dal matrimonio senza essersi mai conosciute come donne (la verginità prematrimoniale era un imperativo sociale), l’impotenza del subire violenza in famiglia o fuori ma non poterlo dire per non esporre la famiglia allo scandalo e per non essere colpevolizzate da altri uomini, anzitutto giudici e polizia, l’impotenza di subire molestie sessuali sul lavoro ma non potersi permettere di perdere il posto. Tutte questioni che, pur nella grande differenza di contesto e di condizioni di * Relazione prodotta al convegno “La autonomia posible”, Universidad autonoma de la Cìudad de Mexico, 24-25-26 ottobre 2006 1 Significativo in merito il libro di Lieta Harrison, La donna sposata. Mille mogli accusano, Feltrinelli, Milano, 1972. 73 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 74 n.19 / 2007 2 Come riporta G. Rovira: “gli uomini semplicemente ‘usano’ la donna”. Colpisce che è lo stesso verbo adottato tempo fa nelle nostre campagne. Il piacere sessuale è qualcosa di sconosciuto, riferisce Rovira. Così era anche per noi prima del movimento. Sebastiana al dialogo con il governo alla fine ’95 denuncia questa situazione gridando arrabbiata che il piacere sessuale da parte della donna “non si usa, questa è l’abitudine” (Donne di mais, Manifestolibri, Roma, 1997, pag. 76). E la stessa dice ancora al tavolo dei dialoghi: “Quando mai abbiamo goduto nei nostri rapporti sessuali? Mai. Perché mai te lo insegnano ed è triste che questo non si faccia nelle nostre comunità, dicono che è il costume e che così è ovunque per le donne” (pag.174). 3 The Boston Women’s Health Collective, Noi e il nostro corpo. Scritto dalle donne per le donne, Feltrinelli, Milano, 1974 (ed. or. Our Bodies, Ourselves, Shimon and Schuster, New York, 1971). 4 I suoi albori quasi si confusero con il periodo (18301850) di auge di un movimento popolare, il Popular Health Movement, che pretese e praticò un tipo di medicina completamente diverso da quello dei medici “regolari” che uscivano dalle Università. In una prospettiva di classe e femminista si preoccupava anzitutto di garantire le cure mediche agli strati meno abbienti di qualunque etnia e di conservare ed elaborare saperi al tempo certamente più validi dell’aspirante scienza medica delle Facoltà di medicina. 74 vita, emergono puntualmente nelle rivendicazioni e nel dibattito che continua a svilupparsi tra le donne Maya. Privilegiando quelle concernenti la disponibilità del proprio corpo trovo: diritto a vivere una sessualità non solo in funzione della procreazione o del soddisfacimento dell’uomo2, diritto a non sposarsi, diritto ad una unione che non sia necessariamente matrimonio, diritto a scegliersi il marito o compagno anziché dover accettare lo sposo scelto dai genitori, diritto a poter controllare il numero dei figli che si vogliono e si possono allevare, diritto ad un’attenzione particolare per sè e i bambini per la salute e l’alimentazione, diritto all’istruzione (che inizia col diritto a conoscere il proprio corpo e le problematiche della sua “salute riproduttiva”), diritto ai servizi fondamentali, diritto a non subire violenza né in famiglia né fuori. Si chiede inoltre che il lavoro domestico, che assorbe tutta la giornata del corpo femminile, venga ripartito più equamente con gli uomini quale premessa per avere più tempo ed energie per poter portare avanti le proprie istanze. Anche questo in estrema corrispondenza con quanto chiedevamo noi che altrettanto non ponemmmo mai una più equa divisione del lavoro domestico come fine ultimo della lotta su questo fronte bensì come premessa per poter lottare per ottenere condizioni di vita e di lavoro migliori per noi e per gli altri soggetti. La lotta della donna sul lavoro di riproduzione infatti è sempre stata trainante di maggior benessere e autonomia per i soggetti che da lei dipendevano, bambini e anziani anzitutto. Notoriamente noi chiedevamo inoltre che tale lavoro fosse retribuito, ridotto nel tempo e supportato da servizi adeguati, ma degli esiti di questa domanda tratterò nella relazione di domani. All’inizio del nostro movimento facemmo un manifesto in cui era raffigurato un corpo di donna e vi stava scritto: “Di chi è il corpo di questa donna? Della chiesa? Dello stato? Dei medici? Dei padroni? No, è suo”. La risposta non era per niente scontata, e la necessità di affermarlo derivava dal fatto che proprio attorno alla sua sessualità e capacità generativa si contendevano il diritto di dominio, permettere o meno che lei potesse avere una vita sessuale, potesse disporre di anticoncezionali, potesse tenere il figlio avuto senza essere sposata, potesse abortire, padri, mariti, medici, giudici e gerarchie ecclesistiche. La conquista dell’autonomia su questo terreno e nei confronti di queste figure, reimpadronirsi del proprio corpo, comportò di muoversi a diversi livelli, costruire anzitutto su tale corpo quella conoscenza che le donne non avevano. A tal fine fu necessario anzitutto redigere e diffondere piccoli opuscoli con alcune illustrazioni, spesso piccoli disegni fatti in casa, che davano informazioni di base su come erano fatti l’apparato riproduttivo femminile e quello maschile, su quali erano i mutamenti e le necessità attorno alle scadenze della vita biologica femminile (menarca, contraccezione, gravidanza, parto, allattamento, aborto, menopausa), su quali erano le patologie più ricorrenti, come riconoscerle e come curarle, su come imparare a conoscere e sperimentare il territorio della sessualità. Nel 1974 fu tradotto in italiano il famoso Our Bodies, Ourselves3, di un collettivo di donne di Boston che aveva focalizzato il suo impegno sulla questione della salute e della sessualità della donna. Ma l’impegno su questo terreno e sulla salute in generale aveva caratterizzato il Movimento femminista statunitense fin dall’8004. Riemergeva ora come asse portante nel Movimento femminista internazionale degli anni ’70 traducendosi in una attività di “controinformazione” rispetto alle storture o ai silenzi della scienza medica per restituire invece alla donna quel sapere e potere di decisione riguardo a sessualità e pro- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:03 Pagina 75 Di chi è il corpo di questa donna? creazione che la nascita della medicina ufficiale, fin dai suoi albori, con la violenza le aveva tolto5. Era più che urgente lanciare la campagna per l’interruzione volontaria e gratuita di gravidanza da praticarsi nelle strutture ospedaliere (avremmo ottenuto questo con la legge 194/1978), creare mobilitazione attorno ai processi per aborto (quello di Padova del 5 giugno 1973 fece partire la lotta su questo terreno per l’insieme di iniziative che avevamo messo in piedi con tutto il movimento femminista), far emergere che la maggioranza di donne che abortivano erano madri di famiglia già con figli che non potevano permettersi di averne un altro, far emergere che le donne che morivano o rimanevano menomate con l’aborto clandestino erano troppe, che non avremmo permesso altre morti e altre sofferenze (ancora il 7 aprile 1976 muore a Padova per aborto una madre di famiglia di 27 anni con due figli, fatto che determina l’occupazione da parte del movimento delle sedi universitarie dove si insegnava e si praticava la ginecologia). Denunciammo pubblicamente come sull’aborto clandestino (condotto in genere oltre che con mezzi pericolosi, senza anestesia e quindi in mezzo ad atroci dolori della donna) molti medici obiettori costruissero ingenti quanto illeciti guadagni6. Nelle zone rurali del Messico apprendo che 1 donna su 5 è toccata da questa esperienza, e di sovente a seguito di violenze sessuali subite in famiglia7. Auspico che non debba più affrontarla da sola, nelle condizioni, rischiose e dolorose patite anche dalle donne italiane fino a prima dell’insorgenza del movimento, e soprattutto che presto possa avere la disponibilità di quei mezzi8 che permettono di controllare le nascite, e in caso di rapporto dall’esito incerto, mezzi come la “pillola del giorno dopo”, che permettono di evitare l’aborto. Anche il parto9 divenne momento di grandi mobilitazioni e lotte negli ospedali ove pure morivano ingiustificatamente donne che partorivano (tre nel volger di pochi mesi alla Divisione Ostetrica dell’Ospedale civile di Padova) e ove non solo il problema della eccessiva medicalizzazione dell’evento, della totale passivizzazione della donna trasformata in paziente, ma dei gratuiti sadismi (suture senza anestesia tanto per fare un esempio) e dei comportamenti autoritari e arroganti da parte dei medici fecero crescere come risposta una vasta mobilitazione e un movimento per una nascita attiva che intendeva restituire alla donna il ruolo di protagonista di quell’evento e darle diverse condizioni per poterlo vivere come evento naturale, in serenità, con la presenza di persone di sua fiducia. E’da quei tempi che la presenza del marito o di un’altra persona è ammessa in sala parto. Per noi una difficile conquista mentre apprendo che il marito delle donne Maya è presente e coopera a quell’evento. Sarebbero poi nate anche delle vere e proprie “case per il parto”, poche, in grado di fornire assistenza ospedaliera se fosse stata necessaria ma strutturate anzitutto come ambiente domestico ove il parto torna a essere evento naturale e non malattia. Si rivalutò pure che la donna potesse partorire a casa sua ma con la garanzia di un veloce raccordo con l’ospedale in caso di necessità. Si riscoprirono posizioni del corpo femminile per il parto, già praticate nel medioevo e nell’antichità, certamente più naturali e confortevoli per la donna di quella imposta negli ospedali e funzionale solo ai medici. Ora alcuni ospedali, pochi, le rendono praticabili. Sulla questione del parto mi ha colpito una cosa che Guiomar Rovira10 riportava nel suo libro che ho molto apprezzato e cioè che le levatrici del villaggio sapevano girare il bambino nel ventre della madre se si presentava di piedi. Anche da noi le vecchie levatrici sapevano fare questo. Ora quasi nessuno, nè medico nè leva- 5 Ehrenreich B. e English D., Le streghe siamo noi. Il ruolo della medicina nella repressione della donna, Celuc libri, Milano, 1975; S. Federici e L. Fortunati, Il grande Calibano. Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, FrancoAngeli, Milano, 1984, in particolare il capitolo di S. Federici, La caccia alle streghe; S. Federici, Caliban and the Witch. Women, the Body and the Primitive Accumulation , Autonomedia, New York, 2004. 6 Collettivo internazionale femminista (a cura di) , Aborto di Stato. Strage delle innocenti, Marsilio Editori, Venezia, 1976. 7 G. Rovira, op. cit. 8 Mi sembra giusto informare che non sono solo la pillola o il preservativo il mezzo possibile, o il diaframma di cui parlerò più avanti. Sono stati messi a punto ormai dei piccoli dispositivi che la donna può amministrare da sola, dei marcatori che al contatto con la sua saliva determineranno un colore o un altro a seconda che sia o meno in giorni fecondi. 9 Gruppo femminista per il Salario al Lavoro Domestico di Ferrara, (a cura di), Dietro la normalità del parto. Lotta all’Ospedale di Ferrara, Marsilio Editori, Venezia, 1978. 10 G. Rovira ,op. cit. 75 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:03 Pagina 76 n.19 / 2007 11 Gruppo femminista per il Salario al lavoro Domestico di Ferrara, (a cura di), op.cit. 12 Comitato di lotta delle ragazze madri, Ragazze madri in lotta. Documenti e testimonianze delle ragazze madri della Casa della Madre e del Fanciullo di Via Pusiano n. 22, Milano ( raccolta di documenti ciclostilati relativi all’azione condotta), Milano, ottobre dicembre 1973. Vedi anche Lotta femminista di Modena, Madri in azione, ciclostilato che informa sulla storia e l’attività di “Mothers in Action” collettivo di donne sole con figli senza distinzione di razza, religione o nazionalità, presente a Londra dal 1967. 13 M. Dalla Costa, “A proposito del Welfare”, in Primo Maggio, n. 9/10, inverno 1977/78. 14 Movimento di Lotta Femminista di Ferrara, Basta tacere. Testimonianze di donne. Parto, aborto, gravidanza, maternità, (stampato in proprio, senza data). 15 Piaggio, L. C. , Avanti un’altra. Donne e ginecologi a confronto, La Salamandra, Milano, 1976 76 trice, riesce più ad esserne capace e questa eventualità diventa l’ennesima ragione per fare un parto cesareo. Preservare questo sapere, questa professionalità, evidentemente non è giudicato conveniente dalla professione medica. Il parto cesareo invece ha avuto una crescita esponenziale in questi ultimi anni, in certe strutture rappresenta il 40% e più dei parti. Ma si tratta di un’operazione chirurgica, non è un altro modo di partorire. Riguardo al parto avevamo anche denunciato in certi ospedali11 l’alta percentuale di nascite di bambini spastici o lesi per male prassi e per l’uso incompetente del forcipe. In Chiapas invece il neonato può morire per cattive condizioni igieniche o per non avere abbastanza di ciò che serve per sopravvivere. In entrambi i casi la distruzione della lunga cura e fatica della donna e dei diritti fondamentali suoi e del neonato. La condizione della ragazza madre, cioè della donna non sposata che attendeva un figlio, era ancora molto punitiva prima del movimento. Spesso cacciata di casa dalla famiglia, esattamente come le donne Maya, senza sapere dove andare e come fare a continuare la gravidanza e a cercare lavoro per mantenere il bambino. Di sovente doveva lasciarlo ai brefotrofi. Vi erano alcuni istituti per ragazze madri dalle condizioni piuttosto tristi e colpevolizzanti. Facemmo lavoro di intervento con le donne presso questi istituti12. Nella nostra campagna internazionale per il salario al lavoro domestico la figura della donna sola con figli era una figura fondamentale poiché quasi tutti gli stati avanzati destinavano dei soldi e delle facilitazioni a queste donne. L’Italia invece faceva una molto negativa eccezione. Le Family Allowances date dallo stato inglese, o il welfare delle Welfare Mothers negli Stati Uniti13 rappresentavano un primo concreto livello di retribuzione del lavoro di procreare ed allevare figli. Nell’attivismo che dedicammo a questa condizione femminile denunciavamo come lo stato italiano fosse disposto a dare ingenti finanziamenti agli istituti che accoglievano i figli che le donne, per mancanza di mezzi, dovevano abbandonare. Finanziamenti che poi si disperdevano nei rapporti clientelari della politica. Sarebbe stato più logico che desse quel denaro, bastava anche molto meno, alla donna per metterla in condizione di allevare il suo bambino. Più complessivamente le donne, per reimpadronirsi del proprio corpo, misero in discussione e cercarono di reimpostare il rapporto con ogni aspetto della ginecologia. Allora quasi tutti i ginecologi erano uomini, iniziavano appena alcune compagne a laurearsi in questa disciplina e divennero un punto di riferimento fondamentale, così come furono preziosi quei compagni ginecologi che, con la nuova consapevolezza che il movimento femmnista aveva creato, si misero effettivamente dalla parte della donna e prestarono una attività seria e generosa. Particolarmente in questo settore della medicina raccogliemmo testimonianze14 come usavamo fare in tutti i campi in cui ci muovevamo. Fu fatta un’inchiesta15 da parte di alcune compagne di Milano sul modo di funzionare delle strutture pubbliche di questa città, delle donne si prestarono come finte pazienti. Dire che vi era mancanza di rispetto e delicatezza è dire poco. L’autoritarismo medico trovava in questo settore un terreno ancora più facile. E’ significativo quanto emerse negli ambulatori pubblici. Le donne, oltre a dover essere presenti tutte molto presto ad una stessa ora, la qual cosa comportava di aver attraversato la città a ore antelucane per dover attendere poi per larga parte della mattina (scaglionare gli appuntamenti sarebbe stato segno di troppa considerazione), avevano il divieto di parlare fra loro, come annunciava un cartello appeso alla parete. Divieto di comunicazione. La cosa oggi può apparire paradossale. Ben dà l’idea RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 77 Di chi è il corpo di questa donna? comunque del dispotismo della professione medica al tempo. Ma presto il movimento avrebbe infranto quel silenzio obbligato. Nel 1974 a Padova, nell’ottica di avviare un’esemplarità di altro rapporto medico-donna costruivamo il primo consultorio autogestito, ove, come dicevo, anche medici prestarono la loro opera gratuita oltre a numerose donne. Di lì a poco ne sarebbero seguiti altri in altre città16. Si insegnò l’autovisita, si insegnò a usare lo speculum, si insegnò come riconoscere le affezioni più comuni e come curarle, si fece conoscere il diaframma come mezzo anticoncezionale che la donna poteva amministrare da sola senza la necessità del medico e senza costi. Forse per questo fu un mezzo che in Italia non si diffuse mai più di tanto. Ma era un mezzo che le studentesse scoprivano nei loro primi viaggi in Gran Bretagna in quanto molto diffuso nelle strutture di Family Planning di questo paese e scoprivano il senso di autonomia e l’economicità con cui potevano gestirlo. Di lì a poco sarebbe uscita la legge n. 405 del 1975 che istituiva i consultori ma questi sarebbero stati sempre sottodimensionati e carenti quanto a svolgere le funzioni di informazione e prevenzione loro assegnate, ben lontati dall’esemplarità che avevamo voluto costruire. Tali carenze ovviamente erano funzionali al business pubblico e privato sulla malattia. Tra le informazioni che fornivamo c’era quella che già allora esisteva l’iniezione epidurale che avrebbe potuto evitare alle donne i dolori del parto. Ma ottenerla restava una chimera. Le strutture pubbliche consideravano uno spreco, un costo inaffrontabile, avere anestesisti per fare l’iniezione alle partorienti che l’avessero richiesta. Ma soprattutto non si era mai dato che la donna non dovesse patire in quell’evento. Rimaneva ben saldo nella professione medica che la donna non dovesse avere alternative al fatto di soffrire nel parto e, nonostante noi sottolineassimo nei nostri opuscoli che “anche per una carie si fa l’anestesia, perché non si deve farla per i dolori del parto?”, l’obbedienza medica al precetto biblico “Partorirai nel dolore” rimaneva pressocché assoluta. Solo in anni recenti questa forma di anestesia ha cominciato ad essere più presente nelle strutture ospedaliere, penso, data l’impostazione privatistica della sanità, per timore della concorrenza fra strutture che offrono o meno questa possibilità. Quest’anno finalmente il Ministro della Sanità Livia Turco di recente insediato ha deciso che tutti gli ospedali devono offrire questa procedura alle partorienti. Una svolta nella storia del dolore femminile. Altrettanto lo stesso Ministro ha deciso che la “pillola del giorno dopo”, che può evitare aborti in caso di rapporti sessuali a rischio di gravidanza, sia disponibile in tutte le farmacie e venduta senza necessità di ricetta medica. Anche qui finalmente una risposta che riconosce che le donne hanno diritto ad esercitare la sessualità come è sempre stato riconosciuto agli uomini, che i rapporti sessuali in certi casi possono avere esiti incerti, e che in tale evenienza è doveroso fornire alla donna i mezzi di cui oggi la scienza medica dispone per evitare la sofferenza, in ogni senso, dell’aborto. Quanto alla pillola abortiva RU486, che, se assunta entro il secondo mese di gravidanza, evita la procedura più cruenta dell’aborto chirurgico, dallo stesso Ministero ne è stata autorizzata la sperimentazione negli ospedali di tutto il territorio nazionale. Essendo comunque già stata sperimentata da tempo in altri paesi europei ove è anche in vendita, questo equivale alla sua ufficiale accoglienza tra le procedure abortive. Anche qui rompendo con il comandamento della massima sofferenza, è stato messo a disposizione della donna un mezzo che causa almeno, in una scelta sempre drammatica, minor patimento. Resta 16 Jourdan C., Insieme contro. Esperienze dei consultori femministi, La Salamandra, Milano, 1976 77 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 78 n.19 / 2007 17 Per isterectomia si intende l’asportazione chirurgica dell’utero, per ovariectomia l’asportazione chirurgica delle ovaie Ho dedicato all’abuso di questa operazione uno studio che contiene anche molte testimonianze di donne e di medici. M. Dalla Costa (a cura di) Isterectomia. Il problema sociale di un abuso contro le donne, FrancoAngeli, Milano, 1998, 3° ed. 2002 (trad. giapponese, Tokyo 2002; trad. inglese, Gynocide, Autonomedia, New York, 2007). 18 Al confronto con la vicina Francia e sulla base del tipo di patologie per cui viene praticato l’80% di questi interventi appare ingiustificato. Negli Stati Uniti, paese tristemente leader nell’effettuare questa operazione, l’aspettativa di subirla è di 1 donna su 3 entro i 60 anni, del 40% entro i 64 anni. 19 Lotta femminista, Vogliamo decidere noi. Donne, referendum, divorzio, ciclostilato in proprio, marzo 1974. 78 significativo che il metodo Karman cioè il metodo per aspirazione, anch’esso meno cruento dell’aborto chirurgico, riportato alla luce dal Movimento femminista degli anni ’70, era nel frattempo tornato in oblio. Se procreare o interrompere una gravidanza erano stati eventi che una parte di noi aveva incontrato, e su cui quindi avevamo costruito consapevolezza e determinazione per cambiarne le condizioni, non avevamo invece avuto occasione di sperimentare come in età più matura il corpo femminile divenisse oggetto di nuovi abusi, come, senza fondata ragione, ma solo per gli interessi delle strutture sanitarie e della professione medica, venisse di sovente menomato, privato di quegli organi che lo caratterizzavano come corpo di donna. Alludo all’abuso di isterectomie17 non giustificate dalle patologie (accompagnate in circa la metà dei casi da ovariectomie di ovaie sane). Questa operazione ha molti risvolti negativi anzitutto sul piano della sessualità, delle malattie cardiovascolari e della statica pelvica, ma in questi decenni il suo abuso ha caratterizzato la prassi medica in molti paesi avanzati. In Italia vi è l’aspettativa di subire questo intervento per una donna su 5, in alcune regioni come il Veneto ove vivo, 1 su 4.18 Questa è quindi la terza grande battaglia che il corpo femminile deve affrontare dopo quelle del parto e dell’aborto, in diverse regioni del mondo, avanzate e non, per difendere la sua integrità e la qualità della sua vita nell’età matura di contro alla violenza e all’abuso della scienza medica. L’approccio medico che sostiene questo abuso conferma la concezione della donna come macchina di riproduzione. Quando ha già partorito il numero di figli desiderato, o comunque è vicina (spesso purtroppo non vicina) all’età di menopausa, affermano molti medici, meglio asportare quegli organi che non servono più e che forse potrebbero un giorno contrarre serie malattie. Quegli organi invece, utero e ovaie, contano molto per la salute e il buon equilibrio ormonale della donna prima e dopo la menopausa. Ma agli occhi di troppi ginecologi non conta la donna come persona, non conta l’integrità del suo corpo, tanto meno la sua sessualità che spesso questa operazione compromette. Soprattutto per le aziende ospedaliere è profittevole fare molte operazioni. E per la professione medica è bene avere al suo attivo molti di questi interventi che rappresentano l’operazione più importante della ginecologia. E’ una battaglia questa in cui la conoscenza del proprio corpo, la determinazione a salvaguardarlo e una larga comunicazione fra donne sono cruciali. Sono anche sorti nel web siti attivati da gruppi di donne che informano su questa operazione e molte pazienti che l’hanno subita offrono la loro testimonianza. Il 1974 era stato un anno particolarmente importante. Avevamo anche vinto con tutte le donne il referendum sul divorzio19, avevamo ottenuto che questo istituto in vigore nella nostra legislazione da pochi anni, non venisse abolito condannando le donne, e gli uomini, a scelte irreversibili qualunque cosa succedesse o si rivelasse a posteriori in quei matrimoni. Una vittoria, quella del movimento, contro una dispotica condanna ad una vita di sofferenza senza possibilità di riscatto. L’altro grande tema concernente il corpo femminile fu quello della violenza, violenza sulla donna adulta o sulla donna bambina. Leggendo di come nei villaggi Maya spesso alla donna succede di subire violenza in famiglia oltre che fuori mi veniva alla mente come cominciammo a scoprire la violenza che le bambine subivano a casa dai temi che svolgevano alle scuole elementari. Temi cui le donne del movimento che facevano le insegnanti cominciarono a prestare particolare RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 79 Di chi è il corpo di questa donna? attenzione. Ma subito scoprirono anche la situazione di estrema impotenza in cui la madre si dibatteva: se il marito veniva denunciato e andava in prigione chi avrebbe mantenuto la famiglia? Come avrebbe reagito il contesto, spesso rurale, in cui la famiglia viveva, nei confronti di quella famiglia? Come avrebbe reagito il marito una volta tornato a casa? Problematiche molto simili a quelle incontrate dalle donne Maya. Per i casi di violenza nei confronti di donne adulte costruimmo molta mobilitazione determinando soprattutto, con la nostra battagliera presenza nei processi contro chi aveva esercitato violenza, che la vittima non fosse trasformata in imputata da giudici, avvocati e uomini in generale. Decidemmo che era una cosa intollerabile, indice della mancanza di considerazione per la donna come persona, il fatto che la violenza sessuale su di lei fosse rubricata nel codice penale tra i reati contro la morale e il buon costume e non tra i reati contro la persona, e lavorammo perché fossero meglio determinate le casistiche e le pene. Furono fatti vari progetti di legge in merito ma nessuno passò per vent’anni. Si dovette arrivare al 1996, con la legge n. 66, perché la violenza sessuale contro la donna fosse rubricata fra i reati contro la persona anziché contro la morale e il buon costume, le pene inasprite e le casistiche catalogate con più attenzione. Nel frattempo però l’onda lunga della nostra azione e del nostro dibattito avrebbe generato il sorgere di associazioni di donne20 che avrebbero fatto crescere una consapevolezza diversa e quindi determinato un atteggiamento più rispettoso da parte di operatori e operatrici di quelle sedi (ospedali, questura, tribunale) attraverso cui avrebbe dovuto passare la donna che denunciava la violenza. Oggi la guida telefonica di alcuni comuni, Padova inclusa, offre tra i numeri di pubblica utilità quello del “Servizio antiviolenza donna”. Altri comuni, di paesi di campagna, si oppongono al fatto che le donne costruiscano un centro antiviolenza perchè considerano disdicevole che questi fatti escano dalle mura domestiche, “ i panni sporchi si lavano in casa”. Perché questo dominio, controllo altrui, sul corpo della donna e la sua impossibilità o per lo meno difficoltà a disporne? Perché tanta inerzia delle istituzioni per quanto in alcuni luoghi l’attività del movimento abbia fatto poi generare iniziative che in qualche modo la affrontano? La risposta sta in un altro manifesto che ritrae un corpo di donna rannicchiato e compresso dalle mura di una casa e che reca scritto: “Il lavoro domestico sostiene il mondo ma soffoca e limita la donna”. Appunto, il suo corpo deve essere imprigionato per erogare quel lavoro domestico gratuito che sostiene il mondo e, nel mondo, anzitutto gli uomini. Ma tale risposta sta prima ancora nelle raffigurazioni di donne accusate di stregoneria e fatte ardere sui roghi che imperversarono per l’Europa attraverso il XVI e XVII secolo causando una morte atroce a centinaia di migliaia di donne, molte delle quali levatrici e guaritrici in seno al popolo, colpevoli solo di sapere del parto, dell’aborto e delle pratiche anticoncezionali21. L’espropriazione delle donne del loro corpo e la trasformazione di questo in macchina riproduttrice di forza-lavoro iniziò appunto cinque secoli fa, agli albori del capitalismo, quando la forza lavoro divenne la merce più preziosa, ed ebbe al cuore lo stravolgimento della sessualità femminile in funzione procreativo-riproduttiva di altri. Sul rogo delle streghe si distrusse non solo un sapere ostetrico ginecologico che era sempre stato in mano alle levatrici in un rapporto paritario con le altre donne ma si forgiò il modello di donna che la famiglia del nascente capitalismo esigeva: donna isolata, sessualmente repressa, sottomessa all’autorità del marito, fattrice di figli, priva di auto- 20 A Padova ha condotto questo tipo di attività, oltre a quella di supporto per le donne che avevano subito violenza, il Centro Veneto Progetti Donna per iniziativa di Lucia Basso, una femminista che era stata molto attiva nel Comitato per il Salario al Lavoro Domestico di questa città e aveva con altre costituito il Gruppo Donne Ospedaliere che ebbe un ruolo molto importante nelle lotte negli Ospedali sulla salute della donna. 21 S. Federici, L. Fortunati, op. cit.; S. Federici, op. cit. 79 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 80 n.19 / 2007 22 Questa tematica è stata approfonditamente analizzata in Giovanna F. Dalla Costa, Un lavoro d’amore. La violenza fisica come componente essenziale del “trattamento”maschile nei confronti delle donne, Edizioni delle donne, Roma, 1978 (trad. giapponese, Ai no rodou, Impact Shuppankai Tokyo, 1991; in via di pubblicazione in inglese con Autonomedia, New York). 23 In Europa i primi Centri antiviolenza o Case delle donne (che hanno subito violenza) sorgono sul finire degli anni ’70. In Italia, al di là delle iniziative messe in piedi dal movimento femminista degli anni ‘70, sorgono nei primi anni ‘90. Sono sostenuti da finanziamenti pubblici e lavoro volontario. Oggi ne esistono più di ottanta, di cui circa un quarto offre ospitalità in un appartamento segreto chiamato anche rifugio. Le prime quattro Case per donne che subiscono violenza sono sorte tra il 1990 e il 1991 a Bologna, Milano, Modena e Roma. 24 Canale 5, venerdi 29 settembre 2006, ore 13,30. 80 nomia economica nonché di sapere e potere di decisione riguardo a sessualità e procreazione. Ma soprattutto con quell’espropriazione omicida lo stato avocava a sè, sottraendolo al sapere delle donne, il controllo sulla riproduzione della forza-lavoro, avvalendosi della mediazione della nascente professione medica a sua volta sotto il controllo dello stato e della chiesa. Il modello di donna forgiato sul rogo era ancora vero in Italia subito prima che il movimento cominciasse a rifiutarlo. Come fu denunciato e analizzato già negli anni ’70, quindi, il dominio maschile sul corpo della donna è funzionale a poterne estrarre il massimo di lavoro anzitutto domestico e a poter assicurare la soddisfazione delle esigenze sessuali dell’uomo senza che questi debba confrontarsi con le esigenze femminili (da cui anche la funzionalità della non conoscenza del sesso da parte delle donne). La violenza interviene come strumento disciplinatorio in questo rapporto di lavoro in cui non c’è il potere disciplinatorio di un salario22. Interviene quando l’erogazione del “mantenimento”, che è quanto la donna ha in cambio del suo lavoro in base al contratto matrimoniale, non basta a garantirgli una determinata quantità e qualità di lavoro. Ma dobbiamo intendere lavoro domestico nella sua complessa accezione di lavoro di riproduzione, combinato di mansioni materiali e immateriali, per capire in quanti casi tale violenza possa esplodere, tanto più nel tempo presente in cui le donne almeno in parte si sono riappropriate del loro corpo e dei suoi desideri. Resta comunque significativo come ancor oggi, da quanto riferiscono esponenti di alcuni Centri antiviolenza23 in Italia, emerga che spesso la causa scatenante della violenza maschile sia che lei si rifiutava di fare i lavori domestici o non li faceva come lui desiderava. Cioè la donna “poco portata” o poco addestrata nel lavoro domestico (certamente lo è molto meno delle generazioni precedenti) è più a rischio di violenza. Aggiungiamo che oggi è sempre più rara l’ipotesi di un salario maschile che possa garantire il mantenimento della moglie e dei figli. Piuttosto sono i due salari precari di lui e di lei a garantirlo. Da cui deriva che il sentirsi obbligata al lavoro domestico da parte della moglie è certamente ancor meno radicato. Quanto all’inerzia delle istituzioni, vera a livello mondiale, e che in varie regioni italiane è ancora molto pesante, trova largamente ragione come già era stato analizzato negli anni ’70, nella funzionalità dell’offrire all’uomo una valvola di sfogo rispetto alle frustrazioni del lavoro e della vita. Offrirgli qualcuno, la donna, si cui avere ed esercitare potere. Aggiungiamo anche la complicità maschile degli operatori negli ospedali, nelle questure, nei tribunali quale si è sempre data e quale continua in situazioni meno toccate da un lavoro di sensibilizzazione e formazione. Oggi, come ripeto, si sono aperte alcune situazioni in queste sedi in cui vi è una maggiore competenza e sensibilità, grazie anche alla presenza di donne ove un tempo o erano del tutto assenti o erano presenti in numero irrilevante. Ma tale lavoro di formazione e sensibilizzazione ha dato comunque esiti positivi anche sugli operatori uomini. Rimane il fatto che mentre si sono allargate le iniziative volte ad offrire almeno punti di riferimento per un primo aiuto alle donne colpite da violenza e si è fatta, come dicevo, attività di sensibilizzazione e formazione degli operatori, si sono moltiplicate forme di violenza sulla donna ancora più efferate, con torture ed esiti mortali, spesso condotte dal branco, uomini in gruppo. Per quanto concerne la violenza all’interno della coppia un servizio televisivo di questi giorni24 riportava che dal 2000 al 2005 nel nostro paese 405 di questi casi si sono conclusi con l’omicidio della donna. Moltissime donne che subiscono violenza non spor- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 81 Di chi è il corpo di questa donna? gono denuncia ma sta aumentando il numero di quelle che lo fanno. In un contesto sociale in cui la dimensione neoliberista riduce a merce la vita umana e il corpo fisico e sociale che la racchiude la sessualità della donna resta una merce che, emergendo da un recente passato di scarsa o nulla considerazione come diritto della sua persona, può essere tranquillamente rapinata. Quel corpo di donna, secondo il punto di vista di ancora troppi uomini, in fondo non è suo, è dell’uomo che se lo prenderà. I movimenti delle donne si trovano quindi a mettere a punto reti di difesa e nel contempo a dover fronteggiare un attacco sempre più duro. In questi mesi la contesa sul corpo della donna, la contesa su chi è il padrone del suo corpo, ha visto in Italia verificarsi due casi drammatici conclusisi con la morte della donna. Una giovane immigrata pakistana che aveva deciso di vivere come vedeva vivere altre donne italiane, lavorando e coabitando con il suo compagno, è stata uccisa per decisione del padre per aver scelto questa vita anzichè accettare di essere data in sposa ad un uomo scelto dai suoi genitori. Una giovane donna indiana rimasta vedova si è invece uccisa stendendosi sui binari del treno perché non voleva accettare di essere data in sposa al fratello del marito e voleva inoltre che i suoi due bambini potessero continuare a vivere in Italia dove erano andati a scuola e dove avevano costruito la loro formazione e avuto le loro prime amicizie. Ha lasciato scritto che pregava il comune di prendersene cura in tal senso. Sono due casi significativi di come la globalizzazione, nei flussi di emigrazione-immigrazione che genera, veda anche un planetario processo di confronto ed elaborazione dei diritti e della loro condizione da parte delle donne. Veda crescere una determinazione ad ogni costo a reimpadronirsi del loro corpo non più come macchina da lavoro comandata da altri ma come loro corpo che desidera e decide. Quello che i movimenti che si sono dati un quarto di secolo fa nei paesi avanzati hanno vinto attorno alla disponibilità del proprio corpo costituisce momento di confronto e di forza per altre che affrontano oggi questa non facile battaglia. Il diritto più fondamentale, poter disporre appunto del proprio corpo, delle emozioni e sentimenti che genera, non essere ingabbiate una volta per tutte in matrimoni con uomini non scelti, poter controllare il numero dei figli, poter decidere di non avere figli, di non sposarsi e avere comunque un posto rispettato nella società, la dignità anche della solitarietà, tutto questo è sempre più una posta irrinunciabile. E’ vero: avere denaro proprio, poter avere ed ereditare la terra, avere istruzione, avere i servizi fondamentali, sono tutti strumenti importantissimi nella costruzione dell’autonomia della donna. Cionondimeno la battaglia sulla riconquista del proprio corpo non può essere rimandata, nè subordinata ad altre scadenze, e deve approntare la sua strumentazione per essere condotta. In questo senso sono partita dai nostri piccoli opuscoli degli anni ’70 e dalle iniziative che allora conducemmo per cominciare a scoprire e liberare il nostro corpo. Riferimenti bibliografici BOSTON WOMEN’S HEALTH COLLECTIVE, Noi e il nostro corpo. Scritto dalle donne per le donne, Feltrinelli, Milano, 1974 (ed. or. Our Bodies Ourselves, Shimon and Schuster, New York, 1971). COLLETTIVO INTERNAZIONALE FEMMINISTA (a cura di) Aborto di stato: strage delle innocenti, Marsilio Editori, Venezia, 1976. 81 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 82 n.19 / 2007 COMITATO DI LOTTA DELLE RAGAZZE MADRI, Ragazze madri in lotta. Documenti e testimonianze delle ragazze madri della Casa della Madre e del Fanciullo di Via Pusiano n.22 Milano, Milano, ottobre-dicembre 1973. DALLA COSTA Giovanna, Un lavoro d’amore. La violenza fisica come componente essenziale del “trattamento” maschile nei confronti delle donne, Edizioni delle donne, Roma, 1978 (trad. ingl. in via di pubblicazione con Autonomedia, New York). DALLA COSTA Mariarosa, “A proposito del welfare”, in Primo maggio, n. 9/10, inverno 1977/78. DALLA COSTA Mariarosa (a cura di) Isterectomia. Il problema sociale di un abuso contro le donne, FrancoAngeli, Milano, 1998, 3° ed. 2002 (trad. inglese, Gynocide, Autonomedia, New York, 2007). EHRENREICH B. e ENGLISH D., Le streghe siamo noi. Il ruolo della medicina nella repressione della donna, Celuc Libri, Milano, 1975. FEDERICI S. e FORTUNATI L., IL grande Calibano. Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, FrancoAngeli, Milano, 1984. FEDERICI S., Caliban and the Witch. Women, the Body and the Primitive Accumulation, Autonomedia, New York, 2004. FEDERICI S., La caccia alle streghe, in FEDERICI S. e FORTUNATI L., IL grande Calibano. Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, FrancoAngeli, Milano, 1984. GRUPPO FEMMINISTA PER IL SALARIO AL LAVORO DOMESTICO DI FERRARA (a cura di), Dietro la normalità del parto. Lotta all’Ospedale di Ferrara, Marsilio Editori, Venezia, 1978. HARRISON Lieta, La donna sposata. Mille moglli accusano, Feltrinelli, Milano, 1972. JOURDAN C., Insieme contro. Esperienze dei consultori femministi, La Salamandra, Milano, 1976. LOTTA FEMMINISTA, Vogliamo decidere noi. Donne, referendum, divorzio, ciclostilato in proprio, marzo, 1974. MOVIMENTO DI LOTTA FEMMINISTA di FERRARA, Basta Tacere. Testimonianze di donne. Parto, aborto, gravidanza, maternità (stampato in proprio senza data). PIAGGIO L. C., Avanti un’altra. Donne e ginecologi a confronto, La Salamandra, Milano, 1976. ROVIRA Guiomar, Donne di mais. Voci di donne dal Chiapas, Manifestolibri, Roma, 1997. 82 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 83 Mariarosa Dalla Costa Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura nelle nuove emergenze* Il Faro Ogni costruzione di autonomia ha una sua storia che nasce in un contesto e deve affrontare precisi ostacoli e battaglie. Ieri ho accennato alle prime tappe di questa storia attraverso le iniziative di quel movimento femminista in cui ho direttamente agito, le tappe per riconquistare da parte della donna la disponibilità del proprio corpo. Ho anche ricordato come a livello planetario questa battaglia sia lungi dall’essere conclusa. Qui vorrei considerarne altri aspetti partendo sempre dai momenti iniziali di quell’esperienza politica per arrivare a valutare il rapporto autonomia - donna oggi di fronte ad alcuni problemi emergenti e rivisitando anche, alla luce di questi, cosa ne è stato della rivendicazione di una retribuzione del lavoro domestico (o di cura) e dell’autonomia economica della donna. * Relazione prodotta al convegno “La autonomia posible”, Universidad autonoma de la Cìudad de Mexico, 24-25-26 ottobre 2006 Atto primo. C’è oggi una grande esaltazione delle differenze. Ma sento sempre l’esigenza che si specifichi di che differenza si tratta, da quale punto di vista e per chi costituisce un problema, a vantaggio o a svantaggio di chi. E’il solo modo per mettere a fuoco la questione e cercare soluzioni. Noi ci accontentammo, ai tempi del movimento, di indicare una differenza, gerarchizzante: quella di essere, in quanto riproduttrici della forza lavoro, lavoratrici non salariate in un’economia salariale rispetto agli uomini destinati, nella divisione sessuale capitalistica del lavoro, ad essere, in quanto produttori di merci, lavoratori salariati. E lavorammo su quello. La cosa ci bastò a tenerci occupate una decina di anni. Il resto seguiva da questo fatto fondamentale. Chiedendo un salario per il lavoro domestico volevamo attaccare la stratificazione capitalistica del lavoro a partire dalla sua divisione più profonda, quella fra lavoro maschile di produzione di merci e lavoro femminile di produzione e riproduzione di forza lavoro. Ma se questo lavoro è vitale per il capitalismo in quanto produce e riproduce la sua merce più preziosa, la forza lavoro stessa, avevamo in mano una leva formidabile di potere, potevamo rifiutare di produrre e, a partire da questo, potevamo pretendere un nuovo tipo di sviluppo che avesse al centro diverse condizioni per la cura degli umani: anzitutto l’autonomia economica della donna e una più equa ripartizione del lavoro di cura con gli uomini. Per questo chiedevamo anche una drastica riduzione del tempo di lavoro esterno in generale in modo che tutti, uomini e donne, potessero condividere la fatica ma anche il piacere della riproduzione. Quindi tempo, denaro e servizi erano in quegli anni gli elementi fondamentali delle nostre rivendicazioni. 83 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 84 n.19 / 2007 Il momento alto dei movimenti in Italia alla fine degli anni ’60 inizio anni ‘70 costituì la nostra palestra di militanza, l’arena in cui molte di noi impararono a lottare e ad analizzare quella perversa cosa che era lo sviluppo capitalistico. Io stessa alle mie prime armi all’Università (avevo iniziato a lavorarvi nel 1967) facevo lettorati sul Capitale agli studenti ma prima andavo, in albe lattiginose e piene di zanzare, a volantinare a PortoMarghera scoprendo cosa era una fabbrica, i suoi ritmi, la sua nocività, la sua storia. Poiché le fabbriche, ricordo che scrissi su un volantino cercando di spiegare il concetto, non sono come gli alberi che esistono da sempre... Non ricordo affatto quel periodo come momento di società conviviale, come altri scrissero di ricordare. Era piuttosto un periodo di grande apprendimento, di grande austerità di vita, di molto sacrificio e tenacia, di molta determinazione. Forse la cosa più bella era l’immediatezza dei rapporti, il loro significato di riconoscersi attivi in una stessa causa, il generarsi di questa grande comunità cui si apparteneva. Non occorreva fissare appuntamenti per incontrarsi, tutti sapevamo dove gli altri si trovavano, vi era una vita comune. Visto da un punto di vista di donna quel passaggio costituì senz’altro la forte emancipazione dalla famiglia di origine e dalle sue attese, l’aver trovato un territorio libero e amico da dove scoprire il mondo senza essere costrette presto al matrimonio. Un territorio ove imparare cose diverse da quelle necessarie per essere una buona moglie. Si, come per le insurgentes dell’Ezln. La domanda “quando ti sposi” rimase sempre più inevasa. Ma proprio quella capacità, che avevamo elaborato, di avvertire il problema e analizzarlo, ci fece a un certo punto scoprire che da parte di noi donne in quei rapporti c’era comunque della sofferenza e del disagio. Perché tutti i rapporti sono comunque rapporti di potere, anche nella rivoluzione sessuale che pure avvenne, e tutto quello che noi rappresentavamo e facevamo come donne continuava comunque a valere molto poco e non essere riconosciuto. Soprattutto ci sentivamo scisse fra un imperativo che ci voleva omologate agli uomini, capaci di essere e fare come loro, e sentire invece di appartenere comunque a un altro mondo dove anche gli uomini venivano a chiederci cose diverse e si aspettavano che fossimo diverse. Ma poi la finestra si richiudeva su quel mondo che rimaneva senza nome. Una specie di clandestinità della femminilità. Di lì a poco saremmo uscite dalla clandestinità, saremmo passate dalla resistenza all’attacco. Già nel corso del 1970 iniziai l’elaborazione del nuovo percorso, l’analisi e la strada femminista che avrei intrapreso. Ma indico in genere il 1971 come anno della svolta, perché nel giugno di quell’anno a Padova, invitando alcune compagne a discutere un documento che avevo redatto, feci la prima riunione femminista. Diedi avvio a quella formazione che si sarebbe chiamata Lotta femminista trasformatasi poi nella rete dei Comitati e Gruppi per il Salario al Lavoro Domestico presente a livello nazionale e internazionale. Il distacco dai compagni non fu indolore. Il fatto che dovessero essere contenti che con nuove lotte ampliavamo il fronte anticapitalstico era una nostra ipotesi che non trovò molto riscontro. Anzi, se loro consideravano cruciali alcune battaglie, le donne, volendo privilegiarne altre, rappresentavano una forza militante sottratta a quelle lotte. Scontammo anche il punto di vista che non essendo sotto i loro occhi nelle stesse azioni “non stavamo facendo nulla”. Come non avevano visto il nostro lavoro domestico non vedevano il nostro autonomo lavoro politico. Scontammo l’accusa, specie agli inizi, che rischiavamo di occuparci di cose che non portavano 84 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 85 Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura avanti un punto di vista di classe, erano interclassiste, per esempio l’aborto e la violenza, che riguardavano appunto tutte le donne. Inoltre le donne in movimento cambiavano e i rapporti, anche personali, si rompevano. Quando cominciammo a parlare di lavoro domestico la prima reazione sul fronte maschile fu un sorriso irrisorio. Ma di cosa andavamo a far questione, in fondo non era una gran cosa, nemmeno un lavoro nel senso vero del termine, e con gli asili si sarebbe risolto ogni problema. Questa strana idea che con gli asili, cioè con alcune ore di custodia dei bambini, si sarebbe esaurita ogni problematica relativa al lavoro domestico, durò a lungo. Non c’era minimamente idea del complesso di incombenze materiali e immateriali, prevedibili e imprevedibili, che costituiscono il quotidiano corredo di questo lavoro. Anche noi subimmo l’accusa di separatismo, di voler dividere il movimento, in realtà credo che non potesse più essere possibile parlare di lotta anticapitalistica senza vedere quanto lavoro non pagato il salario comandava, anzitutto il lavoro domestico delle donne, e quindi senza mettere in conto la loro “insorgenza”. A Roma il 7 luglio 1972 avevamo organizzato all’Università un seminario sull’occupazione femminile. Avevamo deciso che dovesse essere aperto solo a donne. Una novità assoluta, non si era mai dato all’Università. La reazione di gruppi di uomini, genericamente definitisi compagni, fu di impedire che il seminario avesse luogo lanciando da fuori all’interno dell’aula preservativi colmi d’acqua che infransero i vetri. Ne seguì un acceso dibattito sui giornali Il Manifesto e Lotta Continua1, che dà l’idea dell’aria dei tempi. Il solo fatto che le donne si riunissero da sole poteva suscitare reazioni violente. Non corrisponderebbe a verità assolutizzare reazioni come queste. Vi erano anche compagni che capirono la centralità del nostro discorso, l’importanza del lavoro che portavamo avanti e si comportarono di conseguenza. Ma quell’episodio resta significativo della risposta isterica maschile che ci poteva essere di fronte a questo fatto nuovo, l’autonomo analizzare e discutere da parte delle donne non in presenza di uomini. Riguardo all’accusa di separatismo voglio precisare che noi non teorizzammo mai il separatismo ma l’autonomia. Ciononostante vi sono almeno tre buone ragioni per cui noi, come molte altre, dovemmo lavorare separatamente: che la presenza degli uomini, proprio per il rapporto di potere che avevano nei confronti delle donne, avrebbe condizionato la nostra capacità di parlare, di far emergere e analizzare approfonditamente le questioni che più direttamente ci toccavano, e, per alcune di queste, avrebbe certamente creato del disagio; che tali questioni erano talmente grandi che avrebbero assorbito tutte le nostre energie, e quindi, come dissi anche in altre occasioni, la doppia militanza (nel femminismo e in qualche gruppo extraparlamentare) non ci riguardò mai perché non ne avremmo avuto il tempo; infine, se i comportamenti dei compagni erano anche una ragione della nostra separatezza, dovevano affrontare loro il problema di mutarli. Rovesciando l’accusa potevamo dire che erano i loro comportamenti maschilisti a dividere il movimento. Da quanto apprendo l’accusa ritorna anche per l’autonomo organizzarsi delle donne Maya. Ma ritengo che solo le donne che vivono una determinata situazione possono decidere quanto separatamente e quanto assieme possono condurre un ciclo di lotte. Resta fermo però che quanto “assieme” è un problema che deve porsi anche dall’altra parte, da parte degli uomini in sostegno delle istanze sollevate dalle donne, perché in genere il sostegno si dà da una parte sola, quella femminile. In Italia le ragazze di oggi che sono attive su una qualche questione, spesso la 1 Il Manifesto 14 e 20 luglio, 4 agosto, Lotta Continua 15 e 21 luglio, 1 agosto 1972. Vedi anzitutto L’Offensiva. Quaderni di Lotta Femminista n. 1, Musolini Editore, Torino, 1972 che raccoglie le relazioni destinate a quel seminario e il materiale militante che uscì attorno a quel momento di scontro. 85 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 86 n.19 / 2007 2 Si è fatto particolarmente sentire in questi anni il tentativo da parte di forze cattoliche di rimettere in discussione la legge 194/78 che autorizza l’interruzione volontaria di gravidanza. La Regione Veneto ha presentato un progetto di legge regionale per autorizzare la presenza di esponenti di queste forze presso i consultori e le corsie degli ospedali. In risposta a tutto ciò le donne hanno deciso di farsi sentire, e, anche con l’adesione della Cgil (Confederazione generale italiana del lavoro) hanno organizzato una manifestazione a Venezia il 7 ottobre 2006 all’insegna di “Usciamo dal silenzio”. Era infatti dai tempi del movimento femminista degli anni ’70 che le donne non facevano sentire con tanta forza la loro voce. E questa volta molti uomini partecipando alla manifestazione hanno sostenuto la causa delle donne. 3 Se in Europa i primi Centri antiviolenza o case delle donne (che hanno subito violenza) sono sorti sul finire degli anni ’70, in Italia, al di là delle iniziative messe in piedi dal movimento femminista, bisogna aspettare i primi anni ’90. Significativamente deve passare un decennio di repressione e normalizzazione prima che si comincino a costituire i Centri antiviolenza. Oggi ne esistono più di ottanta, di cui circa un quarto offre ospitalità in un appartamento segreto chiamato anche rifugio. Le prime quattro case per donne che subiscono violenza sono sorte tra il 1990 e il 1991 a Bologna, Milano, Modena e Roma. 86 precarietà del lavoro o la trasformazione dell’Università, considerano una cosa inaccettabile lavorare politicamente separate dai loro compagni, non ne sentono l’esigenza. Ma evidentemente godono delle acquisizioni vinte dalle loro madri, dal movimento femminista degli anni ’70. Il rapporto con i loro compagni è più paritario, la strada dura del reimpadronirsi del loro corpo è stata in gran parte percorsa da chi le ha precedute, anche se non mancano le forze politiche che cercano sempre di far arretrare la libertà della donna2, vi sono oggi mezzi per vivere la sessualità con meno rischi di un quarto di secolo fa. Comunque, anche se si rimane incinte, è improbabile essere cacciate di casa e anzi varie donne decidono di voler portare avanti una maternità indipendentemente dal rapporto con un uomo. Determinate ad avere un figlio, meno convinte di imboccare un tipo di vita dove è necessario mediare quotidianamente le proprie scelte con quelle di un compagno. Determinate ad interrompere il rapporto, anche maritale, se non è soddisfacente. Su altre questioni invece sono nate varie associazioni solo o prevalentemente di donne, prima di tutto quelle dei Centri antiviolenza3. Quindi una situazione composita, dove a seconda della questione, si avverte l’esigenza di lavorare solo fra donne o meno, in un quadro comunque non paragonabile a quello del movimento degli anni ’70. Oggi l’organizzarsi come associazioni in rapporto con le istituzioni, ha preso il posto dell’azione dei gruppi spontanei che funzionarono come testa d’ariete abbattendo le porte delle molte prigioni in cui erano rinchiusi i diritti delle donne. Le associazioni cercano di monitorare la situazione e offrire un primo riferimento ed aiuto per chi continua ad essere vittima della violazione di quei diritti. Ci fu chiaro da subito che costruire autonomia per le donne comportava una grande battaglia. Dovevamo attrezzarci. Emerse immediatamente che il nodo difficile da sciogliere era la maternità, scelta irreversibile che condiziona tutta la vita femminile, e che non si risolveva col portare i bambini all’asilo. Ma soprattutto ci fu chiaro che il rifiuto del lavoro, che pure condividevamo come mezzo di lotta, non era applicabile in tutti i casi al lavoro di riproduzione, al lavoro di cura. Spingemmo il rifiuto al rifiuto del matrimonio, al rifiuto della coabitazione con uomini per non vedere le nostre energie assorbite dal dover rispondere alle aspettative maschili (una donna in casa è sempre di turno, dicevamo) ma non avremmo mai potuto avere un figlio e rifiutarci di curarlo, allevarlo. Il lavoro di cura in quanto inerisce ad esseri umani poneva dei limiti precisi alla nostra azione, prospettava situazioni in cui la strategia del rifiuto appariva impraticabile, un’utopia. In cuor nostro dovemmo decidere. Quelle di noi più impegnate nel lavoro organizzativo rinunciarono ad avere figli perché sarebbe stato incompatibile non solo con la mole di lavoro politico che ci prefiggevamo per riuscire a rendere il mondo un po’ più lunare (per richiamarmi all’antica divinità Maya metà luna e metà sole), ma incompatibile soprattutto con la disponibilità mentale a programmare ed affrontare le scadenze e gli imprevisti del nostro agire. Anche qui in perfetta corrispondenza con la decisione di molte insurgentes in Chiapas, data l’impossibilità di coniugare maternità e quel tipo di militanza. Ma la maternità divenne un punto cardine del nostro discorso: se la produttività della famiglia capitalistica e del corpo femminile passava per la produzione di figli, la liberazione della donna passava anche attraverso il rompere con questa imposizione, con questa unicità di funzione ascritta, con la fissità di questo ruolo. Da cui lo slogan “Donne partoriamo idee non solo figli!”, un grido di liberazione dal comandamento biologico, un invito a una creazione diversa, partorire idee RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 87 Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura che riuscissero a generare un altro mondo dove il ruolo di moglie-madre non costituisse l’unica identità possibile né fosse pagata a tale prezzo di fatica, isolamento, subordinazione, mancanza di autonomia economica. Per questo appunto avanzammo la richiesta di retribuzione del lavoro domestico, per respingere la sua attribuzione gratuita esclusivamente al genere femminile, perché l’autonomia economica della donna si costruisse a partire dal riconoscimento di quel primo lavoro. Nel rifiuto della maternità interpretammo un comportamento che si sarebbe sempre più diffuso in Italia come in altri paesi avanzati e, più recentemente anche in paesi non particolarmente avanzati4, causando da noi un tasso di natalità di 1, 2 giudicato molto negativamente dai politici5. Non solo la richiesta, ma soprattutto la prospettiva di far costare il lavoro di riproduzione in tutti i luoghi che questo lavoro sosteneva, portò le nostre lotte, un tipo di lotta diversa da quelle che fino allora si erano date, nei quartieri, nelle scuole, nelle Università, nelle fabbriche, negli ospedali. Sarebbe impossibile trattarne qui, comunque tutto è stato puntualmente documentato nel materiale usato sul fronte militante: volantini, pamphlets, giornali, piccoli libri6. Ma quale fu la risposta dello stato a tutto questo, a quell’autonomia che le donne avevano iniziato a costruire reimpadronendosi del loro corpo ma che richiedeva di radicarsi in un’autonomia economica a partire dal riconoscimento del loro primo lavoro? La risposta fu fondamentalmente un po’ più di emancipazione. Assieme, verso la fine degli anni ’70, ad un’azione di repressione di tutti i movimenti. Dal 1972 al 1979 l’occupazione femminile aumentò di un milione e mezzo di unità. Passò il nuovo diritto di famiglia7 incardinato sulla parità dei coniugi (anche questo corrispondeva all’esigenza di non subordinare necessariamente alla volontà del marito le scelte di una moglie che sempre più veniva chiamata sul mercato del lavoro). Ma il salario reale diminuì, e durante gli anni ’70 il potere d’acquisto delle famiglie fu garantito piuttosto da un più largo coinvolgimento nel mondo del lavoro, spesso in nero, dei vari membri della famiglia nel nuovo quadro offerto dal decentramento produttivo8. Questa da allora si sarebbe retta di norma sulla presenza di almeno due buste paga che il passaggio dal fordismo al postfordismo e quindi alla globalizzazione neoliberista avrebbe sempre più precarizzato. Perciò lo stato riuscì ad eludere la domanda che sul piano economico il movimento delle donne aveva avanzato, le donne raccolsero quel tipo di autonomia che solo veniva offerto, cioè l’emancipazione, ma non fecero il miracolo di coniugare ad ogni costo lavoro gratuito familiare con presenza di figli e lavoro esterno. Molte non si sposarono mai, molte decisero di vivere da sole, aumentarono i divorzi e le separazioni9, la caduta della natalità continuò. Il rifiuto femminile della procreazione innescò quel tipo di crisi della riproduzione sociale che si sarebbe più tardi rappresentato nello squilibrio giovani - anziani nella società, ma per un certo tempo non vi furono grandi allarmi. La letteratura sociologica prevalente parlò della doppia presenza femminile come capacità delle donne di coniugare i due lavori, domestico ed extradomestico, e scrisse delle molte strategie adottate per realizzarla. In realtà a mio avviso le strategie furono solo due: o la drastica riduzione del numero dei figli o l’impiego di altre donne, parenti a titolo gratuito oppure domestiche a ore. Ma di questo risvolto la letteratura sociologica non parlava mai. Anche se la domestica “fissa”, cioè convivente, italiana era praticamente una figura in via di estinzione le domestiche a ore invece costituivano un importan- 4 Al fenomeno dedica il servizio “Ecco la generazione No figli” il giornale La Repubblica del 28 agosto 2006 informando dei tassi di natalità molto bassi prodottisi, oltre che in Italia, in altri paesi dell’Europa del sud, del nord, dell’est e dell’estremo oriente ove per Singapore e Sud Corea il fenomeno è nuovo. 5 Il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy Bindi ha dichiarato in televisione: la più preoccupante mancanza di crescita in Italia è quella che concerne la natalità (Rai 3, trasmissione in prima serata Ballarò, martedi 3 ottobre 2003). 6 Citiamo qui anzitutto il giornale “Le operaie della casa” edito da Marsilio Editori, Venezia, e inoltre la collana di piccoli libri per uso militante edita dallo stesso autore e a cura del Collettivo Internazionale Femminista di cui uscirono i seguenti volumi: Le operaie della casa, 1975; 8 marzo 1974. Giornata internazionale di lotta delle donne, 1975; Aborto di Stato, strage delle innocenti, 1976; Dietro la normalità del parto. Lotta all’ospedale di Ferrara, 1978; Contropiano dalle cucine, 1978. E ancora L’Offensiva, prec. cit., e a Il Personale è politico. Quaderni di Lotta Femminista n.2, Musolini Editore, Torino, 1973. 7 La riforma del diritto di famiglia codificato nel 1942 avvenne con la legge del 19 maggio 1975, n. 151 che stabilì anzitutto la parità dei coniugi. Sarebbero poi seguite nuove leggi che avrebbero regolamentato diversamente anche altri rilevanti aspetti di tale diritto. 87 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 88 n.19 / 2007 8 M. Dalla Costa,”Emigrazione, immigrazione e composizione di classe in Italia negli anni ’70”, in Economia e lavoro, n. 4, ottobre-dicembre 1981. 9 La Repubblica del 9 novembre 2006 riporta che dal 1995 al 2004 le separazioni sono cresciute del 59%, i divorzi del 66,8% e che è il Sud a registrare l’incremento più consistente (pag.38). 10 Questo avvenne con l’accettazione di modifica del paragrafo 120 del documento “Forward Looking Strategies for the Advancement of Women”. 88 tissimo supporto del lavoro esterno femminile. Quindi la salarizzazione del lavoro domestico era proceduta per vie traverse. Le donne avevano sempre più consistentemente rifiutato il lavoro domestico gratuito mutando le modalità della sua conduzione, “razionalizzandolo” al massimo, e riducendolo anche attraverso scelte di vita diversa rispetto alle loro madri. Si erano poste invece come obiettivo prioritario la costruzione di una loro autonomia economica che le politiche statuali permettevano di attingere solo attraverso il lavoro extradomestico. Ebbero in mano propria più denaro che nello scenario precedente il movimento. Con quel denaro pagarono altre donne per quote significative di lavoro domestico mentre altre quote ancora uscivano sempre più dalla casa per essere trasformate in merci e servizi offerti dal mercato. Basti pensare, per fare solo un esempio, al settore della ristorazione. Quindi il lavoro domestico gratuito in ogni caso si contrasse, aumentò quello salarizzato all’interno e fuori della famiglia. Anche se spesso l’impiego della domestica e/o della baby sitter consumava gran parte del salario femminile le donne rifiutarono sempre più il lavoro che non produceva denaro. Inoltre negli anni ‘70 già si contava in Italia un flusso di immigrazione di alcune centinaia di migliaia di unità. Al suo interno nel ’77 si calcolava che le colf di colore fossero 100.000 su un totale di forza lavoro immigrata reputata di 3-400.000 unità. Questa forza lavoro femminile tendeva ad occupare quei posti di domestica convivente che le donne italiane non volevano più ricoprire. Iniziava già quindi quel tipo di immigrazione di donne e uomini, provenienti soprattutto dall’Africa e dall’Asia, di cui molte e molti destinati al servizio domestico, flusso che si sarebbe irrobustito e riarticolato quanto alla provenienza nei decenni seguenti. Questa questione del rapporto donne immigrate e lavoro di cura, la cosiddetta questione della globalizzazione del lavoro di cura, sarebbe diventata nel tempo vieppiù importante. Alla fine degli anni ’70 quindi l’autonomia della donna aveva fatto passi significativi, almeno in paesi come l’Italia e altri paesi avanzati, per ciò che concerneva il riappropriarsi del proprio corpo e di sè come persona. Erano passate leggi fondamentali come quella sull’interruzione volontaria di gravidanza e sui consultori, si era vinto il referendum sul divorzio e c’era un nuovo diritto di famiglia. Tale autonomia rimaneva invece in una situazione difficile per ciò che concerneva il lavoro domestico o di cura che dir si voglia, costretta tra un rifiuto di questo lavoro che passava anche attraverso pesanti rinunce, come la rinuncia alla maternità, ed emancipazione. Ma proprio attraverso quell’emancipazione il lavoro domestico sarebbe divenuto sempre più visibile e salarizzato. Gli anni ’70 sono anche il decennio in cui, sull’onda del movimento, iniziano i convegni mondiali delle Nazioni Unite sulla condizione femminile. Il primo, per celebrare l’anno internazionale della donna, proprio a Città del Messico nel 1975. Nel 1979 si ratificava la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne che sarebbe andata in vigore nel 1981. Si sarebbe dovuto attendere invece fino al 1993, data del convegno di Vienna sui Diritti Umani, perché i diritti fondamentali delle donne venissero riconosciuti come parte integrante dei diritti umani e si ratificasse la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, problema che era stato denunciato in tutta la sua gravità e nelle varie forme che assumeva nel mondo al convegno di Nairobi nel 1985 a conclusione del primo Decennio delle Nazioni Unite per la donna. Nello stesso convegno si era anche statuito nel documento conclusivo10 che si dovesse riconoscere il contributo remunerato e non remunerato che le donne portano ad ogni RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 89 Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura aspetto dello sviluppo e che tale contributo dovesse essere quantificato nelle statistiche economiche e nel prodotto nazionale lordo. C’è sempre molto scetticismo sull’efficacia di queste “Carte” ma indubbiamente la planetarietà del confronto ha fatto crescere la forza per decidere cosa è giusto o cosa è ingiusto nelle tradizioni e nelle legislazioni, e per oltrepassare quindi i confini delle une e delle altre affermando nuovi principi e nuove norme. Atto secondo. Gli anni ’80 segnano il decollo del neoliberismo che si sarebbe dispiegato pienamente con la globalizzazione neoliberista degli anni ’90. Sono gli anni della repressione e della normalizzazione dopo le grandi lotte in vari paesi nel decennio precedente. Sono gli anni dell’aggravarsi dell’indebitamento internazionale e dell’applicazione sempre più drastica delle politiche di aggiustamento strutturale11 ufficialmente adottate per permettere ai paesi indebitati di pagare almeno il servizio sul debito. In realtà tali politiche erano tese ad abbassare le condizioni e le aspettative di vita affinché le nuove modalità produttive, che prevedevano minor costo e generale precarizzazione del lavoro, si dispiegassero ovunque permettendo alle imprese una vantaggiosa competizione nelle varie regioni del pianeta. Soprattutto, attraverso le politiche di aggiustamento, il tipo di sviluppo imposto, fortemente orientato all’esportazione, non poteva che aggravare il debito. In quel periodo la privatizzazione di beni comuni come la terra e l’acqua, la privatizzazione di beni pubblici come aziende statali e parastatali, la svalutazione della moneta, il ritiro delle sovvenzioni ai beni di prima necessità, le forti sovvenzioni all’agricoltura modernizzata monoculturale, l’abbassamento dei salari, la riduzione e precarizzazione dei posti di lavoro, la riduzione della spesa in ambito sociale a cominciare dalle pensioni, la riduzione della spesa e riorientamento in senso privatistico dei settori della sanità e dell’istruzione con aumento degli oneri per gli utenti, la liberalizzazione del commercio con misure atte a favorire sia l’esportazione che l’importazione, rappresentarono una poderosa opera di sottosviluppo della riproduzione a livello mondiale in funzione del decollo della nuova fase di accumulazione, e con ciò un attacco senza precedenti alle lotte delle donne non solo per il benessere familiare e per il miglioramento del contesto di vita ma soprattutto per i livelli di autonomia acquisiti. Nelle aree avanzate questo volle dire perdita di “buona occupazione”, perdita quindi di quella forma di emancipazione che tale occupazione garantiva e immersione nella precarietà, povertà, dipendenza. Nelle aree meno avanzate questo significò soprattutto che sempre più terra veniva espropriata nelle cosiddette modernizzazioni agricole o per grandi e spesso devastanti progetti finanziati dalla Banca mondiale di cui la costruzione di dighe è solo l’esempio più noto. E’da questa povertà generata dalle politiche del debito, con al cuore l’espropriazione della terra, e poi in particolare negli anni ’90, dall’intervenire di una costante politica di guerra che rende sempre più inagibile la terra a causa delle operazioni militari e dei residuati bellici, che si generano quei flussi migratori che portano nei paesi avanzati, anzitutto europei, nuovi soggetti di cui una parte consistente, soprattutto donne, si occuperà di larghe quote del lavoro di riproduzione. Tali politiche neoliberiste e belligene (cioè generatrici di guerra) saranno all’origine di una nuova divisione del lavoro di riproduzione nel mondo per cui sempre più donne provenendo da aree cosiddette in via di sviluppo o da altre definite come in via di transizione (“transizione alla democrazia” per i paesi dell’est europeo), verranno a svolgere questo lavoro per le aree più 11 Sulla problematica del debito internazionale la letteratura è molto vasta. Rimandiamo anzitutto alle opere di Susan George fra cui: Il debito del Terzo Mondo, Edizioni Lavoro, Roma, 1989; Il boomerang del debito, Edizioni Lavoro, Roma, 1992; M. Dalla Costa, «L'indigeno che è in noi, la terra cui apparteniamo», in A. Marucci (a cura di) Camminare domandando, DeriveApprodi, Roma, 1999 (trad. ingl. «The Native in Us, the Land We Belong to», in Common Sense, n.. 28, 1998 e in The Commoner, n. 6, 2002, in www.thecommoner.org); M. Dalla Costa e G.F. Dalla Costa (a cura di), Donne e politiche del debito, Franco Angeli, Milano, 1993 (trad. ingl.: Paying the Price. Women and the Politics of International Economic Strategy, Zed Books, London, 1995) e, delle stesse curatrici, Donne, sviluppo e lavoro di riproduzione. Questione delle lotte e dei movimenti, FrancoAngeli, Milano, 1996 (trad. ingl.: Women, Development and Labour of Reproduction. Struggles and Movements, Africa World Press, Trenton, N.J., EE.UU. e Asmara, Eritrea, 1999). 89 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 90 n.19 / 2007 avanzate lasciandosi alle spalle lacerazioni del loro contesto riproduttivo, quello familiare anzitutto, ricucite a prezzo della moltiplicata fatica di chi resta ma ripagate almeno con le rimesse delle emigrate. Si disastra la riproduzione delle aree considerate“più periferiche” per ridefinire e approfondire a livello planetario la stratificazione del corpo sociale lavoratore. Si vuol così provvedere forza lavoro a basso costo da impiegare anche nell’ambito della riproduzione nelle regioni più sviluppate. In tal modo lo stato potrà largamente eludere di confrontarsi con la realtà dei problemi emergenti in questo ambito non assumendo i carichi finanziari che sarebbero di sua competenza. Ma quali erano questi problemi? Quali le urgenze che si ampliavano sempre più se di figli se ne erano procreati sempre meno? Da dove l’allargarsi di questa nuova domanda di lavoro? La questione emergente , anche se non la sola, era quella della cura degli anziani non autosufficienti, che avrebbe avuto una particolare crucialità nel discorso che stiamo conducendo sull’autonomia della donna. 12 UN Census 2000 13 (Oecd, 1992). In Italia gli immigrati registrati come ufficialmente residenti nel 2002 erano 1.512.324 di cui il 45,8% donne (Caritas, Dossier statistico immigrazione 2003, Roma, Edizioni Nuova Anterem). 14 Si calcola che in Italia la componente maschile del lavoro di badante sia del 25%, e che il 73% di chi fa questo lavoro abbia tra i 30 e i 40 anni (La Repubblica, 16 ottobre 2006 pag. 16, che cita le fonti Inps, Caritas Ambrosiana e Cgil Lombardia). 90 Atto terzo. E’dal 1990 in poi, dopo il decennio di generalizzata applicazione delle politiche del debito e con il dispiegarsi della globalizzazione neoliberista, che l’emigrazione diventa un fenomeno veramente mondiale arrivando a contare, secondo le stime delle Nazioni Unite12, più di 175 milioni di migranti nel pianeta. L’Italia, tradizionalmente esportatrice di forza lavoro, negli anni ’80 e ’90 ha un saldo come importatrice attraendo manodopera dall’Asia, dall’Africa e più recentemente dall’Europa dell’est. Sempre più donne emigrano verso l’Europa negli ultimi decenni. Alla fine degli anni ’90 il 45% degli immigrati in Europa sono donne in coincidenza con una crescente richiesta di servizio domestico nel Sud Europa13. Ed è proprio dagli anni ’90 che una nuova figura del lavoro di cura comincia a delinearsi in modo preciso e viene sempre più ricoperta da donne immigrate, la badante. E’ colei (a volte anche colui)14 che cura una persona non più in grado di essere autosufficiente nelle incombenze quotidiane, in genere un anziano o un’anziana con problemi di non autosufficienza più o meno gravi. Il bisogno di questa figura, la domanda emergente di questo specifico lavoro di cura, scaturisce da mutamenti demografici che hanno visto da un lato allungarsi la vita delle persone dall’altro aumentare la percentuale di anziani nella popolazione nella misura in cui il rifiuto femminile della maternità ha notevolmente ridotto la percentuale di giovani. E’ un mutamento, questo, che riguarda complessivamente i paesi europei, non solo l’Italia. E’ una crisi della riproduzione sociale perché viene meno nella società l’equilibrio giovani anziani, non vi è più adeguato ricambio generazionale. Il rifiuto delle donne nei confronti della maternità in Italia (paese che, secondo i dati Istat, ha uno dei tassi di natalità più bassi nel mondo, quell’1, 2 di cui abbiamo detto sopra e che recentemente è salito a 1, 3 solo per l’intervenire dei nuovi nati di donne immigrate) ha fatto sì che si prospetti nel volger di 30 anni uno scenario per cui una su tre persone sarà oltre i 65 anni. Il dato rilevante e che va adeguatamente interpretato è il fatto che in Europa la maggioranza degli ultrasessantacinquenni (ad eccezione degli ultranovantenni) vive a casa, non in istituzioni private o pubbliche. Una situazione che evidentemente è frutto della decisione non solo degli anziani stessi quando ancora in grado di esprimersi, ma della donna più giovane, parente, in genere la figlia, RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 91 Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura che è consapevole di come questa sia l’opzione più umana. Anche se, per il complesso di incombenze che richiede, condizionerà pesantemente la sua autonomia di vita, pur con l’intervenire, quando possibile, del lavoro retribuito di altre donne. Il rifiuto femminista nei confronti del lavoro di riproduzione gratuito, passato anche attraverso il rifiuto della maternità, non ha liberato in modo consistente le donne dal lavoro di cura se non per un certo periodo di vita, quello in cui avrebbero dovuto allevare un figlio. “La mamma è uscita” recitava il titolo di una mostra organizzata dal Gruppo Femminista per il Salario al Lavoro Domestico di Varese15. Ma “è dovuta rientrare” dovremmo scrivere oggi se riallestissimo quella mostra. La libera uscita è durata un tempo breve. Il problema della cura, in una veste ancor più pesante e complessa, si è ripresentato con gli anziani, spesso non autosufficienti. La donna di cinquanta, sessant’anni o più, che aveva partecipato alle lotte del movimento femminista, a sua volta bisognosa almeno di un po’ di riposo, e, se in pensione, di concedersi quello che durante la vita lavorativa non aveva potuto avere, si trova a fronteggiare le problematiche di genitori in età molto avanzata, spesso ultraottantenni, pregiudicati da patologie tipiche dell’invecchiamento. A farsene carico è lei spesso senza figli adulti che potrebbero almeno in parte cooperare. Dopo il faticoso percorso che la costruzione della sua autonomia aveva implicato questa autonomia si riduce nuovamente perché si ripresenta irrisolto il problema della cura di altri, più deboli, che da lei dipendono. Il corpo sociale è appunto un corpo, non è divisibile, e ripropone il problema della cura in un eterno ritorno. E’ in questo quadro che il lavoro di badante16 da parte di donne che immigrano in Italia a seguito dei disastri provocati nel loro paese dalle politiche di aggiustamento, dalle guerre e dalle “operazioni di democratizzazione” si situa, rispondendo a un bisogno rispetto a cui le politiche dello stato sono ancora troppo carenti. La loro occupazione indica anzitutto che anche questo tipo di lavoro di cura è stato progressivamente sussunto da quel processo di salarizzazione del lavoro domestico di cui parlavamo poco sopra e che il problema è tale che occorre in genere l’ impiego a tempo pieno di una persona per essere affrontato. Ma alcuni luoghi comuni vanno sfatati. Il primo è che questa figura libera tout court la donna parente dal compito di prendersi cura dell’anziano. Non esiste invece lavoro di badante che possa funzionare bene se non c’è assieme il continuo lavoro di guida, cooperazione e verifica da parte della donna parente. Lavoro che inizia con la presentazione del caso, sempre diverso e in continuo mutamento, e richiede aiuto continuo, praticamente una ripartizione di compiti fra donna parente e donna salariata. E’ la prima in genere che deve provvedere a fare la spesa poiché è difficile farla assieme alla persona badata, è lei che fa le pratiche burocratiche, tiene l’amministrazione della casa e la gestione finanziaria, porta l’anziano a fare le visite e gli esami medici e deve garantire presenza immediata e azione in ogni emergenza. Proprio per la condizione di solitudine costituita dal vivere tutti i giorni con l’anziano, spesso con una certa deficienza mentale, la badante a sua volta ha bisogno di essere riprodotta. Quindi il famoso “lavoro d’amore”17 ritorna non solo come esigenza imprescindibile nella cura dell’assistito che sarà mal badato se non c’è anche una sollecitudine reale per il suo benessere ma anche come esigenza nel rapporto fra datrice di lavoro (spesso la figlia) e badante. La prima dovrà seguire la situazione che viene a crearsi per capire in tempo eventuali momenti di difficile sostenibilità e offrire tutte le risor- 15 Ne parla l’omonimo articolo in Le operaie della casa , n. doppio 0 bis, novembre-dicembre 1975/gennaio-febbraio 1976, pag.21 16 Si calcola che circa la metà di questa occupazione in Italia non sia regolarizzata. Molte delle donne che fanno questo specifico lavoro provengono dall’est europeo, da Romania, Moldavia e Ucraina. Ancora La Repubblica con il servizio già menzionato espressamente dedicato alla presenza e lavoro delle badanti in Italia (16 ottobre 2006, pag. 16-17) riporta di una crescita della loro presenza regolare che va dalle 51.110 del 1994 alle 142.196 del 2000, alle 490.678 del 2003 alle 693.000 di cui 619.000 straniere del 2006.Vedi in merito Rossana Mungiello, “Segregation of Migrants in the Labour Market in Italy: the Case of Female Migrants from Eastern European Countries Working in the Sector of Care and Assistence for the Elderly. First Results of an Empirical Study Carried Out in Padova” in Zu Wessen Diensten? Frauenarbeit zwsischen Care-Drain und Outsourcing, Zurich, Frauenrat fur Aussenpolitik, 2005, pp. 72-77. 17 G. F. Dalla Costa, Un lavoro d’amore, Edizioni delle donne, Roma, 1978. 91 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 92 n.19 / 2007 18 Per quelle che hanno un contratto regolare esso prevede da 750 a 900 euro netti, più 200 euro di contributi da parte del datore di lavoro, un mese di ferie pagato, un’altra mensilità all’anno come tredicesima, e un’altra come liquidazione. Il vitto viene fornito dal datore di lavoro e anche una stanza nell’appartamento, problema che in genere si risolve con il cambio di destinazione di un’altra stanza. La badante convivente che comunque stipula un contratto per 8 o 9 ore giornaliere al massimo, ha diritto ad avere libere due ore al giorno, una giornata e mezza alla settimana, in genere la domenica e il sabato pomeriggio. Ma ci sono ovviamente anche contratti a ore, non come convivente, dipende dalle condizioni della persona che deve essere assistita e da cosa interessa di più alla badante. Molte preferiscono essere conviventi per alcuni anni per non avere spese alimentari e di affitto e poter inviare a casa così quasi tutto lo stipendio. 92 se e facilitazioni che possano rendere meno faticoso quel lavoro, di sovente dovrà direttamente sostituire la badante per offrirle dei riposi extra nei momenti più gravosi, e soprattutto più denaro se la situazione diviene più pesante. Teniamo presente che, se non ci sono abbastanza soldi in famiglia per pagare un’altra badante il sabato e la domenica, e questo tipo di lavoro costa molto18 rispetto ad un normale budget familiare, saranno la figlia ed eventuale marito a badare al congiunto in quei giorni, vedendo vanificarsi, se lavorano ancora, il loro riposo settimanale e il tempo solitamente dedicato agli approvvigionamenti. Molte coppie trascorrono così il fine settimana e il problema si ripresenta ovviamente durante il mese di ferie perché, mentre un lavoro di pulizia può attendere o trovare soluzioni tampone, un anziano non autosufficiente non può essere lasciato solo nemmeno un minuto e non può trovarsi di fronte improvvisamente persone che non conosce e non istruite su come rapportarsi a lui e quali mansioni svolgere. Tendenzialmente non è un lavoro precario perché non c’è alcuna convenienza per la donna che ha assunto la badante a cambiarla dopo tutto il lavoro di insegnamento che questo compito richiede e dopo che si è già costruito un buon rapporto tra la persona badata e la badante. La precarietà invece interviene quando ci sono condizioni di lavoro irregolare e questo rimanda all’urgenza di un maggior e più esteso sostegno economico alle famiglie per poter stipulare regolari contratti. Ho ritenuto importante esplicitare questa combinazione di lavoro, quello da parte della parente con quello della badante, perché non si commetta a livello sociologico l’errore contrario a quello precedente. Una volta, dopo la fase del movimento femminista degli anni ’70, la lettura dell’emancipazione femminile attraverso il lavoro esterno teneva sottaciuto il ruolo svolto dal servizio domestico a ore, oggi, trattando del lavoro di badante, ci può essere il rischio di trattarlo come un “a solo” tenendo sottaciuto il lavoro della donna parente. L’impiego di donne immigrate ha evidenziato la grandezza del problema. Non è un lavoro di cura che la donna parente, se lo fa in prima persona, possa combinare con altri impegni di lavoro. Se oggi i soggetti che se ne stanno facendo carico sono stati obbligati dalle politiche che hanno disastrato i loro contesti di vita, è auspicabile che domani questo lavoro possa rappresentare una normale “buona occupazione” ricoperta anche da donne italiane (in parte ha già cominciato ad esserlo) soprattutto se miglioreranno le condizioni per un maggiore sostegno economico da parte dello stato. Certamente infatti, se il suo costo già oggi per molte famiglie è inaffrontabile, e questo conduce a situazioni di irregolarità, occorre che lo stato destini molto di più a sostenerlo. Teniamo presente che si tratta di un terreno su cui qualche riscontro economico per il lavoro di cura, o lavoro domestico, c’è stato. Ed è grazie a tale riscontro che alcune famiglie riescono a fare il contratto di lavoro. Anzitutto l’assegno di accompagnamento, 450 euro al mese, a carico della previdenza nazionale destinati, indipendentemente dal reddito, direttamente alla persona da assistere non autosufficiente sul piano fisico o mentale. Ma va detto che il suo ottenimento è molto difficile. Deve intervenire una dichiarazione di invalidità totale e permanente. Molti casi, specie di non autosufficienza sul piano fisico piuttosto che mentale, non vengono ritenuti tanto gravi da giustificarlo. Vi sono poi altre misure, di provenienza regionale e subordinate a livelli molto bassi di reddito, non alternative rispetto all’eventuale assegno di accompagnamento. Tra queste il “contributo badante”, fino a un massimo di 250 euro mensili, erogato dalla Regione Veneto RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 93 Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura a chi ha una badante, il contributo Alzheimer (516 euro mensili) nonchè quanto previsto dalla legge regionale n. 28 del 199119. Così come vi sono specifici servizi di supporto. Proprio per contrastare il fenomeno della clandestinità di molte badanti e dei rischi connessi a possibilità di infiltrazioni da parte di circuiti malavitosi vi sono state iniziative anche da parte di Province come quella di Bergamo che ha deciso di stanziare 400 euro mensili per le famiglie che hanno già una badante o hanno bisogno di assumerla. Pur nella tendenza neoliberista alla decurtazione della spesa pubblica destinata al consumo sociale, va preso quindi atto che il welfare, dentro cui una qualche salarizzazione del lavoro di cura si è data, riemerge come terreno ineludibile di contrattazione a partire proprio da misure come queste. La crisi della riproduzione sociale induce problemi anche per lo stato. Attualmente il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy Bindi propone di coinvolgere banche e fondazioni per ampliare il fondo destinato agli anziani mentre, lanciando l’allarme sulla caduta della natalità, propone di dare 2500 euro all’anno per ogni nuovo nato fino alla maggiore età. Il salario al lavoro domestico, tanto contrastato dalle forze istituzionali nella fase alta di movimento, torna articolato in varie forme come esigenza insopprimibile. Chi avrebbe preferito che questo denaro fosse destinato nuovamente a sovvenzionare gli istituti per anziani ove ghettizzare la terza e quarta età sbaglia. Gli istituti vanno bene per casi estremi che non è più possibile curare a casa. Non solo il livello di cura prestato è di tutt’altra qualità ma soprattutto gli anziani stessi non amano questi luoghi e preferiscono stare a casa. La donna, attraverso il suo rifiuto di essere destinataria del lavoro gratuito di riproduzione qualunque fosse il caso e qualsiasi fossero le condizioni, ha indotto anche in questo specifico settore un processo di visibilizzazione e salarizzazione ma altrettanto ha garantito ancora, accettando una libertà condizionata, un’autonomia relativa, di salvaguardare l’autonomia relativa e il benessere fisico e psichico di chi, in una condizione di debolezza, da lei dipende. Nel suo rifiuto e nella sua relativa accettazione ha fatto emergere che sul lavoro di cura il solo rifiuto tout court è un’utopia e che questo specifico lavoro di cura degli anziani deve essere sostenuto da un maggior finanziamento dello stato perché le famiglie possano affrontarne i costi e possa essere condotto tutto in condizioni di regolarità, così come lo stato deve potenziare i servizi destinati a questa fascia debole di cittadini. Ha fatto emergere altresì che uno degli ostacoli più grandi per poter tenere l’anziano nella propria casa o a casa della parente è l’impennata che c’è stata nel costo degli immobili e degli affitti per cui gli spazi degli appartamenti sono ridotti al minimo e spesso non c’è la disponibilità della stanza per l’anziano o di quella per la badante. Problema che da vari anni già si era presentato per il figlio. Sempre più gli appartamenti sono dei loculi che non contemplano passaggi, né tanto meno permanenze, di genitori o arrivo di figli. Eppure il problema degli anziani non autosufficienti ripropone anche il problema della nascita di figli, e quindi dell’ottenimento di un sostegno economico per allevarli oltre che di diverse condizioni di vita perché le persone possano ricominciare a desiderare e vedere possibile avere bambini. Infatti, all’infuori dei figli, salvo rare eccezioni, nessuno si preoccuperà di tenere a casa gli anziani non autosufficienti, né organizzerà e veglierà sulla loro riproduzione. Questo della cura degli anziani è un problema che in modi diversi e con situazioni molto diverse si pone a livello planetario. Il sostegno economico da parte dello stato credo debba entrare nell’agenda politica come una delle istanze più urgenti. 19 Dal 2007 queste misure regionali sono state sostituite da un’unica provvidenza, l’“assegno di accompagnamento”, per un massimo di 520 euro mensili, introdotto dalla Regione Veneto. 93 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 94 n.19 / 2007 20 A. Negri, Movimenti nell’Impero, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006 pagg. 241, 215, 184. 21 A. Negri, op. cit., pag. 193 22 Cfr. C. Marazzi, Il posto dei calzini, Edizioni Casagrande Bellinzona, 1994. 23 A. Negri, op. cit., pag. 184 24 Le reti emergenti di contadini che muovono nel Sud come nel Nord difendono il poter condurre un’agricoltura secondo metodologie sostenibili spesso molto tradizionali e con largo impiego di lavoro vivo (che vuol dire larga occupazione) poggianti sulla disponibilità di beni molto materiali come la terra, l’acqua e i semi naturali di contro ad altre metodologie che si vorrebbero imporre. Anche nel Nord sono significativi i discorsi contadini che, pur non rifiutando tou court la tecnologia, intendono non ricorrere troppo alle macchine e impiegare invece, dove ha più senso, la grande disponiblità della risorsa lavoro. Vedi su questo J. Bové e F. Dufour, Il mondo non è in vendita, Feltrinelli, Milano, 2001. Credo che le nuove soggettività, significative da un punto di vista politico, emergano da questi percorsi non dalle metodologie d’avanguardia capitalistiche. 25 M. Dalla Costa: L’indigeno che è in noi, la terra cui apparteniamo, prec. cit. e “Rustic and Ethical” in Ephemera, Theory and Politics in Organisation, Vol. 7(1) March 2007, edited by Emma Dowling, Rodrigo Nunes and Ben Trott, in 94 Se queste sono problematiche emergenti del lavoro di cura dire allora che il lavoro domestico, il lavoro di riproduzione, tende a divenire sempre più lavoro immateriale20, o per lo meno che può essere fatto rientrare nell’accezione di lavoro immateriale, vuol dire non conoscerlo. Il lavoro di riproduzione, che passa attraverso molte articolazioni di cui qui ne abbiamo considerato solo una, è sempre stato un insieme di moltissimo lavoro materiale innestato su un lavoro immateriale di riproduzione psichica, affettiva ecc. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Ma dire che oggi la categoria del lavoro immateriale ne coglierebbe meglio le novità rende un gravissimo torto alla realtà di questo lavoro e alle novità reali che lo investono di cui quella trattata sopra è un buon esempio carico di pesanti e materiali incombenze. Il fatto che debbano essere prestate possibilmente con affetto non le trasforma in prestazioni immateriali. Se la condizione anziana non autosufficiente è una differenza rilevante, cogliere che “sulle donne grava sempre di più il controllo dei flussi della differenza”21 e vedere questo come lavoro immateriale nuovamente implica di non vedere nella sua realtà il lavoro che si fa carico di questa differenza e i suoi problemi. Altrettanto è chiaro attraversando il terreno del lavoro di cura degli anziani (e analogamente sarebbe dei bambini), che il lavoro di riproduzione non è risolvibile con la comunicazione22. Tanto più che le sue problematiche non si esauriscono nella ricerca di un migliore accordo fra partners ma rimandano per la donna a molte ore lavorative, mancanza di denaro, rischio di povertà, mancanza di autonomia. Tutti problemi che non si risolvono con la comunicazione. Nè quello che serve è un’ulteriore innovazione tecnologica. Nè l’idea geniale di qualche informatico il cui programma politico mi apparirebbe poco promettente proprio per la sua provenienza dal regno dell’immateriale23. Non servono comunque idee geniali. Serve lavoro, più adeguatamente remunerato, e più tempo libero per tutti, donne e uomini. Serve riconoscere la materialità della vita e dei lavori che la garantiscono, nella casa come nel campo24, i loro vincoli nelle relazioni umane e con la terra, e questo vale per il lavoro delle donne come per quello dei contadini25. Semmai le donne hanno indicato che l’autonomia che ciascuno persegue e desidera incontra condizionamenti non eludibili, si tratti dei figli o degli anziani, e se la differenza oggi è fra chi se ne fa carico e chi no, questa è una differenza da abbattere non da esaltare, costruendo sul lavoro di cura una responsabilità più comune, e pretendendo dallo stato (poiché il “comune” non esaurisce il “pubblico”) erogazioni di denaro e di servizi più consistenti e più generalizzate. Riferimenti bibliografici BOVE’ J. e DUFOUR F., Il mondo non è in vendita, Feltrinelli, Milano, 2001. CARITAS, Dossier statistico immigrazione 2003, Edizioni Nuova Anterem, Roma. COLLETTIVO INTERNAZIONALE FEMMINISTA (a cura di) Le operaie della casa, Marsilio Editori, Venezia, 1975. COLLETTIVO INTERNAZIONALE FEMMINISTA (a cura di) 8 marzo 1974. Giornata internazionale di lotta delle donne, Marsilio Editori, Venezia, 1975. COLLETTIVO INTERNAZIONALE FEMMINISTA (a cura di) Aborto di stato. Strage delle innocenti, Marsilio Editori, Venezia, 1976. COLLETTIVO INTERNAZIONALE FEMMINISTA (a cura di) (autore il Gruppo RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 Mariarosa Dalla Costa 17-01-2008 9:04 Pagina 95 Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura Femminista per il Salario al Lavoro Domestico di Ferrara) Dietro la normalità del parto. Lotta all’Ospedale di Ferrara, Marsilio Editori, 1978. COLLETTIVO INTERNAZIONALE FEMMINISTA (a cura di) (autrice Silvia Federici) Contropiano dalle cucine, Marsilio Editori, 1978. DALLA COSTA Mariarosa, “Emigrazione, immigrazione e composizione di classe in Italia negli anni ’70”, in Economia e lavoro, n.4, ottobre-dicembre 1981. DALLA COSTA Mariarosa, Potere femminile e sovversione sociale, con Il posto della donna di Selma JAMES, Marsilio Editori, Padova 1972, 4° ed. Venezia, 1977. DALLA COSTA Mariarosa, L’Indigeno che è in noi, la terra cui apparteniamo, in MARUCCI Alessandro (a cura di) Camminare domandando, DeriveApprodi, Roma, 1999 (trad. inglese dell’articolo in Common Sense n. 28, 1998 e in The Commoner, n. 6, 2002 in www.thecommoner.org). DALLA COSTA Mariarosa, “Rustic and Ethical” in Ephemera. Theory and Politics in Organization, vol.7(1), 2007, edited by DOWLING Emma, NUNES Rodrigo and TROTT Ben, in www.ephemeraweb.org. DALLA COSTA Mariarosa, La sostenibilidad de la reproducciòn: de la luchas por la renta a la salvaguardia de la vida, in LABORATORIO FEMINISTA, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista. Producciòn, reproduccion, deseo, consumo, Terradenadie, Madrid, 2006. DALLA COSTA Mariarosa e DALLA COSTA Giovanna Franca (a cura di) Donne e politiche del debito. Condizione e lavoro femminile nella crisi del debito internazionale, FrancoAngeli, Milano, 1993 (trad. ingl. Paying the Price. Women and the Politics of International Economic Strategy, Zed Books, London, 1995) DALLA COSTA Mariarosa e DALLA COSTA Giovanna Franca (a cura di) Donne, sviluppo e lavoro di riproduzione. Questioni delle lotte e dei movimenti, FrancoAngeli, Milano, 1996 (trad. ingl. Women, Development and Labour of Reproduction. Struggles and Movements, Africa World Press, Trenton. N. J., EE.UU. e Asmara, Eritrea, 1999). DOWLING Emma, NUNES Rodrigo and TROTT Ben (editors), Ephemera. Theory and Politics in Organization, vol.7(1), 2007 in www.ephemeraweb.org. “Ecco la generazione ‘No figli’ ”, in Repubblica (La), 28 agosto 2006. GEORGE Susan, Il debito del Terzo Mondo, Edizioni Lavoro, Roma, 1989. GEORGE Susan, Il boomerang del debito, Edizioni Lavoro, Roma, 1992. Il personale è politico, Quaderni di Lotta femminista n. 2, Musolini Editore, Torino, 1973. LABORATORIO FEMINISTA, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista. Producciòn, reproduccion, deseo, consumo, Terradenadie, Madrid, 2006. Le operaie della casa, giornale dell’autonomia femminista, bimestrale edito negli anni ‘70. Le operaie della casa, n. doppio zero bis, novembre-dicembre 1975/gennaiofebbraio 1976. L’Offensiva. Quaderni di Lotta femminista n.1, Musolini Editore, Torino, 1972 Lotta Continua, 15 luglio 1972. Lotta Continua, 21 luglio 1972. Lotta Continua, 1 agosto 1972. Manifesto (Il), 14 luglio 1972. Manifesto (Il), 20 luglio 1972. Manifesto(Il), 4 agosto 1972. www,ephemeraweb.org. E ancora della stessa autrice La sostenibilidad de la reproducciòn: de las luchas por la renta a la salvaguadia de la vida, in Laboratorio feminista, Transformaciones del trabajo desde una perspectiva feminista. Produccion, reproduccion, deseo, consumo, Tierra de Nadie, Madrid, 2006. 95 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 96 n.19 / 2007 MARAZZI Christian, Il posto dei calzini, Edizioni Casagrande, Bellinzona, 1994. MUNGIELLO Rossana, “Segregation of Migrants in the Labour Market in Italy: the Case of Female Migrants from Eastern European Countries Working in the Sector of Care and Assistence for the Elderly. First Results of an Empirical Study Carried Out in Padova” in Zu Wessen Diensten? Frauenarbeit zwsischen Care-Drain und Outsourcing, Zurich, Frauenrat fur Aussenpolitik, 2005. NEGRI A., Movimenti nell’Impero, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006. Repubblica (La), 28 agosto 2006. Repubblica (La), 16 ottobre 2006 Repubblica (La), 9 novembre 2006. Oecd, 1992. United Nations Census, 2000. United Nations, Nairobi Forward Looking Strategies for the Advancement of Women, in Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985, United Nations Publications, (Sales n. E.85.IV.10). United Nations, Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievments of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace, Nairobi, 15-26 July 1985, United Nations Publications. 96 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 97 Silvia Bedin Da Le origini del totalitarismo a Vita activa: viaggio nel pensiero di Hannah Arendt Il Sestante Come suggerisce il titolo, questo intende essere un percorso a partire da e attraverso le riflessioni della “filosofa” (termine che qui si adotta ugualmente anche se non ha mai voluto considerarsi filosofo o filosofa) di Hannover, Hannah Arendt. Ebrea, profuga, costretta a vivere di collaborazioni editoriali fino all’età di 50 anni, Hannah Arendt si definì come un’apolide, una sradicata, un pariah della politica come della cultura. Testimone e protagonista dei tragici eventi del secolo scorso, con le sue opere ha indagato la società moderna ed i suoi mali: dall’emergere di una società di massa al totalitarismo; dall’antisemitismo all’imperialismo; dalla degenerazione della politica a mera attività amministrativa alla depoliticizzazione del mondo contemporaneo. Peculiarità della Arendt, che spesso le è costata pesanti critiche, è il suo modo di indagare la realtà. «Comprendere non significa negare l’atroce, dedurre il fatto inaudito da precedenti o spiegare i fenomeni con analogie e affermazioni generali in cui non si avverte più l’urto della realtà e dell’esperienza. Significa piuttosto esaminare e portare coscientemente il fardello che il nostro secolo ci ha posto sulle spalle, non negarne l’esistenza, non sottomettersi supinamente al suo peso. Comprendere significa insomma affrontare spregiudicatamente, attentamente la realtà, qualunque essa sia» (H. Arendt 2004, p. LXXX). Tale consapevolezza, con la quale la Arendt si approccia allo studio del ‘900, permea tutte le sue opere. Di queste, tre, costituiscono l’oggetto della presente analisi, Le origini del totalitarismo, Vita activa e La banalità del male. Perché proprio tali scritti? Qual è il legame, il filo conduttore che li percorre e unisce? L’ipotesi interpretativa proposta suggerisce di guardare al totalitarismo quale denominatore comune. Il primo approccio, il primo “incontro” tra la Arendt ed il fenomeno totalitario lo si ha nell’opera del 1949, Le origini del totalitarismo, nella quale la filosofa di Hannover formula una prima chiave di lettura del fenomeno: il totalitarismo può essere ricondotto al comportamentismo. Nato negli Stati Uniti, il comportamentismo, o behaviourism, si propone di studiare i fenomeni psichici attraverso l’analisi del comportamento manifesto ed osservabile. Influenzano molto il nuovo indirizzo le teorie di Pavlov a cui si deve la teoria dei riflessi condizionati derivata dagli esperimenti sulle relazioni stimolo-risposta. Autori fondamentali allo sviluppo della teoria comportamentista sono d’altraparte Watson e Skinner. Quest’ultimo, in particolare, vedeva nel rinforzo (ovvero nel premio o nella punizione) un meccanismo di cui lo sperimentatore dispone per indurre un comportamento: all’inizio attuato in modo casuale, il comportamento desiderato, grazie al rinforzo, verrà ripetuto sempre più frequentemente. Il rinforzo (nel caso di specie, il cibo, rinforzo positivo, o lo shock elettrico, rinforzo negativo) favorisce l’apprendimento. I comportamenti sono quindi effetto di un rinforzo e la risposta ad uno stimolo è conseguenza della prospettiva di gratificazioni o punizioni. Secondo l’approccio comportamentista, quindi, imparare significa apprendere una capacità che si sviluppa dalla routine stimolo- 97 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 98 n.19 / 2007 risposta, mentre il processo di formazione dei concetti e di interpretazione dei fatti è soltanto conseguente. L’uomo, a sua volta, può essere concepito come entità capace di azione o come entità ridotta a mero movimento, a mero comportamento: nel primo caso diventa attore, nel secondo è invece paragonabile alle cavie di Pavlov. In quanto “somma” di comportamenti, l’uomo è incapace di apprendere da ciò che fa, è un empty organism, è ridotto alla routine del binomio stimolo-risposta. Come influisce tutto ciò sull’analisi del totalitarismo? Semplice! Quest’ultimo e lo stesso Olocausto sono stati possibili e si sono basati sulla trasformazione dell’uomo da attore ad empty organism, da soggetto capace di azione a soggetto capace di comportamenti, da attore a burocrate, passando dall’unicità dell’individuo alla uniformità della massa. Vi è via di uscita a tale “declino”? Vi è rimedio e/o prevenzione al male totalitario? Si. La Arendt lo afferma in Vita activa. Guardando alla polis greca quale luogo di realizzazione dell’uomo-attore, di partecipazione alla vita politica della città-stato, di deliberazione quale prassi decisionale, la filosofa legge nella riscoperta e nella rivalutazione dell’azione, della pluralità e dell’individualità la ricetta anti-totalitaria. Il processo ad Eichmann dà alla Arendt l’opportunità di ritornare a interrogarsi sul totalitarismo. L’ipotesi avanzata nel ’49 si arricchisce così di un nuovo aspetto: la collaborazione degli ebrei. La Banalità del male è quindi la scoperta che l’ideologia totalitaria non sarebbe, da sola, stata sufficiente a condannare a morte 6 milioni di ebrei. Un risultato così numericamente rilevante ed umanamente devastante non sarebbe stato possibile senza il collaborazionismo ebraico. La “forza” del nazismo, la sua “arma segreta”, fu infatti la capacità di trasformare gli ebrei in vittime razionali, razionali rispetto allo scopo del loro stesso carnefice. Capacità, quest’ultima, riconducibile alla cultura e alla mentalità burocratica quali prodotti della modernità. In tal senso Zygmunt Bauman in Modernità e Olocausto si interroga sull’esperienza dello sterminio del popolo ebraico quale invenzione della modernità. Se il totalitarismo è il denominatore comune, il “collante” degli scritti analizzati, qual è la chiave di lettura? L’ipotesi interpretativa proposta suggeri- 98 sce di individuare nei concetti di Politica e di Pubblico la chiave di lettura; di guardare al totalitarismo come alla realizzazione “viziosa” della politica e alla democrazia deliberativa come alla sua realizzazione “virtuosa”; di considerare il totalitarismo e la democrazia deliberativa come due estremi di un continuum in cui si muovono le politiche; di guardare alla shoah, allo sterminio del popolo ebraico, come ad una politica, la “politica ebraica”. Dall’ipotesi dell’esistenza di un continuum che vede ai suoi poli il totalitarismo e la democrazia deliberativa, possiamo derivare la possibilità di classificare le politiche sulla base del loro contenuto in gerarchia o partecipazione scoprendo, probabilmente, che sono caratterizzate da un mix di entrambi, ma soprattutto, possiamo individuare in una rivalutazione dell’agire, quale facoltà principe dell’uomo, e nella pluralità, che ne costituisce la premessa, la “ricetta” al male totalitario. Adottare il punto di vista di Hannah Arendt significa assumere la polis greca quale modello da perseguire e riprodurre, quale esempio di «un pubblico politicamente interessato ed effettivamente sovrano nell’esercizio diretto della libertà politica» (Privitera 2001, p. 16), con la consapevolezza, tuttavia, delle difficoltà insite nel riprodurre un modello nato per «una comunità cittadina numericamente ristretta, libera da urgenze legate alla riproduzione materiale e tanto dedita alla vita politica da poter assegnare le cariche politiche per sorteggio» (Privitera 2001, p. 20). Terminato nel 1949 e pubblicato due anni più tardi, Le origini del totalitarismo si presenta come una ricostruzione storico-politica del processo di nascita del totalitarismo attraverso uno schema interpretativo che legge nel declino dello stato nazione, nella società di massa, nell’imperialismo, nella nascita dei movimenti pan-germanici e panslavi, nonché nell’antisemitismo, le premesse di quello che la Arendt definisce un fatto nuovo del nostro secolo. Leitmotiv dell’intera trattazione è, infatti, la tesi della novità del totalitarismo quale forma politica: «…abbiamo ripetutamente sottolineato come il totalitarismo sia, oltre che più radicale, essenzialmente diverso da altre forme conosciute di oppressione politica come il dispotismo, la tirannide e la dittatura. Dovunque è giunto al potere, esso ha creato istituzioni assolutamente nuove e RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin distrutto tutte le tradizioni sociali, giuridiche e politiche del paese. A prescindere dalla specifica matrice nazionale e dalla particolare fonte ideologica, ha trasformato le classi in masse, sostituito il sistema dei partiti, non con la dittatura di una persona o di una élite, ma con un movimento di massa, trasferito il centro del potere dall’esercito alla polizia e perseguito una politica estera apertamente diretta al dominio del mondo. Quando i sistemi monopartitici, da cui esso si è sviluppato, sono diventati veramente totalitari, hanno cominciato ad operare secondo una scala di valori così radicalmente diversa da ogni altra che nessuna delle categorie tradizionali, giuridiche, morali o del buon senso, poteva più servire per giudicare, o prevedere, la loro azione» (Arendt 2004, p. 630). L’originalità del totalitarismo è tale, prosegue l’autrice, che con esso viene meno la tradizionale demarcazione tra governo legale e illegale, fra potere arbitrario e legittimo. «[…] Il regime totalitario ci mette di fronte a un tipo di governo completamente diverso. Certo, esso sfida tutte le leggi positive, persino quelle che ha promulgato […]. Ma né opera senza la guida di una legge né è arbitrario, perché pretende di obbedire rigorosamente e inequivocabilmente a quelle leggi della natura o della storia da cui si sono sempre fatte derivare tutte le leggi positive» (Arendt 2004, p. 632). «La sua noncuranza per il diritto positivo pretende di essere una forma superiore di legittimità che, ispirandosi alle fonti, può fare a meno della meschina legalità. […] Disprezzando la legalità, il regime totalitario pretende di attuare la legge della storia o della natura senza tradurla in principi di giusto o ingiusto per il comportamento individuale. Esso la applica direttamente all’umanità senza curarsi del comportamento degli uomini» (Arendt 2004, pp. 632-633). Elemento fondamentale, nell’interpretazione della Arendt, è l’antisemitismo quale «nucleo e punto di cristallizzazione dell’ideologia nazista» (Arendt 2004, p. 3), al quale è dedicata la prima sezione del saggio nel tentativo di spiegare come proprio la questione ebraica «apparentemente così insignificante, abbia avuto il dubbio onore di mettere in moto l’intera macchina infernale di un apparato di potere totalitario» (Arendt 2004, p. 3). Problema che trova una risposta in Tocqueville, secondo cui ciò che irrita il popolo è la superfluità, «…irritante 9:04 Pagina 99 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt è la ricchezza senza una funzione visibile, dato che nessuno si spiega perché debba essere tollerata» (Arendt 2004, p. 5). Quest’ultima regola, spiega la Arendt, calza benissimo anche per l’antisemitismo; non a caso esso raggiunge il suo apice nel momento in cui agli ebrei non resta che la loro ricchezza avendo perso la loro influenza nella vita pubblica degli stati nazionali. Se il declino delle comunità ebraiche costituisce lo sfondo per comprendere le ragioni dell’antisemitismo, il coincidente declino dello stato nazione ne costituisce la chiave. Lo stretto rapporto che lega gli ebrei allo sviluppo dello stato nazionale inizia alla fine del XVII secolo quando gli ebrei divennero i principali finanziatori dello stato. In un sistema in cui la condizione dell’individuo era determinata dalla posizione all’interno della sua classe e dalla relazione con le altre (Arendt 2004, p. 20), gli ebrei costituivano un’eccezione derivando la loro condizione dal rapporto con lo stato. Gli ebrei infatti né costituivano una specifica classe sociale né facevano parte delle classi esistenti. Tale legame divenne ben presto una sorta di minimo comun denominatore attraverso cui unire l’opinione pubblica; «ogni classe della società che era venuta a trovarsi in conflitto con lo stato in quanto tale era [infatti] diventata antisemitica perché l’unico gruppo sociale che sembrava rappresentare lo stato erano gli ebrei» (Arendt 2004, p. 37). «A causa della loro stretta relazione con l’apparato dello stato – prosegue l’autrice – essi [gli ebrei] sono stati invariabilmente identificati col potere in genere e, a causa del loro distacco dalla società, del loro isolamento in una cerchia chiusa di tipo familiare, invariabilmente sospettati di lavorare alla distruzione di ogni struttura sociale» (Arendt 2004, p. 41). Fu l’imperialismo a porre fine a tale legame «…quando l’economia capitalista nella sua espansione oltre confine non poté più fare a meno dell’attivo appoggio del governo (…). Nell’era dell’imperialismo la ricchezza [degli ebrei] era diventata insignificante. In un’Europa il cui equilibrio era stato sconvolto per sempre, (…), l’elemento ebraico, non vincolato ad alcuna nazione, tradizionalmente intereuropeo, divenne oggetto di odio universale per la sua inutile ricchezza, oggetto di disprezzo universale per la sua palese impotenza» (Arendt 2004, p. 23). L’epoca dell’imperialismo la cui parola d’ordine, 99 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 100 n.19 / 2007 derivata dal campo della speculazione commerciale, fu “espansione per l’espansione”, viene convenzionalmente collocata tra il 1884 e il 1914. In questi decenni si assistette in Europa all’emancipazione politica della classe borghese che fino ad allora, ricorda la Arendt, si era interessata alla sola preminenza economica. La corsa all’imperialismo nasce dalle necessità economiche della borghesia: nel momento in cui la possibilità di espansione economica si scontrò con i limiti nazionali, la borghesia, per salvaguardare il sistema capitalistico «basato sulla legge del costante sviluppo industriale, dovette imporre questa legge ai rispettivi governi proclamando l’espansione come il fine ultimo della politica estera» (Arendt 2004, p. 175). All’affermarsi dell’imperialismo è legato il diffondersi del razzismo avendo fatto di quest’ultimo l’arma ideologica della politica di espansione; anche se, come ricorda la Arendt, le origini del razzismo risalgono già al XVIII secolo. All’invenzione della razza quale strumento di organizzazione politica, si aggiunge quello della burocrazia quale strumento per la dominazione dei popoli stranieri laddove, il primo «era in sostanza la fuga in un’irresponsabilità dove non poteva più esistere niente di umano», la seconda «derivava la sua coscienza della responsabilità dalla convinzione di governare popoli inferiori, che aveva in certo qual modo il dovere di proteggere, ma per i quali non valevano le leggi del popolo dominante da essa rappresentato» (Arendt 2004, p. 289). Razzismo e burocrazia, sottolinea la Arendt (2004, p. 259), nascono e si sviluppano indipendentemente l’uno dall’altra: «nessuno degli uomini in qualche modo implicati nella loro creazione intuì quali possibilità di accumulazione del potere e di distruzione offrisse una combinazione del genere» (Arendt 2004, p. 260). Fu solo con il nazismo che si pensò di organizzare burocraticamente lo sterminio di un popolo, quello ebraico, come spiega Bauman nel saggio Modernità ed Olocausto. Altrettanto importante, quale elemento che favorì la nascita del totalitarismo, è la società di massa: «né [Hitler] né Stalin avrebbero [infatti] potuto mantenere il dominio su vaste popolazioni (…) se non avessero goduto la fiducia delle masse» (Arendt 2004, p. 424). D’altraparte, «i movimenti totalitari mirano a organizzare le masse, non le classi» (Arendt 2004, p. 427), laddove per massa, 100 spiega la Arendt, intendiamo «gruppi che, per entità numerica o per indifferenza verso gli affari pubblici o per entrambe le ragioni, non possono inserirsi in un’organizzazione basata sulla comunanza di interessi» (Arendt 2004, p. 431). La nascita delle masse, prosegue la filosofa, fu preceduta dall’atomizzazione sociale e da un’estrema individualizzazione: «le masse si formarono dai frammenti di una società atomizzata, in cui la struttura competitiva e la concomitante solitudine dell’individuo erano state tenute a freno soltanto dall’appartenenza a una classe. La principale caratteristica dell’uomo di massa non era la brutalità e la rozzezza, ma l’isolamento e la mancanza di normali relazioni sociali» (Arendt 2004, p. 439). I movimenti totalitari, quindi, si configurano quali «organizzazioni di massa di individui atomizzati e isolati, da cui (…) esigono una dedizione e “fedeltà” incondizionata e illimitata» (Arendt 2004, p. 448); tale fedeltà è possibile solo da un soggetto completamento isolato, privo di qualsiasi relazione sociale o familiare, al punto da far discendere il suo posto nel mondo dall’appartenenza al movimento. Le masse vanno tuttavia conquistate mediante lo strumento della propaganda. Peculiarità della propaganda totalitaria è quella di attribuire «alle proprie affermazioni la forma di predizioni, portando al massimo l’efficienza del metodo e l’assurdità del contenuto, perché dal punto di vista demagogico non c’è un modo migliore, per evitare la discussione, che svincolare un argomento dal controllo del presente dicendo che soltanto il futuro può rivelarne i meriti» (Arendt 2004, p. 478). «Il linguaggio della scientificità profetica corrispondeva ai bisogni delle masse che non avevano più una patria nel mondo ed erano ora pronte ad abbandonarsi a forze eterne, dominatrici di tutto, che avrebbero condotto l’uomo (…) al lido della salvezza» (Arendt 2004, p. 484). Nel momento in cui un movimento totalitario conquista il potere, si trova di fronte ad un duplice pericolo, «quello di fossilizzarsi in seguito all’assunzione delle leve dell’apparato statale, degenerando in una forma di governo assoluto, e quello di essere limitato nella sua libertà d’azione dai confini del territorio…» (Arendt 2004, p. 535). «Il governante totalitario si trova infatti di fronte a un duplice compito, contraddittorio fino all’assurdo: deve instaurare il mondo fittizio del movimento RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin come realtà tangibile della vita quotidiana e, allo stesso tempo, impedire che questo mondo “rivoluzionario” si stabilizzi, perché la stabilizzazione delle sue leggi e istituzioni distruggerebbe sicuramente il movimento e con esso la speranza della futura conquista del globo» (Arendt 2004, p. 538). Con l’avvento al potere il movimento, ora regime, «utilizza l’amministrazione pubblica per il suo obiettivo di conquista del mondo (…); attribuisce alla polizia segreta il ruolo di esecutrice e custode dell’esperimento interno di costante trasformazione della realtà in finzione; e infine istituisce i campi di concentramento come speciali laboratori perfettamente attrezzati per verificare sperimentalmente le pretese di dominio totale» (Arendt 2004, p. 539). Infine, caratteristica fondamentale del totalitarismo è il binomio terrore-ideologia. Al diritto positivo il totalitarismo sostituisce il terrore quale «realizzazione della legge del movimento; [esso] si propone principalmente di far sì che le forze della natura o della storia corrano liberamente attraverso l’umanità, senza l’impedimento dell’azione umana spontanea. È il movimento stesso che individua i nemici dell’umanità contro cui scatenare il terrore (…). Colpevolezza e innocenza diventano concetti senza senso; “colpevole” è chi è d’ostacolo al processo naturale o storico, che condanna le “razze inferiori”, gli individui “inadatti a vivere”, o le “classi in via di estinzione” e i “popoli decadenti”» (Arendt 2004, p. 636). È il terrore il “boia” che attua tali sentenze di condanna, di fronte al quale le parti sono «soggettivamente innocenti: gli uccisi perché non hanno nulla contro il sistema, e gli uccisori perché non assassinano realmente, ma si limitano ad eseguire una sentenza di morte pronunciata da un tribunale superiore» (Arendt 2004, p. 636). È il terrore che sceglie vittime ed esecutori, e, per preparare i singoli al ruolo che dovranno rivestire all’interno del sistema, si affida all’ideologia. Le ideologie, scrive la Arendt, sono «ismi che per la soddisfazione dei loro aderenti possono spiegare ogni cosa e ogni avvenimento facendoli derivare da una singola premessa» (Arendt 2004, p. 641). L’ideologia «pretende di conoscere i misteri dell’intero processo storico – i segreti del passato, l’intrico del presente, le incertezze del futuro – in virtù della logica inerente alla sua “idea”» (Arendt 2004, p. 642) ovvero, sulla base delle leggi di natura e delle leggi del divenire storico, prescindendo 9:04 Pagina 101 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt quindi da ogni esperienza o accertamento fattuale. Il pericolo insito nella spiegazione ideologica, che tende a derivare ogni esperienza da una singola premessa, consiste «nell’abbandonare la libertà implicita nella capacità di pensare per la camicia di forza della logica» (Arendt 2004, p. 644). La forza del ragionamento logico poggia sulla considerazione secondo cui «se rifiuti, contraddici te stesso e, con tale contraddizione, privi di ogni senso la tua vita»; «la tirannia della logicità comincia con la sottomissione della mente alla logica come processo senza fine, su cui l’uomo si basa per produrre le sue idee. Con tale sottomissione egli rinuncia alla sua libertà interiore» (Arendt 2004, p. 648). Così, se credi che ci siano razze superiori e razze inferiori, razze adatte e razze inadatte, non è difficile giustificare lo sterminio delle “razze in via di estinzione”. «Come il terrore (…) distrugge tutti i legami fra gli uomini, così l’autocostrizione del pensiero ideologico distrugge tutti i legami con la realtà» (Arendt 2004, p. 649). Strumenti nelle mani del regime totalitario, l’ideologia ed il terrore producono isolamento, impotenza ed estraniazione, privando gli uomini della capacità di esperienza, pensiero ed azione; laddove, l’isolamento definisce una «situazione in cui non posso agire perché non c’è nessuno disposto ad agire con me», e l’estraniazione, «una situazione in cui come persona mi sento abbandonato dal consorzio umano» (Arendt 2004, p. 650). Vi è rimedio all’isolamento e all’estraniazione? Qual è l’antidoto più efficace, se ve ne è uno, all’instaurarsi delle premesse totalitarie? Alla possibilità che l’esperienza dell’Olocausto si ripeta? Possiamo trovare una risposta a tali interrogativi nella rivalutazione dell’agire e nella sua premessa, la pluralità, di cui la Arendt si occupa nel saggio Vita activa, pubblicato nel 1958, e con il quale la filosofa di Hannover si propone di analizzare la natura della nostra società e la sua duplice alienazione, «la sua duplice fuga dalla terra all’universo e dal mondo all’io» (Arendt 1998, p. 6). «Nel 1957 un oggetto fabbricato dall’uomo fu lanciato nell’universo, e per qualche settimina girò intorno alla terra seguendo le stesse leggi di gravitazione che determinano il movimento dei corpi celesti…» (Arendt 1998, p. 1). Con tale incipit inizia Vita activa, ricordandoci come oggi la scienza con i suoi progressi, le sue invenzioni e le sue sco- 101 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 102 n.19 / 2007 perte domini la nostra epoca, sia il mezzo attraverso cui “liberare” l’uomo dalla prigione terrestre. A fronte di tale realtà, la filosofa di Hannover, evidenzia pericoli e contro-effetti insiti nella difficoltà «che le “verità” della moderna visione scientifica del mondo, benché dimostrabili in formule matematiche e messe alle prova nella tecnologia, non si prestano più all’espressione normale del discorso e del pensiero» (Arendt 1998, p. 3). Spingendo tale tendenza all’estremo, si potrebbe arrivare ad una situazione paradossale in cui «non riusciremo mai a comprendere, cioè a pensare e a esprimere, le cose che pure siamo capaci di fare» (Arendt 1998, p. 3) e, laddove «la conoscenza si separasse irreparabilmente dal pensiero, allora diventeremmo esseri senza speranza, schiavi non tanto delle nostre macchine quando della nostra competenza, creature prive di pensiero alla mercé di ogni dispositivo tecnicamente possibile per quanto micidiale» (Arendt 1998, p. 3). Perdendo la capacità di pensare ed esprimersi, l’uomo perde la sua qualificazione di essere politico, perde la sua pluralità: «ogni qual volta che è in gioco il linguaggio, la situazione diviene politica per definizione, perché è il linguaggio che fa dell’uomo un essere politico» (Arendt 1998, p. 3). Altrettanto temibile è l’avvento dell’automazione che libererà l’uomo dal giogo «del lavoro e [dal]la schiavitù della necessità» (Arendt 1998, p. 4); aspirazione quest’ultima antica quanto la storia dell’umanità che tuttavia è destinata a realizzarsi in una società di lavoratori, «una società che non conosce più quelle attività superiori e più significative in nome delle quali tale libertà meriterebbe di essere conquistata (…). Persino i presidenti, i re e i primi ministri considerano le loro funzioni come un lavoro necessario alla vita della società, e anche tra gli intellettuali sono rimasti solo pochi individui isolati a considerare il loro lavoro come un’attività creativa piuttosto che come un mezzo di sussistenza. Ci troviamo di fronte alla prospettiva di una società di lavoratori senza lavoro, privati cioè della sola attività rimasta loro. Certamente non potrebbe esserci niente di peggio» (Arendt 1998, p. 4-5). Il termine vita activa, spiega la filosofa, designa tre attività umane fondamentali: l’attività lavorativa, l’operare e l’agire, ciascuna delle quali corrisponde «a una delle condizioni di base in cui la vita sulla terra è stata data all’uomo» (Arendt 1998, p. 102 7); così, il lavorare corrisponde allo sviluppo biologico del corpo umano; l’operare, il cui frutto è un mondo artificiale, corrisponde alla dimensione non-naturale dell’esistenza umana e l’agire, attività politica per eccellenza, è «la sola attività che metta in rapporto diretto gli uomini senza la mediazione di cose materiali, [e] corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini, e non l’Uomo, vivono sulla terra e abitano il mondo» (Arendt, 1958 p. 7). Il termine vita activa traduce il termine aristotelico bios politikos, designando una vita dedicata alle questioni pubblico-politiche. Nella concezione del filosofo greco tuttavia, né l’operare dell’artigiano né il lavorare dello schiavo erano “degni” di costituire un bios, «un modo di vita autonomo e autenticamente umano; poiché essi servivano e producevano ciò che era necessario e utile, non potevano essere liberi, indipendenti dalle necessità e dalle esigenze umane. La vita politica [invece] sfuggiva a questa condanna perché la concezione greca faceva della polis una forma di organizzazione peculiare e liberamente scelta, non una mera forma d’azione necessaria per tenere uniti gli uomini in modo ordinato» (Arendt 1998, p. 11). Costante è, nella Arendt, il richiamo all’esperienza della polis quale esempio di comunità politica fondata sull’agire. Così richiamandosi all’esperienza greca, la Arendt ricorda come il pensiero greco opponesse alla capacità di organizzarsi politicamente, l’associazione naturale basata su casa e famiglia. Con la nascita della polis, l’uomo greco riceveva “una seconda vita”, il bios politikos costituito dalle uniche due attività, secondo Aristotele, politiche: azione e discorso. Con la nascita della città-stato, sfera privata e sfera pubblica, dimensione domestica e dimensione politica si affermano quindi come entità distinte: mentre la necessità e la soddisfazione dei propri bisogni caratterizzavano la sfera privata, la libertà era il tratto distintivo della vita nella polis, della sfera pubblica. Il controllo delle necessità e dei bisogni, da attuarsi anche mediante la forza e la violenza – per esempio mediante il dominio sugli schiavi – era il solo modo di diventare liberi, di accedere alla vita nella polis. Ulteriore tratto distintivo della sfera pubblica realizzata nella polis, era l’uguaglianza su cui essa si fondava che si opponeva alla sfera privata, regno della disuguaglianza. «L’eguaglianza, lungi dall’es- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin sere connessa con la giustizia, come nell’epoca moderna, era la vera essenza della libertà: essere liberi voleva dire essere liberi dalla disuguaglianza connessa a ogni tipo di dominio e muoversi in una sfera dove non si doveva governare né essere governati» (Arendt 1998, p. 24). Ricapitolando, mentre la sfera privata è il regno della necessità, il pubblico è il luogo della libertà intendendo con essa la partecipazione ad una comunità di liberi ed uguali. Lo spazio pubblico ateniese consentiva e promuoveva l’azione, l’impresa straordinaria attraverso cui conquistare l’immortalità; «per gli ateniesi [infatti] l’impegno in pubblico per il bene comune costituiva la vera libertà» (Privitera 2001, p. 18). La novità insita in un pubblico quale luogo di libertà consiste nell’affermazione di «una diversa modalità d’azione, che ha bisogno di essere coordinata e legittimata tramite la comunicazione. Nel pubblico la motivazione dell’azione non può mai essere il mero arbitrio, e rinvia invece all’obbligo insito in tale dimensione di giustificare di fronte agli altri le proprie azioni» (Privitera 2001, p. 18). Per quanto selettivo e discriminatorio, lo spazio pubblico ateniese «contiene in sé la maggiore conquista cognitiva del pensiero politico antico (…) l’ideale normativo dell’uguaglianza, che per le sue particolari forme definisco principio di uguaglianza come reciprocità» (Privitera 2001, p. 18) su cui si fonda l’esperienza della partecipazione democratica affermando il principio secondo cui è riconosciuto ad uomini diversi, per natura o sorte, pari accesso alle decisioni di interesse comune. Scomparsa la città-stato, il termine vita activa perse tuttavia il suo significato più prettamente politico, finendo per indicare «ogni genere di partecipazione attiva alle cose di questo mondo» (Arendt 1998, p. 12); l’azione, ricondotta tra le necessità della vita terrena, perse la sua libertà e venne spoliticizzata, «cosicché rimaneva la contemplazione come solo modo di vita veramente libero» (Arendt 1998, p. 12), affermando in tal modo la subordinazione della vita activa a quella contemplativa, ovvero la superiorità di quest’ultima. Con l’avvento della modernità il confine tra spazio pubblico e spazio privato diventa più labile «poiché con il sorgere della società, cioè con l’estendersi della “comunità domestica” o delle attività economiche al dominio pubblico, la gestione della 9:04 Pagina 103 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt casa e tutte le faccende che rientravano precedentemente nella sfera familiare sono diventate una questione “collettiva”. La società moderna si configura come un ibrido in cui «gli interessi privati assumono significato pubblico» (Arendt 1998, p. 26). «L’emergere della società (…) dall’oscura interiorità della casa alla luce della sfera pubblica ha non solo confuso l’antica demarcazione tra il privato e il politico, ma ha anche modificato, fino a renderlo irriconoscibile, il significato dei due termini e la loro importanza per la vita dell’individuo e del cittadino» (Arendt 1998, p. 28). La società moderna, prosegue la Arendt, al pari della dimensione privata greca, elude la possibilità dell’azione, richiedendo invece ai suoi membri «un certo genere di comportamento, imponendo innumerevoli e svariate regole, che tendono tutte a “normalizzarli”, a determinare la loro condotta, a escludere l’azione spontanea o imprese eccezionali» (Arendt 1998, p. 30). Il conformismo richiesto dalla società crea uguaglianza rendendo la distinzione una faccenda privata dell’individuo. «Questa eguaglianza moderna, basata sul conformismo intrinseco alla società e possibile solo perché il comportamento ha sostituito l’azione come modalità primaria di relazione tra gli uomini, è sotto ogni aspetto differente dall’eguaglianza dell’antichità, e particolarmente della città-stato greca. Infatti, appartenere ai pochi “eguali” significava poter vivere tra i propri pari; ma la stessa sfera pubblica era permeata da uno spirito agonistico, dove ognuno doveva costantemente distinguersi dagli altri, mostrare con gesta e imprese fuori dal comune di essere il migliore di tutti. La sfera pubblica, in altre parole, era riservata all’individualità; era il solo posto dove gli uomini potessero dimostrare il loro effettivo e insostituibile valore» (Arendt 1998, p. 31). La polis greca quindi, «fu il più individualistico e il meno conformistico dei corpi politici noti (…). Data l’importanza attribuita all’azione e al discorso, [essa] poteva sopravvivere solo se il numero dei cittadini rimaneva ristretto»; infatti, «più sono le persone, tanto più probabile sarà l’adeguamento al comportamento di tutti, e meno probabile la tolleranza del non conformismo» (Arendt 1998, p. 32). L’avvento della società moderna determina quindi da un lato la sostituzione dell’azione con il comportamento, dall’altro la sostituzione del «potere personale con 103 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 104 n.19 / 2007 la burocrazia, cioè il governo di nessuno» (Arendt 1998, p. 33), laddove “nessuno” configura «il preteso interesse comune della società nel suo insieme» (Arendt 1998, p. 30). Con l’ingresso della sfera domestica e delle sue attività nell’ambito pubblico, il lavoro – quale attività dedita alla sopravvivenza della specie mediante la soddisfazione di bisogni e necessità – viene ammesso nella dimensione pubblica; asceso all’ambito pubblico, perde la sua connotazione negativa di fatica e afflizione e diventa un ambito in cui si può eccellere. «L’eccellere – ricorda la Arendt – (…) è sempre stato caratteristico della sfera pubblica (…). Ogni attività compiuta in pubblico può raggiungere una eccellenza mai conseguita in privato: infatti l’eccellere, per definizione, ha bisogno della presenza di altri» (Arendt 1998, p. 36). Con l’avvento della società moderna si assiste ad un capovolgimento nelle attività umane fondamentali: il lavoro, relegato dai greci alla vita privata, ascende all’ambito pubblico e l’agire, da attività politica diviene esperienza privata. «Mentre siamo divenuti eccellenti nel lavoro che compiamo in pubblico, la nostra capacità di azione e di discorso è molto decaduta da quando l’avvento della sfera sociale l’ha relegata nella dimensione dell’intimità e della vita privata» (Arendt 1998, p. 36). All’analisi della sfera sociale, segue quella della dimensione pubblica, dell’essere-in-comune. Con “pubblico”, spiega la Arendt, intendiamo «che ogni cosa che appare in pubblico può essere vista e udita da tutti e ha la più ampia pubblicità possibile (…) [e] ciò che appare – che è visto e sentito da altri come da noi stessi – costituisce la realtà» (Arendt 1998, p. 37), ma intendiamo anche «il mondo stesso, in quanto comune a tutti e distinto dallo spazio che ognuno di noi vi occupa privatamente» (Arendt 1998, p. 39). Mondo che non è rappresentato né dalla terra né dalla natura, essendo piuttosto connesso «con l’elemento artificiale, il prodotto delle mani dell’uomo, come pure con i rapporti tra coloro che abitano insieme il mondo fatto dall’uomo»; quindi, «il mondo, come ogni infra, mette in relazione e separa gli uomini nello stesso tempo» (Arendt 1998, p. 39). Date tali premesse, «ciò che rende la società di massa così difficile da sopportare non è, o almeno non è principalmente, il numero delle persone che la compongono, ma il fatto che il mondo che sta 104 tra loro ha perduto il suo potere di riunirle insieme, di metterle in relazione e di separarle» (Arendt 1998, p. 39); la società di massa si configura quindi come una situazione in cui «gli uomini sono divenuti totalmente privati, cioè sono stati privati della facoltà di vedere e di udire gli altri, dell’essere visti e dell’essere uditi da loro» (Arendt 1998, p. 43), rendendo necessaria la ricerca di un legame suppletivo sufficientemente forte da rimpiazzare il mondo. La Arendt designa con il termine vita activa l’attività lavorativa, l’operare e l’agire. Caratteristica del lavoro è «il fatto di non lasciare nulla dietro di sé, il fatto che il risultato del suo sforzo sia consumato quasi con la stessa rapidità con cui lo sforzo è speso. E tuttavia questo sforzo, malgrado la sua labilità, nasce da un grande bisogno ed è motivato da un impulso più potente di qualsiasi altro, perché la vita stessa vi si fonda» (Arendt 1998, p. 62). Come anticipato, nella società moderna il lavoro è asceso alla più importante tra le attività umane: quand’è iniziata la sua valorizzazione? La sua ascesa? Fu, storicamente parlando, «il processo di accrescimento della ricchezza, della proprietà e delle capacità acquisitive» (Arendt 1998, p. 75) ad attrarre la modernità verso il lavoro. La nostra è una società di lavoratori in quanto solo il lavoro, al pari della vita, è fecondo, è garante e produttore di abbondanza; il che significa altresì che la nostra è una società di consumatori essendo «lavoro e consumo (…) due fasi dello stesso processo, imposte all’uomo dalle necessità della vita» (Arendt 1998, p. 90). All’analisi del lavoro quale attività dell’animal laborans, segue l’opera dell’homo faber che con le sue mani «fabbrica l’infinita varietà delle cose la cui somma totale costituisce il mondo artificiale dell’uomo» (Arendt 1998, p. 97). «Diversamente dall’animal laborans, la cui vita sociale è priva di mondo e simile a quella del gregge, e quindi è incapace di edificare e abitare una sfera pubblica e mondana, l’homo faber è pienamente in grado di avere una sua sfera pubblica, anche se non sarà politica, propriamente parlando. La sua sfera pubblica è il mercato di scambio, dove può mostrare i prodotti della sue mani e ricevere la considerazione che gli è dovuta» (Arendt 1998, p. 115). L’homo faber è quindi capace di stabilire, di creare relazioni anche se solo mediante lo scambio dei suoi prodotti che, tuttavia, necessitano, per essere fabbri- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin cati, dell’isolamento dagli altri «che consiste nell’esser soli con l’”idea”, l’immagine mentale della cosa da creare» (Arendt 1998, p. 115). Nel momento in cui l’homo faber esce dal suo isolamento si fa mercante. L’azione, terza ed ultima tra le attività umane analizzate dalla filosofa di Hannover, vede nella pluralità umana la sua condizione fondamentale che si contraddistingue per l’eguaglianza e la distinzione. «Se gli uomini non fossero uguali, non potrebbero né comprendersi fra loro, né comprendere i propri predecessori, né fare progetti per il futuro e prevedere le necessità dei loro successori. Se gli uomini non fossero diversi, e ogni essere umano distinto da ogni altro che è, fu o sarà, non avrebbero bisogno né del discorso né dell’azione per comprendersi a vicenda» (Arendt 199, p.127). Caratteristiche dell’azione sono l’illimitatezza, «poiché l’azione riguarda esseri capaci a loro volta di agire, la reazione, oltre che una risposta, è sempre una nuova azione che inizia qualcosa di proprio, e influisce autonomamente su altri» (Arendt 1998, p. 139); e l’imprevedibilità derivante non tanto dall’incapacità di prevedere le conseguenze, quanto piuttosto dalla constatazione che il pieno significato di ogni storia, quale risultato dell’azione, si rivela quando essa finisce. «L’azione si rivela pienamente solo al narratore, cioè allo sguardo retrospettivo dello storico, che quindi conosce sempre meglio dei partecipanti ciò che è accaduto» (Arendt 1998, p. 140). «Discorso ed azione sono le modalità in cui gli esseri umani appaiono gli uni agli altri non come oggetti fisici, ma in quanto uomini. Questo apparire, in quanto è distinto dalla mera esistenza corporea, si fonda sull’iniziativa, un’iniziativa da cui nessun essere umano può astenersi senza perdere la sua umanità (…) una vita senza discorso e senza azione (…) è letteralmente morta per il mondo; ha cessato di essere una vita umana perché non è più vissuta tra gli uomini» (Arendt 1998, p.128). Il totalitarismo quindi, rendendo gli individui isolati ed estraniati, privi dell’iniziativa come dell’azione, “disumanizza” l’uomo, lo priva della sua umanità. Agire significa prendere l’iniziativa, mettere qualcosa in movimento, e proprio su tale capacità di iniziare, che è «la suprema capacità dell’uomo [e che] politicamente si identifica con la libertà umana» (Arendt 1998, p. 656), riposa la speranza- 9:04 Pagina 105 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt possibilità di far fronte ai mali del nostro secolo. «Il fatto che l’uomo sia capace d’azione significa che da lui ci si può attendere l’inatteso, che è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile. E ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità» (Arendt 199, p. 129). «L’azione come cominciamento corrisponde [quindi] al fatto della nascita, se questa è la realizzazione della condizione umana della natalità, allora il discorso corrisponde al fatto della distinzione, ed è la realizzazione della condizione umana della pluralità, cioè del vivere come distinto e unico essere tra uguali» (Arendt 1998, p. 129). La capacità di «rivelazione del discorso e dell’azione emerge quando si è con gli altri; non per, né contro altri, ma nel semplice essere insieme con altri. Sebbene nessuno sappia chi egli riveli quando si esprime con gesti o parole, tuttavia deve correre il rischio della rivelazione» (Arendt 1998, p. 131). L’azione quindi necessita dello stare insieme della sfera pubblica. Di conseguenza, ogni qualvolta l’essere insieme degli uomini viene meno, come nei regimi totalitari, azione e discorso perdono la loro funzione di rivelazione e diventano meri strumenti volti ad uno scopo. La sfera pubblica, quale «spazio potenziale dell’apparire fra uomini che agiscono e parlano» (Arendt 1998, p. 147) è «potenzialmente ovunque le persone si raccolgano insieme, ma solo potenzialmente, non necessariamente e non per sempre» (Arendt 1998, p. 146). Linfa della sfera pubblica è il potere che «è realizzato solo dove parole e azioni si sostengono a vicenda, dove le parole non sono vuote e i gesti non sono brutali, dove le parole non sono usate per nascondere le intenzioni ma per rivelare realtà, e i gesti non sono usati per violare e distruggere ma per stabilire relazioni e creare nuove realtà» (Arendt 1998, p. 146). Il potere, quindi, «scaturisce fra gli uomini quando agiscono assieme, e svanisce appena si disperdono» (Arendt 1998, p. 147); nasce dalla partecipazione alla vita della polis, dall’esercizio della cittadinanza, dalla pratica di discutere e decidere, dalle sinergie tra parole ed azioni. Condizione fondamentale alla generazione di potere è, riassumendo, il vivere insieme delle persone. Esso quindi corrisponde alla condizione della pluralità. Dalla relazione potere-azione deriva la priorità 105 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 106 n.19 / 2007 accordata all’agire nella gerarchia della vita activa. «Alla base dell’antica stima riservata alla politica è la convinzione che l’uomo in quanto uomo, ogni individuo nella sua irripetibile unicità, appare e conquista la sua identità nel discorso e nell’azione, e che queste attività, malgrado la loro futilità da un punto di vista materiale, posseggono una qualità durevole, perché provocano il ricordo di sé, la sfera pubblica, lo spazio nel mondo di cui gli uomini hanno bisogno per apparire, è quindi “opera dell’uomo” più specificamente di quanto non lo sia l’opera delle sue mani o il lavoro del suo corpo» (Arendt 1998, p. 153). Si oppongono a tale concezione sia la convinzione dell’homo faber secondo cui i prodotti di un uomo possono contare di più dell’uomo stesso, sia la convinzione dell’animal laborans secondo cui la vita è il bene supremo. Entrambe le visioni «tendono a condannare l’azione e il discorso come occupazioni vane e chiacchiere oziose, e generalmente a giudicare le attività pubbliche in termini di utilità rispetto ai presunti fini superiori – rendere il mondo più usabile e più bello nel caso dell’homo faber, rendere la vita più facile e più lunga nel caso dell’animal laborans» (Arendt 1998, p. 153). La critica di «oziosa inutilità dell’azione e del discorso in particolare e della politica in generale» (Arendt 1998, p. 162), non è tuttavia prerogativa dell’età moderna; «è sempre stata una grande tentazione, sia per gli uomini d’azione sia per quelli di pensiero, trovare un sostituto all’azione nella speranza che la sfera degli affari umani potesse sfuggire all’accidentalità e all’irresponsabilità morale inerenti a una pluralità di agenti» (Arendt 1998, p. 162). Eliminare la pluralità, tuttavia, significa abolire la sfera pubblica: infatti, il principale rimedio alla pluralità, la monarchia, si basa sulla «esclusione dei cittadini dalla sfera pubblica e [sul]l’insistenza con cui li [invita] a badare ai propri affari mentre solo chi governa “deve attendere agli affari pubblici”» (Arendt 1998, p. 162). Dalla diffidenza per l’azione nasce la concezione dicotomica della comunità politica, basata cioè sulla distinzione tra chi governa e chi è governato. In queste circostanze, l’essenza della politica è “sapere come iniziare e governare nelle materie più importanti in termini di opportunità e inopportunità”; l’azione come tale è completamente eliminata ed è divenuta la mera “esecuzione di ordini”. “Platone fu il primo a introdurre la divisio- 106 ne fra quelli che sanno e non agiscono e quelli che agiscono e non sanno (…), così che sapere cosa fare e farlo divennero due prestazioni del tutto differenti” (Arendt 1998, p. 163-164). Da ciò deriva “l’identificazione platonica della conoscenza con il comando e il governo, e dell’azione con l’obbedienza e l’esecuzione” (Arendt 1998, p. 165). La dissertazione sull’agire termina con i “rimedi” alle aporie dell’azione: la facoltà di perdonare quale risposta alla irreversibilità, all’impossibilità di «disfare ciò che si è fatto anche se non si sapeva, e non si poteva sapere, che cosa si stesse facendo» (Arendt 1998, p. 175), e la facoltà di fare e mantenere promesse quale risposta all’imprevedibilità consentendo di «gettare nell’oceano dell’incertezza, quale è il futuro per definizione, isole di sicurezza» (Arendt 1998, p. 175). «Senza essere perdonati, liberati dalle conseguenze di ciò che abbiamo fatto, la nostra capacità di agire sarebbe per così dire confinata a un singolo gesto da cui non potremmo mai riprenderci (…). Senza essere legati all’adempimento delle promesse, non riusciremmo mai a mantenere la nostra identità» (Arendt 1998, p. 175). Tali facoltà quindi, oltre ad essere l’una il complemento dell’altra, «dipendono dalla pluralità, dalla presenza e dall’agire degli altri, dato che nessuno può perdonare se stesso e sentirsi legato da una promessa fatta solo a se stesso» (Arendt 1998, p. 175). All’analisi delle tre attività umane fondamentali la Arendt fa seguire le riflessioni sull’età moderna, sulla duplice fuga che la caratterizza: dalla terra all’universo e dal mondo all’io. Tre sono le scoperte che introducono alla modernità: la scoperta dell’America, la Riforma e l’invenzione del telescopio; scoperte che, ricorda la Arendt, sono accomunate dall’aver indotto forme diverse di alienazione. Diversamente dall’accoglienza riservata alle scoperte geografiche e alla Riforma, l’invenzione del telescopio, pur foriera di profondi cambiamenti, fu accolta tiepidamente, non suscitò nei contemporanei grandi emozioni. Conseguenza fondamentale dell’invenzione galileana – con il passaggio dal sistema geocentrico a quello eliocentrico e da quest’ultimo ad un sistema senza un centro fisso – fu l’alienazione della terra. Vi è un’innegabile corrispondenza, spiega la Arendt, tra la moderna alienazione del mondo e il soggettivismo della filosofia moderna. RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin Quest’ultima, infatti, inizia con il dubbio cartesiano ispirato dalla scoperta di Galileo. «I filosofi compresero subito che le scoperte di Galileo non implicavano semplicemente una sfida alla testimonianza dei sensi (…). Non era la ragione ma uno strumento artificiale, il telescopio, che praticamente cambiava la visione del mondo fisico; non era la contemplazione, l’osservazione e la speculazione che conducevano alla nuova conoscenza, ma l’attivo procedere dell’homo faber, del fare e del fabbricare (…). In altre parole, l’uomo si era ingannato nel confidare che la realtà e la verità si rivelassero ai suoi sensi e alla sua ragione se solo egli rimaneva fedele a ciò che vedeva con gli occhi del corpo e della mente» (Arendt 1998, p. 203). Se non ci possiamo più attenere all’evidenza allora dobbiamo dubitare di tutto. La certezza è quindi la principale perdita della modernità. Nel momento in cui ogni cosa è dubitabile, solo l’attività di dubitare è certa e reale: «dalla mera certezza logica che quando dubito di qualcosa io rimango consapevole di un processo di dubbio che si svolge nella mia coscienza, Descartes concluse che i processi che si svolgono nella mente dell’uomo hanno una loro propria certezza e possono diventare oggetto di un’indagine introspettiva» (Arendt 1998, p. 207). L’introspezione crea certezze, «perché nulla conta eccetto ciò che la mente produce da sé; nessuno interferisce se non il produttore del prodotto, e l’uomo è posto di fronte a nient’altro e a nessun altro che a se stesso» (Arendt 1998, p. 207). Principale conseguenza dell’introspezione, dell’assunto secondo cui la mente può conoscere solo ciò che ha prodotto, è la perdita del senso comune, quale senso condiviso della realtà che «diventa ora una facoltà interna senza alcuna relazione con il mondo» (Arendt 1998, p. 210). «Privati di quel senso “comune” che adegua i cinque sensi animali dell’uomo al mondo comune a tutti gli uomini, gli esseri umani non sono più che animali capaci di ragionare, di “calcolare le conseguenze”» (Arendt 1998, p. 210). Ulteriore conseguenza derivata dalle scoperte moderne fu «il rovesciamento dell’ordine gerarchico tra la vita contemplativa e la vita activa» (Arendt 1998, p. 214); dalla dissociazione di essere e apparire deriva l’impossibilità di conoscere mediante la sola osservazione: «per essere certi occorreva accertarsi e per conoscere, fare. Una 9:04 Pagina 107 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt conoscenza certa poteva essere raggiunta solo a una duplice condizione: in primo luogo, che la conoscenza concernesse solo ciò che si era fatto da se stessi (…), in secondo luogo, che la conoscenza fosse di natura tale da poter essere verificata solo dal fare» (Arendt 1998, p. 215). Tuttavia, ancora più radicale fu il rovesciamento tra il pensare ed il fare, con la subordinazione del primo al secondo. «La convinzione che la verità oggettiva non è data all’uomo, ma che egli può sapere solo ciò che fa lui stesso, non è conseguenza dello scetticismo ma è una scoperta dimostrabile, e quindi non conduce alla rassegnazione ma o a un’attività ancora più intensa o alla disperazione» (Arendt 1998, p. 217). La modernità sembra quindi caratterizzarsi dalla vittoria dell’homo faber quale diretta conseguenza dell’invenzione del telescopio, del fatto che uno strumento realizzato dall’uomo fosse stato vettore di modernità. Ciononostante, all’ascesa dell’homo faber segue quella del lavoro nella gerarchia della vita activa. L’invenzione del telescopio fu infatti tanto la ragione dell’ascesa, quanto della decadenza dell’homo faber che, avendo quale obiettivo l’edificazione del mondo e la produzione di cose del mondo, risentì dell’alienazione dello stesso. L’ascesa dell’animal laborans, della vita quale punto di riferimento dell’età moderna deriva dal fatto «che il rovesciamento moderno si produsse nel quadro di una società cristiana – la cui credenza fondamentale nella sacralità della vita è sopravvissuta (…) alla secolarizzazione e al generale declino della fede» (Arendt 1998, p. 234). Il cristianesimo con la sua insistenza sulla sacralità della vita tendeva da un lato «a livellare le antiche distinzioni e articolazioni all’interno della vita activa; tendeva a considerare il lavoro, l’opera e l’azione come egualmente soggetti alla necessità della vita presente», dall’altro «contribuiva a liberare in parte l’attività lavorativa, cioè quanto è necessario a sostenere il processo biologico, dal disprezzo in cui l’aveva tenuto l’antichità» (Arendt 1998, p. 236). Tuttavia, sottolinea la Arendt, la vittoria dell’animal laborans non sarebbe stata completa senza la perdita della certezza nell’immortalità derivata dalla secolarizzazione: «l’uomo moderno, quando perse la certezza di un mondo a venire, si ripiegò su se stesso» (Arendt 1998, p. 239). La vittoria dell’animal laborans non comporta tuttavia 107 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 108 n.19 / 2007 la perdita totale delle altre capacità umane così, «gli uomini continuano a fare, fabbricare e costruire, benché queste facoltà siano sempre più ristrette alla perizia dell’artista. (…) la capacità di agire, almeno nel senso della liberazione di processi, è ancora con noi, sebbene sia diventata la prerogativa esclusiva degli scienziati» (Arendt 1998, p. 241), ma «l’azione degli scienziati, poiché agisce nella natura dalla prospettiva dell’universo e non nel tessuto delle relazioni umane, manca del carattere di rivelazione dell’azione come della capacità di produrre vicende e storia, che insieme formano la fonte da cui scaturisce il significato che illumina l’esistenza umana» (Arendt 1998, p. 242). Come anticipato, il processo Eichmann, a cui la Arendt partecipa in veste di inviata del The New Yorker, offre alla filosofa l’occasione per ritornare sul totalitarismo. Dal processo ad Eichmann – gerarca nazista, catturato dagli israeliani in Argentina nel 1960, processato a Gerusalemme, condannato e giustiziato nel 1962 – nasce La banalità del banale in cui la Arendt si interroga sugli artefici, sui burocrati dell’Olocausto. L’aspetto più “sovversivo” ed “irriverente” del testo, fonte di critiche ed attacchi, sta proprio nel titolo che riprende la tesi avanzata dalla filosofa: la banalità, la quotidianità del male, rappresentata, nel caso di specie, da Eichmann, mediocre burocrate del regime nazista. «Il guaio del caso Eichmann – scrive la Arendt – era che di uomini come lui ce n’erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali. Dal punto di vista delle nostre istituzioni giuridiche e dei nostri canoni etici, questa normalità è più spaventosa di tutte le atrocità messe insieme, poiché implica (…) che questo nuovo tipo di criminale, (…), commette i suoi crimini in circostanze che quasi gli impediscono di accorgersi o di sentire che agisce male» (Arendt 2001, p. 282). Ricordiamo a tal proposito come Eichmann non rinnegò mai le sue azioni, ma rifiutò sempre l’accusa di omicidio in quanto infondata: «con la liquidazione degli ebrei io non ho mai avuto a che fare; io non ho mai ucciso né un ebreo né un non ebreo; insomma non ho mai ucciso un essere umano; né ho mai dato l’ordine di uccidere un ebreo o un non ebreo», affermò l’imputato (Arendt 2001, p.30). Anzi, «“personalmente” egli non aveva mai avuto nulla contro gli ebrei (…). 108 Ahimè, nessuno gli credette (…) [perché era difficile ammettere che] una persona comune, “normale”, non svanita né indottrinata né cinica, potesse essere a tal punto incapace di distinguere il bene dal male. Essi [i giudici] partivano dal presupposto che l’imputato, come tutte le persone “normali”, avesse agito ben sapendo di commettere dei crimini; e in effetti Eichmann era normale nel senso che “non era una eccezione tra i tedeschi della Germani nazista”, ma sotto il Terzo Reich soltanto le “eccezioni” potevano comportarsi in maniera “normale”» (Arendt 2001, p. 34). La logica a cui ripetutamente Eichmann si appellava, era l’obbedienza agli ordini: in quanto cittadino ligio alla legge e zelantissimo nell’eseguire gli ordini impartiti, quale egli stesso si definì, «non si sarebbe sentito la coscienza a posto se non avesse fatto ciò che gli veniva ordinato – trasportare milioni di uomini, donne e bambini verso la morte – con grande zelo e cronometrica precisione» (Arendt 2001, p.33). Oltre a denunciare la normalità dei vari Eichmann, le irregolarità e i toni teatrali del processo, la Arendt denuncia un’altra verità scomoda: il collaborazionismo degli ebrei. «Senza l’aiuto degli ebrei nel lavoro amministrativo e poliziesco (…) o ci sarebbe stato il caos completo oppure i tedeschi avrebbero dovuto distogliere troppi uomini dal fronte» (Arendt 2001, p. 125); «…i funzionari ebrei erano incaricati di compilare le liste delle persone da deportare e dei loro beni, di sottrarre ai deportati il denaro per pagare le spese di deportazione e sterminio, di tenere aggiornato l’elenco degli alloggi rimasti vuoti, di fornire forze di polizia per aiutare a catturare gli ebrei e a caricarli sui treni, e infine, ultimo gesto, di consegnare in buon ordine gli inventari dei beni della comunità per la confisca fiscale» (Arendt 2001, pp. 125-126). Tale verità, scomoda per l’accusa quanto per i sopravvissuti, non solo ridimensiona le responsabilità dell’imputato, dal momento che «la designazione degli individui da mandare a morte, salvo poche eccezioni, [era frutto del] lavoro dell’amministrazione ebraica» (Arendt 2001, p. 127), ma rende più labile il confine tra vittime e persecutori. La condiscendenza degli ebrei, apparentemente incapaci di ribellarsi al loro destino, ai lori persecutori, può essere letta alla luce delle riflessioni di Mancur Olson, da un lato, e di Anthony Downs, RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin dall’altro. Il primo, nel saggio La logica dell’azione collettiva, confuta la tesi secondo cui «se i membri di un qualche gruppo hanno un interesse o un obiettivo comune, e qualora la situazione di tutti migliorerebbe grazie al conseguimento di tale obiettivo, ne segua logicamente che i singoli membri di tale gruppo, qualora siano razionali e mossi dal proprio interesse, debbano agire allo scopo di conseguire tale obiettivo» (Olson 1983, p. 14); presupponendo che dalla «razionalità del comportamento ispirato all’interesse personale derivi logicamente l’idea secondo cui i gruppi tendono ad agire in difesa dei propri interessi di gruppo» (Olson 1983, p. 14). Secondo l’autore, quindi, «individui razionali e ispirati dal proprio interesse non si comporterebbero in modo tale da conseguire il loro interesse comune o di gruppo, a meno che il numero dei componenti del gruppo sia piuttosto piccolo, o a meno che non si ricorra a coercizioni o a qualche altra misura allo scopo di spingere gli individui ad agire nel loro comune interesse» (Olson 1983, p. 14). Spesso, evidenzia Olson, interesse individuale ed interesse collettivo confliggono; per il singolo può quindi essere irrazionale perseguire l’obiettivo comune, anche se facendolo otterrebbe un vantaggio. Quindi si astiene. Olson evidenzia inoltre come in presenza di gruppi numerosi «il partecipante tipico sa che i suoi sforzi probabilmente non influenzeranno molto il risultato finale» (Olson 1983, p. 67). Analogamente Downs, in Teoria economica della democrazia, analizzando il comportamento elettorale, si imbatte nelle ragioni degli astenuti, di coloro cioè che, perché indifferenti o perché convinti che il loro voto sia “insignificante”, si astengono dal partecipare al momento elettivo. Nella sua analisi Downs distingue gli elettori in diverse tipologie sulla base del grado di confidenza nella decisione. Tra questi rilevano, ai nostri fini, gli apatici, coloro cioè «che si astengono sistematicamente, ritenendo che per loro il differenziale fra i partiti sia nullo» (Downs 1988, p. 122) e i semi-neutrali «che hanno raggiunto la conclusione per cui non vi è differenza significativa fra i partiti e fra il governo in carica e quelli precedenti» (Downs 1988, p. 122), in quanto accomunati da un grado di confidenza prossimo allo zero, se non nullo; in quanto uniti dalla percezione dell’irrilevanza del loro voto, dalla convinzione di non poter cambiare lo statu quo. 9:04 Pagina 109 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt Intersecando le riflessioni di Olson a quelle di Downs si può comprendere meglio come milioni di ebrei abbiano “passivamente” accettato il ruolo di vittime, sulla base della convinzione, maturata dal singolo, che la sua azione non avrebbe mutato le circostanze, anzi forse le avrebbe peggiorate per lui e per il gruppo. Così, di fronte alla minaccia nazista, gli ebrei si dimostrarono incapaci di perseguire l’interesse comune, la lotta contro un destino di angherie e morte. Essendo stati trasformati in vittime razionali rispetto agli obiettivi nazisti, lo stesso interesse comune cambia, dall’opposizione al nazismo alla sopravvivenza dei più, divenendo a sua volta funzionale allo scopo del carnefice. Così, gli ebrei si trovarono ad interpretare il duplice ruolo di vittima e collaboratore. Specularmente, gli Eichmann, i burocrati nazisti incaricati di attuare l’Olocausto, hanno accettato il ruolo di esecutoricarnefici svolgendo con diligenza e rigore i compiti loro assegnati sulla base della medesima convinzione: il singolo non può cambiare le cose. Nell’analisi della Arendt, Eichmann rappresenta l’archetipo dell’uomo moderno incapace di azione, pensiero ed esperienza, isolato ed estraniato, che trova il senso della sua vita nell’appartenenza ad un movimento, ad una ideologia senza tuttavia esservi spinto da una profonda convinzione. «Già prima di entrare nel partito e nelle SS Eichmann aveva dimostrato di avere la mentalità del gregario, e l’8 maggio 1945, data ufficiale della sconfitta della Germania, fu per lui un tragico giorno soprattutto perché dal quel momento non avrebbe più potuto essere membro di questo o di quell’organismo. “Sentivo che la vita mi sarebbe stata difficile, senza un capo; non avrei più ricevuto direttive da nessuno, non mi sarebbero più stati trasmessi ordini e comandi, non avrei più potuto consultare regolamenti – in breve, mi aspettava una vita che non avevo mai provato”». (Arendt 2001, p.40). Dal resoconto della Arendt emerge, quale aspetto fondamentale, la constatazione secondo cui le azioni non hanno nessun valore morale intrinseco, ben riassunta dalla linea di difesa dell’avvocato di Eichmann, il signor Servatius: «…in base al sistema giudico nazista [Eichmann] non aveva fatto niente di male; perché le cose di cui era accusato non erano crimini ma “azioni di Stato”, azioni che nessuno stato straniero aveva il diritto di giudicare; (…) egli aveva il dovere di obbedire e – parole 109 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 110 n.19 / 2007 testuali di Servatius – aveva compiuto atti “per i quali si viene decorati se si vince e si va alla forca se si perde”» (Arendt 2001, p. 30). Riconoscere che gli esecutori dello sterminio di massa non erano persone immorali, sadiche, pazze o antisociali è indubbiamente inquietante. Scrive la Arendt, «[i nazisti] non erano sadici o assassini per natura; anzi, i nazisti si sforzarono sempre, sistematicamente di mettere in disparte tutti coloro che provavano un godimento fisico nell’uccidere (…). Perciò il problema era quello di soffocare non tanto la voce della loro coscienza, quanto la pietà istintiva, animale, che ogni individuo normale prova di fronte alla sofferenza fisica degli altri» (Arendt 2001, p. 114). Di fronte alla constatazione della normalità dei perpetuatori dell’Olocausto bisogna quindi accettare la possibilità che la morale possa contrastare con principi socialmente approvati, che la morale non sia un prodotto sociale spontaneo. «Anche se condannata dal gruppo (…) la condotta individuale può sempre essere morale; un’azione raccomandata dalla società (…) può sempre essere immorale» (Bauman 1992, p. 243). Le azioni, quindi, non sono «…immanentemente immorali. Il giudizio morale è qualcosa di esterno all’azione in quanto tale, ispirato a criteri diversi da quelli che guidano e danno forma all’azione stessa» (Bauman 1992, p. 38). Dove cercare quindi i fattori responsabili della capacità morale? Nella sfera sociale, nello stare assieme ad altri, nella coesistenza. Riprendendo le riflessioni di Lévinas (citato in Bauman 1992, p. 249), “essere con altri” significa innanzitutto essere responsabili; la responsabilità nasce dalla prossimità ed è l’unica forma in cui l’altro esiste per me. «Prossimità significa responsabilità, e la responsabilità è la prossimità» (Bauman 1992, p. 250). Come la morale nasce dalla prossimità, così l’immoralità è più probabile all’aumentare della distanza: «…la morale sembra conformarsi alla legge della prospettiva ottica. Essa appare grande e massiccia quando è vicina all’occhio. Al crescere della distanza, la responsabilità verso gli altri si riduce, la dimensione morale dell’oggetto si sfoca, finché entrambe raggiungono il punto di fuga e spariscono dalla vista» (Bauman 1992, p. 260). È sicuramente più semplice, meno inquietante e meno problematico interpretare l’esperienza dell’Olocausto come «un orribile crimine, com- 110 messo dai malvagi contro gli innocenti. [Laddove] gli assassini uccidevano perché erano folli (…). [e] le vittime andarono al massacro perché non erano in grado di competere con un nemico forte e ben armato» (Bauman 1992, p. 7). È più semplice leggere l’esperienza della shoah quale cancro della società, quale momentanea deviazione dal normale corso della storia del saggio, civilizzato mondo occidentale. A tale interpretazione salva coscienze, Bauman contrappone tuttavia l’idea secondo cui lo sterminio degli ebrei è in realtà il logico prodotto della modernità e come tale riguarda la società moderna nel suo complesso: «l’Olocausto fu pensato e messo in atto nell’ambito della nostra società razionale moderna, nello stadio avanzato della nostra civiltà e al culmine dello sviluppo culturale umano: ecco perché è un problema di tale società, di tale civiltà e di tale cultura» (Bauman 1992, p. 11). Proprio perché tale esperienza è il frutto della modernità, l’autoassoluzione è pericolosa: «esercitarsi ad individuare nella germanicità del crimine l’aspetto in cui deve risiedere la sua spiegazione è contemporaneamente un esercizio che assolve chiunque altro e, in particolare, qualunque altra cosa. L’ipotesi secondo cui i responsabili dell’Olocausto rappresentano una ferita o una malattia della nostra civiltà e non il suo prodotto terrificante ma coerente sfocia non soltanto nella consolazione morale dell’autoassoluzione, ma anche nella tremenda minaccia dell’inerzia morale e politica» (Bauman 1992, p. 13). Quale prodotto della modernità, la shoah può essere considerata «come un laboratorio sociologico. L’Olocausto ha messo in luce e permesso di esaminare alcuni attributi della nostra società non rilevabili, e perciò empiricamente inaccessibili, in condizioni ordinarie. In altre parole proponiamo di trattare l’Olocausto come un raro, ma tuttavia significativo e affidabile, test delle possibilità occulte insite nella società moderna» (Bauman 1992, p. 30). Ricapitolando, la tradizionale visione della shoah che legge la stessa quale insuccesso della civiltà nella sua opera di controllare le barbare inclinazioni che l’uomo ha ereditato dalla natura viene accantonata e sostituita con una lettura alternativa che legge l’Olocausto «come evento che ha rivelato la debolezza e la fragilità della natura umana (dell’orrore per l’omicidio, del rifiuto della violenza, della paura del senso di colpa e della responsa- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin bilità derivante dal comportamento immorale) di fronte all’efficienza fattuale dei più celebrati prodotti della civiltà: la sua tecnologia, i suoi criteri razionali di scelta, la sua tendenza a subordinare pensiero ed azione alla pragmatica economica ed efficientista» (Bauman 1992, p. 32). L’Olocausto è un mix di tecnologia e burocrazia, è un derivato della società industriale e della società burocratica: l’influenza della prima si può leggere, come sottolinea Kuper (citato in Bauman 1992, p. 32), nell’attenzione per il risparmio, il recupero dei materiali e l’efficienza produttiva dei centri di sterminio; mentre nell’attenzione per la correttezza delle procedure, per le definizioni precise e per il rispetto della legge, possiamo leggere l’influenza della seconda. Partendo da un percorso intellettuale diverso da quello della filosofa di Hannover non essendo caratterizzato, in particolare, dal tema del totalitarismo, Bauman ridimensiona, in parte, il giudizio della Arendt sul collaborazionismo ebraico. Circa un terzo degli ebrei, ricorda infatti il sociologo, fu ucciso senza nessun contribuito dei consigli o dei comitati ebraici. Tuttavia, «se la cooperazione non vi fosse stata, o almeno non su scala così ampia, le complesse operazioni dell’omicidio di massa avrebbero posto agli amministratori tedeschi problemi gestionali, tecnici e finanziari di ben altre dimensioni» (Bauman 1992, p. 168). Anche senza l’aiuto degli ebrei, l’Olocausto ci sarebbe stato comunque, ma probabilmente avrebbe avuto una portata più ridotta. Nelle sue riflessioni, Bauman evidenzia come la cooperazione che gli ebrei offrirono ai loro nemici risponde allo spirito «di sopravvivenza razionalmente interpretato, gli ebrei fecero dunque il gioco dei propri oppressori, facilitarono il loro compito, avvicinarono la propria fine» (Bauman 1992, p. 173). Il sociologo chiama in causa la burocrazia in quanto capace di promuovere azioni funzionali ai propri scopi anche se in contrasto con gli interessi degli attori. «In altre parole, la burocrazia che conduce una politica “mirata” ed ha il diritto esclusivo di condurla è pienamente competente a fissare i parametri di comportamento delle proprie vittime, e perciò di includere le stesse motivazioni razionali delle vittime tra le risorse di cui dispone per poter svolgere il proprio compito. [Tuttavia] prima che il potere burocraticamente organizzato possa contare sulla coopera- 9:04 Pagina 111 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt zione della categoria destinata ad essere colpita o distrutta, quest’ultima deve essere efficacemente isolata» (Bauman 1992, p. 174). Da qui l’importanza del ghetto, efficacemente sintetizzata nelle parole del rabbino Prinz (citato in Bauman 1992, p. 174), «il ghetto è il “mondo”. Il mondo esterno è il ghetto. Il ghetto è dappertutto: sulla piazza del mercato, per le strade, nelle pubbliche osterie. Ed ha un segno distintivo. Questo segno è l’assenza del prossimo». Le vittime dell’Olocausto, scrive il sociologo polacco, «non potevano contare sulla solidarietà di altri. La loro sofferenza apparteneva soltanto a loro. Le altre persone, fisicamente così vicine, sul piano spirituale erano infinitamente remote, in quanto non condividevano la stessa esperienza. E l’esperienza della sofferenza è difficile da comunicare» (Bauman 1992, p. 175). Gli ebrei erano isolati rispetto all’esterno, separati dal mondo circostante. L’isolamento fu funzionale alla conduzione del “gioco” del nazismo in cui gli unici partecipanti dovevano essere gli ebrei e i nazisti, e in cui le regole erano dettate da quest’ultimi. In una siffatta situazione, gli ebrei, «in quanto esseri razionali, dovevano affidarsi agli stessi principi di comportamento promossi dalla burocrazia che li teneva prigionieri: l’efficienza, la massimizzazione del vantaggio, la riduzione dei costi» (Bauman 1992, p. 181). Laddove la posta in gioco era la sopravvivenza o la morte, la razionalità aveva quale suo unico fine accrescere le possibilità di sfuggire allo sterminio o contenerne le dimensioni. Per realizzare il loro compito senza resistenze, i nazisti dovevano rendere il comportamento delle loro vittime prevedibile, quindi manipolabile, quindi controllabile, dovevano cioè indurre le vittime a comportarsi in modo razionale. Obiettivo, quest’ultimo, raggiunto facendo loro credere che c’era qualcosa da salvare, e che per farlo occorreva attenersi alle regole del gioco. Fu così che «in ogni fase del processo di distruzione – esclusa quella finale – vi furono individui e gruppi desiderosi di salvare ciò che poteva essere salvato, di difendere ciò che poteva essere difeso, di esentare ciò che poteva essere esentato: e perciò – sebbene soltanto indirettamente – di cooperare» (Bauman 1992, p. 188). Il sacrificio di alcuni per la salvezza dei molti divenne il principio guida, la giustificazione e l’autogiustificazione dei collaborazionisti ebrei. 111 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 112 n.19 / 2007 Le riflessioni di Bauman, le interconnessioni da lui esplicitate tra burocrazia e sterminio del popolo ebraico, ci aiutano d’altraparte a capire la mentalità di Eichmann e dei burocrati nazisti in generale. La burocrazia, evidenzia Bauman, si basa sulla separazione dei mezzi dalla valutazione morale, essendo, i primi, soggetti esclusivamente a valutazioni strumentali. Tale dissociazione è il risultato di due processi: la divisione del lavoro e la sostituzione della responsabilità tecnica a quella morale. Il primo processo consente di frapporre una certa distanza tra coloro che partecipano al risultato finale ed il risultato stesso facendo sì che «la maggior parte dei funzionari della gerarchia burocratica possa impartire ordini senza avere piena conoscenza dei loro effetti» (Bauman 1992, p. 144). Distacco che aumenta laddove la divisione diventi funzionale, in tal modo alla mancanza di esperienza diretta dei risultati delle proprie azioni si somma l’«assenza di analogia tra compito immediato e compito della struttura nel suo complesso (…). Una cosa è impartire l’ordine di caricare bombe su un aeroplano, un’altra è provvedere alla regolare fornitura dell’acciaio destinato a una fabbrica di bombe» (Bauman 1992, p. 145); o, richiamando l’esperienza di Eichmann, provvedere alla logistica dei treni. Ulteriore conseguenze della divisione funzionale dei compiti è l’affermazione della responsabilità tecnica. Quest’ultima, spiega il sociologo, si caratterizza per il considerare l’azione un fine in sé e perciò ogni azione va giudicata sulla base dei principi di adeguatezza e di successo; ciò che conta è che essa sia eseguita minimizzando i costi sulla base delle conoscenze disponibili. In sintesi, «una volta che, grazie alla complessa differenziazione funzionale della burocrazia, [gli attori] siano stati separati dai risultati ultimi dell’operazione a cui contribuiscono, le loro preoccupazioni morali si possono concentrare pienamente sulla buona esecuzione dei compiti immediati. La moralità si riduce all’imperativo di essere un buon lavoratore: efficiente, diligente ed esperto» (Bauman 1992, p. 147). La burocrazia inoltre, porta ad una disumanizzazione degli oggetti della sua attività che, spiega Bauman, inizia nel momento in cui tali oggetti sono ridotti a misurazioni quantitative: «per gli amministratori delle ferrovie l’unica espressione significativa dell’oggetto del proprio lavoro è data in termini di tonnellate per chilome- 112 tro. Essi non hanno a che fare con esseri umani (…), bensì semplicemente con un “carico”, cioè con un’entità costituita esclusivamente da quantità misurabili e priva di qualità» (Bauman 1992, p. 148). In sintesi, «fu la burocrazia a realizzare l’Olocausto» (Bauman 1992, p. 152). L’Olocausto mostra come il “male” non nasca «dall’infrazione dell’ordine, ma da un impeccabile, perfetto e incontrastabile dominio dell’ordine», come esso sia compiuto da «uomini in uniforme, obbedienti e disciplinati, che seguivano le norme e rispettavano meticolosamente lo spirito e la lettera delle istruzioni ricevute» (Bauman 1992, p. 211). Secondo il sociologo polacco, l’agghiacciante lezione-verità che possiamo ricavare da tale esperienza non è «costituita dalla probabilità che qualcosa di simile [possa] essere fatto a noi, ma dall’idea che [siamo] noi a poterlo fare» (Bauman 1992, p. 212). Il male, la crudeltà, l’assenza di umanità e pietà verso l’altro, non sono quindi intrinseci ad un soggetto, possono essere suscitati, provocati, forzati. Sulla base degli esperimenti di Milgram (citato in Bauman 1992, p. 214), la crudeltà sarebbe infatti correlata più con il rapporto di autorità e subordinazione che con le caratteristiche personali dell’attore; tali esperimenti hanno inoltre dimostrato come la disponibilità ad agire contro la propria coscienza sia maggiore all’interno di un’organizzazione che non ammette opposizioni né autonomia, ovvero derivi da un rapporto con una fonte di autorità risoluta, unica e monopolistica. Da ciò consegue che «il pluralismo è la migliore medicina preventiva contro la possibilità che individui moralmente normali commettano azioni moralmente anormali» (Bauman 1992, p. 228), o altrimenti detto, «la voce della coscienza morale individuale si ode meglio nel rumore della discordanza politica e sociale» (Bauman 1992, p. 229). Esempi “storici” di tale “verità”, li possiamo trovare nel resoconto della Arendt: «…i nazisti non avevano né gli uomini necessari né il coraggio di restare “duri”, quando urtavano in un’opposizione decisa» (Arendt 2001, p. 172). Così, di fronte alla resistenza delle istituzioni danesi ad obbedire ai loro ordini, le autorità tedesche insediate in Danimarca «…cambiarono mentalità. Non vedevano più lo sterminio di un intero popolo come una cosa ovvia. Avevano urtato in una resistenza basata su saldi principi, e la loro “durezza” si era sciolta RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Silvia Bedin come ghiaccio al sole» (Arendt 2001, p. 181). La stessa soluzione finale è un risultato dello strumento burocratico in quanto mezzo ottimale volto all’attuazione di un fine. Hitler fissò l’obiettivo del nazismo nel rendere il territorio del Reich libero dagli ebrei, senza tuttavia indicare i mezzi per raggiungerlo. La scelta dei mezzi fu affidata ad esperti che sulla base delle circostanze valutarono fattibilità e costi delle diverse alternative, fino ad arrivare alla soluzione ottimale; “il resto fu una questione di cooperazione tra diverse sezioni della burocrazia statale, di attenta pianificazione, di progettazione della tecnologia e delle attrezzature tecniche adatte allo scopo, di bilancio, di calcolo e mobilitazione delle risorse necessarie: a tutti gli effetti, una questione di tediosa routine burocratica” (Bauman 1992, p. 36). L’Olocausto non fu quindi altro – e in questo sta la banalità del male, l’inquietante lezione – che il prodotto di procedure burocratiche, il prodotto del processo volto a trovare, al mutare delle circostanze e al comparire di nuovi problemi ed esigenze, il mezzo ottimale per conseguire il fine dato. Come sottolineano Sabini e Silver (citati in Bauman 1992, p. 133) «…un omicidio accurato, globale, definitivo richiedeva la sostituzione della folla con la burocrazia, della furia collettiva con l’obbedienza all’autorità. Tale necessaria burocrazia sarebbe stata comunque efficace a prescindere dal fatto che fosse costituita da antisemiti estremisti oppure moderati (…); essa avrebbe governato le azioni dei propri membri non suscitando passioni, ma organizzando procedure di routine». L’Olocausto sottolinea il sociologo è inoltre stato reso possibile dallo svilupparsi del progetto ingegneristico, tipico della modernità, che in genere viene ingentilito nella forma della metafora della società quale giardino da organizzare in un modo razionale volto a realizzare una società migliore. «L’esistenza e la convivenza umana divennero oggetto di pianificazione e di amministrazione: come la vegetazione dei giardini o gli organismi viventi, esse non potevano essere lasciate alle proprie tendenze spontanee, e meno che mai si poteva consentire che fossero minacciate da erbe infestanti o sopraffatte da tessuti cancerosi» (Bauman 1992, p. 106). Nel momento in cui, con l’avvento della modernità, gli ebrei passano da peccatori a viziosi, mediante la «trasformazione del “delitto” del giudaismo nell’elegante “vizio” dell’ebraicità» 9:04 Pagina 113 Viaggio nel pensiero di Hannah Arendt (Arendt 2004, p. 122), la loro sorte fu segnata irreparabilmente. Come ricorda infatti la Arendt (2004, p. 122), vi è una differenza fondamentale tra peccato e vizio: mentre il primo può essere punito, il secondo può solo essere estirpato. «Il cancro, i parassiti o le erbe infestanti non possono pentirsi. Essi non hanno peccato, hanno semplicemente vissuto secondo la propria natura. Non c’è niente di cui punirli. Vista la natura della loro malignità, essi devono essere sterminati» (Bauman 1992, p. 109). Ricapitolando, sono tre le condizioni necessarie per arrivare a concepire lo sterminio di un popolo: il richiamo alla razza, ad un difetto innato ed incurabile; il richiamo alla medicina e al modello di salute e normalità; ed il richiamo all’approccio ingegneristico della società. Gli ebrei non dovevano morire perché odiati, bensì «perché si collocavano tra una realtà imperfetta e carica di tensioni e l’agognato mondo della tranquilla felicità. (…) la scomparsa degli ebrei era strumentale alla realizzazione di un mondo perfetto» (Bauman 1992, p. 113). «Le vittime di Hitler e Stalin (…) furono uccise perché non rientravano, per una ragione o per un’altra, nel progetto di una società perfetta. Furono eliminate affinché fosse possibile fondare un mondo umano obiettivamente migliore: più efficiente, più morale, più bello» (Bauman 1992, p. 136). Come fu possibile, si chiede infine Bauman, trasformare persone normali in assassini? La risposta sembra venire da Kelman (citato in Bauman 1992, p. 41) secondo cui «le inibizioni morali che impediscono di commettere atrocità violente tendono ad essere erose in presenza di tre condizioni (…): quando la violenza è autorizzata (da ordini ufficiali provenienti da istanze investite di autorità legale), quando le azioni violente sono routinizzate (da pratiche rispondenti a norme e da una precisa definizione dei ruoli); e quando le vittime della violenza vengano disumanizzate (grazie a una definizione e a un indottrinamento di carattere ideologico)». Ricapitolando, se in Le origini del totalitarismo la Arendt si interroga sulle origini e le dinamiche di funzionamento dei regimi totalitari e in La banalità del male si concentra sulle ragioni che sottostanno all’assenso dei singoli al regime nazista, soffermandosi sui funzionari, sugli Eichmann quali archetipo del burocrate totalitario, in Vita Activa rivendica il primato assoluto dell’agire politico su tutte le altre 113 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 114 n.19 / 2007 attività umane eleggendo la politica a rimediocompensazione del male del totalitarismo. Sommando i contributi della filosofa di Hannover e del sociologo polacco Bauman si può leggere in una modernità caratterizzata dalla preminenza dell’animal laborans sull’attore politico, dalla degenerazione della politica da ambito di azione e discorso a mera attività amministrativa e del cittadino a uomo-massa isolato e atomizzato nonché dalle invenzioni di burocrazia e tecnologia la fonte e la causa della deriva totalitaria. La modernità sembrerebbe responsabile di una regressione dell’uomoattore, anima della polis greca, a semplice “cavia” da laboratorio che è stata privata di iniziativa, spontaneità ed unicità, ed è stata ridotta ad una somma di comportamenti conformati, prevedibili ed indotti mediante la regola del “bastone e della carota”, attraverso la prospettiva di sanzioni e gratificazioni. In un contesto nel quale l’uniformità è la regola, in cui vittime e carnefici sono pedine dello scacchiere della legge della storia o della natura, il singolo si sente solo, isolato, incapace di reagire perché convinto che ogni sua azione rimarrà priva di significato e conseguenze. Laddove la democrazia nell’antica Grecia era praticata, vissuta e sperimentata garantendo e producendo un apprendimento by doing, il totalitarismo riduce l’apprendimento alla routine stimolo-risposta, crea compartimenti stagni in cui “incasellare” i diversi “prototipi” – il burocrate, il soldato, l’ebreo 114 – isolandoli l’uno rispetto all’altro, privandoli di un ambito di azione e discorso, della capacità di comunicare tra loro. Infine, la degenerazione della democrazia in totalitarismo o viceversa la riconquista della democrazia non è un percorso breve né brusco, quanto il risultato di chi trovandosi ad un bivio deve scegliere se intraprendere la tortuosa strada della partecipazione, della deliberazione, della pluralità o la più lineare strada dell’uniformità, della routine e dalla costrizione della logica, base di ogni ideologia. Riferimenti bibliografici Arendt, Hannah, Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi 2004. Arendt, Hannah, Vita activa. La condizione umana, Sonzogno, Bompiani 1998. Arendt, Hannah, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli 2001. Bauman, Zygmunt, Modernità e Olocausto, Bologna, Il Mulino 1992. Downs, Anthony, Teoria economica della democrazia, Bologna, Il Mulino, 1988, pp.69-83; 119123; 297-313. Olson, Mancur, La logica dell’azione collettiva. I beni pubblici e la teoria dei gruppi, Milano, Feltrinelli Editore 1983, pp.13-29; 67-71. Privitera, Walter, Sfera pubblica e democratizzazione, Bari, Laterza 2001, pp. 16-23. RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 115 Recensioni LibriLibriLibri WLADIMIRO DORIGO, Battaglie urbanistiche. La pianificazione del territorio a Venezia e in Italia, fra politica e cultura. 1958-2005, Verona, Cierre Ed., 2007 Wladimiro Dorigo nasce nel 1927 e si laurea a Padova, alla facoltà di Lettere, con una tesi sulla pittura tardoromana nel 1954. Nel 1956 diventa assessore all’urbanistica della città di Venezia. Ha cominciato la propria attività politica come democristiano e se ne allontana quando capisce che la filosofia di vita della DC si è costruita sull’idea della piccola proprietà famigliare e non riesce ad accedere ai valori e ai bisogni di comunità più ampie. Dorigo sostiene, nel 1961, che il partito di maggioranza italiano “mai fino ad oggi aveva mostrato di sospettare l’esistenza di un piano di lavoro, scientifico, amministrativo, tecnico e politico quale è quello dell’urbanistica” (p. 71). In effetti, probabilmente la giovane età impedisce in quegli anni a Dorigo di comprendere fino in fondo che la DC è profondamente cambiata negli ultimi anni e che egli, come democristiano, si è trovato di fronte alla crisi di una democrazia cristiana che ha abbandonato le sue originarie ispirazioni all’autonomia e alla sussidiarietà e sta sempre più qualificandosi per la difesa ideologica di interessi particolari nelle campagne e nelle città. La scelta di Dorigo, quando nel 1958, per la mancata approvazione dei bilanci comunali, il Consiglio Comunale viene sospeso e subentra un Commissario Governativo alla guida del Comune di Venezia, è quella di lasciare la DC e di avvicinarsi al PSI. Rimane tuttavia dentro il centrosinistra nella convinzione che la soluzione cercata è quella che questa alleanza ha realizzato, nel 1964: la DC, nell’alleanza, ha “abbandonato proprio il settore urbanistico all’impostazione del Psi. Abbiamo denunciato più volte l’incapacità della Dc di comprendere il problema urbanistico, in sede culturale prima ancora che politica, e proprio qui è, a nostro avviso, alla fine la spiegazione più vera. La Dc ha sempre ignorato il problema urbanistico, sia per il rifiuto aprioristico che le ispirava il termine ‘pianificazione’ che accompagna il suo farsi, sia perché la struttura ideologica del partito, radicata sulla dimensione famigliare e piccolo-proprietaria, non riusciva a considerare la cultura delle città e del territorio in termini diversi da una questione di disegno architettonico e tipologia edilizia da una parte, e di rendita legittima e inalienabile del suolo dall’altra” (p. 100). Ci vorrà al crisi del giugno 1964 a convincere Dorigo che anche questa è un’illusione e che il centrosinistra non riesce a rappresentare la svolta che egli si auspicava. Per Dorigo, nel 1958, finisce l’attività di assessore, anche se egli non smetterà mai di interessarsi di urbanistica e continuerà la propria battaglia come giornalista, attraverso la rivista Questitalia e la collaborazione ad altre riviste. Parte di questi scritti su Venezia sono stati raccolti in questo volume che ha l’obiettivo di presentarci la figura e l’opera di Dorigo che, nel 2005, ha ricevuto, dallo IUAV di Venezia, la laurea honoris causa in Pianificazione del territorio. La lectio magistralis tenuta in quella occasione è la degna chiusura dell’opera. Dorigo muore nel 2006. L’uscita di Dorigo dalla DC, alla fine degli anni Cinquanta, coincide con l’intuizione della necessità di realizzare i Piani Regolatori Generali attraverso forme di democrazia diretta e non affidandosi alla mediazione dei politici e alle soluzioni dei tecnici. Egli denuncia, inoltre, il fatto che le Giunte provinciali amministrative siano illegittimamente investite del problema della revisione della pianificazione urbanistica, mentre questo compito la Costituzione lo avrebbe affidato alla Regione (ma siamo in un’epoca in cui le Regioni non sono state ancora istituite). Dorigo vive, come tutta la sinistra del tempo, la convinzione che l’attuazione integrale della Costituzione avrebbe realizzato migliore e più complete forme di democrazia. Solo dopo l’istituzione delle Regioni nel 1970, si capirà che questo non era del tutto vero o non era sufficiente. Una seconda illusione è quella che la pianificazione, che egli concepisce ancora come razionalizza- 115 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 116 n.19 / 2007 zione ex ante degli interventi sul territorio, possa risolvere gran parte dei nodi politici irrisolti. La sua idea è che le tante pianificazioni settoriali si trasformino in un’unica antipianificazione. Questa illusione che si debba pianificare il territorio con una valutazione generale del contesto in cui si inserisce un intervento urbanistico non gli appare, al tempo, come di difficile conciliazione con l’aspirazione a forme di democrazia diretta. Dorigo ha ragione quando contrappone la pianificazione alla legge della domanda e dell’offerta, cioè alle forze anarchiche del mercato che curano solo gli interessi individuali ma non difendono (e spesso offendono) gli interessi collettivi. Ma ha meno ragione quando spera nella capacità di pianificare ex ante. Lo mostrano alcuni suoi scritti in questa raccolta nei quali denuncia il “Triste bilancio urbanistico al Congresso di Bologna” o il fallimento del Convegno internazionale di Venezia del 1962. Un fallimento, quest’ultimo, che egli denuncia immediatamente: “come non rilevare che, quando non si dichiara esplicitamente di non conoscere i problemi e quindi di trattenere il giudizio, si fanno affermazioni generiche, in vario modo apprezzabili, che tuttavia nulla danno di nuovo, in nulla contribuiscono a distogliere la querelle veneziana, come altra volta abbiamo lamentato, dalle secche delle posizioni astratte, non storicizzate, incapaci di un esame nuovo e aperto di una realtà inclassificabile come a Venezia? È proprio quest’ultima constatazione che avvalora un giudizio di totale fallimento culturale del convegno veneziano, almeno per quanto riguarda il contributo esterno” (p. 233). Il riferimento è alle presenze internazionali di urbanisti famosi per avere realizzato il piano regolatore o di ricostruzione di varie città internazionali i quali si presentano a Venezia a proporre soluzioni generiche perché non hanno una conoscenza profonda della situazione veneziana. Del resto, come illudersi che noti professionisti, abituati a incassare cifre stratosferiche per ogni grande opera realizzata, si impegnino più di tanto per il solo prestigio di essere presenti a Venezia e fornire una loro idea su come pianificare a Venezia? Una loro idea che, peraltro, non può non essere generica dal momento che le grandi idee nascono dalla conoscenza del contesto, dai gruppi di lavoro che si riescono a costituire e dalla ricerca 116 di una via condivisibile tra le tante vie conflittuali messe in campo in ogni progetto di pianificazione urbanistica. Il resto del convegno, conclude Dorigo, è andato bene perché ha permesso che si palesassero i conflitti tra le diverse linee (egli ne individua due: la linea Zanon, Dal Bo, Astengo, Samonà, appoggiata da Piccinato e una seconda che egli definisce di pretese “modernistiche” formulata da “Venezia viva”). Ma è poca cosa se si pensa che, nel saggio successivo, egli lamenta che queste linee sono presentate senza un adeguato approfondimento attraverso la ricerca: “A un esame siffatto non risulta si sia accinta la cultura veneziana o italiana, né pare che allo stridente contrasto di queste realtà alcun istituto di ricerca – quali non mancano a Venezia – e alcun ente pubblico abbia portato un’attenzione non episodica o parziale, ma coordinata e attenta a scoprire nelle ricche virtualità umane pur presenti in tutto il territorio gli elementi essenziali di un’articolata terapia” (p. 246). Né l’autonomia sembra lavorare molto a questo obiettivo dal momento che, palesemente, le varie comunità locali si dilaniano tra una comunità centrale (Venezia storica) sempre più gelosa della sua supremazia perduta e le altre parti della città che aspirano a recuperare quella completa autonomia che il centro insulare nega loro (lo scritto è del 1964 e già anticipa i referendum per la separazione da Venezia di Mestre o di altre comunità della laguna). Il 1970, anno in cui finisce l’attività della rivista Questitalia, è per Dorigo l’anno in cui diventa chiaro che tutto (quello che di male si poteva fare a Venezia) è già stato fatto “là dove si puote” e si è affidato lo sviluppo della città “alla belletta negra dei falsi, delle ignominie, dei sordidi interessi speculativi e di classe, che si annidano nella querelle sulla bellezza, sull’arte e sulla civiltà di cui Venezia è fatta palladio” (p. 259). Molti degli scritti di Dorigo sono dedicati, ovviamente, a Porto Marghera e agli errori che vengono fatti nella progettazione dello sviluppo industriale di quest’area. In questa polemica, Dorigo, nel 1967, conia il termine Padania per indicare gli interessi monopolistici che hanno spinto verso un modello di sviluppo industriale estraneo alla logica di Venezia. Oggi, il termine Padania serve a indicare una realtà politica che comprende anche il Veneto, anche se la natura del Veneto è quella di RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 essere estranea alla realtà fluviale del Po, dal momento che i suoi fiumi non sono affluenti di questo fiume e gettano direttamente le loro acque nel mare. La Padania di Dorigo ha la responsabilità di avere spinto verso un’idea di sviluppo industriale basata sul chimico e sullo sconvolgimento dell’equilibrio della laguna. Dorigo si batte molto contro questo coacervo di interessi. Ma, come confesserà nella sua lectio magistralis, anche questa seconda sarà una sconfitta: “nel tentativo di perseguire una pianificazione e una politica di correzione pubblica della Marghera monopolistica degli anni Sessanta, debbo qui confermare un duplice riconoscimento di sconfitta, che è ben presente nella mia bibliografia. Nel primo caso, si incaricò la politica moderata e cieca degli anni Cinquanta in Italia” (p. 368). Nel secondo caso, l’ampliamento del Porto di Marghera. (Giuseppe Gangemi) [email protected] WLADIMIRO DORIGO, Battaglie urbanistiche. La pianificazione del territorio a Venezia e in Italia, fra politica e cultura. 1958-2005, Verona, Cierre Ed., 2007 Venezia e l’altro da sé “dialettica pericolosa e indispensabile” Wladimiro Dorigo è stato una persona con interessi molteplici dal punto di vista culturale, forse focalizzati su Venezia come oggetto universale di conoscenza e di amore; e con modalità di presenza poliedriche per ambiti disciplinari, stratificate per stile di intervento, onnivore per curiosità intellettuale e rigorose, fino a rasentare la maniacalità, nell’azione di responsabilità pubblica, intellettuale e politica che fosse. Oltre a Venezia un altro “fuoco” della sua attitudine morale è la democrazia, come vero orizzonte della convivenza sociale, non solo come assunto procedurale di partecipazione civica, ma anche come forma di trasferimento del grande capitale sociale di cui Venezia è eterna, diamantina testimonianza, in tutta la compagine della comunità civile. Pertanto le sue straordinarie battaglie urbanistiche (raccolta di scritti 1958 – 2005, Cierre edizioni, 9:04 Pagina 117 Venezia, 2007) sono per Venezia e nella democrazia. La prima parte del volume è dedicata a “La pianificazione urbanistica nella vita democratica” e raccoglie interventi svolti su “Questitalia” e ai congressi dell’INU presieduto da Adriano Olivetti, grande sismografo dei cambiamenti del Paese nella seconda metà degli anni ’50 e nei primi anni ’60. Lo spirito dell’epoca è segnato da un problema che fa da sfondo sia all’asprezza dello scontro politico – parlamentare sia a quello tra gli specialisti del territorio. In un saggio del 1962 Dorigo espone con nitida consapevolezza il problema: “Non soltanto non è stata ancora data una sistemazione teorica soddisfacente al problema delle metodologie di ricerca e di programmazione, ma non è stata ancora immaginata quella legislazione generale, vera ‘cornice’ di tutte le leggi – quadro di legislazioni regionali in materie implicate nella pianificazione economica nazionale su basi territoriali, che sola può stabilire i fini, gli strumenti generali, i ruoli istituzionali, le garanzie, i controlli della programmazione economica…di salto qualitativo della politica che l’oggi e il domani ci impongono” (p. 91). L’architettura sintattica e il periodare sono complessi e articolati come per dare respiro alla ricchezza e varietà dell’argomentare, che in questa espressione si trova quasi tutta compresa. Il principio da cui muove è l’idea che la programmazione generale dello Stato si possa articolare nei diversi territori in modo da poter orientare incisivamente la razionalità dei processi di sviluppo. L’anno precedente, nel 1961, questo principio aveva una declinazione ancora più dirigistica, forse condita dell’illuminismo olivettiano, e una fiducia davvero enorme nella capacità programmatoria effettiva della politica: “Bisogna comprendere in una riforma generale tutta la struttura amministrativa dello Stato e degli Enti Locali, in modo che essa corrisponda alla reale struttura del territorio, e, meglio ancora, alle sue prospettive di sviluppo scientificamente determinate, con garanzia democratica diretta, a ogni livello” (p. 65). Questa convinzione è maturata nel vivo confronto con le questioni aperte nel Paese dopo la guerra e nel processo di ricostruzione che sta per trasformarsi nel miracolo economico, in una fase – dirà nella sua Lectio Magistralis all’IUAV che conchiude il volume – “in cui tutto sarebbe stato ancora possibile” (p. 371) per le sorti del nostro territorio e 117 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 118 n.19 / 2007 quindi della qualità del nostro sviluppo -; e con l’inestimabile magistero di Adriano Olivetti, incontrato con un lungo colloquio al Congresso dell’INU nel 1958 a Bologna trovandolo “ben convinto della priorità assoluta, e anzi della pregiudizialità, della soluzione del problema dei rapporti fra legislazione e pratica urbanistica e legislazione pratica economico – politica, in ordine alla questione dell’attuabilità di una effettiva politica di pianificazione urbanistica nel nostro Paese” (p. 58). La programmazione in Dorigo non è mai un concetto dirigistico nell’accezione tecnocratica che ha assunto questo termine successivamente, ma acquista il suo statuto più autentico fondandosi in modo “organico” nella partecipazione democratica di tutti i cittadini ai diversi livelli dell’architettura istituzionale dello Stato: è pertanto programmazione democratica. In questa visione con una cultura significativamente espressiva delle più innovative tendenze del pensiero pragmatico, non solo sa ben contaminare le idee teoriche, ma le sottopone al fuoco sperimentale dei problemi pratici aperti davanti all’agire urbanistico. Questa varietà compositiva del repertorio culturale gli permette di vedere tutti gli aspetti lacunosi della programmazione, sia dal lato della “ascesa” partecipativa non ben regolata e, quindi incapace di incidere sugli indirizzi di fondo della pianificazione; sia dal lato della “discesa” ovvero le sconnessioni della catena decisionale che dallo Stato si dispiega fino al territorio attraverso le corsie della regolazione funzionale delle istituzioni di governo (pp. 32 – 5). Questa insistenza sulle forme non nasce da un’esigenza accademica, del tutto astratta, ma deve fare i conti con un problema molto delicato della situazione italiana: la necessità di rimuovere un grumo potentissimo di interessi arroccati intorno alla rendita sia tra i proprietari fondiari che tra le rappresentanze politiche che li tutelano caparbiamente. Non solo, ma nel rapporto tra rendita fondiaria, valorizzazione automatica delle aree e meccanismi fiscali prevalgono elementi che vanno a premiare l’appropriazione monopolitistica, cui Dorigo assiste de visu a Marghera. Le plusvalenze della rendita fondiaria sono ingentissime e crescono indipendentemente dal realizzo; si tratta quindi di profitti meramente speculativi che non innescano reale sviluppo economico: “Una legge come questa 118 (Pieraccini n.d.s.), che colpisce duramente, globalmente, senza eccezioni, un settore di rendita colossale certo, ma per sua natura pigra, nascosta, interessata a procrastinare il realizzo, invece che ad accelerarlo, è una legge che elimina una forma arcaica di speculazione…” (p. 102). La rimozione dei fattori inerziali di rendita comportano la necessità di un’azione integrata sia di programmazione economica che di strumenti per lo sviluppo territoriale. Con Leonardo Benevolo, relatore a un convegno della DC nazionale nel 1961, Dorigo condivide l’assunto che “una nuova legge urbanistica senza una ferrea disciplina sulle aree non risolverebbe nulla” (p. 73). Il degrado del territorio e il circolo vizioso tra appropriazione monopolistica delle aree, speculazione immobiliare e freno allo sviluppo lo inducono alla ricerca di terapie radicali alla situazione, in linea con una ortodossia propria della cultura sociale cattolica di quegli anni, affinché si “possa raggiungere il fine essenziale di una pubblicizzazione del diritto di superficie tale da consentire alla comunità e ai singoli l’edificazione, al di fuori dell’attuale jugulazione speculativa e di tutte le tendenze urbanisticamente abnormi e amministrativamente intollerabili oggi in atto” (p. 82). La radicalità dell’impostazione sostituisce l’istituto, circoscritto e spesso debole, dell’esproprio con una integrale pubblicizzazione del diritto di superficie; da questo dovrebbe seguire una fissazione a priori degli interessi della comunità e una calmierazione molto drastica dei prezzi delle aree edificabili. Il Comune acquista le aree in base alle previsioni di PRG con la “volontaria decisione degli alienanti privati” (p. 83), per poi metterle all’asta su valori che prospettano il realizzo di quanto previsto dalla pianificazione. Si pensi che questo modello viene proposto in un contesto in cui i Comuni erano in deficit in quanto dovevano sobbarcarsi tutti i costi di urbanizzazione delle aree, senza alcuna partecipazione dei privati! Attraverso questo meccanismo, invece, si “garantisce la completa e preventiva attrezzatura di servizi pubblici e di servizi sociali nei nuovi quartieri, senza onere per il Comune, rientrando ampiamente tali costi nell’equo prezzo delle aree rivendute, al posto dell’attuale plusvalore fondiario” (p. 84). A suffragare la praticabilità di questa strategia Dorigo porta anche la presenza emblematica della RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 stessa proposta nel programma del partito laburista inglese presentato al congresso di Blackpool nell’ottobre 1961 (p. 95). La “battaglia urbanistica” di Dorigo, in realtà nel Paese è sempre più isolata all’interno del suo partito, la DC allora, incapace di “comprendere il problema urbanistico, in sede culturale prima ancora che politica” (p. 100); e viene delusa con l’avvento del centro sinistra a livello nazionale perché la visione laico – socialista da lui fortemente condivisa su questi temi per l’impostazione data al X congresso di Firenze dell’INU nel 1964, presenti anche i pianificatori dal basso come Danilo Dolci (p. 110 -1) più tardi cederà complessivamente al “nemico” doroteo molto spazio (p. 124). Dalla successione incalzante degli eventi che trasforma le grandi speranze nell’avvento di un programma di governo che traduca operativamente i grandi assunti della cultura politica olivettiana in grandi delusioni per una cocente sconfitta sul campo di quelle tesi si evince lo sfondo sul quale collocare la più grande delle battaglie condotte da Dorigo, quella per la sua Venezia. Nessuno dei presupposti fondamentali su cui si è mosso Dorigo è stato logorato dal tempo, ma rimangono tutti estremamente vitali e attuali, persino alcuni risultano rafforzati dagli eventi successivi. Nel 1957 ha in mano la responsabilità diretta del Piano regolatore in qualità di Assessore all’Urbanistica, prima del 1956 e dopo il 1958 è stabilmente presente sia nel Comitato ministeriale che in altri organismi che si succedono nella gestione di problemi pianificatori o gestionali, come il Consorzio per la terza area industriale di Marghera. Una prima tetragona convinzione consiste nell’intrecciare il problema della conservazione di Venezia sia con la questione inerente la sua inimitabile specialità, sia con la necessità di un’impostazione “sistemica” degli interventi, sia, infine, con la connessione con gli obiettivi residenziali, economici e sociali del ripopolamento. Le sue parole, a questo riguardo, sembrano scritte oggi: “conservazione dunque, ma di che tipo? Certo non di conservazione ‘archeologica’ si intende parlare” (p. 208); e ancora: “si deve insomma riconoscere anzitutto che l’ormai scontata impostazione conservativa data dalla cultura urbanistica al problema dei centri storici ha un’applicabilità assai ridotta nel 9:04 Pagina 119 caso di Venezia insulare, che non è…propriamente un centro storico, ma una completa città storica, posta dalle condizioni geofisiche ed economiche del suo territorio, oggi, in una situazione quanto mai precaria ed eccezionale, non foss’altro per il suo isolamento, per i costi delle sue comunicazioni, per il suo progressivo distanziamento sociologico dalla vita normale dei nostri giorni” (p. 252). Fondamentale, in secondo luogo, è l’idea di modernità ritardata di Venezia, come necessità di governare le forme anche orripilanti che assume la sua rincorsa, soprattutto con ciò che significa l’industrializzazione di Marghera e la conurbazione mestrina. A questo proposito usa un’espressione di inarrivabile efficacia: “Marghera come dialettica, pericolosa e indispensabile” (p. 354). Ma le sue esperienze sia di assessore che di studioso militante lo portano a riconoscere sia il problema urbanistico nell’ampliamento senza dispersione diffusiva degli agglomerati urbani di terraferma (p. 216) che snatura la stessa opposizione tra città e campagna: “che senso ha delimitare entro un territorio comunale le zone urbane da quelle rurali, se poi la campagna può essere pacificamente, e senza particolari licenze, trasformata in città” (p. 222); sia il problema che trascende e determina quello urbanistico della terraferma conurbata, ovvero la crisi di identità mestrina: “per il più imperioso dei suoi problemi, quello che li assomma tutti: la nascita e il riconoscimento alla terraferma di una personalità precisa, di una forma di civiltà compiuta” (p. 247). Per terzo, Dorigo è uno dei primi al mondo a rilevare l’esistenza dei problemi climatici, l’influenza sui mari e le possibili conseguenze sulla sostenibilità fisica della vita in laguna (p. 234) fin dal remotissimo convegno alla Fondazione Cini dell’ottobre 1964. Presupponendo questi tre formidabili capisaldi la sua sferzante invettiva non ha grandi difficoltà, sul piano polemico, a ridurre a brandelli la tesi di Astengo sulla necessità di una minuziosa documentazione storica e fotografica di tutti i manufatti veneziani (A che servono gli studi di Astengo? p. 240); o quella, speculare e irrealistica di Samonà di pianificare Venezia cominciando dal livello regionale (p. 241). E, ancora, la critica frontale alla pianificazione comprensoriale che esclude i Comuni dal processo partecipativo alla pianificazione stessa (p. 269). Capace di disinnescare con mirabile sistematicità ed ineguagliabile precisione i danni 119 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 120 n.19 / 2007 indotti dall’ “informazione disinformante” (p. 259) – quanto ne avremmo bisogno oggi! - Dorigo documenta in modo inoppugnabile una tesi politically non correct e scomoda anche ai giorni nostri: ha fatto più male a Venezia la CIGA di Volpi con le sue ambizioni alberghiere a tutto campo e la sua azione espropriativa di tutto ciò che non fosse monocultura turistica (p. 353). Solo un uomo di possente respiro storico – umanistico unito alla passione civile e al padroneggiamento degli strumenti di governo della realtà civile poteva contestare senza tema di smentita il partito di Venezia che cancellerebbe Mestre e Marghera dalla faccia della terra: “Marghera – ossia il nuovo porto industriale – petrolifero, e la maggior parte del porto commerciale di Venezia…sta dentro il problema di Venezia, insieme con Mestre, con l’aeroporto di Tessera, e con tutti gli altri aggregati urbanistici della terraferma comunale, con il diritto – dovere di un complesso strutturale di grandi dimensioni che la città storica non poteva che concepire fuori di sé, ma accanto a sé, come proiezione e luogo di riconciliazione e mediazione con la società, il lavoro, l’economia moderna, pena la propria fine” (p. 351). Gli stessi concetti vengono ribaditi senza eludere la coscienza della natura profondamente antiestetica dell’altra Venezia, quella contemporanea: “senza Marghera, e senza la conseguente e pur orribile conurbazione mestrina, la monocultura turistica veneziana sarebbe oggi ben più esclusiva e oppressiva, e la morte economica e civile di Venezia ben più isolata e conchiusa” (p. 352). Escludendo quindi la comoda scorciatoia della rimozione estetico – aristocratica Dorigo entra sempre nel merito della realtà concreta e delle potenzialità diverse di sviluppo di Porto Marghera e della sua zona industriale, prevedendo con straordinaria premonizione i guasti non dell’industrializzazione tout court ma di quella fordista e monopolista che lo stava “colonizzando”: “un progetto di legge che volesse veramente risolvere il problema dell’allargamento della zona industriale di Porto Marghera nella maniera più propria e più rispondente alle esigenze sia locali che nazionali, dovrebbe principalmente favorire al massimo il sorgere di medie e piccole imprese legate da vincoli tecnologici complementari alle industre già esistenti” (p. 335). 120 Ne derivava che ai due criteri di destinazione – imprese piccole e complementari tecnicamente se ne doveva aggiungere un terzo che privilegiasse iniziative imprenditoriali locali (p. 336). Una disciplina di esproprio che non tenesse conto di questi tre criteri, è facile profeta l’Autore – comporterà che “chi ne trarrà vantaggi saranno ancora una volta i grandi complessi monopolistici già esistenti nella zona” (p. 336). L’esodo abitativo, altro problema tragico e scabroso, ripetuatamente stravolto dalla pubblicistica ignorante dell’orecchiamento privo di riscontri, viene minuziosamente analizzato nelle sue componenti economiche, sociali, demografiche, psicologiche e culturali. La lucidità e precisione nell’analisi della composizione sociale sono riccamente documentate negli scritti di allora qui raccolti (pp. 312 – 3). Nell’analisi di Dorigo i criteri di utilizzo dei fondi derivanti dalla quarta legge speciale per Venezia, la n. 171 del 9 aprile 1973, devono essere strettamente vincolati dalle risultanze dell’inchiesta, da lui stesso coordinata per conto del Censis, sulla situazione abitativa. Anche in questo caso Dorigo è estremamente puntuale nel cogliere come una visione del restauro conservativo della città insulare basata solo su teorie e metodi accademici non possa che incidere in modi invasivi se non addirittura controproducenti sulle dinamiche dell’esodo verso la terraferma. Tale esodo, contrariamente a quanto si pensi generalmente, non è stato per nulla determinato da motivazioni economiche primarie, bensì al contrario, ha colpito soprattutto le classi socialmente più dinamiche e legate per ragioni di lavoro all’insularità nel commercio e nei servizi. In altre parole Dorigo rileva che l’inizio dell’esodo non è caratterizzato dalle fasce più povere della popolazione, ma da quelle che percepiscono come non tollerabile lo squilibrio tra il proprio reddito e condizione sociale e le condizioni igieniche, edilizie e logistiche dell’abitazione insulare. Questa consapevolezza avrebbe dovuto orientare in modo molto sagace la predisposizione degli strumenti normativi “speciali” di sostegno a Venezia (le quattro leggi speciali!) privilegiando proprio il popolamento delle classi più giovani e dinamiche, che formano tessuto connettivo di una città. Viene riportato un passaggio esplicito della relazione del gruppo urbanistico che è parte del RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 Comitato ministeriale per la difesa di Venezia, il quale mette in luce questa delicatissima connessione: “la grande operazione di risanamento, possibile mediante i 90 miliardi stanziati dalla legge in 5 anni, avvenga necessariamente con forme organizzative del tutto nuove, con specifica finalizzazione al contenimento dell’esodo ancora in atto dalla città storica, e alla possibile riacquisizione di famiglie giovani emigrate i cui membri continuano a lavorare nella Venezia insulare” (p. 326). Il rapporto culturale con il Censis non sembra davvero casuale vista la preoccupazione di Dorigo di finalizzare in modo completo l’operazione di risanamento conservativo non come un’impresa tecnica, ma di “ingegneria sociale interamente gestita dalla mano pubblica e democraticamente controllata dagli enti locali, tesa al recupero di famiglie giovani che hanno dovuto abbandonare la città storica negli ultimi anni ma che – avendo conservato in essa il loro posto di lavoro – tornerebbero a risiedervi se fossero loro garantite civili ed eque condizioni abitative” (pp. 327 – 8). In questa sequenza è contenuto tutto il repertorio dell’immensa sapienza pratica di Dorigo, dallo stile dell’inchiesta sul campo ai raffinati strumenti di interpretazione sociologica, dalla completa conoscenza storico – culturale dei manufatti alla scelta delle tecniche di restauro e conservazione più adatte agli interventi, dalla finalizzazione dell’intervento tecnico a una precisa politica abitativa che si traduce in coerente politica economica e sociale di rilancio di Venezia, alla condensazione, infine, nelle normative nazionali di incentivo e nelle procedure concrete della loro applicazione. Rispetto alla Laguna e quel che si definisce come il problema dell’acqua alta ci sono nel volume delle bellissime ricostruzioni storiografiche che mostrano come l’acqua sia “elemento dominante e condizionante di tutte le pianificazioni urbane e territoriali dei veneti da almeno 25 secoli, come interlocutore protagonista della loro vita, come fattore ineliminabile, dolce e salata che fosse ( e non è la stessa cosa) della loro ‘arte del territorio’” (p. 375). In una recensione a un libro del 1967 di Giulio Obici e Cesare De Michelis sul post - alluvione si offre a Dorigo l’opportunità di demistificare una tesi molto diffusa che stabilisce l’equazione tra il contrasto dell’acqua alta e le opere di miglioria rivolte all’ampliamento della Laguna, una tesi in 9:04 Pagina 121 continuità storica con il Cornaro e Sabbadino, basata sul binomio “gran laguna fa gran porto”. Con un’invettiva di stringente argomentazione Dorigo sottolinea che il livello dell’acqua alta che raggiunge Venezia e la Laguna è del tutto indipendente dalle dimensioni di quest’ultima; è solo condizionato dalla legge dei vasi comunicanti, ovvero, mare e laguna. Semmai la dimensione lagunare può condizionare la velocità di entrata e di uscita dell’acqua: “Come è noto, un’onda di marea meno veloce sarà anche meno dannosa per lo zoccolo dell’abitato insulare veneziano; e quindi, da un punto di vista teorico, una diminuzione di ampiezza del bacino lagunare è oggi non già pericolosa, ma anzi auspicabile” (p. 343). Il pericolo primario per Venezia non è tanto l’acqua alta in sé, fenomeno sostanzialmente inevitabile, quanto “quello che aumentino ulteriormente la forza e la violenza dell’acqua, con conseguente smottamento delle fondamenta urbane (v. bacino di san Marco , forte di Sant’Andrea ecc.) e accelerato disfacimento delle barene (pure in atto, verso la gronda lagunare)” (p. 343). Nel corso di un dibattito all’IUAV nel 2004 Dorigo rispondendo a una domanda sul MOSE sottolinea ancora in continuità con questa posizione che i livelli previsti di innalzamento del mare superano quelli delle relazioni giustificative le barriere mobili (p. 194). La profonda informazione conoscitiva che ha alimentato nel corso di cinquant’anni la sua tempra di combattente sembra cominciare a incrinarsi in un pessimismo più forte di quello che sostiene l’ottimismo della volontà: “Si continua a portar acqua con secchi sfondati” (p. 243) Eppure la linea di pensiero e azione ha ancora un tale vigore che nella lectio magistralis tenuta all’IUAV in occasione del conferimento della laurea honoris causa riecheggiano con inalterata pertinenza e appropriatezza tutti i “luoghi” del suo magistero esemplare, dalle battaglie urbanistiche per il Paese a quelle per la sua Venezia. Un brivido di commozione assale anche chi non era presente e rivive, dalle pagine della lectio la formazione universitaria trasmessa dal grande Sergio Bettini al salvataggio della Chiesa di san Lorenzo o, con Emilio Vedova, dei magazzini del sale alle Zattere; e, ancora con questo formidabile circolo tra storia e presente, tra sapienza e azione, la necessità di investire nel capitale sociale della vita nazionale (p. 372) e 121 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 122 n.19 / 2007 una sorta di memorandum per chi continuerà dopo di lui in questa azione: “Non mi smuova, in questa convinzione, l’amarezza di un modesto eppur significativo episodio vissuto all’inizio degli anni Novanta nel comitato scientifico del Consorzio Venezia Ricerche, dove illustri colleghi, scettici di fronte ai numeri che già accertavano le nere prospettive del riscaldamento globale, rifiutarono una mia proposta di programma pluriennale interdisciplinare centrato sui rapporti fra il territorio veneziano e altoadriatico e i regimi delle acque, preferendo optare per l’occasionalità permanente di piccole commesse di ricerche settoriali” (pp. 376 -7). La complessità dell’operari dorighiano è commisurata al suo splendido, fragilissimo e vulnerabilissimo oggetto. Leggendo queste pagine è spontaneo chiedersi: e oggi qualcuno ha raccolto un’eredità così preziosa, soprattutto di intreccio tra i diversi piani del sapere e del fare? Vi è modo di stabilizzare una continuità, certo con le innovazioni dovute ai cambiamenti non da poco che ci separano da quei decenni, di una convergenza operativa così stringente di saperi e di strategie governamentali? Oggi si sta disvelando con un’imprevedibile capriola del tempo una verità che solo un decennio fa poteva apparire il massimo dell’irrealtà: la globalizzazione sta restituendo una nuova centralità a Venezia come icona e come nodo, con la sua grandezza memoriale che si impasta nei sogni di come vorremmo che fosse il futuro. Ma in questo cortocircuito del tempo la grandezza di uomini come Dorigo risulta ancora più imponente, proprio per aver saputo coltivare una grande storia nel nome di un futuro che trasformasse in sviluppo e bellezza anche quanto di orribile contiene il presente. (Luca Romano) [email protected] GIANNI DE MICHELIS, La lunga ombra di Yalta. La specificità della politica italiana (Conversazione con Francesco Kostner), Marsilio, Venezia 2002 La lunga ombra di Yalta e la politica scomparsa 1. Uscito nell’ottobre del 2002 con una ristampa nel giugno dell’anno successivo per Marsilio La 122 lunga ombra di Yalta. La specificità della politica italiana (Conversazione con Francesco Kostner) di Gianni De Michelis è un testo di cui non è rimasta traccia nel confronto degli anni successivi alla sua pubblicazione: è scorso via come acqua su marmo. Evitando di ascrivere questo fatto a un complotto generalizzato per circondare di silenzio un protagonista e testimone scomodo di un periodo storico confuso e problematico dell’Italia contemporanea, non si potrà che pensare il contrario: le tesi esposte in questo libro sono talmente imbarazzanti per l’establishment politico, mediatico e accademico – vogliamo cominciare a parlare delle tre “caste”? – che vi è stata un’ inintenzionale preordinazione di estrometterle preventivamente dalla circolazione. Che cosa sostiene De Michelis, politico di lungo corso del PSI, già Ministro delle partecipazioni Statali, del Lavoro, degli Esteri e Vice Presidente del Consiglio tra il 1980 e il 1992? L’idea di partenza è che le decisioni uscite da Yalta hanno completamente determinato la politica, l’economia e l’evoluzione della società italiane fino al periodo in cui Bettino Craxi e la dirigenza socialista non decisero di porre mano alla “costituzione invisibile” cui quell’accordo storico aveva dato corpo. Quali sono gli elementi, duri come diamante, che compongono l’intesa di Yalta per le conseguenze che ebbe per l’Italia premessa la collocazione internazionale nel sistema occidentale con tutto quello che significa con una sorta di “condizione speciale” (p. 15) conferita al PCI? Essa ha costituito una vastissima trama di rapporti scritti e soprattutto non scritti nel funzionamento strutturale della democrazia connessa alla non alternanza delle coalizioni di governo: la celebre democrazia consociativa; la forma assunta dalla vita politica istituzionale che ne è derivata, con la scelta del regime parlamentare puro contro la democrazia connotata da forti istituti di governo; la debolezza dei governi di coalizione parlamentare e la potenza, per converso, dei partiti, veri e propri arbitri della costruzione delle liste e, quindi, dei gruppi parlamentari; le dinamiche della spesa pubblica rispetto alla composizione sociale e territoriale del Paese; la costruzione di un soggetto economico in condizioni normative del tutto anomale (le cooperative) e così via. Nella lettura storica proposta in questo libro il RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 tema della democrazia consociativa è strettamente collegato agli equilibri geopolitici di Yalta, rilievo non inedito certamente, ma che assume contorni di grande interesse nel momento in cui mette in luce alcune conseguenze sia nella cultura politica di chi ha gestito tale processo - il PCI, ma anche la DC - e, soprattutto, formula una straordinaria chiave esplicativa alla crisi della politica italiana che comincia con il dissolvimento di Yalta. Esso non è datato alla Caduta del Muro nel 1989 ma al 1991 con la disintegrazione rapidissima dell’URSS, proiettato, con le sue ombre, ben dentro gli anni Novanta fino a lambire, per motivi che vedremo, i nostri giorni. Non siamo ancora fuori dal cono d’ombra che Yalta proietta ben dopo il dissolvimento dei motivi storici che l’avevano ispirata. La novità interpretativa di questo libro, quindi, non consiste nella relazione tra Yalta e il sistema consociativo. Essa consiste invece – ed è questo il motivo dello scandalo e del silenzio che lo ha circondato in via preventiva – nella diagnosi del periodo che corre tra il tentativo di rottura con il sistema di Yalta prima della sua “caduta” epocale, e il fallimento del disegno di Craxi. E, a seguire, del permanere strisciante ma incontrovertibile della logica di Yalta “in un paese solo” dopo la crisi definitiva sia dei suoi assetti, sia dell’unico progetto politico per farla saltare a vita ancora corrente. E se sulla prima parte del ragionamento c’è oggi ormai un’ampia condivisione del giudizio storico – politico sulla seconda e terza parte non si conoscono pronunciamenti espliciti, critiche o autocritiche che non abbiano il sapore di abiure opportunistiche, colpevoli silenzi o diversivi tattici. Non ci sono giudizi politici veri, soprattutto, che siano coerentemente collegati a delle politiche conseguenti. Non c’è ancora un giudizio sul PSI e Craxi che non abbia debordanti conseguenze politiche; e questo la dice lunga sul fatto che quell’esperienza politica con il periodo di governo del Paese gestito in prima persona non è stata per nulla compresa, metabolizzata e acquisita nel corso della politica successiva. 2. Veniamo pertanto alla tesi più scabrosa del libro: Craxi e il PSI avevano ragione nel loro disegno di scardinamento degli equilibri di Yalta e delle formule politiche, istituzionali e socio – economiche 9:04 Pagina 123 che ne erano derivate per l’Italia. La forza dell’idea che li ha ispirati consiste in questo: la politica italiana e il suo modello consociativo non sono più all’altezza delle sfide e dei problemi che ha di fronte l’Italia. Sia il modello di democrazia che il rapporto delle istituzioni con la società vanno completamente ristrutturati sia nell’esercizio effettivo dell’alternanza al governo del Paese, sia nel rafforzamento degli strumenti della democrazia governante. Allora, ovvero negli anni Ottanta, si parlava di decisionismo e di modernizzazione, di bisogni e di meriti: una nuova cultura politica, strettamente legata ad un’azione di governo, faceva irruzione nello scenario italiano. Rispetto invece al ruolo dello Stato imprenditore e amministrativo, sia detto di passaggio, le intenzioni di discontinuità o di riforma sono state meno declamate anche se determinate decisioni, anche molto dolorose, rimandano a quel periodo [A questo riguardo è molto interessante per l’attualità il libro Gianni De Michelis: Verso il XXI secolo: idee per fare politica, Marsilio, Venezia 1987]. La base di analisi è che la società italiana ha generato straordinarie energie modernizzatici che hanno bisogno di estrinsecarsi in un disegno di riforma istituzionale che rafforzi un posizionamento più competitivo e più autonomo del Paese nel mondo. La prova politica indiscutibile dei nuovi rapporti di forza presenti nella società è rappresentata dall’abolizione della scala mobile e dalla sconfitta del PCI nel referendum che ne seguì, rispetto al quale, peraltro, Lama e i riformisti come Giorgio Napolitano non erano d’accordo nel portare fino in fondo lo scontro sociale. Il progetto craxiano era congegnato per uscire da Yalta, perché ne aveva decostruito i vincoli e prefigurato le opportunità: ma l’uscita era molto stretta. Le opportunità erano di due tipi, la prima ineriva la trasformazione del Paese: nuova composizione sociale, vitalità del made in Italy, allargamento dei ceti produttivi, espansione dei consumi, del ceto medio e del lavoro non rigidamente salariato. Nel 1985 il PSI aveva redatto una proposta di legge per le pensioni che avrebbe rivoluzionato il baricentro del concetto retributivo con nuovi criteri contributivi (questa proposta aveva delle caratteristiche che vent’anni prima rispondevano all’emergenza previdenziale che stiamo vivendo da allora) ed era totalmente osteggiato dall’ala dura della 123 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 124 n.19 / 2007 CGIL e del PCI: ma, se approvata a stretto ridosso del referendum da loro perduto, avrebbe avuto conseguenze esiziali per la componente più radicale e militante della sinistra italiana. Va anche osservato che l’argomento sempre richiamato per censurare il grande disegno socialista – il deficit dello Stato – conobbe nel 1986, quarto anno di governo Craxi, un rallentamento (p. 115). La seconda opportunità era il processo di disgelo internazionale seguito all’Ottantanove, e rispetto a cui, come nel caso della vicina Jugoslavia l’Italia aveva un grande ruolo potenziale dal giocare: “l’azione internazionale del nostro paese è sempre stata il frutto del modo in cui si combinavano gli atteggiamenti e le iniziative in tre direzioni: una nord – occidentale, che chiamavo “gallica”, una centro – orientale, verso l’Europa danubiana e balcanica, e una terza mediterranea” (p. 95). Un ulteriore ingrediente internazionale è, nella visione retrospettiva del leader socialista, un europeismo attivo, basato su un saldo rapporto con l’asse franco – tedesco lungo il crinale confederativo per giocare la carta mediterranea al momento di sottoscrivere Maastricht: al Trattato l’Italia è rappresentata da De Michelis e da Guido Carli per la Banca d’Italia, molto considerato soprattutto dai tedeschi. Nel ripercorrere i capisaldi della stagione craxiana va puntualizzato che nelle analisi di De Michelis convivono l’elogio e la critica all’incompiutezza del Grande Disegno craxiano: “facemmo alcuni errori” (p. 73). Le titubanze del leader socialista rispetto alla “spallata” su scala mobile e sulle pensioni, l’evocazione retorica della Grande Riforma del sistema politico – istituzionale non solo mai attuata ma neppure semplicemente tentata nei fatti; e poi, la mancata comprensione di quello che sarebbe accaduto nel rapporto tra politica e magistratura proprio per l’allentarsi dei vincoli di Yalta. Con l’Ottantanove, ma ancor più con il 1991, infatti, l’Europa deve assumersi nuove responsabilità nel disordine mondiale che segui l’eclisse del bipolarismo; in Italia finisce lo statuto della “condizione speciale” che aveva forgiato il modello consociativo; per il nostro Paese nasce un problema del tutto nuovo, mai affrontato con la dovuta radicalità dalle classi dirigenti, di posizionamento competitivo; l’intensificazione dei processi di globalizzazione 124 economica inasprisce tutte le questioni incancrenite di debito pubblico, mancata riforma della pubblica amministrazione, di sbilanciamento previdenziale a favore dei garantiti. In buona sostanza non vi è da fare una critica al disegno craxiano per quello che voleva realizzare nelle istituzioni e nella società, bensì la critica va rivolta all’incompiutezza dell’opera di riforma, al perdersi per strada degli obiettivi e alla contraddizione tra l’assunto – la consapevolezza di dover uscire dal sistema Yalta – e l’adozione di alcuni mezzi che erano figli indissociabili proprio di quel sistema. 3. Un punto non chiarito in modo soddisfacente nel libro consiste nel ruolo dei partiti nella transizione dal modello consociativo a quello della democrazia decisionista. Prima di addentrarci nel cosiddetto fenomeno di Tangentopoli va ribadita una convinzione dell’Autore che è in filigrana di tutto il libro: “sull’Italia ha gravato il peso di una grossa anomalia per ciò che riguarda i costi della politica, che tra il 1945 e il 1991 sono stati molto più alti che altrove” (p. 135). La visione del gruppo dirigente del PSI era in frontale contrasto con la tesi di fondo perorata da Eugenio Scalari dalle colonne di “Repubblica”: “Non era necessaria in altre parole la contrapposizione che, negli anni successivi, quelli che hanno portato a Mani Pulite, ha fatto falsamente ritenere che non potessero coesistere una politica forte e un’imprenditoria o una finanza altrettanto forte” (pp. 82 – 3). Questo è un nervo scoperto, una ferita mai rimarginata nella storia italiana recente. Infatti, la crisi del “sistema Yalta” avrebbe dovuto indurre il passaggio da un sistema politico imperniato su partiti fortemente invasivi dello spazio della società civile nazionale come viatico della loro legittimazione “proporzionale” nelle istituzioni rappresentative a partiti più duttili e strumentali rispetto agli assetti strategici delle elite dirigenti. La potenza della politica si sarebbe misurata sulla capacità di coinvolgimento della società e dell’economia nelle strategie di sviluppo, non nella loro produzione e controllo. La velocità e l’intensità dei cambiamenti che convenzionalmente denominiamo “globalizzazione” ha messo in crisi il progetto politico di “nazionalizzazione della società” che era perfettamente com- RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 patibile con gli equilibri geopolitici derivati da Yalta. Tanto è vero che la scopertura del “malaffare” politico – economico da parte della Magistratura è avvenuta proprio per l’allentamento della giustificazione dell’interesse nazionale prevalente che Yalta aveva legittimato con i suoi intoccabili equilibri. Anche Helmut Kohl in una fase successiva, per lo stesso motivo, il venir meno di Yalta, ha visto offuscare i suoi meriti storici relativi alla riunificazione tedesca per accuse di finanziamento occulto, non dimentichiamolo! In buona sostanza, Tangentopoli e il crollo del sistema politico hanno messo a nudo un sistema dei partiti, una modalità di selezione del professionismo politico e un intreccio tra politica ed economia che sono molto più compatibili con il modello consociativo derivato da Yalta che con il Grande Disegno di modernizzazione governante pensato da Craxi e dal gruppo dirigente del PSI. E’ del tutto evidente che la “condizione speciale” determinata dal 1945 non aveva permeato solo il PCI e, per contraltare, quella parte della DC che era più consapevole degli equilibri geopolitici da rispettare. La consociazione aveva favorito il costituirsi di un blocco imponente di interessi politici ed economici che da “figlio” della politica a un certo punto ha cominciato a rendersi parzialmente indipendente dai partiti e a diventarne “padre” controllandone molti snodi strategici: ci sono figure molto determinate che svolgono questa funzione di interfaccia con la dimensione “invisibile” ovvero più importante del potere rappresentativo. Se è vero che la democrazia è tale in quanto esiste un sistema pluralistico di partiti, è altrettanto vero che il modo di funzionamento, di legittimazione e di relazioni tra questi con le istituzioni e la cosiddetta costituzione economica sono altamente variabili nella storia comparata dei sistemi politici. Un altro risvolto significativo nel rapporto tra politica ed economia è quella particolare declinazione intellettuale che, all’interno del PCI, ne dà in quegli stessi anni il gruppo confluito in “Laboratorio politico”: alle prese con uno scontro frontale con l’area operaista, poi dell’Autonomia, sulle matrici teoriche del marxismo coltiva una teoria dell’autonomia del Politico che oscura i processi materiali di crescita dello spazio dell’economico e del tecnico, sposandosi con la tesi scalfariana, capovolgen- 9:04 Pagina 125 dola: una politica forte coesiste con un’economia debole. Nel corso degli anni Ottanta, soprattutto quando alla segreteria del PCI approda Achille Occhetto, il gruppo dirigente di quel partito è in parte animato da una cultura politica anticonsociativa. E’ francamente un mistero capire come mai quel segmento di leadership comunista “aggiornata” non trovi alcuna sponda nella visione aperta al dopo Yalta che permeava il PSI. Nel libro viene abbondantemente narrata l’incomunicabilità, la diffidenza se non addirittura l’ostilità che non permisero mai un incontro vero tra Craxi e Berlinguer, ma non è altrettanto messo in luce il periodo successivo alla segreteria Natta nel PCI. In effetti almeno il terreno delle riforme istituzionali rivolte alla forma della rappresentanza, con la maturazione di un comune convincimento sul logoramento irreversibile del modello consociativo avrebbe dovuto creare delle condizioni diverse di dialogo. Inoltre, se si fosse posto mano con maggiore forza al problema di differenziare il ceto politico di rappresentanza da quello di governo, riuscendo, come PSI, a diventare alfieri di una riforma elettorale in senso maggioritario, e non retroguardia conservatrice del sistema per eccellenza che aveva favorito la consociazione, probabilmente i partiti al governo non sarebbero stati distrutti dalle inchieste giudiziarie. A ben vedere, però, si trattò di un periodo molto breve, Achille Occhetto è segretario dal 1988, e nel 1989 comincia una stagione dominata da cambiamenti epocali su scala mondiale che resero il superamento di Yalta un fatto decretato dalla storia stessa. Mentre all’inizio degli anni Ottanta la vocazione riformatrice del PSI è incontrovertibile e permea sistematicamente tutti i titoli di un’agenda di Grande Politica dal rafforzamento degli istituti di governo alla forma di Stato, dalla modernizzazione del sistema paese alla sua collocazione internazionale, dall’analisi sociale ed economica ai rapporti con il Vaticano, il declinare del decennio ha consumato buona parte della spinta e ha prodotto la caduta di legittimazione dei partiti per una società che usciva dal cono d’ombra di Yalta e sentiva premere i processi di globalizzazione economica. Gianfranco Miglio rappresenta la cartina di tornasole del cambiamento. Nel 1983, infatti, appare 125 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 126 n.19 / 2007 come il più grande alleato di cultura istituzionale del decisionismo governante craxiano. Nei due tomi di proposta di riforma costituzionale prodotti dal “gruppo di Milano” tutto si concentra proprio sulla critica al parlamentarismo puro, al ruolo dei partiti come detentori assoluti del potere di coalizione e di consenso per via clientelare sugli strumenti della democrazia governante, mentre non vi appare mai la questione del federalismo [Miglio ha poi spiegato la ragione di questa assenza: “All’inizio del lavori del Gruppo, io posi la questione pregiudiziale di un’alternativa tra i due modelli, cioè tra uno Stato federale ed uno Stato unitario. Rimasi però subito in minoranza. Anzi, rimasi isolato anche nel porre soltanto la questione: tutti i miei colleghi si dichiararono convinti di non dover mettere in causa l’attuale struttura unitaria dello Stato italiano”, cfr. Gianfranco MIGLIO: Una Costituzione per i prossimi trent’anni. Intervista sulla terza repubblica a cura di Marcello Staglieno, Laterza, Bari 1990, p. 140]. Ma ciò che è più rilevante è che tra il 1983 e il 1990 Miglio abbandona l’unilateralismo decisionista che aveva sposato per un federalismo radicale, di chiara impronta secessionista. Sono bastati soli sette anni per avere la più disincantata posizione sull’impossibilità di produrre la Grande Riforma e per aderire non tanto al credo federalista, che Miglio aveva sposato fin dalla Resistenza, quanto per propugnare un’azione sovversiva della Costituzione centralistica vigente. Pertanto, il sistema dei partiti, proprio per il fatto di essere stato plasmato completamente sui binari decisi a Yalta – con i connessi costi supplementari della politica dovuti alla condizione speciale della democrazia italiana - risentiva di un crollo di legittimazione per la ragione esattamente diagnosticata da Gianni De Michelis: la società e l’opinione pubblica italiane si stavano liberando di Yalta più velocemente dei partiti. 4. L’adozione di una spiegazione politica per decifrare il fenomeno “Tangentopoli” è asserita perentoriamente dall’Autore: “I comunisti non avevano alcuna intenzione di allearsi con noi perché avevano già in testa la strategia dell’uso politico di Mani Pulite e puntavano a liquidarci” (p. 125). La dissoluzione dei partiti di governo viene perpetrata da un’alleanza ritenuta intenzionale tra PCI 126 ormai PDS e settori della Magistratura, il cui nuovo orientamento di “autonomia” è talmente veloce per l’Autore da trovare impreparati gli stessi dirigenti del PSI (p. 141). Vi sono due elementi di grande innovazione nel ragionamento di De Michelis. Il primo è sintetizzato dall’idea che Tangentopoli sia stata un’insperata opportunità di sopravvivenza per il ceto politico che altrimenti si sarebbe comunque dissolto con la Caduta del Muro: “nella fase iniziale di quei mesi del 1992, il corto circuito tra l’azione di settori della magistratura e di quella parte del mondo politico italiano di cui il PDS era la forza prevalente, ha avuto una motivazione che a livello politico potremmo definire di tipo difensivo” (p. 153). L’idea di una maggiore sintonia in termini di cultura della legalità, per l’ex Ministro in realtà è stata solo uno schermo del tutto pretestuoso per realizzare un regolamento di conti con chi aveva avuto le responsabilità di governo e avrebbe beneficiato certamente delle conseguenze epocali dell’Ottantanove. Come è noto a più riprese Craxi aveva alluso all’annessione del PDS nel PSI come un fatto naturale, irreversibile e a suo modo “europeo”. Alla fase difensiva ne segue una offensiva, volta a “introdurre modificazioni tali nel sistema politico e istituzionale da rendere perseguibile, rimanendo sul terreno democratico, l’obiettivo di andare al potere” (p. 153). Ma la seconda innovazione è ancora più importante, ovvero attraverso le inchieste di Tangentopoli, infatti, il risultato politico è il seguente: “Solo in Italia c’è stata una conseguenza estrema e anomala: la scomparsa, cioè, della gran parte del sistema dei partiti legato alla storia democratica del paese, con la sola eccezione delle due forze espressione dell’esperienza totalitaria, cioè degli sconfitti della storia” (p. 175). Questa amara ma inoppugnabile constatazione fa sorgere un interrogativo che riguarda sia quel periodo storico che l’attualità. Come mai in Italia il partito politico non si riforma rimanendo nel solco della propria tradizione secolare come avviene in Francia, Germania, Gran Bretagna? In altri termini, come mai il fallimento di una leadership, la sconfitta di un’elezione, il declino di una politica si risolvono nella produzione di nuovi partiti e non nell’autoriforma di quelli esistenti? La constatazione di De Michelis riguarda infatti la RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 sorte di Dc, Psi, Pri, Pli e Psdi dopo il 1992 ed è sintomo non solo della vittoria degli “sconfitti della storia” ma anche del peso della legittimazione che tali partiti avevano avuto non solo dalla società italiana, ma soprattutto dalle “potenze esterne” che hanno potuto sovraintendere a Yalta e dalla presenza della Chiesa in Italia. Ma dopo il 1992 la creazione di nuovi partiti ha un indice di fertilità proliferante e, ad eccezione della Lega, mostra un’estrema vulnerabilità ai cicli brevi dell’elettorato. La facilità e la velocità con cui la Magistratura con le sue inchieste su tutto il territorio nazionale, pur nelle opinabili azioni messe in campo dalla Procura di Milano, trasformatasi senza nessuna norma esplicita in Superprocura contro la corruzione e le diversità di trattamento riservate ai politici inquisiti, ha potuto di fatto eliminare i partiti di governo dalla scena è dovuta anche al fatto che la loro delegittimazione era cominciata prima di tangentopoli e, ripeto, proprio per i motivi messi in luce da De Michelis. 5. Una tesi molto importante è quella che la politica dopo il 1993 è in mano a dei sopravvissuti. De Michelis parla dei “dieci anni della disattenzione e della disinvoltura” ovvero un decennio in cui la politica è senza consapevolezza, senza potenza e senza strategia: “Vi è stato cioè un ritardo nell’adeguamento dei meccanismi politici alle nuove esigenze, derivanti dalla consapevolezza dell’opinione pubblica di vivere in una situazione complessiva profondamente mutata…Ebbene, in questi dieci anni, non si è saputo dare alcuna soluzione definitiva a questi problemi. Per cui noi oggi, non solo in Italia e in Europa, ci troviamo a dover affrontare le stesse questioni avendo praticamente perso o usato in maniera inadeguata il tempo trascorso” (pp. 130 – 1). Che cosa rimane, infatti, della politica italiana dopo Tangentopoli? Per l’Autore vi è stata semplicemente un’opera “più o meno confusa” di recuperare la divaricazione tra il sentire del mutamento che investe l’opinione pubblica e le risposte politiche, sia istituzionali che economiche – da dare alla nuova situazione. Il 1992 è l’anno dell’emergenza speculativa contro la lira contro cui Giuliano Amato inaugura la fase, non ancora compiuta, del primato tecnocratico e monetario sulla politica, poi condotto da Ciampi, 9:04 Pagina 127 Dini e in forme solo apparentemente più soft, da Draghi; i cambiamenti istituzionali procedono per via referendaria e danno due risultati di carattere procedurale: l’elezione diretta dei Sindaci (1993) e il sistema maggioritario per il parlamento (1994) con l’apparizione del primo partito post Tangentopoli (Forza Italia) e di un leader mediatico di forte carica antipolitica come Berlusconi. Un terzo ingrediente, che merita di essere ricordato, è l’iniziativa di Giuseppe De Rita al CNEL intorno al protagonismo del territorio come piattaforma dell’economia italiana nella globalizzazione [Vedi i sei volumi CNEL sulla questione settentrionale risultati di ricerche sul campo delperiodo 1996 - 1998]. In tutto questo processo di frammentazione e di scomposizione del sistema dei partiti il baricentro della sovranità si sfrangia, subisce le spinte dei poteri forti extrapolitici da un lato, gli umori dell’antipolitica e, soprattutto le inerzie pesantissime del sistema statuale non riformato. Il percorso delle riforme, privo di una sua consequenzialità e piena responsabilizzazione degli attori di sovranità ne esce fortemente indebolito, a volte creando più dissensi che consensi. In questo modo non poteva che aprire la strada a controriforme quasi più pesanti che hanno l’effetto di rafforzare il peso burocratico e non governante dei partiti; non attivano un processo di lettura del ruolo geopolitico e geoeconomico dell’Italia che sia propedeutico a una vera riforma della costituzione materiale del Paese; si stanno perdendo colpi nella progettazione di uno “Stato – funzione” che sia strumento efficace proprio nel dare risposte ai bisogni di nuovo welfare, di innovazione ecc… In buona sostanza tra il 1992 e il 2001 – anno in cui viene scritto il libro, ma 2007 possiamo tranquillamente dire, entrano in crisi tutte le strategie parziali che avevano tentato di riempire il vuoto postcraxiano: le riforme istituzionali come riforme elettorali, le riforme rivolte alla forma dello Stato, le riforme di tipo costituzionale inerenti gli ordinamenti dei poteri, le politiche interventiste in ambito economico, infrastrutturale, formativo, previdenziale o del welfare. Ora la domanda non presente esplicitamente nel libro è: “il veltronismo è la malattia senile della sopravvivenza della politica come ceto?”. Possiamo permetterci ancora il lusso di eludere tutti i nodi che si sono accumulati dalla mancata soluzione 127 RIVISTA FOEDUS N° 19:RIVISTA FOEDUS N° 15 17-01-2008 9:04 Pagina 128 n.19 / 2007 alle crisi del 1991 – 1993? La nascita del Partito Democratico è di fronte a un bivio: o offrire una sorta di stabilizzazione più nobile al ceto politico “sopravvissuto” o dare finalmente forma a un disegno politico che porti l’Italia oltre l’ombra che ancora Yalta le proietta sopra. Prendendo in rassegna tutti i capitoli di questa crisi, dal modello di democrazia competitiva che sostituisse quella consociativa, dagli strumenti di una più efficace democrazia governante che prendesse corpo in luogo di caste e di clientele, dalla domanda di modernizzazione del Paese al fine di diventare più competitivo in un contesto internazionale sempre più agguerrito, alla strategia di politica estera per una politica di pace e volta a cogliere la restituita centralità al Mediterraneo, alla questione fiscale e al federalismo oggi la povertà, l’inconsapevolezza e la frammentazione della classe politica italiana non lasciano dubbi: il decennio della disattenzione e della disinvoltura sta continuando. De Michelis si pronuncia per una cultura politica del posizionamento, una democrazia “prigoginiana” e un nuovo grande disegno di democrazia governante, di riforma dello stato e di liberismo sociale spinto. Il grande problema è che il partito politico come soggetto di sovranità parziale si è rivelato subalterno ai processi e non attore. Ma è lo stesso paradigma cruciale della politica- quello della sovranità – che si sta modificando strutturalmente sotto la spinta dei cambiamenti globali. In questo modo la politica dei partiti non ha la forza di fare riforme, se non quelle che consistono in provvedimenti tecnocratici di compatibilità con L’Unione Europea o quelle autoreferenziali a incremento delle proprie prerogative, offrendo argo- 128 menti quotidiani ai critici del processo di trasformazione in casta. Un tentativo di De Michelis è quello di riproporre il partito come soggetto di sovranità, dotato di un disegno sul ruolo internazionale e sullo sviluppo del Paese. La democrazia governante si trova ad affrontare, in Italia e ovunque un problema di integrazione: “Per integrazione dev’essere inteso un processo di progressivo superamento delle sovranità nazionali finalizzato alla costruzione di entità sopranazionali, ma senza eliminare le differenze e le specificità delle diverse realtà nazionali” (p. 195). In un mondo globale l’integrazione che è stata richiamata implica un “riformismo diverso” in cui “ci sarà una dialettica basata non più semplicemente su destra e sinistra, moderati e socialdemocratici, ma anche su innovazione e conservazione” (p. 213). Pertanto esiste politica se c’è un disegno di integrazione di diversi piani della realtà, e tale integrazione deriva anche da un metodo che è sostanza – il riformismo – che si deve legittimare per la sua capacità di innovazione. L’essenza finale del ragionamento è che se il partito come soggetto della democrazia è disintegrato dai processi di integrazione “globale” che lo trascendono e lo dissolvono, come è pensabile un progetto di integrazione che è governato da un attore politico, costituito su basi di libera associazione e che agisca solo attraverso gli strumenti di governo legittimati dalla democrazia rappresentativa? L’ultimo messaggio dell’Autore del libro è che ci crede. Ma gli altri? (Luca Romano) [email protected]
Scarica