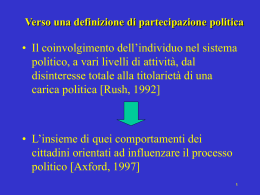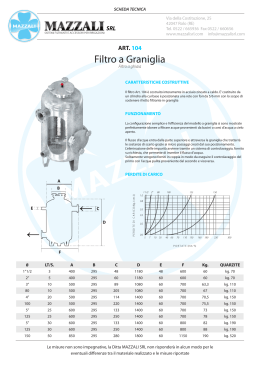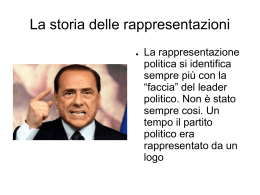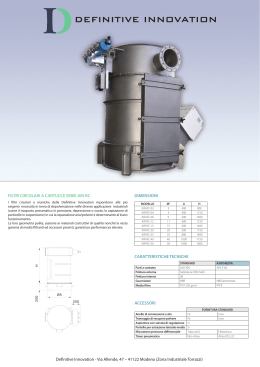CAMBIO Rivista sulle trasformazioni sociali Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 «Again there were predetermined evaluations at work. A higher value was implicitly placed on the changeless than on the changeable.» Norbert Elias (1970) ... siamo [costantemente] di fronte a un giudizio di valore preconcetto... [che attribuisce] implicitamente un valore superiore a ciò che non cambia rispetto a ciò che cambia Norbert Elias (1970) Direttore: Paolo Giovannini Vice-Direttore: Angela Perulli Comitato scientifico: Franca Alacevich, Giacomo Becattini, Ian Budge, Sergio Caruso, Alessandro Cavalli, Idalina Conde, Franco Crespi, Florence Delmotte, Johan Goudsblom, Paolo Jedlowski, Hermann Korte, Massimo Livi Bacci, Alberto Marradi, Stephen Mennell, Andrea Messeri, Fausto Miguelez, Giovanna Procacci, Teresa Torns, Marcello Verga,Giovanna Vicarelli. Comitato editoriale: Carlo Baccetti, Luca Bagnoli, Francesca Bianchi, Massimo Bressan, Filippo Buccarelli, Dimitri D’Andrea, Michael Eve, Paolo Giovannini, Laura Leonardi, Steve Loyal, Emmanuele Pavolini, Angela Perulli, Rocco Sciarrone, Annalisa Tonarelli. Redazione: Andrea Bellini, Filippo Buccarelli, Vincenzo Marasco, Giulia Mascagni (Coordinatore), Andrea Valzania. CAMBIO via delle Pandette, 21 - 50127 Firenze Tel.055 2759428 Fax: 055 4374931 [email protected] ISSN: 2239-1118 La rivista si avvale di una rete di referee 2 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 [Indice/Index] This Issue/Questo numero 5 Political Cultures in Transformation - a cura di Carlo Baccetti, Dimitri D’Andrea Introduzione alla sezione monografica 9 Old and New Political Subjects - Daniel Innerarity 13 Come in uno specchio: populismo e governamentalità neoliberale - Laura Bazzicalupo 25 Le regioni rosse nell’Europa continentale. Un’epopea del Novecento - Mario Caciagli 35 Quante Italie? Il ritorno al tradizionale cleavage tra Nord e Sud del paese - Paola Bordandini, Roberto Cartocci 47 Il cambiamento delle culture politiche in Italia: note per un programma di ricerca Antonio Floridia 67 Uno spettro s’aggira per l’Europa... Sugli usi e gli abusi del concetto di “gender” Lorenzo Bernini 81 Il partito-paradosso: il modello teorico di Fabrizio Barca come tentativo di riconciliazione tra sfera sociale e oggettivazione partitica - Lorenzo Bruni 91 Eliasian Themes Production and Reproduction of Social Inequalities: The Role of Group Charisma and Group Disgrace - Angela Perulli Lo Stato Giano bifronte: intervista a Norbert Elias - a cura di Peter Lides, Franklin Adler e Paul Piccone (traduzione di Angela Perulli) Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 105 119 3 Essays and Researches The Urban Panopticon - Vanesa Lio 129 La capacità di aspirare. Immagini di futuro di figli e figlie di migranti a Reggio Calabria - Simona Miceli 141 Contributions Il populismo e l’eguaglianza immaginaria - Franco Rositi 157 Francia, Europa, Islam: un’intervista a Marc Lazar - a cura di Paolo Giovannini e Giulia Mascagni 167 Book Reviews The Social Reproduction of the Mafias: Mechanisms and Processes - Paolo Giovannini on Mafie del nord by R. Sciarrone (ed.) Alla ricerca dell’operaio perduto - Annalisa Tonarelli su Un racconto del lavoro salariato di G. Baglioni 189 193 Reviews and Profiles 4 Trade Unions inWestern Union. Hard Times, Hard Choices di R. Gumbrell-McCormick, R. Hyman - Marcello Pedaci 199 The Moral Neoliberal. Welfare and Citizenship in Italy di A. Muehlebach - Alberto Nucciotti 201 Recommendations - Segnalazioni 207 Authors 209 Call for Papers 213 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228736 [This Issue] The eighth issue of CAMBIO is interesting for several reasons. First, for the long interview with Marc Lazar, dramatically timely in the wake of the tragic terrorist incidents that shook Paris and France - and for this very reason published in preview on the journal’s website. It is now the fourth interview with a prominent European intellectual that CAMBIO has undertaken and published in the past two years: a cycle that will continue in the next issue in a conversation about Spain and Europe with Fausto Miguelez, Emeritus of the Autonomous University of Barcelona. The second item of interest is the translation of an unpublished excerpt (in Italian) of Norbert Elias - an interview on civil society and political society - which fits in well with the monographic section but which also has the merit of continuing to present to the Italian public some of Elias’ little-known writings. We are now at the third unpublished excerpt (translated, as always, by Angela Perulli), and plan in our next issues to adhere to this recent but in our opinion important tradition of CAMBIO. On Political cultures in transformation (the topic chosen for the journal’s monographic section), there are contributions of different disciplinary orientations - sociology, political science, political philosophy - and at times, as is just, of different assessments of the matter at hand. Edited by Carlo Baccetti and Dimitri D’Andrea (not coincidentally a political scientist and a political philosopher), it addresses, with contributions of the first order (from Laura Bazzicalupo to Daniel Innerarity, from Mario Caciagli to Roberto Cartocci and Paola Bordandini), the crucial problems of the decline or radical transformation of the old political cultures, particularly in the face of the rise in Italy and Europe of populist movements and parties. And on these topics - in the Contributions Section - Franco Rositi also reflects, in a keen and brilliant contribution, on populism and imaginary equality. In addition to the translation of the above-cited Elias interview, the Section Eliasian Themes hosts an original essay by Angela Perulli on the processes of production and reproduction of social inequalities and how they act on the relational dynamics of power. The Essays and Researches Section, as always open to different disciplinary topics and approaches, presents an interesting essay by an Argentine researcher (Vanessa Lio) on the new forms of social control made possible by closed-circuit TV; and a research on the aspirations of second-generation immigrants who have settled in southern Italy (Simona Miceli). Lastly, in the next issue (V, 9, June 2015), as indicated by the Call for papers on our website, the monographic section will be devoted to studies and researches on the topic: which spaces of recognition are opening up for new families. Though within the obviously free choice of analytical outlooks, we are especially eager for contributions that keep a background focus on the processes of social change and on the complex relationship between individuals, families and society. CAMBIO will continue to host articles in Italian and English. Any offerings by scholars of other languages are welcome, and if they are positively evaluated by our Editorial Board and referees, we will ask for a translation in one of the journal’s two “official” languages, with the possibility of also consulting the original version online. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 5 DOI: 10.1400/228736 [Questo Numero] L’ottava uscita di CAMBIO si presenta interessante per diversi motivi. Innanzitutto per la lunga intervista a Marc Lazar, di drammatica centralità a seguito dei tragici episodi di terrorismo che hanno sconvolto Parigi e la Francia - e proprio per questo pubblicata in anteprima sul sito della rivista. È ormai la quarta intervista ad un intellettuale europeo che CAMBIO ha realizzato e pubblicato in questi due ultimi anni: un ciclo che proseguirà nel prossimo numero in una conversazione su Spagna ed Europa con Fausto Miguelez, emerito dell’Università autonoma di Barcellona. Il secondo motivo di interesse sta nella traduzione di un brano inedito (in Italia) di Norbert Elias - un’intervista su società civile e società politica - che bene si lega alla parte monografica ma che ha anche il merito di proseguire nella presentazione al pubblico italiano di scritti poco conosciuti del sociologo tedesco. Siamo ormai al terzo brano inedito (tradotto come sempre da Angela Perulli) e contiamo di rispettare anche nei prossimi numeri questa breve giovane ma a nostro parere importante tradizione di CAMBIO. Sulle Culture politiche in trasformazione (tema prescelto per la parte monografica della rivista) si segnalano contributi di diverso orientamento disciplinare - sociologia, scienza politica, filosofia politica - e a volte, come è giusto, di diversa valutazione del processo in esame. Curata da Carlo Baccetti e Dimitri D’Andrea (non a caso un politologo e un filosofo della politica) affronta, con contributi di primo piano (da Laura Bazzicalupo a Daniel Innerarity, da Mario Caciagli a Roberto Cartocci e a Paola Bordandini) i problemi cruciali del declino o comunque della radicale trasformazione delle vecchie culture politiche, in particolare a fronte dell’ascesa in Italia e in Europa di movimenti e partiti populisti. E su questi riflette - nella Sezione Interventi - anche Franco Rositi, in un acuto e brillante contributo su populismo ed eguaglianza immaginaria. Accanto alla traduzione dell’intervista di Elias di cui sopra, la Sezione Temi eliasiani ospita poi un originale saggio di Angela Perulli sui processi di produzione e riproduzione delle disuguaglianze sociali e come su essi agiscano le dinamiche relazionali del potere. La Sezione Saggi e ricerche, come sempre aperta a tematiche e approcci disciplinari diversi, presenta l’interessante saggio di una ricercatrice argentina (Vanessa Lio) sulle nuove forme di controllo sociale consentite dalle tv a circuito chiuso; e una ricerca sulle seconde generazioni di immigrati stabilizzatisi nel Sud Italia e le loro aspirazioni (Simona Miceli). Si segnala infine che nel prossimo numero (V, 9, Giugno 2015), come indicato dal Call for papers sul nostro sito, la parte monografica sarà dedicata a studi e ricerche sul tema: Se e quale spazio di riconoscimento si stia aprendo per le nuove famiglie. Pur nell’ovvia libertà di scelta delle prospettive di analisi, si sollecitano in particolare contributi che sappiano tenere sullo sfondo della propria riflessione i processi di mutamento sociale e la complessità del rapporto individuo/famiglia/società. CAMBIO continuerà ad ospitare articoli in lingua italiana e in inglese. Eventuali proposte di studiosi di altra appartenenza linguistica sono benvenute: qualora siano valutate positivamente dal Comitato Editoriale e dai referees, se ne chiederà la traduzione in una delle due lingue “ufficiali” della rivista, lasciando la possibilità di consultare online anche la versione originale. 6 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Political Cultures in Transformation a cura di Carlo Baccetti e Dimitri D’Andrea Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 7 8 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228737 Carlo Baccetti, Dimitri D’Andrea [Culture politiche in trasformazione] Introduzione alla sezione monografica I contributi che presentiamo nella parte monografica di questo numero affrontano il tema della trasformazione delle culture politiche in Italia e in Europa con approcci disciplinari diversi e con differenti interessi di ricerca. Con il termine cultura politica intendiamo riferirci in questo contesto a quell’insieme composito di orientamenti teorici - valori, norme, principi, credenze, opinioni, aspettative - e atteggiamenti pratici nei confronti delle istituzioni politiche nel loro insieme o di fenomeni, attori, processi politici particolari in cui si esprime la risposta, magari implicita, che ogni cittadino elabora alla domanda sulla natura, il senso e il valore della politica e sul proprio posizionamento rispetto ad essa, in contesti storicamente e geograficamente definiti. In questa prospettiva - come ci ricordano Roberto Cartocci e Paola Bordandini nel loro contributo - la cultura è propriamente «quello che gli individui fanno nelle loro scelte quotidiane, è un repertorio di modelli e valori “dato per scontato” che orientano l’azione dei cittadini offrendo soluzioni efficienti ai loro problemi ricorrenti». Ciò che accomuna i contributi raccolti in questi numero non è, dunque, tanto una tesi o una diagnosi, quanto piuttosto una prospettiva: l’idea, cioè, che la crisi o comunque le metamorfosi delle democrazie liberali contemporanee possano essere adeguatamente comprese soltanto intrecciando il piano del cambiamento delle regole e degli assetti istituzionali con quello delle culture politiche, vale a dire degli atteggiamenti teorici e pratici, delle aspettative e delle pretese delle cittadine e dei cittadini nei confronti della politica. Con la fine del secolo breve si è, infatti, prodotto un cambiamento radicale della società e delle culture politiche che ha inciso profondamente sul funzionamento delle democrazie anche laddove queste hanno conservato immutati i propri assetti istituzionali (Daniel Innerarity). Al di là dei differenti approcci disciplinari e delle diversità di oggetto e di scala i contributi qui raccolti sembrano convenire su una doppia presa d’atto: da una parte, quella di una trasformazione delle culture politiche ben più profonda della semplice modificazione degli orientamenti elettorali; dall’altra, quella di una crescente difficoltà nel funzionamento della logica rappresentativa tipica delle istituzioni politiche non soltanto liberal-democratiche (Laura Bazzicalupo). Si tratta di fenomeni particolarmente rilevanti e di indubbia attualità sopratutto in Italia, dove il tramonto delle subculture politiche territoriali ha lasciato campo libero a diffusi orientamenti particolaristici ed ha messo in luce la carenza del senso di responsabilità collettiva. In Italia, infatti, il collasso delle culture politiche bianca e rossa ha fatto riemergere un po’ ovunque - come sottolinea Antonio Floridia - «il sostrato […] di una cultura politica antidemocratica, antiparlamentare, mai veramente identificatasi con le basi antifasciste della Repubblica». Tanto da chiedersi se l’Italia oggi possa propriamente essere definita «una comunità politica». Vero è che culture politiche omogenee al livello di un’intera società non ne esistono, non esiste uno “stereotipo nazionale” di cultura politica. Al contrario, la cultura politica di una determinata società è costituita da una pluralità di subculture, spesso molto diverse e in contrasto tra loro. In una prospettiva comparata e utilizzando strumenti d’analisi storico-politologici si muove il contributo di Mario Caciagli, che ci offre una sintetica ed efficace narrazione della vicenda delle regioni rosse in Europa nel corso del Novecento, ovvero della natura e delle sorti delle subculture politiche socialiste e comuniste in alcuni ambiti territoriali della Germania, della Francia, dell’Austria e dell’Italia. Caciagli ci ricorda che il cardine delle Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 9 Carlo Baccetti, Dimitri D’Andrea DOI: 10.1400/228737 subculture rosse, creatura e strumento, fu il partito di massa, che mobilitava permanentemente gli iscritti grazie alla rete delle associazioni collaterali che li accompagnavano “dalla culla alla bara”. Quel partito che non era solo strumento per competere alle elezioni o per selezionare la classe politica delle democrazie di massa ma, in primo luogo, fonte di identità e luogo di integrazione sociale, un partito per il quale la dimensione locale e il radicamento territoriale erano aspetti centrali e primari. Tra le culture politiche rosse che fiorirono in Europa nel corso del Novecento, il caso dell’Italia presenta aspetti di specificità perché la subcultura che si radicò nelle regioni dell’Italia centro-settentrionale non fu monoclasse, qui il PCI costruì un blocco sociale e una base elettorale che fu in sostanza un’alleanza interclassista, il «capolavoro» di quel partito fu di conquistare i mezzadri e, accanto ad essi, larghi settori di artigiani, commercianti, intellettuali. Della subcultura rossa, o meglio dell’eredità che essa ha lasciato si occupa anche Antonio Floridia, che avanza ipotesi interpretative e indicazioni di ricerca facendo particolare riferimento alla Toscana. Floridia rintraccia in questa regione i segni di una mobilitazione civica e di una domanda di partecipazione “dal basso” sopravvissute alla scomparsa del partito di riferimento e che si sono riversate, al momento, sull’offerta elettorale del Movimento 5 Stelle. A suo parere, la crisi della politica assume i tratti, in questa regione, di uno iato tra la cultura ormai propria della classe politica, pervasa dalla personalizzazione della leadership e da meccanismi di comunicazione verticistici che tendono a saltare la mediazione dei corpi intermedi, e una cultura politica diffusa, degli individui e dei cittadini, che mantiene invece i tratti ancora forti di una cittadinanza attiva, di una attitudine alla partecipazione civica che sottende la presenza di una buona dotazione di capitale sociale. Di capitale sociale e in particolare della sua distribuzione in Italia al livello regionale si occupa il saggio di Cartocci e Bordandini, che tracciano «una geografia del senso civico». Come il lettore vedrà, i dati di ricerca, individuali e territoriali su cui si basano questi autori li porta a conclusioni più pessimiste (rispetto alle ipotesi di Floridia) riguardo alla persistenza di dotazioni di capitale sociale anche nelle ex regioni rosse come appunto la Toscana. Appare piuttosto che la disarticolazione delle subculture politiche territoriali «da un lato ha portato alla contrazione di atteggiamenti collaborativi e cooperativi […] dall’altro ha fatto riemergere il tradizionale cleavage tra Nord e Sud del paese». Le reti di solidarietà, di fiducia generalizzata, il senso di corresponsabilità interpersonale, il rispetto delle norme, anche e soprattutto di quelle informali, la diffusa informazione e competenza politica e l’identificazione con gli assetti istituzionali, insomma tutte le variabili che definiscono il concetto di capitale sociale, risultano appannate proprio in quelle regioni della Terza Italia che costituivano in passato le eccellenze. Se le Italie della Prima Repubblica erano tre, ma forse anche quattro o cinque, nel “nuovo” e mai stabilizzato sistema politico che le è succeduto dagli anni Novanta, la complessità si è ridotta, le Italie sono ancora e sempre due: «Esce confermata la frattura fondamentale tra un Nord più dotato di comunità civiche e più aperto a orizzonti di fiducia generalizzata e un Mezzogiorno più chiuso». Il contributo di Laura Bazzicalupo attraverso un percorso argomentativo esplicitamente critico nei confronti della contrapposizione fra populismo e neo-liberalismo, fra iper-politica e spoliticizzazione, difende la tesi di un legame stretto fra il populismo contemporaneo e la governamentalità neoliberale, le tecniche di regolazione sociale incentrate sull’estensione all’intera vita sociale, privata e politica della logica economica e del principio della concorrenza. A differenza del populismo novecentesco - che si «riferiva a ideologie e movimenti storicamente identificabili, dal populismo russo a quello americano del Popular Party o al peronismo argentino, per non parlare della dimensione populista dei grandi movimenti novecenteschi ad esito totalitario - quello contemporaneo è un populismo che con la governamentalità neoliberale condivide l’estraneità ad ogni logica rappresentativa, ad ogni solidificazione identitaria, ad ogni mediazione riflessiva. Le nuove forme di populismo appaiono così adeguate ad una forma di soggettività recalcitrante ad ogni forma di appartenenza e alla logica della mediazione. Anche per Innerarity, al fondo della sfiducia nei confronti della politica, dei politici e delle istituzioni rappresentative - alla base del fenomeno di liquefazione dei partiti di massa novecenteschi - va collocata una trasformazione profonda della società e delle soggettività delle liberaldemocrazie occidentali. Globalizzazione, postfordismo, nuove tecnologie, crescita della complessità sociale hanno polverizzato i partiti politici novecenteschi e segnato la fine del partito di massa e hanno dato vita ad una cultura politica frammentata e contraddittoria che oscilla fra le fascinazioni della tecnocrazia e le sirene del populismo. Compito ineludibile per chi ha a cuore i destini della democrazia è ripensare il partito politico dopo la fine del partito-contenitore novecentesco. 10 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228737 Carlo Baccetti, Dimitri D’Andrea Il contributo di Lorenzo Bruni, attraverso un’analisi sociologica e una discussione critica del documento di Fabrizio Barca dal titolo Un partito nuovo per un buon governo. Memoria politica dopo sedici mesi di governo, propone una riflessione sulle chances di rinnovamento e ridefinizione della forma-partito nell’epoca della crisi della rappresentanza. Nella prospettiva di Bruni la proposta di Barca, sicuramente apprezzabile in termini di elaborazione ideale e di sforzo di immaginazione politica, sconta una sottovalutazione delle trasformazioni che hanno investito il rapporto fra società e politica. Sfiducia e disaffezione nei confronti dei partiti non si spiegano esclusivamente con le loro pessime performance in termini di efficienza e democrazia, ma con un definitivo trasferimento al sociale di funzioni un tempo tipiche della politica. «Economie collaborative e pratiche di condivisione, reti di vicinanza e prossimità, pratiche di credito reciproco, di auto-costruzione e co-working, pratiche sempre più diffuse di autofinanziamento e azionariato popolare», «nuove forme di mutualismo, gruppi di acquisto solidali, formule aggregative e auto-organizzative intorno ai beni comuni» sono tutte forme di «fare politica nel fare società» che sono disinteressate - quando non diffidenti - nei confronti della politica partitica e scarsamente disponibili alla sua mediazione. Infine Lorenzo Bernini offre uno spaccato delle culture politiche che animano il variegato e talvolta anche conflittuale mondo dei movimenti femministi e di quelli che rivendicano i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali/transgender, queer e intersessuali. Il contributo ricostruisce analiticamente il ruolo che l’utilizzazione o il rifiuto del concetto - o meglio il dispositivo concettuale - di gender ha svolto nella definizione delle diverse posizioni relative ai diritti delle donne e delle minoranze sessuali. In linea generale si può concludere che, pur nella diversità degli approcci, i contributi di questa parte monografica convergono su un punto decisivo: i cambiamenti delle istituzioni e delle norme che regolano la convivenza civile sono orientati dalle trasformazioni delle culture politiche. E le trasformazioni della cultura politica che vengono registrate e discusse in questi saggi sono importanti ma non sono confortanti. I problemi che ne derivano per il buon funzionamento della democrazia sono tutt’altro che marginali. Lo scarso senso civico e la mancanza di corresponsabilità sociale richiederebbero istituzioni ed attori politici orientati a frenare il particolarismo e il clientelismo con soluzioni politiche efficaci; soluzioni non impossibili da attuare ma evidentemente non convenienti per le classi dirigenti: se le clientele funzionano - è la mesta riflessione di Cartocci e Bordandini - perché cambiare? Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 11 Carlo Baccetti, Dimitri D’Andrea 12 DOI: 10.1400/228737 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228738 Daniel Innerarity [Old and New Political Subjects] Abstract: With the end of the twentieth century there has been a radical change of society and political culture that has had a profound impact on the functioning of democracies even where these have maintained unchanged its institutional structures. Starting point of the article presented is thus: who are the protagonists of politics? And therefore proper reflection about politics nowadays should start with the question of who should take part in it and which the new and old political issues are, if it should be the purview of a select few or open to everyone, to experts or to what we call the people, a difficult concept to define longer available, in a space which is no longer clearly structured by social classes, nor mobilized by political parties. Keywords: Political parties, Legitimacy, Democracy, Political class, Participation. Political transformations, either revolutionary or evolutionary, modify three different issues: subjects, themes or conditions. There are political changes which are due to a change in the subjects considered legitimate enough to participate in politics, which contest the fact that politics is the purview of some and not others, of a certain social class and not every social class (democratic revolutions), of the state and not the civil society (a neoliberal twist). In other cases, this change takes place because there is a variation in the most important themes (political agenda) or in government priorities. This has occurred at times because of a certain weakening of social issues as articulated in the left-right axis or with the eruption of identity politics and the environment issue. In politics same themes that had disappeared may reappear and others which are vital today just fall permanently by the wayside. The third group concerns the conditions in which politics is carried out, because - as we can see today - events accelerate and new spaces open up, due to cutting-edge technologies or financial instruments that change the rules of the game and governments. Public issues, sovereignty and limits become something very different from what they used to be and, most importantly, new realities no longer permit us to go on as we once did. A proper reflection about politics nowadays should start with the question of who should take part in it and which the new and old political issues are, if it should be the purview of a select few or open to everyone, to experts or to what we call the people, such a difficult concept to define, in a space which is no longer clearly structured by social classes, nor mobilized by political parties. The most reasonable answer to this question should be that participation in politics should be open to everyone, but this affirmation does not provide any information about how these different types of authority relate to each other, especially when their aims are incompatible. Should we pay more attention to surveys or to experts? Stock prices or popular sovereignty? Political parties or social movements? We must determine what is old and what is new - where political participation is concerned - in the age of social networks, with active societies, global responsibilities and more complex problems. How shall we divide empowerment anew among ordinary citizens, experts, parties, the people (as a national entity) and social movements? The intensity of our political debate ultimately follows from the fact that we are living through a time of redistribution of political authority among different levels of government, with different claims of authority, representation and identification that are very hard to organize. Obviously this redistribution produces a notable degree of perplexity and disorientation, and comes about in the midst of intense conflicts. It is clear to everybody that the way in which the subject issue is solved will have consequences in the sectors of themes and conditions. We are in the midst of a crisis of democratic authorization, and it is painfully clear that we do not know if we Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 13 Daniel Innerarity DOI: 10.1400/228738 should listen to what extent we should leave things to experts, if judges are the only ones capable of resolving political problems, what to make of leadership in a democratic society, who represents us, who decides to what (from which the territory debates or European governance proceed) or to whom political parties belong (whence the controversies about political primaries, whether candidates should be drawn from leading cadres, militants, voters or everyone). The task of organizing the world by stuffing some things into an old drawer and arranging others on a new shelf entails the danger that the hindsight of history may prove us wrong. This should not keep us from venturing a hypothesis as to how things will evolve. But we need to be cautious before definitively interring what seems debilitated or heralding the advent of something that may wind up straying afar or proving ephemeral.Who knows, when dealing with political issues, if we are at a funeral or a baptism, at the beginning of a new cycle, a trend, a reinstatement or a historical turningpoint? Likewise, there was no decision in virtue of which our ancestors decided the precise moment to leave the Stone Age and enter the Iron Age, because they were in no condition to recognize such a momentous change. The job of being history’s undertakers and midwives is never left to contemporaries but to future historians. In the world of politics everything, as Raymond Aron said of ideologies, is «anticipations waiting for time to judge» (1948: 313). In any case, intellectual honesty forces us to distinguish the old from the new and to ask ourselves if the death of something was due to natural causes or a lynching. Meanwhile, what we can do is analyze things as rigorously as possible and be reasonably skeptical when tagging things as old or new. It could very well be that they are neither the one nor the other, that we are facing transformations rather than substitutions, so that the old participants of politics must be thought of in a different light rather than of being replaced by new candidates. We must address the problem of how to bring about, in a mature democracy, the principle of universal citizenship, and how to cope with new forms of exclusion, what the role of experts is in a decisional process that requires a vast knowledge but that cannot do without democratic legitimation, which political party models have become obsolete and to what extent we can still rely on them; how we can understand the people in a way that is compatible with other often troublesome realities, such as individual rights or the duties of interdependence… Ultimately in short: Who are the protagonists of politics? Praise and scorn of political class Surveys remind us that this is our major concern. Even the expression “political class” includes a disaffection, alluding to a distance and a lack of correspondence between its interests and ours. Peter Mair called this «the Toqueville syndrome» (1995). As occurred with the nobility, politicians have a hard time nowadays justifying their privileges when they carry out tasks that are increasingly less important (or they can scarcely carry out those assigned). This critical attitude towards politicians is nothing new; their detractors allow us to make an inventory of the real nature of politics throughout history (Palonen 2012). The novelty is perhaps that, thanks to the amplificatory power of the media and the internet, criticism has gained the dimensions of an authentic lynching. Beyond the objective causes for this discontent (which go from incompetence to corruption), a hostile constellation has been formed around politics for many reasons, some even contradictory, as is often the case with the motives for indignation: some are seduced by the ecstasy of direct democracy; others long for more modest aspirations such as electoral reform; some make monetary calculations and worry because politicians might be too numerous and too overpaid; some rub their hands together gleefully because a weak political system benefits them… In the forefront of our expressions of discontent is parliamentary performance, a habit that makes as much sense as the old British law prohibiting parliamentarians to die in the parliament building. Maybe we should turn our attention to the rest of the world - especially the media and financial powers - so that parliament - under scrutiny but without any pressure - exercises the functions we expect of it in a democratic society? That politicians of either gender leave much to be desired is so evident that is not worth wasting too much time over.This should be no surprise to whoever knows how other professions work, none of which comes off unscathed from a serious review of greater or lesser harshness. It happens, however, that these other professions, which are just as much in need of improvement, have the good fortune to be less exposed to public scrutiny. My question is, 14 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228738 Daniel Innerarity how on earth such a vilified, difficult, competitive, discontinuous, scrutinized and poorly understood activity still attracts so many practitioners. I am convinced that, in general, politicians are better than their reputation would have them be. But the problem, I anticipate here my position, is not exactly this. If it had been, it would have been easier to solve with a simple substitution. What we are referring to when we take note of political disaffection is the unqualified criticism towards anyone who takes up the task (“they are all alike”, etc.) and herein the problem becomes very serious indeed. Let us start by recognizing that a critical attitude towards politics is a sign of democratic maturity and not the anteroom of its demise. The fact that everybody feels competent to judge their representatives, even in regard to decisions of enormous complexity, is something that should reassure us, because the opposite would worry us more. A society can call itself democratically mature only when it ceases to worship its representatives and maintains jealously its confidence on them. Much political disaffection derives from an error of perception. In any established democracy there is a multitude of political representatives who do their job with profound honesty, but only the few corrupt ones make the headlines. Our underlying sensation is that politics is a synonym of corruption, and we do not realize that scandals are newsworthy as long as the norm is for things to trot along moderately well. The same holds true for medical mistakes: the news media never talks about well-performed surgeries but about their failures, and from there the belief that all doctors are quacks and butchers is just a step away. Thanks to the communications media power has become more vulnerable to criticism, but their spun language and underlying message has fostered a widespread anti-political mentality. It is one thing to reveal a lie, to ridicule arrogance and to air different points of view, but insisting on negative aspects tends to obscure other equally important political dimensions, such as the value of accords or the little spectacular normality of honest behavior. We should not worry so much about cases of corruption as about the ordinary weakness of politics, and, most of all, that focusing on the former keeps us from noting the latter. All this taken into consideration, and without denying that most criticisms are justified, I propose a reversal of perspective, asking ourselves whether behind some of our less substantiated versions there is not a lack of sincerity of society towards itself. In a representative democracy they are there because we are not there, or rather, in order for us not to be there. It is certainly true that the best do not enter politics, but that should worry us more than it does them. Ritual criticism of politicians allows us to avoid certain criticisms that, if they were not aimed at them, we would have to aim at ourselves. Does it make any sense to harp at the same time on certain criticisms of our political representatives and claim that the represented are innocent? It is contradictory to claim that our representatives are like us and at the same time expect them to possess exceptional qualities. It is impossible that such incompetent elites have emerged from a society that seems to know exactly what needs to be done. This shows that populism is an “inverted egalitarism”, to wit, a mentality that is not based on the conviction that the people is equal to its rulers, but better than them (Shils 1956:191). If politicians do everything so wrong, it cannot be that we have done everything well. There is a growing intolerance of voters against the oligarchic connotations of consolidated systems of representation. But let us not simplify the complexity of democratic life to the populist format of a victimized, healthy, virtuous common people, as against a corrupt and disoriented institutional body, a format that finds ardent supporters in the whole ideological gamut, that have in common the stigmatization of whatever seems to oppose the homogeneity of an imaginary common people; be it the enemy, the foreigner, the oligarchy, or the institutional bodies (Rosanvallon 2006). There is a paradox behind political criticism that can be named “the paradox of the last wagon”. I refer to an old joke about railroad authorities who, after finding out that train accidents mostly affected the last wagon, decided to eliminate the last wagon in all trains. Now, let us suppose that politics does not function. How can we suppress the whole political class? Who could substitute it? Who could be sent into a social space without political formatting? Who would benefit from such a world? In the last instance, we could even ask ourselves if there exists a “political class” and, above all, if it is possible that there is nothing similar to it? Obviously, when we use this expression as a means of expressing our discontent we are complaining about their distant attitude, their elitism Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 15 Daniel Innerarity DOI: 10.1400/228738 and indifference towards the problems of the common people which they should represent. Well, can we imagine a society whose political protagonists are a mere transmission belt of society’s aims? Politics is an activity that can be improved, but above all it is something inevitable. Populisms ignore and hide this inevitability; they foster mistrust in politicians, as if their activities could possibly be carried out by others who are not politicians or who act as if they were not. There are even those who at bottom would like to suppress the mediation which lies at the core of political representation: consultations without deliberation, irreversible constitutional frameworks, taxation without representation, binding mandates … It is one thing to introduce procedures to contrast the popular will, to prevent representatives from taking too many liberties, or hold onto their positions forever - participation, accountability, rotation of responsibilities, prohibiting re-election - and attempting to overthrow representative democracy. In our contempt for the political class there lurk no few platitudes and some discredit that betray a great ignorance about the nature of politics and promote contempt for politics as such. Let me remind those critics of the principle that whenever we challenge something, we have the right to know who or what will take its place. In order to be reasonable criticism should ascertain who at times its disproportion favors. We are talking about incompetence and thus we encourage technicians to take over the job of governing; we criticize their wages and so justify placing politics in the hands of the rich; we totally discredit politics and entrust it enthusiastically to those who owe nothing to politics because they already have other kinds of power. Is there anything worse than bad politics? Yes, its absence, an anti-politics mentality that would extinguish the desires of those who count only on politics because they are powerless in other areas. In a world without politics we would save some on wages and avoid certain shameful spectacles, but we would lose the representation of our interests and the ambitions for equality of those who have no other means for achieving them. Politics isn’t much of a help? Consider then what their fate would be if they couldn’t even count on a political enunciation of their rights. Politics for all, politics of a few When the political waters are troubled - and this happens quite often - the eternal question arises as to who is the right person for the job. Attention is given not so much (or not only) to how it is done but to who does it. This triggers a suspicion that maybe it is a career monopolized by unworthy people. Negative opinions polarize around those who believe that it is the purview of an élite and those who believe it is too easily accessible to anyone. That is, some believe that the political fields are monopolized by the few and others that it is invaded by a mob of upstarts. Thus there appears once again the same old tension typical of democracies, between the old guard and the newcomers, the man-in-the-street and the élites, the professionals and the amateurs, the well-paid and the volunteers. Let us acknowledge from the outset that we observe all this with a certain perplexity and that is why we often ply politicians with contradictory demands. We want expertise to be taken into account in making political decisions but do not want to be governed by experts; we demand that our interests be defended, but we despise politicians who only defend interests and are unable to compromise and agree; we demand that only the best should go into parliament but are unwilling to pay them accordingly; we want them to speak frankly, but are not always content to hear the truth. There is also an unresolved contradiction between assuming that anyone can engage in politics and arranging things in a such a way that it ends up in the hands of experts or the rich. Further demands: we want participation, but there is little willingness to participate; we would like open lists, but only 3% of voters take advantage of those offered for the Senate11; we would like politicians to have less of a say but would strongly protest against leaving government in the hands of civil servants… So who should take on the job of politics? The answer to this question about the “who” of political involvement, who can and should do it, is one alone: everyone. There is no one we can forbid to take this step or declare unfit to exercise it (except for specific cases of eligibility dictated very restrictively by law). In a democracy there is no sense in the phrase “eligible citizen” to elect or be elected, which Guizot talked about. If a political career is open 11 Referred to the Spanish Senate (tr. note). 16 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228738 Daniel Innerarity to all it is because we assume that everyone has a capacity for judgment and decision. This indeterminacy of political occupation contrasts with the fact that politics usually ends up being monopolized by a caste with little turnover, which is one of our main complaints about political parties; but every now and then we also move in the opposite, direction, and once in a while, outsiders take the system by storm to renew it. This was the case of Ross Perot , the Texas businessman who burst onto the scene of the 1992 presidential elections, or of Ruiz Mateos, or Mario Conde in Spain, or Beppe Grillo in Italy. In many countries there are politicians whose validity derives precisely from their running as enemies of the political establishment (in a certain sense, this was the case of Obama) and, on occasion, they have proven successful in other areas of social life (communications, business, law, academia…). It is a very old idea, that of discrediting other politicians and presenting oneself as a non-politician, i.e., as objective, disinterested, suprapartisan (Schmitt 1932: 21). In all these cases, success depends on a nimble management of the tension between exteriority vis-à-vis the system and the need to act with the original contributions one wishes to promote - according to a political logic. Otherwise the tension gets transformed into a self-destructive contradiction. In any case, in a democratic society we must be careful about qualifying those who have political aspirations as outsiders because politics is open to all and requires no particular qualification. No one is an intruder because he or she is an unknown in the political system; what can make him/her an intruder in the worst sense of the term is seeking to behave in politics with a different logic and trying to turn it into a media issue, a business arrangement or a self-righteous mission. That politics is open to everyone means, first, that it is not the exclusive purview of the rich. This has not always been so and the democratization of the political profession is a recent and not always guaranteed conquest of humanity. The pre-democratic politician was an aristocrat who lived for politics and not from it, a gentleman politician. Since the French Revolution parliamentarians’ allowances have been a remuneration enabling those who were not aristocrats to participate in politics. The fact that parliamentarians could make a living from politics gave people from varied backgrounds the chance to be part of the game.The salary of politicians, slender but sufficient, is a guarantee of equal access to political activity. The powerful often have other means of furthering their interests, but the surprising thing is that we put at risk the achievement of equal access to politics with such stupid proposals. I will not even judge whether they are too many or they earn too much. I merely point out that this debate harms its legitimacy and hints at a future ideal of parliaments that are weak and in the hands of the rich. A parliament of a few idle gentlemen would be a parliament even less able to keep a rein on its executives. If politicians earned no wages, only the rich or their flunkies would devote themselves to it. Defending the number and salaries of parliamentarians may sound today like a provocation but it is more egalitarian than certain populist measures that weaken democracy. The second consequence of keeping politics open to all is that, in principle, it makes little sense to divide people between those who are competent for it and those who are not, and turn it over to the so-called experts. However, this declaration of universality poses some problems: certain types of decisions are at stake. Some have argued that recourse to experts is justified by the greater ease of experts in managing the complexity of decisive issues and because only experts provide the political system with attention to long-term interests, while politicians work only in the short term and in accordance with the electoral cycle. Hence the tendency of the political system to delegate to non-representative institutions that are not obliged to account to anyone (or only indirectly), institutions called «non-majoritarian» (Majone 1996: 3) and that Everson has defended for counteracting the «predatory inclinations of a transitional political class» (2000: 110). This is why a purely tactical approach to politics leads inexorably to technocracy. Either politics introduces long-term strategies and learns to deal with complexity, or the increased use of experts will be the only way to avoid the dysfunctionality of that simplification and tactical approach in which, too often, elected politicians fall. However, one thing is that the use of experts must occupy a prominent place in complex democracies and another is that expert knowledge can do without any democratic legitimacy. One thing is to take into consideration the opinion of experts and another is to leave governing in the hands of someone who supposedly decides according to objective criteria. For how can we know who are the best and how can we be sure that, if we do find them, they Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 17 Daniel Innerarity DOI: 10.1400/228738 would make the best decisions? Who decides when experts disagree and construe objectivity in a different way? Politics is an activity that requires maintaining balance among people, experts, civil servants and political professionals. And the latter, politicians, play a key role if we consider the type of activity that is involved. Politics is a vague occupation which calls for judgment capacity, comprehensive vision, prudence, intuition, sense of timing and opportuneness, communication skills, and a willingness to make decisions about which there is no absolute certainty. Whoever dedicates himself to it should also accept a certain superficiality that allows him to form and overview of things, a vision that would be lost if it delved too much into details. One can be neither an amateur nor a specialist (Bullit 1977). Herein lie many of the reasons for the low esteem of politicians: we respect specialists more than laymen; the former protect themselves better from criticism than the latter. Administrators of objectivity who would like politics to be an exact science, have great difficulty in understanding its true purpose because they do not take into account that politics, rather than managing objectivities, involves weighing the social significance of decisions, their opportuneness in certain contexts, the way they affect people. Hence there is no specific training for politics and anyone can in principle exercise it. Politicians are necessarily self-taught (Scheer 2003: 33). It requires learning skills that have little to do with a technical objectivity of the issues at hand; this is why highly qualified persons in their fields (doctors or professors, for example) can be very bad ministers of that same field (health and education) and vice versa (without being experts in that field they can manage it well politically). Thanks to this versatility politicians can move from one ministry to another and whoever mistakes this will interpret this versatility as incompetence, an interpretation that is at the origin of the populist contempt for those who govern us. It is a paradox of the current disaffection towards politics: behind the complaint about the incompetence of politicians there all too often lurks an elitist contempt for ordinary people. Why is it not a good idea to put the experts at the head of government? Because there are bad experiences with technocrats, because they have a tendency to persist in their mistakes, to defend their position not as the product of a decision but as a logical deduction of a truth, but above all because they would stop fulfilling their role as allies in the task of reducing the complexity of the world and building trust. Democracy is a political system that involves experts in the decision-making process but refuses to leave everything in their hands, to replace politicians with civil servants and experts. At the apex of politics there is a precarious balance between administration and government, between technical skill and politics. This scale should never become imbalanced because it is as bad to rely only on the continuity of the bureaucracy as it is to risk everything with political creativity. Without ordinary administration, politics would turn into a solution of ineffectual improvisation; without politics, nothing would protect us from the machinery of self-conservation into which ordinary administration would degenerate. Now if we remain confident that politics has the final say in administration or that parliaments can oversee governments, we need a certain degree of professionalization of politics. «Politics as Vocation» (Weber 1919) is as necessary for fulfilling its functions as a major consideration for the role of expert knowledge in our decisions to increasingly complex problems (Innerarity 2013). A democracy requires both experts and the wisdom to protect itself from experts. There are different profiles of politicians and there is no ideal type. The best case scenario is a balance between amateur and professional politicians. The absolute professionalization of politics should be limited as much as its absolute lack of professionalism. It is a good sign that accredited professionals in other fields enter politics, but we should not let them replace political logic with what rules their specific areas. If we keep this tension alive we can free ourselves as much from the experts’ presumption of exactitude as from the frivolity of politicians, thus taking advantage of the competence of the former and the creativity of the latter. Because political problems are too complex to be left in the hands of those who deal in exactitude, for they also require an effort of political imagination. The end of political parties? The current crisis of political parties, their discredit, loss of relevance or fragmentation, is a manifestation of a deeper crisis. In my opinion we are at the end of a political era that we may call “the era of containers” and we 18 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228738 Daniel Innerarity still do not know what material can be salvaged from the old containers and what new institutional forms will adopt the new. A container is the symbol of globalized commerce, a device for storing things, fitting them into homogeneous, standardized, classifiable, manageable spaces so that nothing is left out. The anthropologist Clifford Geertz (2000) criticized this concept of the world as a puzzle of same-sized (or type of) pieces, developed under the assumption that nations and cultures can be matched up indifferently; he announced for the future a new disharmony among spaces, greater heterogeneity of the elements that make up social reality. This coincided with Ulrich Beck’s criticism of the container model of society and nation states (1997), as if we were locked up inside self-sufficient capsules endowed with sovereign authority. Reality has long been out of whack with this definition, nor can we govern from such assumptions; free trade and communicative connectivity make it very difficult to maintain a national container with which to protect the unity of economy, culture and politics. The world of containers presupposed a social context structured into stable communities with specific occupational roles and forms of recognition and established reputation. In that social reality political machines were developed which are our classic mass parties. «Party democracy» was the political form appropriate for a society structured stably into social classes, groups clearly defined by their own productive function, whose social and cultural identifications were destined to find a correspondence in terms of representation. Like other social organizations, parties acted as containers in that they were ponderous organizations that were not confined to managing institutional processes of representation but that also incorporated into their structures entire areas of society, culture and their values, and therefore could ensure the predictability of its political and electoral behavior. Probably our social practices continue to take for granted the existence of a world that has disappeared or, at least, has undergone a transformation that has made few inroads in our concepts and actions. What happens when interactions multiply, social functions become evanescent and identities precarious, when the logic of flows is stronger than the logic of places? We have to answer these questions instead of displaying the perplexity that it produces in us, for example, the fact that the logic of pork-barreling has stopped working with mechanical precision (between left and right, depending on who governs and who is in the opposition). Maybe this scheme of communicating vessels has lost much of its plausibility because there are phenomena that are no longer explainable as adjustments or rebalancing within the system but obey deeper changes. When mass democracy arose, political parties stabilized over a long period both political identities and their corresponding electoral choices. To speak, at that time, of voters «choosing» a specific political option had as little sense as saying that a believer chose to go the Anglican Sunday Mass instead of the Presbyterian or Baptist, as Rose and Mossawir keenly observed in a classic study (1967: 186). According to the best studies, the class vote has declined significantly since the mid-70s, especially in those countries in which class identity had been a fairly certain determiner of electoral preferences (Knutsen 2006). The period of «party democracy» as we have known it represented a solid geography, while today we seem to be moving more towards a liquid scenario, an instability and even a volatility which has had an affect on the great containers of the past (parties, churches, identities, communication media and even states). Bernard Manin years ago warned us about this change in our schemes of representation, which he summarized in the idea of a shift from a «party democracy» to a «democracy of the public» or «audience» (Manin 1997). All this is what lies at the origin of the widespread crisis of confidence that has eroded channels of representation and the traditional organizations of consensus and antagonism. This liquid panorama, to use the expression coined by Bauman, whose flows do not have any recognizable direction, affects both the public and its representatives, society and political parties. What the former receive from it confers a disconcerting unpredictability. Citizens are fleeing the venues of conventional politics. «The democracy of the public» takes on the fluidity of a fickle, unpredictable electorate. In marketing terminology we can speak of a less loyal, intermittent, volatile electorate. There has been what we might call a liquification of the electoral body, which at other times was a rather viscous, stable and loyal material. We have gone from an «electoral body» to a «political market» with all the rules (or lack thereof), all the risks and all the unpredictability of the market. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 19 Daniel Innerarity DOI: 10.1400/228738 Instead of voters, a party is a hodgepodge of hooligans and clients (in variable percentages). The difficulty of identifying them and gaining their trust has to do with the fact that their demands have become more complex and fragmented. Individuals emit diffuse signals that the political system cannot identify, develop and adequately represent. So the parties have great difficulty listening to their constituents and understanding, collating or processing their claims. The electorate is less differentiated and presents issues of cross-convergence, with less transparent and identifiable demands and expectations. In all verisimilitude we can apply to it the property of an «undetectable people» (Rosanvallon 1998). The personalization of electoral choice has much to do with that amorphous and dis-ideologized electoral market. As in the origins of parliamentarism before mass democracy, we do not vote in the first place for a party or a program but for a person. With the difference that then confidence in representation was the result of a more or less personal and immediate relationship, while now it is the product of a media image construct. The volatility of voters, together with the acceleration of the processes of social change likewise affects political actors and parties. If voters are so «unfaithful», parties are increasingly less forced into ideological commitments. I do not mean this to excuse these failures but to try to understand their cause. It is the overall volatility of the political space which explains that the idea of an electoral program has weakened and imposed a certain randomness in decisions and programs, as subject to improvised adjuncts as to rapid retractions. Probably electoral programs can no longer be understood as the old «programming» was because of the extremized complexity within which political decisions have to be made, when relevant interdependencies and consequent unpredictability multiply. Strategic rationality has become very difficult when the circumstances of world stability that once made it possible no longer hold. An extreme case of this institutionalized improvisation is the proliferation of «instant parties,» which represent disaggregated interests and try to respond off the cuff to the often contradictory demands of different sectors of opinion, in former times formulated for example around the consistency of class coherence. Perhaps in this we find an explanation for the success of certain contemporary social movements, like the pirate parties in 2011-12, one of whose German leaders stated that they had «a procedureless program». And this is why today we call ideologies political «sensitivities», because we dare not use any other name that might refer to something more solid and stable. While all this has been going on, parties have undergone a transformation that has distanced them from social reality. On the one hand, the distance between citizens and parties has increased at the same time that differences between parties have decreased, both processes becoming reciprocally reinforced, and causing public indifference to the world of politics in general. On the other hand, for some time now, in most democracies, parties have ceased to be organizations whose survival depends on the proportioned resources provided by its members and have become dependent on public funding, as if they were agents of the state. This linkage with the state has also been consolidated by the fact that parties have prioritized their role as instruments of government to the detriment of their representational function. Whoever is in opposition tends to consider himself so only temporarily because the name of the game is office-seeking; he is someone whose vocation is to achieve power rather than represent the people. Parties dedicate themselves above all to governing or waiting for their turn to govern. The center of gravity moves towards institutional responsibilities, parties are controlled by governments and their role in identifying and representing the interests and social demands weakens, which sometimes they are unable to perceive. «Parties have reduced their presence in society at large and have become part of the state. They have turned into actors who govern more than represent. They provide order rather than give voice (...). The result is a new form of democracy in which citizens stay at home and parties get on with governing» (Mair 2013: 97-98). The upshot is that the opposition often appears on the sidelines of conventional parties, in the form of social movements and protests. The mass parties of the nineteenth century were organized according to the matrix of public bureaucracies and as centralized factories, these two great inventions of modernity that were the «Fordist factory» and «Weberian bureaucracy»: standardized production and formalization of functions. In both cases, in the assembly line and in bureaucratic organization, standardized processes made it possible, through container logic, to mete out similar treatment to diversity. The factory and the party were our major means for the standardized production of things and the serial management of mankind. 20 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228738 Daniel Innerarity The transformations of the modes of organizing both entrepreneurial and managerial reality could not leave unscathed institutions such as political parties, designed with their logic. «Post-Fordism» has buried the Weberian bureaucratic model in favor of a light, open, diffused and polycentric one; it promotes a new socio-productive paradigm no longer characterized by the great processes of rationalization and centralization. New theories of organization that invite us to leave room for disorder in the form of irregularity, difference or periphery, and to distrust the container logic where everything fits together perfectly. It is a question of organizing without complaining of too much complexity, too many variables to control, too much subjectivity to sterilize, too much irreducible difference to a standard.The aim would be to create open systems, more like organisms than containers, more porous than closed, in a dialogue with what surrounds them and not protected against the outside. The challenge that these changes pose to political organizations is how to operate in an environment that governs a new style of behavior characterized by dissemination, autonomy and horizontality, with a mobilization that is geared more to specific problems than specific actions through stable bureaucratic organizations such as parties and trade unions (Inglehart 1990). What will the political landscape be like after the current political party crisis? From the outset, the political environment has become more complex with other forms of representation of interests, networks of parallel or alternative participation, participants or aggregations that have complicated the «game». In these new circumstances political parties have not lost their reason for being, but their «political capital», which, like financed capitalism today, has ceased to be insured stably and depends continually on a flow of resources which they occasionally intercept but without being able to capitalize on it once and for all. This instability will force political organizations to develop an adaptive intelligence and rebuild their capacity to represent and govern a society that has become more demanding, keeping a jealous eye on their delegations of authority. The current party crisis will be overcome only when there are better parties. Throwing away the baby with the bathwater, as they say, is not a good solution, and experience teaches us that even worse than a system with bad parties is a system with no parties at all; whoever complains about their oligarchic character will have more reason to complain if parties are weakened to the point of being unable to meet the expectations of representation, counseling, participation and configuration of the political will that is expected of them in constitutional democracies. I say this as an invitation to explore the possibilities of disintermediation which lie before us - the expectations raised by social networks, conducting primaries or renewal via social movements, for example - but not without creating too many illusions about them. As for the former, we can say that the new political organizations that have cropped up with the momentum of immediacy and horizontality of the social networks have had a rather poor showing against the expectations they raised. It is true that the network grants an unprecedented ability to interconnect instantaneously all those who had been reached separately (such as representatives and the represented), enabling observation and control, without the kind of organizational mediation that is provided by parties. It is something similar to what the invention of printing meant to the Protestant Reformation: the technical possibility of “free examination” without ecclesiastical mediation. Internet enables access of all citizens to the decisional process, making the interposition of political parties seem obsolete. However, turning that immediacy into a sole democratic register leads us to underestimate other central elements of democratic life, such as deliberation or organization. The time for decision is important, but it requires spaces and procedures of deliberation, whose importance is ignored by those who seem to conceive of democracy simply as a series of consultations. As occurred with Margaret Thatcher, who weakened the state and strengthened herself – in some of the political movements that have emerged from the social networks, devoid of any structure, regulations or program, authority is exercised sometimes in a more despotic manner than in traditional parties, because their alleged flexibility allows a less limited adoption of decisions for the rights of its members, commissions of guarantee and reference to a body of doctrine or stable program. The destiny of the Italian Cinque Stelle movement is a very illustrative case of digital ambiguity. In such a disorganized organization who guarantees the rights of its members or who is responsible for the results? As Michels (1911) said in the early twentieth century in a famous essay on Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 21 Daniel Innerarity DOI: 10.1400/228738 the sociology of political parties, organization is the weapon of the weak against the power of the strong. What can we say, secondly, about the primaries and other similar procedures by which internal democratization is seen as the best means for recovering the faith of voters? From the outset, it is an interesting resource that introduces an element of unpredictability in the life of political parties, but that should not be imposed by law, for among other reasons because it will be those parties that fail to mobilize their voters in this or any other way that will pay the price. But it also has its ambivalence, allowing parties to create a simulacrum of external democracy while maintaining an impoverished inner life, externalizing participation at a particular moment and around a choice of individuals, which is often resolved with media logic rather than political logic. Nor should we expect from social movements what they cannot give. I do not say this to diminish our expectations of them, but on the contrary, so that we can keep them high. What social movements can give us is something more radical than what is provided by political parties, which cannot be replaced. As Michael Walzer says, political parties spend their time gathering votes and social movements in modifying the terms of this gathering (2012). Both things do not go together very well, but from that tension we can hope for a greater revitalization of our exhausted politics rather than that fatal mixture of magic formulas, populist proposals and clichés. To compare Grillo with Thatcher is, in my opinion, neither rhetorical nor slanderous. It responds to an objective coincidence that I have always considered very suspicious among those who want to deregulate the political space from the digital left and those who, from the extreme right, push for the deregulation of the public sphere because they trust that by so doing certain social needs and policies regarding justice and the welfare state will wither away. The triple alliance between ineffectual political parties, a left with little sense of reality and a right that knows it all too well is an undeclared conspiracy that threatens our democratic life more than any other dysfunctionality. The combination of the two can weaken the values of a democratic and egalitarian society, which is what should concern us much more than the concrete future of our political organizations. What is obsolete and what is not at a time when so often the demise of political parties is heralded? What is gone is the monopolistic control of the public space by political parties, but in absolute the need for mediation in which the political will and the antagonism which lies at the core of collective decisions are formed. One thing is that parties and trade unions must undergo a profound process of renewal, and another that social victories and those of civic participation can be assured without organizations such as political parties and trade unions. The criticisms that are directed toward them are partly just and partly a result of ignorance about their functions. While we criticize the fact that parties and unions set up a filter and a mediation that often falsifies social reality, in civil society there are power imbalances in the groups competing for centers of decision that could be even more unfavorable to the weak if we had a more deregulated political space. Institutions that establish mediations and regulate the political parties game, generate many inequalities, which are not corrected by leaving that political space without any mediation. For better or worse, a democratic practice seems unlikely without institutions that perform this type of filter function, selection and guarantee or, at the very least, any alternative destructuring of the political field would be much worse. Parties are essential for clarifying the options available to voters; they serve the purpose of training political personnel, selecting candidates, managing the circulation of the political class throughout the institutions and making sure that those elected keep the promises they made to their voters. Thanks to political parties citizens can vote for a political program linked to an identifiable line of ideas. Confidence in candidates usually relies on an identification with the political ideas of the party they represent. Calling attention to these useful factors collides with a critical current established with few niceties, such as political correctness. One of the most frequent criticisms of political parties presents them to us as tools for reinforcing the power of politicians. The implication is that if the members of parliament were completely independent they could better represent their constituents, which is far from obvious. This was the famous argument of the late eighteenth-century conservative politician Edmund Burke, raised with a rather aristocratic conception of representation (1999: 156). The result of this would be to increase the confusion of citizens, lack of government leadership and increased fragility of the entire political system against populist and media pressures. Although it does not do so well on many occasions, political parties serve the purpose of keeping a tight rein on those elected. Without political parties the elected would be more of a caste than they are now and at any rate less controllable. 22 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228738 Daniel Innerarity What has gone by the wayside is the container-party, but not the idea of a political organization that helps to make the world an intelligible place, orients the decisions of citizens, that can lay out pathways of political participation and keep a watchful eye over their representatives. It is clear that the poltical parties of the present are far from living up to these expectations; in the aftermath of the political party crisis we are at a crossroads of either creating better parties or entering into an amorphous space whose territory will be occupied by technocrats and populists, thus defining a new battlefield that would be worse than the one we have today. References Aron R. (1948), Introduction à la philosophie de l´histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique, Paris: Gallimard. Beck U. (1997), Was ist Globalisierung?, Frankfurt: Suhrkamp. Bullit S. (1977), To be a Politician, New Haven:Yale University Press. Burke E. (1999), Speech at Mr.Burke’s Arrival in Bristol (1774), in The Portable Edmund Burke, ed. Isaac Kramnick, London: Penguin Books. Everson M. (2000), Beyond the Bundesverfassungsgericht: On the Necessary Cunning of Constitutional Reasoning, in Z. Bankowski, A. Scott (eds.), The European Union, Oxford: Blackwell: 91-112. Geertz C.(2000), Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics, Princeton University Press. Inglehart R. (1990), Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton: Princeton University Press. Innerarity D. (2013), The Democracy of Knowledge, New York: Bloomsbury. Knutsen O. (2006), ClassVoting inWestern Europe: A Comparative Longitudinal Study, New York: Lexington Books. Majone G. (1996), Temporal Consistency and Policy Credibility: Why Democracies Need Non-majoritarian Institutions, Robert Schuman Centre Workent Paper 96/57, Florence: European University Institute. Mair P. (1995), Political Parties, Political Legitimacy and Public Privilege, in «West European Politics», 18 (3): 40-57. Mair P. (2013), Ruling theVoid.The Hollowing of Western Democracy, London: Verso. Manin B. (1997), The Principles of Representative Government, Cambridge: Cambridge University Press. Michels R. (1911), Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, Leipzig: Werner Klinkhardt. Palonen K. (2012), Rhetorik des Unbeliebten. Lobreden auf Politiker im Zeitalter der Demokratie, Baden-Baden: Nomos. Rosanvallon P. (1998), Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris: Gallimard. Rosanvallon P. (2006), La contre-démocratie. La politique à l’age de la défiance, Paris: Seuil. Rose R., Mossawir H. (1967), Voting and Elections: A Funtional Analysis, in «Political Studies» 15 (2): 173-201. Scheer H. (2003), Die Politiker, München: Kunstmann. Shils E. (1956), The Torment of Secrecy: the Background and Consequences of American Security Policies, Glencoe: Free Press. Walzer M. (2012), Social Movements and Election Campaigns, in «Dissent» 59 (3): 25-28. Weber M. (1919), Politik als Beruf, en MaxWeber Gesamtausgabe, Band 1/17, Tübingen: Mohr Siebeck [1992]. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 23 24 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Laura Bazzicalupo DOI: 10.1400/228739 [Come in uno specchio] Populismo e governamentalità neoliberale Title: Like in a Mirror. Populism and Neoliberal Governmentality Abstract:The aim of the essay is to problematize the seemingly obvious dichotomy: liberalism - populism. A double bond holds today the two poles, both involved in the decline of the representative logic. An immanentism broadly aesthetic (at the same time, spectacular and immediately sensitive ) prevails; forms of life and power presume to manifest themselves and act without mediation. Moreover, even the conceptual couple populism/ neoliberalism, which presents itself as emphatically oppositional: hyper - political v/s depoliticization, reveals a paradoxical mirroring. We must rethink the populism of the twenty-first century beyond the traditional categories in which it was framed and we have to bring it back to the neoliberal context from which it emerges. Keywords: Populism, Neoliberalism, Representation/Immanence. Metodo e percorso L’intento di questo saggio è di problematizzare la dicotomia apparentemente ovvia liberalismo e populismo ed evidenziare il legame a doppio filo che stringe oggi le due polarità e le trascrive entrambe nel registro del tramonto della logica rappresentativa in un immanentismo in senso lato estetico (insieme spettacolare e immediatamente sensibile) di forme di vita e di potere che presumono di presentarsi e agire senza mediazione. D’altronde, anche la coppia concettuale populismo/neoliberalismo, che si presenta enfaticamente come oppositiva - iper-politica/spoliticizzazione -, rivela una paradossale specularità che ci costringe a ripensare il populismo del ventunesimo secolo al di là delle tradizionali categorie nelle quali è stato inquadrato e a ricondurlo al contesto neoliberale dal quale emerge. Tradizionalmente le teorie liberali e la stessa liberaldemocrazia si definiscono oppositivamente rispetto ai fenomeni populisti e a quella che si chiamava un tempo psicologia delle masse o fenomenologia psicosociale dei regimi totalitari. Facendo leva su un soggetto individuale pieno, autonomo e responsabile di sé, che autorizza e delega un potere sovrano, a condizione di legittimarne le decisioni attraverso criteri di convenienza e/o argomentazioni razionali, questa rappresentazione teorica si definisce ritagliando i suoi tratti sullo sfondo contrastivo del fenomeno populista: potenza del legame sociale inconscio fondato su meccanismi di identificazione e idealizzazione, dinamiche “irrazionali” (come si usava definirle) di grandi masse anonime e al proprio interno disarticolate, che superano l’impotenza dei singoli attraverso l’appartenenza, identità individuali deboli suggestionabili e manipolabili, inclini al conformismo. L’opposto della democrazia procedurale tanto di quella razional-deliberativa che di quella aggregativa e utilitaristica. Un fenomeno dunque, quello populista, da gestire con la diffidenza preoccupata di chi vede in esso degradarsi la “natura umana” e il soggetto individuale oltre che, ovviamente, veder minacciato il proprio primato di élites1. L’accusa di antipolitica e di deriva plebiscitaria tradisce l’ansia e l’animosità verso coordinate poco controllabili (prive di accountability) che la teoria politica liberale aveva espunto dal discorso. Le cruciali osservazioni di 1 Dell’amplissima recente letteratura sul tema cfr. in tal senso Mény, Surel 2001; Taguieff 2003; Urbinati 2013 e 2014; M. Ciliberto 2010; in senso critico rispetto alla idealizzazione della democrazia rappresentativa che non mantiene le sue promesse, J. Mc Cormick 2014. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 25 Laura Bazzicalupo DOI: 10.1400/228739 Freud in Psicologia delle masse e analisi dell’io2, restano peraltro ancora oggi un supporto forte della diagnosi che sembra puntualmente confermato dall’esperienza: la identificazione collettiva nel leader è maggiore quanto più debole è il processo di identificazione del singolo e la corretta formazione edipica. E, oggi il percorso di soggettivazione individuale, molto diverso da quello del primo Novecento che vedeva solo le prime crepe del meccanismo edipico (interdetto del desiderio e castrazione simbolica che strutturano il soggetto e ne avviano la sublimazione/identificazione in valori e identità che lo trascendono), è giunto a completa disarticolazione, spiazzato com’è da una soggettivazione narcisistica dove la pulsione al godimento sembra prendere il posto del desiderio antropogenico. Una soggettivazione narcisistica che procede per associazioni e contagi metonimici piuttosto che attraverso idealizzazione metaforiche. Andrebbe considerato peraltro nel nostro discorso, quanto questa rappresentazione narcisistica/edonista e consumista sia messa in mora dal contestuale governo delle vite spinte all’empowerment incessante e, nella attuale crisi, costrette a valutazioni e autovalutazioni molto umilianti. Non si tratta evidentemente di colorire la indispensabile analisi antropologica con qualche categoria psicoanalitica. La premessa teorica della mia analisi è la presa d’atto che la interrogazione sul soggetto individuale e collettivo della fenomenologia populista, se vuole afferrare il senso della mutata temperie sociale e culturale, è costretta a misurarsi con la sua attuale declinazione fortemente anti-dualistica, anti-rappresentativa, estranea alla liberaldemocrazia classica che, per esempio, Urbinati difende. Questo soggetto intreccia in modo indissolubile vita esistenziale e forme, corporeità del vivente umano e contesto istituzionale simbolico e linguistico: il soggetto, oggi, è forma del corpo vivente, forma di vita3. E inevitabilmente, l’inconscio, grande protagonista delle dinamiche populiste - al di là delle persistenti ritualità formali del soggetto moderno, Stato e individuo - viene a svolgere un ruolo di protagonista, essendo contemporaneamente vitale e simbolico, luogo in cui pensiero e immaginario conservano una densità materiale e desiderio e godimento forniscono i moventi del vivente umano, tra soglia biologica e contestuale intreccio culturale. Mi si perdoni questo breve excursus metodologico-filosofico, ma la prospettiva nella quale mi pongo per pensare il nuovo populismo del XXI secolo affonda in questa rivoluzione culturale profonda - così profonda da agire nella prassi al di là del persistere di categorie tradizionali che separano ragione e irrazionalità, corpo e anima - che vede tramontare, non teoreticamente ma nelle pratiche, la dicotomia tra forma e esistenza vivente. Esito estremo di una curvatura biopolitica della vita che spinge verso una sua radicale (ancorché molto problematica) naturalizzazione. L’effetto di questa curvatura è che l’intero regime della rappresentazione, la sua logica di identificazione dualistica e fondata sul trascendimento delle pluralità, logica che regge il politico e ne determina la pensabilità - viene messa in crisi, nelle pratiche, con effetti dirompenti sulla coppia rappresentazione-rappresentanza della politica4. Per la logica moderna, nel doppio fondo della rappresentazione unitaria del popolo si apriva lo spazio per l’antagonismo che è strutturale in ogni gruppo sociale, così come, per la psicoanalisi, nel soggetto si cela la fantasmizzazione di un residuo “reale”, una non coincidenza che fa attrito con la pienezza dell’Io. Se oggi si dichiara il venir meno di questo doppio fondo, si priva l’apparire (il presentarsi collettivo o individuale sulla scena comune) di questa feconda opacità, che è lo spazio della mediazione riflessiva. A questo livello “radicale” si pone la questione del populismo oggi e a questo livello, esso incontra, a mio avviso, il suo limite. Come conseguenza di questa dislocazione della questione al livello di una presenzializzazione anti-rappresentativa - assai più che nel vecchio populismo - si profila una pesante contraddizione teorica, perché definire il popolo del populismo significa nuovamente e inevitabilmente pensare un universale e adottare la logica classica e moderna della rappresentazione e così mancare il bersaglio. E allora? In realtà il populismo è una pratica e concentra la sua specifica natura proprio nel rifiuto esplicito e diretto dell’elaborazione intellettuale ed elitaria, del lavoro della mediazione riflessiva5. 2 Freud 1989; cfr. Tarizzo 2012. 3 Cfr.A. Badiou 2013, che sintetizza l’aspetto filosofico che accomuna, su questo terreno filosofi molto diversi (Bachelard, Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, Foucault, Lyotard, Derrida, Nancy, Lacoue-Labarthe, Rancière, e lo stesso Badiou). Ma, paradossalmente, su una naturalizzazione spinta dell’umano converge da tutt’altra tradizione anche la scienza cognitivista anglosassone. 4 Mi permetto di rinviare a Bazzicalupo 2010, 2013a. 5 Diverso, a mio avviso, il popolo di J. Ranciere che non può in alcun modo essere pensato attraverso la dinamica egemonica del populismo; condivide però il radicale rifiuto ugualitario del ruolo delle élites (Ranciere 2007 e 2008) 26 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228739 Laura Bazzicalupo E’ possibile? Con quali limiti si profila una pratica (non solo quella populista, ma anche di alcune sperimentazioni di autogestione partecipativa) irrappresentabile e contraddittoria dal punto di vista teorico? Le tappe del nostro discorso passano per il parziale recupero della diagnosi di alcuni sociologi liberal degli anni Sessanta Settanta, che ha il merito di andare alla radice antropologica del problema, focalizzando il ruolo attivo del cittadino democratico nel successo dell’appello populista - ruolo attivo che ci permette di tematizzare l’altro capo della relazione speculare, la logica neoliberale, in quanto sarà esaltato nelle soggettivazioni centrate su libertà e autogoverno - e che si riflette nel profilo dello stesso leader, mutato rispetto alla dinamica classica del populismo. Il paradigma di Ernesto Laclau ci fornisce, poi, una persuasiva descrizione della modalità retorica e contingente con cui, in tempi post-fondazionali, l’attore politico leader forma il messaggio populista, caratterizzato dalla relativa indifferenza del contenuto del messaggio, evidenziandone così il rischio nichilista. Significativo, a mio avviso, in questa dinamica il ruolo della credenza e della fiducia - elemento, anch’esso, strettamente speculare alla tecnica governamentale neoliberale che trova la sua norma di organizzazione sociale nell’equilibrio del mercato, incrocio instabile di aspettative e di credito. La credenza, in luogo della mediazione riflessiva, rinvia al tema che abbiamo proposto come cruciale: una soggettivazione che rifiuta la mediazione sia quando si colloca in posizione di totale antagonismo, sia quando sussume “la nazione” nel consenso al governo. La conclusione mette a fuoco il limite di una rappresentazione/ presentazione che si risolve nella persona fisica del leader, evidenziando la contraddizione tra l’esigenza non sottovalutabile di più rappresentatività e più democrazia e azzeramento del conflitto e spoliticizzazione, contraddizione dalla quale il populismo è lacerato. Fenomenologia del populismo: la diagnosi antropologica E’ netta la distanza del populismo del XXI secolo da quello tradizionale, che si riferiva a ideologie e movimenti storicamente identificabili, dal populismo russo a quello americano del Popular Party o al peronismo argentino, per non parlare della dimensione populista dei grandi movimenti novecenteschi ad esito totalitario (Canovan 1981). Se i partiti delle “nuove destre” ancora oggi aggregano il loro popolo attorno a rivendicazioni nazionaliste e regionaliste ostili all’immigrazione, si delineano forme nuove di populismo (cfr. Ignazi 2000; Mastropaolo 2005): innanzitutto dallo stile populista vengono contaminati tutti i messaggi politici, per la inevitabile attrazione che la logica populista esercita su tutte le forze in campo al fine stesso di poter resistere alla sua penetrazione; la fenomenologia, poi, si distende tra populismi antigovernativi, che convogliano uno scontento generico e antiideologico su temi interclassisti; e populismi paradossalmente “di governo”, che intendono modernizzare, cambiare anche radicalmente l’assetto giuridico e economico e fanno leva sullo scontento contro la vecchia classe dirigente che ha perso, per gestire il consenso senza dover contrattare e mediare con le minoranze. Se nuovo è il populismo, nuova è anche la forma del liberalismo che oggi trionfa “senza alternative” nella governamentalità neoliberale: tecnica di governo strutturata attorno ad una logica economica che si estende all’intera vita sociale e privata e alle istituzioni politiche stesse, dissolvendo in quest’ultime la solidità identitaria e lanciando tutti gli agenti pubblici e privati in una competizione infinita. Neoliberalismo libertario e anarchico che comporta paradossalmente un principio d’ordine tanto severo quanto irresponsabile - non ascrivibile ad una decisione sovrana - ma di volta in volta definito dal mercato, topos inclusivo ed acefalo di veridizione della democrazia, criterio ultimo che a sua volta si fonda sull’intreccio cieco delle aspettative e delle credenze circa le future preferenze della domanda (Bazzicalupo 2013b). Se il populismo cambia e, come vedremo, si fa labile e larvatamente nichilista, non può non essere in relazione con un quadro di organizzazione del sociale così mobile e instabile, così fluttuante e, ciò nonostante, né lieve né poco oneroso. Entrambi i poli della dicotomia liberalismo-populismo sono dunque cambiati e sono solo parzialmente valide le diagnosi sociologiche degli anni Sessanta-Settanta (penso a Riesmann, a Sennett e alla sua disputa con i francofortesi o, più di recente a Lasch), attestate su quella contrapposizione. L’interesse che esse ancora suscitano dipende da fatto che mettono a fuoco l’antropologia psico-sociologica che muove la dinamica populista, e in essa individuano precocemente quello che diverrà, nella fase attuale della governamentalità neoliberale, un tratto Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 27 Laura Bazzicalupo DOI: 10.1400/228739 innovativo6: il coinvolgimento di soggetti attivi che smentisce la grande diagnosi sociologica di Tocqueville e la sua fulminante analisi del dispotismo dolce (Tocqueville 1835-40). Viene confermata invece la tocquevilliana debole strutturazione dell’ideologia attorno a cui si incardina il consenso populista - a fronte della potente carica ideologica dei movimenti totalitari strutturati attorno ad una “verità” etnica o di classe che generava una rappresentazione forte e idealizzata (alla Freud) del leader/eroe carismatico, compensativa dell’impotenza di masse frammentate ed atomistiche: matrice di un populismo organico, stabile, contraddistinto da forti pulsioni paranoiche di esclusione dell’altro7. E’ esattamente l’identificazione ideologica forte che viene meno nella realtà contemporanea post-ideologica. Per la sociologia cui ci stiamo riferendo, la matrice antropologica è genericamente un individualismo esasperato: quell’ipertrofia dell’individualismo che perverte il tema, carissimo alla cultura liberale, delle differenze, dell’autorealizzazione e della responsabilità in direzione del disconoscimento del bene sociale. La diagnosi, tutta interna alle categorie moderne, contrappone l’estetizzazione della vita (singolarizzazione, inconfrontabilità, emozionalità) alla dimensione etica e relazionale: piuttosto che di manipolazione del consenso si può parlare di dinamiche di marketing elettorale che assecondano e amplificano desideri e fantasmi esistenti. Si fa problematica la classica accusa del populismo come rivoluzione passiva, effetto del dispotismo dolce e del nuovo biopotere pastorale. Rispetto al conformismo e la pastoralità di Tocqueville e dello stesso Riesmann ancora validi fino agli anni sessanta, Sennett, già negli anni Settanta sottolineava la spinta alla differenziazione attiva e disegualitaria implicita nel ripiegamento individualista nel privato, nella valorizzazione delle emozioni e in una forma di realizzazione del sé esposta, a suo avviso, a quello che allora era il tema predominante dell’analisi sociale: la colonizzazione della società dei consumi. L’attiva partecipazione dei governati a quello che Sennett, in modo tranchant, chiama «il proprio degrado» è solo parzialmente compatibile con la ambivalenza delle soggettivazioni neoliberali: Foucault ne sottolinea infatti lo scardinamento della autorità e autorevolezza dei pastori (salvo poi dover affidarsi al management dei tecnici e degli esperti) e il desiderio di essere “meno governati”: desiderio di autogoverno ben più attrattivo per i soggetti liberi e liberali (Foucault 2005) e ben più prossimo, aggiungiamo noi, all’istanza democratica di partecipazione attiva al governo di sé. Sennett correla la privatizzazione della vita - che sarebbe forse meglio pensata come una reciproca porosità di privato e pubblico - con uno specifico, nuovo meccanismo di identificazione del leader. Questa intuizione è persuasiva e degna di essere raccolta e sviluppata. L’indifferenza verso la idealizzazione ideologica segnala infatti un tipo di influenza non autoritaria/autorevole, ma - come emerge dagli studi di Tarde sul pubblico- orientata dai meccanismi di associazione e imitazione tipici delle scelte di consumo e che si estende alla scelta del leader (Clark, Tarde 2010; cfr. anche Lazzarato 2008). Il marketing elettorale si piega a questa preferenza anti-ideologica e la valorizza nella comunicazione politica insistendo su quanto esteticamente (cioè sensibilmente e, insieme, spettacolarmente) “attrae”: il vivente concreto, la personalità, il gesto e lo stile del personaggio che si propone. Il deficit democratico non è dunque ascrivibile a una sottocultura cognitivamente debole, ma alla “superficialità” della costruzione del soggetto, che non mobilita il meccanismo di sublimazione idealizzante: superficie estetica che viene esasperata dalla spettacolarizzazione della politica. Emergono così, a margine di questa diagnosi, i primi tratti del mutato processo di soggettivazione che verrà sostenuto dalle tecniche di governo neoliberale e l’ambivalente radicalizzazione della spinta tutta moderna alla libertà differenziale che, estremizzandosi, finisce col coincidere con l’irripetibilità ed unicità del corpo vivente proprio, del desiderio singolare di ciascuno e dunque nel rifiuto della logica rappresentativa8. Questa radicalizzazione è origine della ambivalenza dello stesso populismo, che assomma senza risolverla la contraddizione di più autogoverno di ciascuno, più partecipazione di ciascuno e eteronomia di tutti in una singola voce e presenza 6 Cfr. il liberal D. Riesmann (2009), che rilancia la tocquevilliana diagnosi di conformismo di massa; mentre in R. Sennett (1982) questa passività viene contestata; il conservatore e comunitarista C. Lasch, (in La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia (2001), in particolare il saggio Comunitarismo o populismo?, pp. 80-97) si pone dalla parte delle ragioni del popolare/populismo, populismo erede di una domanda di legame forte tra cittadini e classe politica contro l’intellettualismo. 7 E’ un classico Brzezinsky 1956; Germani 1975. 8 F. Nietzsche è al centro di questo processo per il quale l’emergenza dal flusso del divenire sarà performativa ed estetica, esperienziale: il pensiero si vive; cfr., la metafisica estetica già in La nascita della tragedia., e il ritornare sulla grande ragione del corpo in Così parlò Zaratustra (Nietzsche 1964). 28 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228739 Laura Bazzicalupo fisica. Il processo di soggettivazione, che diventa così lo scenario vero della politica, ha luogo nel punto di incrocio della potente istanza di autogoverno dei poteri nella loro individualità e differenza, con la logica modale, economica ed inclusiva della governamentalità, ostile ad ogni limite e dunque ad ogni confine strutturante dell’identità. Questa modalità strategica potenzialmente illimitata nei campi di applicazione e che organizza il sociale tutto, attraversa i soggetti incidendo sui processi di identificazione che non si realizzano attraverso la sublimazione in un valore o legge comune, ma sono lasciati a una imitazione/competizione orizzontale, metonimica, reattiva e contingente, senza trasformazioni dialettiche e “profonde”. E letteralmente “superficiale”, di superficie e di contatto prossemico (per lo più trasmesso attraverso social network) si fa la partecipazione populista. Di superficie, retorica, problematicamente priva di radicamento è la stessa linea antagonista che aggrega le diverse posizioni singolari “contro” un nemico. Se, come Lacan già affermava (Lacan 2006, 2011), l’ordine simbolico inteso come corpus di verità “oggettive” rivela la sua inconsistenza e contingenza e perde la funzione di radicare la idealizzazione identitaria, allora la credenza stessa, matrice dell’autorità, si muove in modo metonimico, imitativo, per giustapposizione, senza grandi metafore che determinino la produzione positiva del senso. Nella governamentalità neoliberale, ciascuna singolarità è lasciata alla propria indeterminatezza, che viene vissuta positivamente come una variabile aperta alla propria realizzazione della quale è responsabile. E ciascuna singolarità, nel segno della ottimizzazione, non nega, ma ripete e fissa la matrice vitale. Scegliendo esattamente quella variabile potenziale che il capitalismo, che offre il codice di valutazione, “valorizza”: e in questo modo ciascuna singolarità libertaria entra per via autonoma nell’eteronomia paradossale del sistema. Questo processo lasco, indeterminato e destrutturato si riflette sulla configurazione del leader. Questi evidentemente non riproduce l’identificazione paterna, tipica di tutte le forme di “autorità”: il focus si sposta dai contenuti idealizzanti alla credibilità personale del leader, in quanto vivente che “valorizza” se stesso. Questa valutazione di credibilità o credito ci rinvia, per significativa similitudine, a quella messa in opera dal sistema del mercato dei prezzi azionari, che in fondo non è altro che una agenzia di distribuzione e messa a frutto del “credito”, inteso come potenzialità di convincere la domanda. Il focus neoliberale infatti è concentrato sul vivente come capitale umano nel quale investire, nel quale credere. Il leader politico piuttosto che per il weberiano “dono della grazia”, cioè l’aura sacrale, l’eroicità, le eccezionali doti di orientamento e progettualità - è valutato, in una prospettiva assolutamente biopolitica, in base alle qualità mediane-mediocri che permettono complessivamente, a occhio, di “fidarsi”, di riconoscersi nel leader immediatamente leggibile nello stile visibile dell’abbigliamento, quello suo o quello della moglie, o nella rassicurante somiglianza del linguaggio da strada, che lo rende imitabile: estetica che fa premio sull’analisi ponderata di un provvedimento, per esempio, sulla tutela dei diritti del lavoratore9. Ma su questo paradossale carisma del quotidiano e sulla concretezza presunta della vita a fronte della astrattezza impersonale delle istituzioni, torneremo nelle conclusioni. Il ruolo della credenza, del credito e della sfiducia: l’antirappresentatività Se affrontiamo la trasformazione dall’altro capo del discorso, non facendone solo l’esito dell’individualismo esasperato, troveremo lo sgretolamento del capitale sociale dei partiti di massa dei quali si erode definitivamente la capacità di dare forma alle aspettative condivise e di generare appartenenza (Revelli 2013). Ma anche il fallimento di questa decisiva funzione di mediazione e organizzazione dell’orizzonte interpretativo dei cambiamenti sociali in atto rinvia, al di là delle conclamate incapacità della politica convenzionale, alla trasformazione epocale della logica di organizzazione del sistema che lo rende sempre meno comprensibile e controllabile. Anche da questo lato agisce quella logica economica che già abbiamo chiamato in causa: illimitata e non definibile nel suo oggetto, tarata sulle valutazioni del capitalismo finanziario che, come si è detto, oscillano nell’equilibrio instabile dei vettori di credito e di previsione. I quali devono a loro volta rimanere ciechi all’orientamento complessivo futuro 9 A differenza da quanto pensava M. Weber (2012) la persona carismatica oggi non emerge da un antagonismo ideologico e sociale irrisolubile ma, nonostante l’apparenza di esagitata contrapposizione, è un agente di pacificazione politica (R. Sennett op. cit., p.332) dove l’attrattività subordina possibili divisioni sociali e elude lo scontro proprio radicalizzandolo. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 29 Laura Bazzicalupo DOI: 10.1400/228739 (al senso, nella doppia accezione del termine) del mercato, pena interventi nella sua autoregolazione tramite la concorrenza, che ne altererebbero la corretta dinamica. In un mondo dove la politica (che nella modernità, è progettualità e costruzione di senso collettivo) si autoriduce - con un gesto assolutamente politico, si badi bene - alla custodia attiva delle leggi della libera concorrenza e al ripristino forzoso delle condizioni di cecità dell’insieme, secondo i dettami del marginalismo monetarista di Chicago, la imprevedibilità e opacità dell’economia neoliberale si riverbera sull’orizzonte progettuale di senso e di riflesso sulle vite dei singoli, rendendo opachi, dispersivi i piani di vita: su questa incertezza che genera credenze effimere e labili in una realtà che pure gravita tutta sulla credenza, si ha il doppio innesto delle reazioni antipolitiche e della identificazione populistica con un leader. Rosanvallon considera proprio la s-fiducia il movente costitutivo e in parte fisiologico dell’antipolitica populista. Essa è effetto dello smarrimento di fronte a processi globali inediti che la rappresentanza non sa interpretare e ricondurre ad un senso riconoscibile e chiaro e che viene delegato alla scienza e ai tecnici della società del rischio10. Andrebbe presa in senso letterale questa suggestione: il circuito perverso di cinismo incredulo, impotente e credulità superficiale, labile conferisce al segmento fiducia-credenza-credito, nella nostra post-secolare società, un ruolo decisivo nel sopperire agli orizzonti programmati e progettuali (contrastivi del gioco concorrenziale), alle mediazioni argomentative e istituzionali controllabili e perciò politicamente gestibili. E’ proprio questa dinamica di controllo e di intervento che il capitalismo finanziario e il neoliberalismo che su di esso si struttura considerano una pericolosa forzatura della dinamica dei prezzi che autonomamente regola l’insieme attraverso la pura e semplice interdipendenza dei segnali (i prezzi) che ciascun agente invia, dunque del capitale di credito di ciascuno di essi. L’antipolitica riflette l’impossibilità strutturale di comprendere e dare senso globale e collettivo ad una realtà di interdipendenza economica “necessariamente” congetturale ed opaca, che però ha la forza di determinare le vite, la loro incertezza divorante e, attraverso la competizione ad oltranza, lo slegame sociale (de Caroli 2014). Da parte loro, poi, le differenze reclamano visibilità, manifestazione di sé, del proprio potere e potenzialità vitale da valorizzare sullo scenario della generale competizione: la temperie neoliberale, che esercita grande fascino e consenso, si concentra sulla liberazione dal governo eteronomo dello Stato paternalistico che “sa” quale sia il fantomatico bene comune, estraneo se non opposto alla potenzialità che ciascuno vuole esprimere direttamente, senza mediazioni. L’irruzione del bios (e nel bios va incluso, per la nostra piccola premessa metodologica, il privato degli interessi con la sua strutturazione simbolica e con i suoi fantasmi) scompagina l’organizzazione sociale, svuota le mediazioni che vengono percepite come oppressivo tradimento della concretezza delle vita. Dal punto di vista degli effetti, si determina una paradossale eteronomia che genera sofferenza. La governamentalità neoliberale immette dunque un principio organizzazionale all’interno dell’anarchia che essa stessa ha potenziato: un principio di gerarchizzazione tanto più severo in quanto è un criterio valutativo - la legge della competizione presunta naturale - che responsabilizza ciascuno del proprio successo o fallimento. La capacità personale e il credito delle prestazioni attese funge da unica, flebile bussola in un mondo complesso, atonale come lo definisce Badiou (2006), privo di indirizzo identificabile, contro il quale lottare; un incrocio instabile delle aspettative fiduciarie di tutti i competitors, del quale sfugge il senso. Nessuno sa interpretarlo e renderlo prevedibile, né partiti, né sindacati, né Stato: è screditata qualunque progettualità politica che non sia adattiva. Da questa impotenza strutturale a conoscere l’andamento delle cose - che a sua volta genera e legittima l’utilizzo sistematico dei dispositivi di emergenza, di problem solving sospensivi delle lungaggini della deliberazione democratica - deriva il ripiegamento risentito e privatistico che, per Rosanvallon, risuscita la omogeneità immaginaria del popolo, solo ed esclusivamente nella sua dimensione negativa, oppositiva. Questa opposizione lascia in ombra significativamente il momento costruttivo, che sarebbe divisivo e probabilmente indecidibile: non vengono messi in opera progetti comuni, che richiederebbero, appunto, un orizzonte stabile di previsioni. Solo, come abbiamo detto, programmi di adattamento ottimale. Perciò si formano grandi coalizioni consociative che distruggono definitivamente la mission dei partiti di fornire orientamento, sfiduciando ulteriormente la rappresentanza. Non resta che l’espressione e la manifestazione. Cosa significa questo? La credenza funziona a breve, non va oltre la visibilità diretta: l’attribuzione di credito personalistico risulta 10 P. Rosanvallon 2012; cfr. anche D. D’Andrea 2014, che dalla sfiducia muove per il ripensamento delle forme rappresentative. 30 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228739 Laura Bazzicalupo la più adatta a questo oscuramento delle ragioni costruttive di aggregazione. Si totalizza così lo scontento, ma si annullano le presumibili divergenze che emergerebbero in relazione ad un programma, per esempio politicoeconomico. Il popolo assume una identità reattiva, congiunturale, aggregata da uno stimolo e pronta a disgregarsi rapidamente. Viene in evidenza il suo tratto dominate, la ragion d’essere che salda la credenza alla diretta e variabile posizione dei singoli: l’ostilità alla rappresentanza, alla mediazione stabile che, per la incertezza dei dati, non è credibile, e lo spostamento del patrimonio di credenza su un corpo vivente il più possibile simile a se stessi. Identità reattiva significa anche soggettivazione consapevole e attiva, non passiva, presenzializzata nell’evento: tutta tesa, attraverso l’abbattimento delle ossificate élites di potere, ad una rapida identificazione del proprio indeterminabile Sé, tesa ad un espressivismo politico che nella persona del leader trova la via breve per passare all’atto. L’apparire e il presentificare - la dimensione estetica che prende il posto del processo etico-dialettico sostituisce la rappresentazione e ne oscura quello scarto temporale e mediativo che era decisivo per la politica progettuale. Intendiamoci: questo corto circuito reattivo conserva un tasso di politicità11 che viene ingiustamente negato dalle diagnosi liberal-democratiche; anzi, sarebbe più esatto dire che genera un surplus di politicità perché la sua disposizione negativa e critica, denunciando il deficit di rappresentatività delle élites, custodisce in modo contraddittorio una istanza democratica non sottovalutabile: la richiesta di più partecipazione politica e più rappresentatività che il populismo porta avanti e che poi clamorosamente tradisce. Il populismo, dice Taggart, è un «metro per misurare la salute del sistema politico rappresentativo» (Taggart 2002): forse, più radicalmente, è un segnalatore della erosione della logica rappresentativa che è, a mio avviso, il punto nodale del problema e che rifluisce in una presenzialità estetica. Ciò che entra davvero in crisi è la mediazione, la mediazione riflessiva che la stabilizzazione della rappresentanza permetteva e che risulta “lenta”, inefficace e inespressiva rispetto ad una perpetua instabilità emergenziale. Contingenza e nichilismo nella logica populista: il limite dell’espressivismo politico Il populismo, ci dice Laclau che rilancia esattamente quel plus di politicità, è la costruzione politica del soggetto popolo, che procede raccogliendo e coagulando sotto un significante egemonico, domande sociali differenti, domande che vengono rese intercambiabili ed equivalenti (Laclau 2008). Il popolo populista non è dunque un agente storicamente determinato, come potevano pensare ancora Marx e lo stesso Gramsci: nella cultura post-fondazionista (o più semplicemente postmoderna) cui il modello laclausiano si riferisce, il popolo non esiste prima della sua costruzione egemonica e retorica. E’ l’azione politica comunicativa ed espressiva che lo nomina e in modo performativo ed evenemenziale lo fa esistere, incarnandolo contemporaneamente nella persona vivente del leader. Il concetto gramsciano di egemonia ne evidenzia il carattere strategico e costruito, culturale e sovrastrutturale (Laclau, Mouffe 1985). La logica egemonica infatti aggancia l’immaginario. «Si richiede inventiva e immaginazione politica. [....] La dislocazione capitalista rivela, spietatamente la contingenza della vita sociale, il suo carattere costruito, la sua articolazione politica: cioè egemonica. [...] Egemonia significa primato di una alleanza, di una catena di equivalenze, con leadership culturale che forma un nuovo terreno ideologico, un nuovo spazio per il mito, per l’immaginario comune» (Chritchley 2008:118). La efficace analisi di Laclau, che peraltro mira a sottrarre il populismo alla condanna della tradizione liberale, per evidenziare in esso i caratteri di una istanza democratica e politica da preservare e sviluppare, sottolinea che se la politica democratico-populista opera polarizzando retoricamente lo scontento (il torto) e costruendo l’equivalenza lungo una linea di antagonismo al potere dominante, l’antagonismo populista non si struttura attorno ad una verità “oggettiva” come poteva essere lo sfruttamento di classe ancora operante in Gramsci, ma mostra una contingenza congiunturale. Per il populismo è possibile addensare lo scontento su un qualsiasi battaglia comune: dalla insicurezza alla condanna moralista dei corrotti, dal rifiuto della responsabilità sociale fiscale all’odio verso lo straniero, dal risentimento contro la casta e contro gli intellettuali all’esaltazione della partecipazione collettiva; meglio: il populismo trova la sua bandiera in significanti “vuoti” come libertà, o popolo, trasparenza o giustizia. Il carattere vago e retorico non è una semplice costatazione sociologica ma è esattamente un requisito del significante padrone - significante vuoto - che, 11 C’è politica nell’antipolitica e rovesciamento dell’antipolitica in iper-politica : cfr. Mastropaolo 2005. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 31 Laura Bazzicalupo DOI: 10.1400/228739 per Lacan, regge la catena dei significati, fornendole (in modo simile alla dinamica sovranità/stato d’eccezione, interno e esterno all’ordine che viene costituito12) l’eccezione o eccedenza che la rende possibile. L’efficacia della costruzione egemonica del popolo populista viene a dipendere da una funzione discorsiva in sé vuota e indeterminata, che è in grado di organizzare la sequenza delle equivalenze perché, pur essendo un particolare interno alla catena stessa, è irriducibile ad un significato specifico. Mi soffermo su questa logica del significante vuoto, eccezione interna-esterna, proposta dal politologo argentino, perché è la stessa logica applicabile nella scelta del leader. Il leader è una persona come tutti, interna al gruppo, eppure svolge, rimanendo tale, la funzione di organizzatore dell’insieme. In ogni caso, si evidenzia la natura retorica, mediatica della logica populista, il suo fondo nichilista di intercambiabilità tra destra e sinistra. Il meccanismo populista, al di là del paradigma laclausiano, non argomenta: presenta, attraverso una parola d’ordine, la protesta, ne rivendica la concretezza anti-intellettualistica e antirappresentativa, e perciò la incarna in una persona fisica vivente tra i tanti, una eccezione interna. Unicità del vivente nel quale il passaggio dai molti all’unità si coagula in un precipitato concreto: un unico che è tutti, uno come tutti, con la stessa rabbia, la stessa debolezza, la stessa minacciosa potenza: solo più espressiva e meglio espressa. La voce del leader presentifica risentimento e ansia, ma allo stesso tempo, rende impossibile ascoltare la complessità differenziale delle voci: le esibisce nella loro presunta immediatezza, opponendo alle astrattezze istituzionali un mondo in cui tutto si vede, tutto è trasparente, aperto come una scatola di sardine, e visibile nel corpo esibito del leader, che per questo esibirsi stesso conferma la fiducia nella sua autenticità espressiva. Ripeto: in questa esibizione del popolo - tutto in uno - non tutto si vede. Si cancellano le zone di ombra o che farebbero ombra: la differenza dei progetti e delle situazioni in una realtà che sappiamo gerarchizzata e diseguale. Ciò che viene messo in scena è paradossalmente «la revoca della sfera di apparenza del popolo. La comunità viene senza tregua offerta a se stessa. Il popolo non sarà più impari, incalcolabile, irrappresentabile. Sarà sempre totalmente presente e totalmente assente, interamente coinvolto in una struttura del visibile in cui tutto si vede, in cui non esiste più un luogo dell’apparire» (Ranciere 2007:116). Quando viene meno la rappresentazione politica sempre incompleta del popolo, viene meno la possibilità della parte antagonista di “apparire” davvero, di fare cioè irruzione nella doppiezza della scena. La estrema totale visibilità distrugge «l’apparenza e le sue potenzialità». «Il regime dell’onnivisibile, [...] non corrisponde alla liberazione dall’apparenza. Al contrario è la sua perdita. Il mondo della visibilità globale predispone un reale in cui l’apparenza non ha modo di manifestarsi né di produrre i suoi effetti di raddoppiamento e di divisione. In effetti l’apparenza, in particolare l’apparenza politica, non è ciò che nasconde la realtà, ma ciò che la rende duplice, introducendovi questioni conflittuali» (ibidem). L’irrealismo postmoderno coincide con l’iperrealismo (Baudrillard 1981), con la pretesa di visibilità esaustiva, con il tacitamento delle conflittualità custodite dalla rappresentazione. Il populismo dunque, da una parte si sviluppa nell’alveo culturale della governamentalità neoliberale rispecchiandone il rifiuto dei sistemi istituzionali convenzionali e la spinta anti-rappresentativa, dall’altra nella pratica ricostruisce una soggettività del popolo, un noi in carne ed ossa, contro il loro della astratta e burocratica casta politica e contro il potere opaco e indeterminabile che gerarchizza ed emargina. In questo senso, tiene insieme la politica democratica radicalizzandone l’istanza dell’autogoverno e della partecipazione, con la manifestazione di un sé unitario e non conflittuale nella persona del leader; salda cioè la esigenza di più politica e di antagonismo con l’antipolitica. E proprio in questo contraddittorio movimento, ai margini della logica rappresentativa, incontra il suo limite. Cosa succede infatti quando il popolo coincide con la sua presentazione e totale visibilità senza residui nel “portavoce” che lo incarna? Il problema concettuale, l’impasse teorica del populismo che obbliga a trascriverlo nel registro delle pratiche, è il fatto che si tratta sempre e comunque di una moltitudine che viene presentata come una persona sola, una sola volontà senza conflitti e antagonismi interni: solo così può incarnarsi nel leader senza dover ricorrere alle mediazioni riflessive. Come è possibile l’unificazione di una realtà eterogenea, senza trascendimento e senza sintesi? 12 Il ricorso di Laclau a Lacan è motivato dalla struttura linguistica della psiche lacaniana riscontrabile anche nella linguistica di Saussure. 32 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228739 Laura Bazzicalupo La dinamica della rappresentazione era doppia, inevitabilmente creatrice di esclusioni e dunque di fantasmi e di potenziali conflitti all’interno del popolo stesso. La presentificazione invece toglie ogni ambiguità, il disaccordo è visibile, l’eventuale dissenso si vede: ma quando è visibile è già decretata la sua esclusione. La mossa egemonica populista sta infatti nell’escludere il disaccordo dalla rappresentazione-presentazione del popolo: lo colloca al di fuori, altro dal popolo, minoranza avversaria o ridicolizzata o addirittura criminalizzata. Non riconoscendo la doppiezza della rappresentazione e la dinamica dell’esclusione che crea fantasmi destinati a reclamare spazio e visibilità, l’iper-concretezza non genera fantasmi segreti; chi dissente è semplicemente fuori, pena l’implosione. Riprendiamo quanto avevamo detto: questa somma di singolarità che si fa popolo solo nell’azione egemonica performativa, non è sottoposta ad un processo di trasformazione dialettica come avveniva nell’identificazione idealizzata del modello freudiano. Queste singolarità si assimilano tra loro, contagiandosi orizzontalmente per contatto, per somiglianza, metonimicamente: sono un pubblico partecipe e attivo, interconnesso, sul quale si orienta e si modella il messaggio dell’attore leader. La relazione di identificazione subisce dunque una potente inversione: dalla alienazione in un leader che incarna un ideale, un mito, una missione, ad una influenza virtuale, vivida quanto labile. I singoli mantengono il proprio narcisismo, il proprio immaginario di auto-realizzazione e auto-gestione. Come la sociologia liberal aveva intuito, la persona del leader (costruita dai media come fisica, concreta, ma pur sempre “immagine” virtuale) non è “ideale”: incarna una corporeità comune per somiglianza. Lo scontento inespresso e irrappresentato, si fa presente in una figura alla portata di tutti, di facile immedesimazione che esibisce in modo marcato i desideri e i risentimenti di tutti. Niente sublimazione, né alienazione né sacrificio delle differenze nell’identità unitaria del popolo13. E’ il leader piuttosto che guadagna la sua credibilità perché imita, asseconda le immagini standardizzate del pubblico che emergono dalla rete, dai sondaggi che rispecchiano, nella mediazione statistica, identificazioni senza ombre, senza ambivalenze né fantasmi. Il capo non è un padre, un leader super-io che guida alla terra promessa, ma un fratello più fortunato, più dotato, più furbo, anche divertente, magari, un fratello che oggi, in una lunga crisi senza sbocco plausibile, assume il compito democratico di evidenziare la conflittualità, il dissenso: ma, nello stesso tempo lo monopolizza e lo svuota, negando ad esso l’articolazione di un progetto, di un orizzonte di senso alternativo verso cui muoversi. Dà voce alla protesta, alla istanza di partecipazione, di protagonismo e di incidenza politica: e dunque sembra assumere la mission della democrazia, ma, nella logica della immanenza schiacciata sul presente e sulla presenza, è il rispecchiamento amorfo del “mondo com’è”, del mondo che si autoproclama autentico contro la falsità dei giochi di potere della casta. E, in questa iper-visibilità non solo ignora le dissimmetrie, le complicazioni e il disaccordo, ma assorbe lo scontento e lo blocca senza elaborare alternative, senza il lavoro della mediazione riflessiva che organizzi e dia forma (rappresentazione, sempre parziale, sempre rivedibile) al sociale. Non c’è progetto politico, anche se il vento impetuoso di questo misto di diffidenza e credulità, di cinismo e fiducioso abbandono alla voce di qualcuno, spazza via le fragili e manchevoli istituzioni; e questa è politica: rischiosa, ma politica. Riferimenti bibliografici Badiou A. (2006), Il Secolo, Milano: Feltrinelli. Badiou A. (2013), Le avventure della filosofia francese. Dagli anni Sessanta, Roma: DeriveApprodi. Baudrillard J. (1981), Simulacres et simulation, Paris: Editions Galilée. Bazzicalupo L. (2010), Quando la rappresentazione politica rifiuta la politica, Il Mulino, 3, 2010. Bazzicalupo L. (2013a), Governamentalità, pratiche e concetti, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2:371-394 13 Il capo «deve limitarsi a possedere in forma particolarmente pura e incisiva le caratteristiche tipiche di questi individui e dare l’impressione di una maggiore forza e di una maggiore libertà libidica» (Freud 1989). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 33 Laura Bazzicalupo DOI: 10.1400/228739 Bazzicalupo L.(2013b), Politica. Rappresentazioni e tecniche di governo, Roma: Carocci. Brzezinsky C. F. (1956), Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge: Harvard University Press, Cambridge. Canovan M. (1981), Populism, London: Junction. Ciliberto M. (2010), Democrazia dispotica, in M. Bovero, V. Pazé (a cura di), La Democrazia in nove lezioni, RomaBari: Laterza. Clark T.N., Tarde G. (2010), On Communication and social influence. Selected papers, Chicago: Chicago University Press. Critchley S.(2008), Responsabilità illimitata, Roma: Meltemi. D’Andrea D. (2014), Ripensare la rappresentanza nell’epoca della crisi della rappresentazione, in L. Bazzicalupo (a cura di), Crisi della democrazia, Milano: Mimesis. Foucault M. (2005), Nascita della biopolitica, Corso al Collège de France 1978-79, Milano: Feltrinelli. Freud S. (1989), Psicologia delle masse e analisi dell’Io, in Opere, vol IX, Torino: Bollati Boringhieri. Germani G. (1975), Autoritarismo fascismo e classi sociali, Bologna: Il Mulino. Ignazi P. (2000), L’estrema destra in Europa, Bologna: Il Mulino. Lacan J. (2006), Del nome del padre, Torino: Einaudi. Lacan J. (2011), Il seminario. Libro XX. Ancora 1972-1973, Torino: Einaudi. Laclau E. (2008), La ragione populista, Roma-Bari: Laterza. Laclau E., Mouffe C. (1985), Hegemony and Socialist Strategy, London-NewYork: Verso. Lasch C. (2001), La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia (2001), Milano: Feltrinelli. Lazzarato M. (2004), La politica dell’evento, Soveria-Mannelli: Rubettino. Mastropaolo A. (2005), La Mucca pazza della democrazia. Nuove destre populismo e antipolitica, Torino: Bollati Boringhieri. Mc Cormick J.(2014.), Sulla distinzione tra democrazia e populismo, in «Micromega, il rasoio di Occam», http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it Mény Y., Surel Y. (2001), Populismo e democrazia, Bologna: Il Mulino. Nietzsche F. (1964), Opere, Milano: Adelphi. Ranciere J. (2007), Il Disaccordo, Roma: Meltemi. Ranciere J. (2008), Il maestro ignorante, Milano: Mimesis. Revelli M. (2013), Finale di partito, Torino: Einaudi. Riesmann D. (2009), La folla solitaria, Bologna: Il Mulino. Rosanvallon P. (2012), Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, Roma: Castelvecchi. Sennett R. (1982) , Il declino dell’uomo pubblico, Milano: Bompiani. Taggart P. (2002), Il populismo, Troina (EN): Città aperta. Taguieff P.A. (2003), L’illusione populista, Pearson Italia. Tarizzo D. (2012), Massa e popolo: Freud e Laclau, in M. Baldassarri, D. Melegari (a cura di), Populismo e democrazia radicale. In dialogo con Ernesto Laclau, Verona: Ombrecorte. Tocqueville A. (2007), La democrazia in America, II, (1835-40), Torino: Utet. Urbinati N. (2013), Democrazia in diretta: le nuove sfide della rappresentanza, Milano: Feltrinelli. Urbinati N. (2014), Democrazia sfigurata: il popolo tra opinione e libertà, Milano: Università Bocconi. Weber M. (2012), Economia e società. Dominio, IV vol., Roma: Donzelli. 34 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Mario Caciagli DOI: 10.1400/228740 [Le regioni rosse nell’Europa continentale] Un’epopea del Novecento Title: As an Epopee of the Twentieth Century: The Red Regions in Continental Europe Abstract: As a phenomenon of the XX Century, the few existed mass parties were capable to build territorial political sub-cultures. The cornerstone of the subcultures was the capacity to implant itself in specific regions. In Germany from the end of the XIX Century until the rise to power of the Nazis Red Regions were Thuringia, Saxe and Berlin under socialist hegemony, and then under communist influence too. The Red Region in Austria coincided with Vienna and was also destroyed from the fascist reaction. In France the Red Region was the banlieue of Paris, where the Communist Party was predominant from the ‘30 to the ‘70, when working class and communist subculture disappeared because the de-industrialization. The Red Regions in Italy have had a longer wife, because the different social classes of composition and different electoral support. Economic and social changes as the dissolution of the Soviet World have been causes of the end. Keywords: Red regions, Europe, XX Century. Subculture politiche territoriali e partiti di massa Non c’era nulla di nuovo in questo genere di subcultura di sinistra. In Germania e in Austria i partiti socialdemocratici avevano consapevolmente cercato di organizzare la vita sociale e culturale degli operai negli ultimi due decenni dell’Ottocento e in Italia, nel periodo precedente il fascismo, il Partito socialista aveva anch’esso dato vita a un gran numero di associazioni ricreative. La subcultura del PCI, tuttavia, differiva da queste ultime perché venne creata molto più tardi delle altre, quando ormai il loro periodo d’oro – che può essere collocato tra l’inizio del secolo e il 1914 – era finito da un pezzo. Dopo la seconda guerra mondiale in Germania e in Austria i partiti socialisti non tentarono nemmeno di ricostruire le proprie reti culturali come quelle dei partiti belga e olandese o del PCF furono per lo più una tarda prosecuzione di ben più solide esperienze prebelliche. Il PCI ha dunque creato l’ultima grande subcultura di sinistra in Europa: ed essa, in parte proprio per essere stata fondata più tardi delle altre, è stata anche la più duratura. Poiché coloro che la crearono furono sin da subito costretti a confrontarsi proprio con quelle sfide che avevano indebolito o disperso le altre subculture (si pensi alle comunicazioni di massa, all’industria culturale commerciale e alle attività ricreative e dopolavoristiche statali o gestite dalle aziende), essi furono in grado di rispondervi in maniera creativa e flessibile (Gundle 1995: 9). Questa lunga citazione dall’ottima ricerca di Gundle sul PCI, una citazione che mi consente di aprire un primo orizzonte comparato sulla natura e sulle sorti delle subculture politiche socialisti e comuniste in Europa, abbisogna tuttavia, per il discorso che svolgerò, di alcune correzioni. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 35 Mario Caciagli DOI: 10.1400/228740 Dal punto di vista della loro durata, la tedesca e l’austriaca ebbero sì le loro radici nella fase compresa fra l’inizio del secolo e la prima guerra mondiale, ma vissero in grande fulgore anche nel dopoguerra durante i turbolenti anni della Repubblica di Weimar e della neo-istituita Repubblica austriaca e lo fecero fino all’avvento dei regimi autoritari di destra. Non solo, ma nella Repubblica di Weimar nacque e prosperò una subcultura comunista, che Gundle non ricorda. Quanto a quella comunista formatasi in Francia negli anni Trenta sopravvisse, eccome, fino agli anni Ottanta del Novecento. Le ragioni della loro scomparsa furono diverse. Cercherò di spiegarlo più avanti, facendo ciò parte essenziale della mia esposizione. Se è vero, infine, che la subcultura politica che il PCI istituì è stata l’ultima in Europa, le ragioni sia del suo radicamento che della sua scomparsa differiscono a loro volta dai casi appena ricordati. Cercherò di spiegare anche questo. Inoltre, e soprattutto, occorre ricordare che Gundle si è occupato delle associazioni ricreative e della diffusione di una cultura in senso alto che i partiti di sinistra produssero o tentarono di produrre. Non era interessato, invece, alla cultura politica dei militanti, quella cultura dove rientrava certamente la gestione e la fruizione del tempo libero, ma che voleva dire anche forme di aggregazione e di sociabilità, sistemi di valori, riti e simboli, scelte di voto, strutture politiche. La struttura politica cardine delle subculture rosse delle quali qui si tratta era il partito, con le sue capacità di arruolamento e di mobilitazione, non solo elettorale. Questo partito era un partito di massa, come l’aveva definito Maurice Duverger in una classificazione rimasta insuperata a lungo fino al drammatico liquefarsi dei partiti alla fine del Novecento (Duverger 1951). Il partito di massa era appunto quello che aveva un gran numero di iscritti, si circondava di associazioni collaterali e accompagnava il suo membro in quasi tutte le forme della vita. Duverger non si era limitato a definire il partito di massa, gli aveva pronosticato un grande avvenire come la forma partito più elevata e dai migliori destini. Franz Neumann, a sua volta, tanto per ricordare un altro importante esegeta, ne avrebbe sottolineato, meglio di ogni altro, gli aspetti positivi: l’impegno degli iscritti a contribuire con le loro quote tanto alla retribuzione di persone qualificate, quanto al sostegno di attività permanenti, di agitazioni politiche e di battaglie rivendicative. Il partito di massa non era soltanto uno strumento per la competizione elettorale o per la selezione dei gruppi dirigenti della democrazia di massa. Lo stesso Neumann, mettendone in evidenza le funzioni di integrazione sociale, segnalava la sua capacità di fornire identità ai propri membri. Quel tipo di partito tendeva ad esercitare influenza in tutte o quasi tutte le sfere della vita quotidiana degli iscritti. Gli attivisti cercavano di arruolare e di coinvolgere una grande parte della popolazione, offrendo la possibilità di partecipare tutto l’anno ad una comunità, legata da disciplina e guidata da programmi basati sull’ideologia (Neumann 1968). Per l’organizzazione dei partiti di massa l’impianto territoriale era costitutivo. La gerarchia si articolava dal centro alla periferia, ma la dimensione locale non era derivata, era primaria. Tutte le attività e tutte le strutture rimandavano alla città, al quartiere, al villaggio - alla regione. Era sul territorio che si cementava la cultura politica: sul territorio si cristallizzava la memoria che quella cultura trasmetteva da una generazione all’altra. Alla fine del Novecento è stato possibile fare un bilancio. Un bilancio consuntivo implica un conteggio. Ebbene, il conteggio rivela che i veri e propri partiti di massa sulla scena politica europea sono stati in numero minore di quanto non si fosse ritenuto in corso d’opera e di quanto non si fosse pronosticato sessant’anni or sono. Sono stati, tuttavia, proprio e soltanto quei pochi partiti di massa che hanno dato vita alle subculture politiche territoriali, e che di quelle culture si sono nutriti. Che hanno dato vita alle regioni rosse in Europa1. Il partito di massa è stata la creatura e lo strumento delle culture politiche rosse. Quest’ultime, pur diffondendosi nell’intero territorio degli stati nazionali trovarono insediamento più vasto e più profondo in alcuni territori substatali. Gli stati dove più marcata la loro presenza a livello di specifiche regioni sono stati la Germania, l’Austria, la Francia e l’Italia. 1 Anche il cattolicesimo politico dette vita nel Novecento ad alcuni partiti di massa. Anch’essi, come tali, svilupparono culture politiche regionali: in Veneto, in Baviera e in Tirolo. 36 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228740 Mario Caciagli Le regioni rosse in Germania Gotha e Erfurt sono due città della Turingia. Nella prima si tenne nel 1875 il congresso che fondò il primo partito operaio tedesco. Nella seconda, nel 1891, fu tenuta a battesimo la Sozialdemokratische Partei Deutschlands, l’Urpartei, per dirlo nella sua lingua, cioè il “partito primigenio”, destinato a diventare modello e guida dei partiti della Seconda Internazionale, nonché a durare fino ad oggi. Insieme a indicatori più solidi queste due date fondative comprovano l’appartenenza della Turingia alle roccaforti della SPD, cioè alle regioni rosse dell’impero guglielmino e della Repubblica di Weimar. Se la Turingia era chiamata la “roccaforte rossa”, il “regno rosso” fu, fino al 1933, la Sassonia. Per quasi mezzo secolo percentuali di voto, tassi di iscrizione al partito e al sindacato, organizzazioni collaterali, case del popolo, cooperative di consumo, libri e giornali, biblioteche circolanti e circoli sportivi, teatri e altre istituzioni del tempo libero, organismi culturali, amministrazioni comunali, usi e costumi proletari nelle città e nei sobborghi industriali fecero delle due regioni l’espressione più solida della subcultura territoriale rossa in Germania (Walter et alii 1993). C’erano inoltre compagnie di ciclisti e di escursionisti, sezioni di giovani e di donne, centri per l’educazione scolastica e per il libero pensiero e naturalmente scuole di partito, unioni sportive di partito, funerali di partito. Come si diceva, il socialdemocratico veniva accompagnato dal partito “von derWiege bis zu Bahre”, “dalla culla alla tomba”. E l’esemplare socialdemocratico era un operaio (e un’operaia). La sua visione del mondo era quella marxista, almeno così si veniva conclamando. Le basi, con la prima espansione della subcultura socialdemocratica, intesa come un’isola rinchiusa in se stessa e opposta al regime dominante, vennero gettate durante l’Impero guglielmino. Ma, divenuta addirittura partito di governo, la SPD non rinunciò affatto alle sue aggregazioni subculturali durante la Repubblica di Weimar. Anzi. Se si considera l’espansione quantitativa, l’epoca di miglior fioritura della cultura operaia socialdemocratica non fu l’impero, ma la Repubblica di Weimar. Il mutamento di regime del 1918 non implicò un indebolimento delle “organizzazioni di controcultura”, ma, al contrario, al suo rafforzamento. Ulteriori organizzazioni operaie e socialiste vennero create dopo il 1919… Né le più antiche subirono una diminuzione di militanti, conobbero invece una enorme espansione (Lösche, Walter 1990: 161-187). Nella seconda metà degli anni Venti, con l’aria che tirava, anche i socialdemocratici crearono le loro squadre di difesa, i Reichsbanner e l’Eiserne Front. Le regioni dove la fioritura delle istituzioni della loro subcultura fu più intensa furono ancora la Turingia e la Sassonia, ma lo furono anche l’Assia e, soprattutto, Berlino. L’associazionismo socialdemocratico, che mantenne sempre un carattere di classe, per la natura dei suoi aderenti in regioni molto industrializzate, conobbe una prima crisi nel 1923, l’anno della grande inflazione. Ne conobbe una più grave nel 1930 per la grande depressione economica e per i primi colpi del nazismo. Quell’anno il governo regionale della Turingia cadde in mano ad una coalizione di destra, guidata dal partito di Hitler. Turingia e Sassonia erano divenute ancora più rosse quando vi si impiantò la Kommunistische Partei Deutschlands, nato dalla scissione del 1919. La KPD si impiantò anche a Berlino, dove interi quartieri della zona orientale divennero le basi del suo radicamento. La KPD trovò insediamento di tipo subculturale anche nella Ruhr, riuscendo a convivere con un ambiente operaio cattolico, togliendogli seguaci, laddove non era riuscita la SPD per il suo acceso anticlericalismo. Nonostante i continui contrasti fra i vertici dei due partiti operai, i militanti trovarono modo di intendersi. Spesso socialdemocratici e comunisti condividevano la stessa origine dalla subcultura socialista dell’anteguerra, che continuò in rapporti fraterni. A livello locale rimase fra loro una comunicazione interna, garantita dalle istituzioni e integrata da settori di azione collettiva comune. La rete di istituzioni comuni - quelle dei sindacati e della cooperative, delle associazioni sportive e culturali operaie - non era un luogo di perfetta armonia, ma era tuttavia un luogo di socializzazione, la sede della ricerca e dell’articolazione di interessi comuni… Vi si riproducevano esperienze e prospettive di una subcultura proletaria e socialista unitaria, che univa piuttosto che dividere militanti della SPD e della KPD (Mallmann 1996: 264). Lo stesso era il colore delle bandiere, gli stessi erano i rituali e i simboli, molte campagne per elezioni locali vennero condotte in comune. Lo stesso era il richiamo, talvolta di maniera, alla dottrina marxista. Naturalmente forte era nei comunisti il mito dell’Unione sovietica, ma non tutti i socialdemocratici rifiutavano “il paradiso dei proletari”. Né tutti i comunisti, proprio per la subcultura di appartenenza, avevano i bolscevici come modello. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 37 Mario Caciagli DOI: 10.1400/228740 Nella vita politica quotidiana i comunisti di base si trovavano vicini ai socialdemocratici, talvolta in dissenso con le direttive del vertice. Insieme crearono la Rote Hilfe, il Soccorso Rosso. I comunisti avevano i loro giornali, le loro feste, il loro peso nei sindacati e nelle fabbriche. Avevano locali riservati, dov’era proibito l’ingresso ai rivali e dove si svolgevano le riunioni di partito. Controllavano interi quartieri di Berlino. Le loro squadre di difesa, i Rotfrontkämfer e le Sturmabteilungen, furono protagoniste di scontri anche mortali con le squadre naziste, in specie a Berlino2. Difficile dire quale destino avrebbero avuto ambedue le subculture rosse tedesche dopo il 1933. Di certo esse furono spazzate via dalla dittatura nazista, che non soltanto mise al bando i loro partiti, ma distrusse completamente tutta le rete delle loro associazioni collaterali. Dopo la seconda guerra mondiale la SPD rinunciò espressamente a rimettere in piedi, laddove le aveva, le strutture territoriali del pre-nazismo. La SPD della Bundesrepublik ha avuto una distribuzione territoriale che ricalca i vecchi confini, ma il suo elettorato è fluttuante. Anche se ci sono municipi governati da essa ininterrottamente dal 1946, il tessuto della società dei consumi e dell’informazione non riesce ad esprimere una subcultura politica. La Sassonia riprese il suo colore rosso dopo il secondo conflitto mondiale e fornì un appoggio cruciale al successo della Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, il partito nato dalla fusione di socialisti e comunisti. La SED, presto egemonizzato dai comunisti, divenne il partito del regime fino crollo del Muro di Berlino nel 1989. Una buona parte della classe dirigente della DDR, la Repubblica democratica tedesca, tanto i membri che rientrarono dall’esilio moscovita, quanto coloro che erano rimasti in Germania nazista, era sassone. La loro compromissione con il regime quarantennale fece sì che la Sassonia dopo l’unificazione ha rigettato socialismo e comunismo e il suo Land è governato stabilmente da democristiani. Vienna la Rossa Forse più del tedesco, la Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), il partito socialista austriaco, già forte durante l’Impero asburgico, divenne dopo il 1918 l’idealtipo del partito di massa, sicuramente il partito più forte del socialismo europeo nei rapporti iscritti/voti e iscritti/elettori. Aveva infatti dalla sua la maggioranza relativa degli elettori austriaci e metà di quegli elettori avevano in tasca la sua tessera. Voleva essere un partito operaio: quasi tutte le sue organizzazioni collaterali avevano come attributo “Arbeiter”. Gli operai erano chiamati in causa in tutte le associazioni, dai filatelici ai liberi pensatori, dalle corali ai circoli degli scacchi, dagli escursionisti ai club di lettura. La SPÖ aveva quotidiani, riviste, case editrici; promuoveva biblioteche, teatri, concerti; disponeva, naturalmente, di moltissime case del popolo e di scuole di partito. Come naturalmente era affiancata da una rete di cooperative e da un potente sindacato. Con i tempi che correvano aveva anch’essa una formazione paramilitare, più agguerrita delle Guardie rosse italiane e dei Rotkämpfer tedeschi: il Republikanischer Schutzbund. Tutto questo era a Vienna e praticamente solo a Vienna. Vienna con i suoi dintorni formava la più grande regione per densità demografica del nuovo, piccolo stato austriaco, e questa regione era rossa, circondata da una provincia quasi interamente democristiana o liberal-conservatrice. A Vienna i socialisti ebbero la maggioranza assoluta in consiglio comunale (che coincideva con quello regionale, essendo Vienna anche un Land, una cittàregione). Mantennero quel potere fino al colpo di stato di Dollfuss nel 1934. Al governo della città-regione realizzarono massicci programmi di welfare locale, con alloggi popolari, cliniche, asili d’infanzia, scuole, palestre, parchi. In città sorse, disegnato dai migliori architetti dell’epoca, il Karl-Marx-Hof, città giardino per le famiglie della classe operaia. Negli anni Venti e nei primi anni Trenta, “Vienna la Rossa” era la mecca per migliaia di visitatori che vi andavano ad ammirare i magnifici blocchi abitativi dotati di parchi, palestre, scuole, cliniche, ritrovi comuni e giardini d’infanzia e che erano sparsi in tutta la città. Niente presentava meglio l’incredibile successo della socialdemocrazia austriaca che la vasta gamma di servizi sociali municipali forniti dal governo della città… Per i socialdemocratici 2 Ricavo queste informazioni relative a Berlino da un volume dedicato al nazista ucciso da un comunista nel 1930, il cui nome fu dato all’inno ufficiale del partito nazista che lo glorificò come un martire (Siemens 2009). 38 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228740 Mario Caciagli tutto ciò significava la creazione di una nuova società modello dentro i confini della vecchia e l’anticipazione del futuro socialista (Rabinbach 1983: 1). A Vienna la classe operaia con le sue istituzioni era uno stato nello stato, con le sue credenze e con il suo stile di vita. La cultura politica era, voleva essere una cultura proletaria. In attesa dell’avvento del socialismo, si tendeva ad anticiparlo con una nuova società e con la creazione dell’“uomo nuovo”. Il tentativo del partito di creare una controcultura proletaria non fu soltanto un esperimento… La sua qualità consisté nella ricerca di esplorare l’ignoto – una miscela di cultura e politica attraverso una complessa rete di organizzazioni per la trasformazione della classe operaia (Gruber 1991: 6). A questa finalità erano indirizzati l’edilizia pubblica, la sanità pubblica, le biblioteche, i festival di cinema e di teatro, le manifestazioni sportive. Dopo il nazi-fascismo e dopo la seconda guerra mondiale Vienna tornò ad essere rossa e lo è tuttora, ma solo dal punto di vista elettorale. Le scuole create e controllate dal partito, le sperimentazioni pedagogiche, la rete dei legami della SPÖ con il sindacato e con le cooperative, l’escatologia marxista: questo e tutto quanto aveva fatto cultura politica non venne recuperato dopo il 1945. Nei decenni successivi la composizione sociale della metropoli e della sua regione è cambiata e la base elettorale della SPÖ ai ceti medi impiegatizi, alle professioni intellettuali e non, ai dirigenti. Il largo consenso è rimasto, ma ricorre a motivazioni di ordine pragmatico e strumentale (Shell 1966). Può darsi che sia la memoria del passato a farsi sentire quando la partecipazione alle elezioni torna a crescere e aiuta la SPÖ a superare la soglia del 50% di voti e di seggi: ciò è avvenuto nell’ultimo decennio tutte le volte che si è profilata la minaccia dei liberali, divenuti in Austria una formazione di destra populista (Hofinger et alii 2013). Vienna progressista si contrappone ancora alla rimanente parte dell’Austria, bigotta o xenofoba, ma la subcultura rossa è stata sostituita dalla mentalità della new economy. La “banlieue rouge” di Parigi L’unico vero partito di massa francese è stato il comunista. Dopo una lenta crescita e una trasformazione dall’iniziale partito di quadri, il Parti communiste français divenne un partito di massa e di governo dopo la sua vittoria nelle municipali del 1935 e dopo quella del Fronte Popolare nelle legislative del 1936. Intorno ai comuni conquistati, spesso in coalizione ma più spesso con proprie maggioranze assolute, il PCF finì di costruire la rete delle istituzioni che i francesi chiamano «couronne», ciò che costituisce la rete della subcultura politica. Le reti comuniste si formarono nel Nord-Pas-de-Calais, dopo e accanto alle reti socialiste, e nel Corrèze, a Marsiglia e nel Midi. Ma si formarono e si consolidarono in maniera più vistosa e più durevole nella banlieue parigina, negli agglomerati periferici dove a cavallo del secolo aveva avuto inizio l’industrializzazione con la nascita delle grandi fabbriche e dove era cresciuta numerosa e compatta la classe operaia. Già all’indomani della prima guerra mondiale le elezioni municipali fecero registrare una forte avanzata del partito socialista e del partito comunista. Quest’ultimo si pose come obiettivo «una Parigi circondata dal proletariato rivoluzionario». La periferia dove essere il luogo dove si costruivano le sue colonne: l’organizzazione in fabbrica, le cooperative e le amministrazioni comunali. Negli anni Trenta e Quaranta in quasi tutti i comuni dei dintorni di Parigi, compresa una parte non piccola dell’attuale regione dell’Île-de-France, un elettore su tre era comunista. Nelle elezioni municipali del 1935 il PCI conquistò ben 26 comuni. I comunisti erano più forti nei maggiori, da Bobigny a Ivry, da Drancy a Saint-Denis, da Bagnolet a Nanterre, in una concentrazione territoriale che contribuiva a formare comunità chiuse e antagoniste nei confronti della “società borghese”. Nel 1936 la banlieue fu l’epicentro della vittoria del Fonte popolare, che cementò forti legami fra comunisti e socialisti, favorendo il solido radicamento della subcultura rossa. Molte ricerche di storia sociale locale, ma anche opere letterarie o cinematografiche ci hanno restituito a linee vivaci questa realtà (Brunet 1980 e Fourcaut 1986). L’identità spaziale ne era costitutiva, e si trasferiva in una sorta di «geografia rossa», un «ecosistema». «Terra comunista», scrivevano negli anni Trenta i cronisti del partito, essendo appunto l’identificazione con la fabbrica e con il territorio un elemento centrale della cultura politica Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 39 Mario Caciagli DOI: 10.1400/228740 predominante. Se la fabbrica costituisce una delle grandi matrici dell’identità operaia comunista, ce n’è anche un’altra, altrettanto importante: la matrice territoriale… Il voto comunista appariva meno un voto d’opinione, razionale ed evoluto, e più come un segno per riconoscersi, un fattore d’identificazione con uno spazio voluto come esclusivamente operaio… Questi territori aggregati fra loro potevano trasformarsi in “ecosistemi comunisti” (Courtois, Lazar 1995: 144-145). Intorno ai municipi fiorivano le sezioni del partito e del sindacato, la CGT, le scuole e le organizzazioni di massa, le bande musicali e le feste dell’Humanité, i grandi alloggi popolari costruiti dai comuni negli anni Cinquanta e Sessanta. Se diverse erano le motivazioni dell’adesione al PCF, basilare era quella delle comunità operaie, nella famiglia, nella fabbrica, nel vicinato, nelle reti associative, nei municipi: più che condividere una visione del mondo e un’analisi della società era più importante l’integrazione in un legame di sociabilità con altri comunisti in un contesto territoriale (Molinari 1991). Nella regione parigina il partito elabora un’identità che attiene a quattro dimensioni. Un’identità operaia valorizza il proletario, lo trasfigura, lo erige a esempio e fa della condizione operaia un motivo di fierezza e di speranza… Ma l’identità comunista è anche territoriale, perché il PCF ha permesso alle popolazioni di trovare stabilità e di inserirsi in un quadro spaziale che ha contribuito a strutturare. Il partito fa sviluppare una vera coscienza locale che rafforza lo spirito comunitario e il legame di fedeltà a chi l’ha istituito. Al tempo stesso l’insieme dei comuni parigini forma una spazio particolare, mitico, la banlieue rouge. un’espressione apparsa negli Anni Venti che perpetuava la paura quasi secolare delle classi pericolose che circondavano la capitale… Infine, l’ultima dimensione dell’identità è quella rivoluzionaria, perché il PCF collegava senza cessa la sua azione quotidiana al suo progetto universale… La forza del PCF nella banlieue non si spiega semplicemente con la sua strategia politica, ma nel fatto che aveva creato un modo di vivere e di esistere (Lazar 1992: 210-211). Fra le dimensioni valoriali c’erano la solidarietà e la dignità di classe, assunte accanto a quella teleologica dell’utopia realizzata nel sistema sovietico. Un valore era la memoria della Resistenza, fosse condivisa o nettamente distinta da quella di De Gaulle. Infine, se non soprattutto, c’era il mito dell’URSS, accompagnato da una fedeltà assoluta dei dirigenti a Mosca. La seconda guerra mondiale, con l’occupazione nazista e il regime di Vichy, portò con sé una dura repressione, ma anche una lotta antifascista che alla Liberazione confermò il predominio del PCF. La banlieue rossa ne uscì rafforzata e lo divenne ancora di più nei decenni successivi: il movimento operaio era prevalentemente comunista, l’industrializzazione si fece più intensa, in particolare nel settore metallurgico, la popolazione salariata aumentò, attività culturali e sportive vennero sviluppate, estesi i servizi sociali dall’assistenza medica a quella ricreativa, dai giardini d’infanzia alle case per anziani. Grandi complessi residenziali a basso prezzo, gli HLM (Habitations à loyer moderé), vennero realizzati sui terreni delle amministrazioni comunali comuniste. Se la politica degli alloggi rafforzò l’orientamento politico a favore del PCF fino agli anni Settanta, alcuni fattori cominciarono a minacciare la sua forza. Già alcune riforme territoriali avviate da De Gaulle e la stessa popolarità del generale-presidente cominciarono ad intaccare il sostegno ai bastioni rossi. La cultura comunista della banlieue era essenzialmente una cultura operaia. Come tale venne ferita a morte fra il Settanta e l’Ottanta dalla brutale deindustrializzazione della regione, avviato durante la presidenza di Giscard d’Estaing. Il processo ha accelerato il declino e poi la scomparsa della classe gardée (Brunet 1993). Nei comuni intorno a Parigi al posto degli operai ci sono gli immigrati o i disoccupati provenienti dal Maghreb, oppure il ceto medio delle città dormitorio. Il crollo dell’Unione sovietica dette il colpo di grazia al predominio del PCF. Se nella regione c’è ancora qualche sindaco comunista, non gli resta che gestire politiche più o meno clientelari. Mentre nelle elezioni politiche avanza sempre di più il Front national di Le Pen padre e figlia. Se una parte degli operai vota oggi per il FN, quegli operai sono comunque i superstiti di una classe sociale che ormai non c’è più. Allora, Se non esiste un trasferimento diretto e massiccio di elettori comunisti verso l’estrema destra, è più congruo affermare che esiste un reclutamento da parte del FN di elettori che avrebbero potuto votare in un momento o un 40 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228740 Mario Caciagli altro della loro vita per il PCF, soprattutto in quei comuni perduti dal PCF e che sono entrati nelle zone di forza del FN (Benucci 2005: 111). Quello che è certo è che la regione rossa intorno a Parigi non c’è più. In Italia le ultime roccaforti Insieme a quelle bianche, le regione rosse sono state nel corso della Prima Repubblica una delle chiavi interpretative del comportamento politico degli italiani e del funzionamento del loro sistema politico. La divisione dell’Italia in sei grandi zone, dove spiccavano le due più caratterizzate politicamente fu proposta negli anni Sessanta dai ricercatori della prima generazione dell’Istituto Cattaneo. Fu proposta in particolare in uno dei quattro volumi di quell’insuperata ricerca, quello dedicato al comportamento elettorale (Galli 1968). In quello e negli altri volumi gli studiosi del Cattaneo avevano ben ricostruito che dietro al comportamento di voto delle due grandi zone c’era la forte struttura di due partiti con i loro iscritti e militanti, con le loro sezioni e con una moltitudine di organizzazioni collaterali, con una rete di agenzie di socializzazione. Da tutto ciò il rinvio alla subcultura politica territoriale, categoria introdotta da quegli studiosi nel linguaggio scientifico italiano, e non solo in quello scientifico. La categoria fu ripresa pochi anni dopo da un altro collaboratore del Cattaneo che offrì un contributo decisivo per lo scavo effettuato nel retroterra storico delle regioni interessate. Per quanto riguardava le regioni rosse, già alla fine dell’Ottocento intorno al PSI si erano sviluppate le strutture della subcultura, fossero le camere del lavoro o le società per i funerali civili (Sivini 1971). Portando elementi nuovi alla costruzione della categoria “subcultura politica” e estendendola alle caratteristiche complessive di un sistema politico territoriale, anche Carlo Trigilia è risalito ai processi storici dello stato italiano, utilizzando, oltre ai dati politici dati sul tessuto economico, agrario prima e contraddistinto dopo dalla piccola e media impresa industriale (Trigilia 1981). Se la loro origine risale ai decenni di fine secolo come quella delle regioni rosse tedesche, il loro sviluppo non fu altrettanto immediato e impetuoso. Però le regioni rosse italiane sono state le più longeve, oltre che le più estese geograficamente. Senza soluzione di continuità territoriale, andavano, com’è noto, dal Veneto meridionale (la provincia di Rovigo) alla Toscana meridionale (la provincia di Grosseto), comprendendo l’intera l’EmiliaRomagna e le due province settentrionali delle Marche (Pesaro-Urbino e Ancona). Alla fine dell’Ottocento il PSI conquistò il bracciantato agricolo emiliano e mise piede nei piccoli centri urbani dell’Italia di mezzo, dove accanto ad un diffuso artigianato s’era affacciata una prima industrializzazione e dove , conquistando i comuni di quello che sarebbe diventato il “socialismo municipale”, uno dei cardini della sua cultura territoriale. Fu il PSI a creare i primi bastioni della sinistra nelle regioni rosse: leghe sindacali e case del popolo, cooperative e società di mutuo soccorso, la festa del 1° Maggio e un’escatologia (“la società del futuro”), soprattutto i municipi. Oltre che fra gli operai e gli artigiani delle città, i socialisti effettuarono con successo il loro proselitismo fra i braccianti della Valle Padana. Non riuscirono fino alla prima guerra mondiale a penetrare nel mondo mezzadrile, che costituiva la maggioranza economica e sociale di quelle regioni. I mezzadri conversero sul PSI all’indomani della prima guerra mondiale, che produsse una potente loro mobilitazione, sostenendolo con il voto per la conquista di una gran numero di comuni in quelle che da allora meritarono il nome di “regioni rosse”. Ma i mezzadri rimasero in parte delusi dagli sbandamenti dei socialisti e, soprattutto, furono vittime della repressione fascista. La scelte politiche del regime furono molto dure proprio nei confronti dei mezzadri. Le reti clandestine del PCI nelle campagne negli anni Trenta e l’esperienza collettiva della Resistenza avvicinarono i mezzadri al PCI. Durante e dopo la fine del regime il PCI subentrò quasi del tutto al PSI, trovando la sua più larga base di massa e il sostegno più sicuro nelle masse mezzadrili, che erano statisticamente presenti e diffusi in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria. La mobilitazione dei mezzadri durante l’ultimo periodo della guerra e le loro lotte nel dopoguerra furono il motore dell’espansione elettorale e organizzativa del PCI. Già nelle elezioni del 1946 si configurò la “cintura Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 41 Mario Caciagli DOI: 10.1400/228740 rossa” della mezzadria, da Rovigo a Grosseto, appunto. Da allora, per quasi mezzo secolo le zone rosse spaziano senza soluzione di continuità… sui due versanti dell’Appennino tosco-emiliano e umbromarchigiano. Le due zone di maggior rilievo, quella emiliana e toscana, sono anche le più estese e politicamente compatte… Nella zona emiliana l’egemonia comunista appare incentrata su un blocco composito di forze sociali dove spiccano in forme massificate, gli strati mezzadrili… Nella zona rossa toscana, come in quella emiliana, l’egemonia comunista è consolidata dalla corporazione dei consensi tributati dagli strati mezzadrili delle campagne (di straordinaria intensità soprattutto nel Senese) e dalla classe operaia consegnata nel sistema urbanizzato… L’area di forza del PCI è, comunque, in entrambe le regioni, quella della mezzadria (Anderlini 1987: 470-471). Così il PCI si insediò nelle regioni già rosse, ereditando antichi valori e gloriose strutture. Innestandovi tuttavia elementi di novità. Insieme alla capacità di acquisire il voto delle donne (delle mezzadre, soprattutto, s’intende) ne ricordo tre, molto importanti. Il primo fu la definitiva irruzione sulla scena politica dei mezzadri, che dilatò il consenso del PCI e rafforzò la sua militanza, quei mezzadri che, divenuti operai e piccoli imprenditori, avrebbe costituito l’ossatura del PCI in voti, iscritti e amministratori locali. Il secondo fu la sostituzione del PSI e il porsi della giovane e robusta organizzazione politica al centro di tutti i rapporti e di tutte le dinamiche della società delle regioni rosse: ”il” partito divenne l’asse della vita politica e non solo della vita politica delle popolazioni di quelle regioni. Infine, il terzo elemento di novità fu il mito dell’Urss che risaliva agli entusiasmi delle masse popolari degli anni Venti, ma che crebbe nel corso della seconda guerra mondiale e dei decenni successivi: se i dirigenti del PCI furono meno proni verso Mosca dei dirigenti del PCF, la base del PCI tenne gli occhi voltati verso Oriente come quella del PCF (Flores 1991, Fincardi 2007). Mentre la crisi della grande impresa avrebbe travolto la cultura rossa della banlieue parigina, la cultura delle regioni rosse italiane avrebbe accompagnato in qualche modo favorito la loro grande trasformazione da regioni prevalentemente agricole in regioni industriali. Insieme all’ambiente politico poco polarizzato e aperto al nuovo, i governi substatali delle regioni rosse italiane, prima i comuni e poi le regioni, contribuirono alla nascita e all’espansione di fittissime reti di piccole e medie imprese industriali, gestite spesso da ex operai e da ex mezzadri (Fedele 1983, Trigilia 1986, Anderlini 1986 e 1990). Conservando molti dei valori tradizionali, dalla solidarietà al senso di appartenenza comunitaria, coltivando riti e miti vecchi e nuovi, ribadendo la centralità dei municipi con le loro politiche di welfare, la cultura regionale rossa italiana divenne sempre più interclassista secondo l’ideologia popolare progressista in piena consonanza con la strategia del “blocco sociale” del PCI. Il PCI toccò la punta del suo consenso elettorale a metà degli anni Settanta. Subito dopo cominciò il suo declino. L’industrializzazione, la secolarizzazione, la diffusione dei mass media, gli alti livelli di reddito, insomma il benessere diffuso prese a far cambiare la società. Crescita economica e mutamento sociale cominciarono a rivolgersi contro il ventre che li aveva prodotti. I rutilanti anni Ottanta, che innalzarono ancora i livelli di benessere, scompaginarono l’articolazione delle classi sociali e stravolsero abitudini e comportamenti, mettendo in crisi gli antichi valori di solidarietà e di comunità. Le istituzioni della cultura regionale, dalle case del popolo alle feste dell’Unità, persero lentamente la loro funzione di trasmissione della comunicazione politica. La subcultura rossa era un edificio con le stanze da tempo in disordine e con molto mobilio tarlato, quando vi si abbatterono il crollo del sistema sovietico e il dissolvimento del PCI. L’agonia è durata a lungo, mascherata dai vari nomi dati ai partiti che sono successi al PCI e da alcune abili scelte di alleanze, in specie a livello locale. Ma il consenso elettorale copre un involucro dentro al quale la cultura delle regioni rosse non c’è più. Ancora nel 2005 uno studioso delle regioni rosse, attento e partecipe, poteva scrivere: La cultura politica prevalente in queste regioni – seppure sottoposta a sfide non irrilevanti, provenienti sia dall’interno sia dall’esterno della sua tradizione - sembra in grado di fronteggiare i rischi di ripiegamento che pure si sono intravisti. Quindi, nessun crollo… (Ramella 2005: 14). Invece, non è andata così. 42 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228740 Mario Caciagli Il partito, che ha cambiato ancora nome nel 2007 e ha un leader del tutto estraneo alla tradizione rossa, ha perso il suo primato.Tutti i vecchi collateralismi sono caduti. Ma anche se ci fosse un “partito” - cioè forma politica ormai obsoleta di quello che è stato, in Italia come altrove, ho ricordato all’inizio, il secolo dei partiti di massa e delle loro subculture - con quale colore si presenta oggi? Il partito che raccoglie più consensi nell’Italia di mezzo non sventola bandiere rosse, ma tricolori. La tradizione conta per la conservazione di alcuni valori: ma solidarietà e uguaglianza che «avevano una spiccata matrice politica si trasformano in norme sociali legate all’appartenenza comunitaria» (Bordignon, Ramella 2011: 131). Forse sono rimasti alcuni valori fondanti, come uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale e, più sicuramente, la difesa della democrazia repubblicana. Forse questi valori venivano da più lontano nei secoli e sono stati riconvertiti nell’esperienza dal Novecento - come propone la più recente interpretazione della cultura politica dei toscani, che così però conclude: «Un tentativo di risposta alla domanda se esista ancora, e propriamente, una subcultura rossa … La risposta non può essere che negativa… Una semplice continuità degli orientamenti politici generali non può essere sufficiente per parlare di persistenza di un subcultura» (De Sio, Floridia: 172). Insomma, anche le regioni rosse italiane appartengono al passato. Una comparazione per cercare di spiegare Nei cinque medaglioni che ho confezionato si leggono bene, credo, le somiglianze e le differenze fra le regioni rosse europee. Provo a metterle in evidenza. Tutte le regioni rosse nacquero in contrapposizione al sistema capitalista.Tutte si schierarono, almeno nelle fasi nascenti, contro gli stati borghesi. Nutrite di una visione del mondo che prospettava un’altra società, proletaria e socialista, si crearono una realtà altra rispetto a quella dominante. In attesa dell’uomo nuovo e della società del futuro furono autoreferenziali. Se questa era la loro natura comune, le diversità dovrebbero essere emerse dall’esposizione che precede. Cerco di rispondere ad alcuni perché. Nelle tedesche, sia nella socialdemocratica che nella comunista, nell’austriaca, socialdemocratica, e nella francese, comunista, si esprimeva una cultura che voleva essere ed era monoclasse. In quelle regioni c’era una classe gardée ed era la classe operaia. In Germania e in Austria divennero rosse le regioni dove si erano sviluppati i processi di industrializzazione: il paesaggio era quello dei grandi complessi industriali e minerari, dove era appunta nata e cresciuta la classe operaia. Industrializzate con una forte popolazione operaie erano le grandi città, Berlino e Vienna. Intorno ad una terza grande città, Parigi, era impiantata la classe operaia delle grandi fabbriche. Diverso è stato il caso dell’Italia. Nelle future regioni rosse i socialisti arruolarono i ridotti nuclei di classe operaia che andavano formandosi, ed arruolarono artigiani e braccianti. Ebbero difficoltà a conquistare alla loro causa i mezzadri che in quelle regioni costituivano la maggioranza degli occupati e della popolazione tutta. La conquista dei mezzadri fu il capolavoro del PCI. Nel suo lavoro comparativo fra il PC e il PCF, prendendo ad esempio l’Emilia Romagna e contrapponendola alla banlieue parigina Marc Lazar ha sottolineato: I mezzadri costituiscono il principale vettore di penetrazione comunista in Emilia-Romagna… L’abilità del PCI fu di non accontentarsi di quella che Maurice Thorez chiamava “una materia prima di prim’ordine”… Il PCI si rivolse agli artigiani, ai commercianti e agli intellettuali… I suoi sforzi suscitano tensioni interne, qualcuno dei suoi militanti più radicali non apprezzano per niente questa politica delle alleanze. Ma non modificano la composizione sociale del partito dominata da mezzadri, braccianti e operai… A differenza del monolitismo operaio delle banlieues parigine, la base sociale del PCI è dunque tridimendionale»(Lazar 1993: 218-219). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 43 Mario Caciagli DOI: 10.1400/228740 Il PCI chiamava quel sistema di alleanze “blocco sociale”; possiamo tranquillamente chiamarlo alleanza interclassista - come ho scritto sopra. Proprio qui stava la forte capacità del PCI di aggregare consenso. Una capacità che mostrerà tutti i suoi effetti quando i mezzadri diventeranno operai e una parte dei mezzadri e degli operai diventeranno piccoli e medi imprenditori nei sistemi di economia diffusa. Da qui venne anche la longevità delle regioni rosse italiane, non perché fossero nate più tardi come sosteneva Stephen Gundle nella citazione che ho messo all’inizio. La classe gardée del PCI, i mezzadri, misero anni a scomparire, la classe gardée del PCF, gli operai delle fabbriche della banlieue, furono spazzati via in poco tempo. Inoltre, PCI e PCF condividevano il mito per la rivoluzione bolscevica, dalle cui costole erano nati, e lo mantennero fino alla sua fine il mito dell’Urss. Rispetto ai loro omologhi del PCF i dirigenti del PCI avevano assunto via via un atteggiamento di maggior distacco dal “socialismo reale”, ma l’Urss rimase fino alla fine il modello e la speranza della parte del popolo comunista delle regioni rosse italiane meno impegnata e meno attenta ai problemi politici immediati, e quindi adagiata in una fede sicura e tranquilla. Il crollo del sistema sovietico fu un colpo di grazia per il PCI che pure perdeva voti nelle regioni rosse da un paio di anni. Il PCF, che pure non cambiò nome, era in crisi, abbiamo visto, già un decennio prima. Il declino della banlieue fu più rapido, perché rapida era stata la sua deindustralizzazione e la scomparsa della classe operaia, come ho ricordato. Il declino delle regioni rosse italiane è stato più lento perché più composita erano la loro economia e la loro società e sono state le ultime a scomparire in Europa alla fine del “secolo breve”, condividendo la sorte delle altre. I partiti di massa appartengono all’archeologia della politica europea. Le regioni rosse dov’erano nati e avevano prosperato sono scomparse. La loro è stata un’epopea, cioè, come dice il mio vocabolario d’italiano, «una narrazione epica di un periodo storico». Una storia magari eroica, come si addice alle epopee. Ma una storia, appunto. Riferimenti bibliografici Anderlini F. (1987), Una modellizzazione per zone socio-politiche dell’Italia repubblicana, in «Polis», 3. Anderlini F. (1986), Modello padano: localismo e modernizzazione, Bologna: Il Mulino. Anderlini F. (1990), Terra rossa. Comunismo ideale e socialdemocrazia reale, Bologna: Istituto Gramsci dell’EmiliaRomagna. Benucci C. (2005), Dal rosso al nero? I mutamenti di voto nella banlieue parigina, in «Quaderni dell’Osservatorio elettorale», 53. Bordignon F., Ramella F. (2011), L’Italia di mezzo, cerniera rossa di un paese diviso, in «Limes», 2. Brunet J.-P. (1980), Saint-Denis la ville rouge (1890-1939), Paris: Hachette. Brunet J.-P. (1993), La fin de la banlieue rouge, in «L’Histoire», 164. Courtois S., Lazar M. (1995), Histoire du Parti communiste français, Paris: Presses Universitaires de France. De Sio L., Floridia A. (2011), Conclusioni. Una tradizione politica territoriale?, in L. De Sio (a cura di), La politica cambia, i valori restano? Una ricerca sulla cultura politica dei cittadini toscani, Firenze: Firenze University Press. Duverger M. (1951), Les partis politiques, Paris: Armand Colin; trad. it., I partiti politici, Milano: Comunità, 1961. Fedele M. (1983, a cura di), Il sistema politico locale. Istituzioni e società in una regione rossa, Bari: De Donato. Flores M. (1991), Il mito dell’Urss nel dopoguerra, in P. P. D’Attorre (a cura di), Nemici per la pelle. Sogno americano e mito sovietico nell’Italia contemporanea, Milano: Franco Angeli. 44 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228740 Mario Caciagli Fincardi M. (2007), C’era una volta il mondo nuovo. La metafora sovietica nello sviluppo emiliano, Roma: Carocci. Fourcaut A. (1986), Bobigny, banlieue rouge, Paris: Editions Ouvrières-Presse de la Fondation National de Sciences Politiques. G. Galli (1968, a cura di), Il comportamento elettorale in Italia, Bologna: Il Mulino. Gruber H. (1991), RedVienna. Experiment inWorking-Class Culture, 1919-1934, NewYork-Oxford: Oxford University Press. Gundle S. (1995), I comunisti italiani tra Hollywood e Mosca. La sfida della cultura di massa, 1943-1991, Firenze: Giunti; ed. inglese, Between Hollywood and Moscow. Italian Communists and the Challenge of Mass Culture, 1943-1991, Durham: Duke University Press, 2000. Hofinger C.H., Ptaszynska A., Zandonella M. (2013), Wien, in F. Karlhofer, G. Pallaver (a cura di), Gemeindewahlen in Österreich im Bundesländervergleich, Innsbruck/Wien/Bozen: Studien Verlag. Neumann F. (1968), Entstehung and Entwicklung der politischen Parteien, in Abendroth W. e Lenk K. (a cura di), Einführung in die Politische Wissenschaft, München: Franke; trad. it. parziale, in G. Sivini (a cura di), Sociologia dei partiti politici, Bologna: Il Mulino, 1972. M. Lazar (1992), Maisons rouges. Les Partis communistes français et italien de la Libération à nos jours, Paris: Aubier. Lösche P., Walter F.(1990), Zwischen Expansion und Krise. Das sozialdemokratische Arbeitermilieu, in D. Lehnert, K. Megerle (a cura di), Politische Teilkulturen zwischen Integration und Polarisierung, Opladen: Westdeutscher Verlag. Mallmann K.-M. (1996), Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozialgeschichte einer revolutionären Bewegung, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. F. Ramella (2005), Cuore rosso?Viaggio politico nell’Italia di mezzo, Roma: Donzelli. Rabinbach A. (1983), The Crisis of Austrian Socialism. From Red Vienna to CivilWar 1927-1934, Chicago:The University of Chicago Press. Roth G. (1963), The Social Democrats in Imperial Germany, Totowa (New York): The Bedminster Press; trad. it., I socialdemocratici nella Germania imperiale, Bologna: Il Mulino, 1971. Shell K. L. (1966), The Transformation of Austrian Socialism, New York: State University. Siemens D. (2009), HorstWessel.Tod undVerklärung eines Nationalsozialisten, München: Siedler. Sivini G. (1971), Socialisti e cattolici in Italia dalla società allo stato, in Id. (a cura di), Sociologia dei partiti politici, Bologna: Il Mulino. Trigilia C. (1981), Le subculture politiche territoriali, Milano: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Trigilia C. (1986), Grandi partiti e piccole imprese. Comunisti e democristiane nelle regioni a economia diffusa, Bologna: Il Mulino. Walter F., Dürr T., Schmidtke K. (1993), Die SPD in Sachsen und Thüringen zwischen Hochburg und Diaspora, Bonn: Dietz Nachf. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 45 46 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci [Quante Italie?] Il ritorno al tradizionale cleavage tra Nord e Sud del Paese Title: How Many Italies? The Old Cleavage North-South is Back Abstract: The paper deals with one of the main traits of Italian political culture: distrust and low levels of civicness, as defined and measured by Robert Putnam. Assuming political culture as an independent variable, we aim to draw an updated map of social capital in Italy at regional level using two different measures. The first is an index builds on hard data (2008-2013) concerning rates of blood donors, electoral participation, volunteering, newspaper readerships. The second measure is the general trust’s variable collected by an unusual large sample. Both measures consistently show the old cleavage between Northern and Southern regions to be still very deep. In the seventies and eighties of the past century, political scientists and sociologists were questioning whether there were three, four or five Italies. Our updated indicators, based on hard and self-reported data, suggest that Northern and Central regions show higher levels of social capital than Southern ones. We conclude underlining that the regional civic gap is larger than the Gdp gap. Keywords: Social capital, Trust, Political culture, Italy. La cultura politica conta È urgente e importante riflettere sugli orientamenti di valore del nostro Paese. Operazione assai rara nel dibattito culturale, al di là di ricorrenti lamentazioni su corruzione e mala politica. Anzi, l’abusata metafora giornalistica della “casta” ha finito per diventare, non troppo paradossalmente, una sorta di assoluzione preventiva per i comuni cittadini, la “gente”, vittime del malaffare e dei loschi raggiri della classe politica. Questa contrapposizione noi-loro alimenta da decenni ondate di risentimento populista e tende a nascondere le responsabilità del tessuto di moralità pubblica che caratterizza la società civile. Dopo almeno trent’anni di stasi economica che ci ha portato ai margini dell’Europa, a venti anni dalla stagione di “Mani pulite”, con un debito pubblico che inibisce la praticabilità di politiche economiche fondate su investimenti pubblici, diventa ineludibile una riflessione sui nostri esili orizzonti di moralità pubblica. Ormai è del tutto impraticabile considerare la nostra arretratezza in termini di cultura politica come l’effetto di un insufficiente sviluppo economico, un epifenomeno oppure, più radicalmente, un tratto per sua natura immodificabile, da considerare necessario, ineliminabile, elemento di sfondo. Nel 1986 Carlo Tullio-Altan descriveva questo rifiuto degli intellettuali italiani a trattare il tema dell’arretratezza socioculturale del paese come una sorta di “rimozione nevrotica”. Ma la cultura non è un convitato di pietra. La cultura è quello che gli individui fanno nelle loro scelte quotidiane, è un repertorio di modelli e di valori “dati per scontato” che orientano l’azione dei cittadini offrendo soluzioni efficienti ai loro problemi ricorrenti (Cartocci 2011). Per questo ogni riflessione sulla cultura politica degli italiani non può limitarsi a ricostruirne le radici storiche, ma deve prendere in esame anche quei fattori che ne garantiscono la sopravvivenza all’inizio del nuovo millennio. Nel caso italiano gli orientamenti particolaristi e la carenza di un senso diffuso di responsabilità collettiva sono alla base del fallimento delle politiche di sviluppo del Mezzogiono, della persistenza di scambi clientelari fra candidati ed elettori, dell’enorme debito pubblico, della 1 Gli autori hanno progettato e discusso l’intero impianto del lavoro. Per quanto riguarda la stesura finale P. Bordandini ha scritto i paragrafi 2 e 5. R. Cartocci è responsabile dei paragrafi 3 e 4. Il primo e l’ultimo sono stati scritti congiuntamente. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 47 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 fallimentare lotta all’evasione fiscale e in fin dei conti della gravità della crisi finanziaria che condiziona le scelte politiche. Si tratta dunque di prendere sul serio le responsabilità che i nostri tratti culturali hanno sia sul declino che ci accompagna in questi anni, sia sulla difficoltà che abbiamo nel trovare soluzioni per uscirne e riprendere il cammino dello sviluppo economico e civile. In questo articolo cercheremo di tracciare una geografia del senso civico in Italia impiegando indicatori aggregati e individuali in modo da descrivere solidamente la distribuzione di questa risorsa nelle diverse regioni del paese. Questo contributo si articola in cinque paragrafi, oltre a questo iniziale. Nel paragrafo seguente vengono richiamati i principali percorsi di studi sulla cultura politica degli italiani. Il terzo paragrafo discute la lente concettuale del capitale sociale, mentre il quarto analizza la distribuzione di questa risorsa a livello regionale . Il quinto paragrafo approfondirà l’analisi della distribuzione del capitale sociale a livello regionale sulla base di un importante indicatore rilevabile solo a livello individuale: la fiducia negli altri. Nell’ultimo paragrafo si tireranno le conclusioni della geografia emersa, evidenziando da un lato la disarticolazione di quelle aree che avevano conosciuto una subcultura politica territoriale forte e dall’altra la persistente della tradizionale frattura tra Nord e Sud del paese. Familismo amorale e regioni civiche Il primo studio empirico sui caratteri culturali degli italiani risale alla metà degli anni cinquanta del secolo scorso. Si tratta di uno studio ermeneutico condotto da un politologo americano, Edward C. Banfield, in un borgo della Lucania (Chiaromonte), dove nel 1953-54 trascorse nove mesi. Attraverso interviste, dati censuari, fonti ufficiali, memoriali autobiografici e libri di conti che i contadini aveva compilato per lui mise a punto la nozione di familismo amorale. L’ethos del familismo amorale - cioè la tendenza «a massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare e a supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo» - è per Banfield un preciso modello culturale che coinvolge tutta la realtà del Mezzogiorno d’Italia e implica una radicale sfiducia negli altri, nelle istituzione nonché l’inibizione di forme di azione collettiva. Secondo Banfield questa sindrome, originata da vicende storiche fatte di dure condizioni economiche, enorme disuguaglianza sociale e dominazione straniera, presentava i caratteri di ogni modello culturale: resistenza al cambiamento e persistenza anche in condizioni diverse da quelle che ne sono all’origine. Le critiche al lavoro di Banfield furono ampie e in parte fondate, ma l’orizzonte del “familismo” resta un tratto tutt’altro che secondario della cultura politica degli italiani1. L’esempio paradigmatico delle ricerche sulla cultura politica italiana degli italiani è però The Civic Culture (1963)2. 1 A tal proposito nell’introduzione dell’ultima edizione italiana del lavoro di Banfield, Bagnasco scrive: «condivido gran parte delle critiche, ma ho la sensazione che non ci si liberi facilmente di Banfield; ho il sospetto che anche in molti dei più accesi critici rimanga la sensazione di avere a che fare con una specie di fantasma nascosto da qualche parte nella casa, e pronto a ritornare quando e dove meno loro se lo aspettano… Bisogna riconoscere che si tratta di una ricerca con la quale è necessario comunque misurarsi, e in modo non banale» (2010, 9). 2 Il concetto stesso di cultura politica è stato definito per la prima volta in questo lavoro. Secondo Almond e Verba «l’espressione “cultura politica” è riferita specificamente agli orientamenti politici - agli atteggiamenti nei confronti del sistema politico e delle sue varie parti, e agli atteggiamenti circa il ruolo del soggetto nell’ambito del sistema. Parliamo di cultura politica come potremo parlare di cultura economica o religiosa. Essa… consiste nella particolare distribuzione di atteggiamenti esistenti nella popolazione nei confronti di ‘oggetti’ politici… Per orientamenti si intende il modo interiorizzato con cui il soggetto guarda ad oggetti o relazioni» (1963, 12-15). Per i due studiosi americani la cultura politica è dunque l’insieme degli atteggiamenti (affettivi, cognitivi e valutativi), delle credenze e degli interessi che una comunità ha nei confronti del sistema politico Ma l’utilità di questo concetto si rintraccia soprattutto abbandonando un’ottica funzionalista che riduce la cultura ad una “somma di tendenze psicologiche” ed identifica la politica in un “sottosistema determinato”. La cultura politica può così essere considerata «un repertorio relativamente coerente di modelli cognitivi e valutativi che consentono agli individui di una comunità politica di conferire senso a se stessi in quanto attori politici, agli altri attori politici, alla comunità in cui fanno parte e alla struttura politico-istituzionale in cui sono inseriti… al pari del complesso degli orientamenti culturali è in larga misura vissuta in modo inconsapevole dagli individui, i quali ne sono prima di tutto i portatori e utilizzatori» (Cartocci 2011, 1968). Questi modelli cognitivi e valutativi costituiscono lo sfondo del concreto comportamento politico degli attori, il framework all’interno del quale gli individui agiscono in modo considerato politicamente appropriato. 48 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci Con questo lavoro Almond e Verba si posero l’obiettivo di comparare cinque sistemi politici (Italia, Messico, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna) per studiare il rapporto tra cultura politica e stabilità democratica. Gli interessi di ricerca dei due politologi americani scaturivano dall’esigenza di capire i motivi che avevano portato al crollo delle democrazie europee prima della seconda guerra mondiale e valutare la stabilità dei nuovi regimi democratici nati in Italia e Germania dopo la sconfitta. I risultati della ricerca misero in luce l’esistenza di tre differenti tipi ideali di cultura politica: parochial, subject, participant. La prima era caratterizzato dalla prevalenza di atteggiamenti fondati su particolarismo, localismo, fiducia a corto raggio e senso di alienazione dallo stato e dalla politica. Le principali caratteristiche della cultura politica subject erano il rispetto e la fiducia nell’autorità dello stato e delle sue decisioni. Il fondamento della cultura politica participant era invece costituito dall’impegno politico attivo dei cittadini attraverso libere associazioni e la consapevolezza della possibilità di influire nelle decisioni politiche dei governanti. La cultura civica - costituita da un equilibrio tra il secondo e il terzo tipo ideale - era considerata dai due politologi il presupposto culturale più adatto per una stabile democrazia. Tra i cinque sistemi politici studiati, la cultura civica era diffusa nelle sole due democrazie anglosassoni. Germania e Italia erano invece considerate democrazie con alto rischio di instabilità, la prima perché era caratterizzata da una cultura politica subject, la seconda perché dominata da una cultura prevalentemente parochial. Per Almond e Verba la cultura politica italiana alla fine degli anni ’50 si distingueva per un impasto di apatia e alienazione politica, diffuso isolamento politico e profonda sfiducia. I dati presentati evidenziavano una maggioranza di italiani non interessati alla vita politica (per questo erano definiti apatici) e un’altra parte, molto inferiore, attiva, ma dall’orientamento comunista o socialista (e perciò, a detta di Almond e Verba, “alienata” in quanto non democratica)3. Nei termini di Almond e Verba «gli italiani tendono a vedere l’amministrazione e la politica come forze minacciose e imprevedibili, e non come istituzioni sociali su cui poter incidere. La cultura politica dell’Italia non costituisce una premessa per la stabilità e l’efficienza di un sistema democratico» (1963: 403). Al di là dell’anticomunismo dei due studiosi - e dei 50 anni di distanza - si tratta di un profilo della cultura politica degli italiani tutt’altro che invecchiato. In Italia The Civic Culture ebbe una ricezione ben poco calorosa, il libro non fu infatti tradotto né recensito. Due le principali ragioni, in parte accennate nel precedente paragrafo. Per molti studiosi italiani la chiave di lettura di Almond e Verba era errata: il (mal)funzionamento del sistema democratico non dipendeva tanto dalla cultura politica diffusa, quanto da altre dimensioni come la situazione socio-economica, la presenza di profonde fratture ideologiche nazionali e internazionali o i traumi connessi al passaggio da monarchia a repubblica. La seconda ragione aveva a che vedere con i risultati poco lusinghieri per gli italiani. La nostra cultura politica era stata descritta prevalentemente come alienata, cinica, diffidente, passiva, fondata su ignoranza e scarsa informazione, frammentata, polarizzata da fratture insanabili. Tutti aspetti che contrastavano con prospettive ed intenti diffusi dell’élite politica del secondo dopoguerra, che fondava retoricamente la cultura politica degli italiani sull’antifascismo, sulla Resistenza e sulla Costituzione - e per questo “sicuramente” ancorata a un orizzonte democratico. Sulla scia di The Civic Culture si è sviluppata poi un’ampia tradizione di ricerche volta a descrivere i caratteri culturali degli italiani in chiave comparata. Anche in anni più recenti (si pensi alle indagini dell’Eurobarometro, della European Social Survey, della World Value Survey) queste ricerche hanno confermato la persistenza in Italia di atteggiamenti in parte descritti da Almond e Verba: insoddisfazione per il funzionamento della democrazia e del sistema politico-amministrativo, sfiducia nei partiti, insofferenza per la pletora dell’offerta politica, sfiducia negli altri. Si tratta di una tradizione di ricerche fondata - anche per ragioni connesse ai limiti della comparazione ad ampio raggio - sull’idea che la cultura politica degli italiani sia omogenea. Opposto è stato invece l’approccio seguito da chi ha mirato a sottolineare le differenze tra le diverse aree del Paese. Negli anni ’60 l’Istituto Cattaneo di Bologna iniziò un ampio progetto di ricerca teso ad analizzate i due maggiori partiti italiani del tempo: Dc e Pci. Sebbene gli obiettivi di queste ricerche non fossero esplicitamente diretti allo studio della cultura politica, ma al funzionamento del sistema politico italiano, l’analisi della cultura politica degli italiani non solo fu inevitabile, ma portò anche a risultati di importanza fondamentale. Fu evidenziata la presenza nel nostro paese di due subculture politiche ben definite - “rossa” e “bianca” - capaci di svolgere 3 Le critiche da rivolgere all’approccio di Almond e Verba allo studio della cultura politica sono numerose e riguardano sia il piano metodologico sia quello concettuale. Su questi ed altri punti si veda Arculeo, Marradi (1983), Fideli (1998) e Bordandini (2006). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 49 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 un’articolata azione di socializzazione politica nei territori in cui si erano radicate. Parimenti fu evidenziata la debolezza e la marginalità nel panorama politico italiano di una subcultura politica laica. Anche questo programma di ricerca - basato su un approccio storico, geograficamente articolato e multidimensionale - costituì un punto di partenza per molti studi successivi. A partire dal presupposto secondo cui «per comprendere il sistema italiano è essenziale comprendere l’articolazione territoriale e le sue funzioni economiche e politiche» (1977: 10), dieci anni dopo Bagnasco descrisse le aree “rosse” e “bianche” come espressione di un’unica formazione sociale, economica e territoriale: la Terza Italia. In altri termini Bagnasco mise in discussione la tradizionale dicotomia che contrapponeva un Nord sviluppato a un Sud sottosviluppato, e individuò una realtà socioeconomica specifica nelle regioni dell’Italia centrale e nordorientale. Nacque quel filone di studi che nei decenni successivi impegnerà sociologi dell’economia e politologi per definire e descrivere i caratteri economici, politici e culturali delle subculture politiche territoriali “rosse” e “bianche”4. Sul piano della cultura politica la Terza Italia venne descritta come caratterizzata da alti livelli di integrazione sociale e di partecipazione politica , fedeltà di voto, forte etica del lavoro, solida identità locale. Tra zone “rosse” e “bianche” esistevano comunque anche importanti differenze: mentre nelle prime il centro dell’intera architettura del mondo associativo era costituito dal partito e le amministrazioni locali davano un sostegno attivo allo sviluppo dell’area, nelle “zone bianche” la DC si legittimava in quanto parte del mondo cattolico e assumeva una funzione di mediazione con Roma. I governi locali “bianchi” erano infatti meno interventisti di quelli “rossi”, tanto che nelle aree bianche si registrava una minore propensione dell’attore pubblico ad intervenire direttamente nella regolazione delle politiche economiche e sociali locali. La regolazione delle politiche si fondava prevalentemente sul meccanismo della “delega” alla rete associativa cattolica presente nel territorio. Le aree rosse invece si caratterizzavano - e si caratterizzano tutt’oggi - per una maggiore cultura interventista risalente al periodo del “socialismo municipale” di un secolo fa. Sul piano più strettamente ideologico e delle identità politiche le zone rosse si distinguevano per la fedeltà al partito, l’anticapitalismo, l’anticlericalismo, il mito della rivoluzione d’ottobre e dell’Unione Sovietica (cfr. Caciagli 1988). I valori dominanti nella subcultura bianca erano invece quelli derivati dalla religiosità (in tutte le sue forme, anche quelle esteriori), dall’accettazione della democrazia pluralista e dall’anticomunismo. A parte le contrapposizioni ideologiche, le due subculture politiche territoriali hanno garantito al loro interno un elevato grado di integrazione sociale (connessa alla condivisione di un particolare impianto valoriale), dense relazioni fiduciarie e reti di solidarietà allargate (legate alla presenza di una cornice di valori condivisi), una diffusa partecipazione politica e sociale, relazioni industriali non conflittuali (pur con un elevato grado di sindacalizzazione), la presenza di istituzioni locali altamente legittimate. Una cultura politica dunque orientata all’interesse collettivo e alla produzione e salvaguardia di beni pubblici e comuni. Sulla scorta de studi dell’Istituto Cattaneo e sulle subculture politiche territoriali, nonché dell’approfondita ricostruzione di Tullio-Altan delle forme dell’arretratezza culturale italiana (1986), all’inizio degli anni novanta Putnam, Leonardi e Nanetti pubblicano la nota ricerca sulle tradizioni civiche delle regioni italiane (1993), che completa il precedente volume del 1985 dedicato all’analisi del rendimento delle regioni a dieci anni dalla loro istituzione. Gli indicatori di rendimento istituzionale spaziavano dal piano organizzativo a quello politico, economico e sociale. In tutti i settori risultò evidente che «gli enti regionali avevano impiantato le proprie radici nella società regionale… [e che] da ciò derivava che i livelli di rendimento variavano notevolmente da regione a regione» (Putnam, Leonardi e Nanetti 1985, 343): le regioni del Nord registravano un rendimento istituzionale nettamente migliore di quelle dell’Italia meridionale. In Making Democracy Work gli autori escludono che queste differenze siano dovute al diverso sviluppo economico regionale. Anzi, questa correlazione viene ritenuta spuria in quanto la variabile indipendente in grado di spiegare sia il rendimento istituzionale sia lo sviluppo economico, è identificata nella diversa dotazione di capitale sociale, così definito: la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, [cioè gli] elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo (Putnam 1993, 196). 4 Si pensi ai lavori su questi temi di Bagnasco e Trigilia (1984 e 1985), Trigilia (1986) e Caciagli (1988). E poi - siamo all’oggi - a quelli volti allo studio delle trasformazioni di queste subculture: Baccetti e Caciagli (1992 e 1994), Messina (2001), Ramella (2005), Bordandini (2006), Baccetti e Messina (2009). 50 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci La mappa del capitale sociale in Italia costruita da Putnam all’inizio degli anni novanta segnalava come tra le regioni più civiche del paese ci fossero il Trentino-Alto Adige e le due maggiori regione a subcultura politica rossa (Emilia Romagna e Toscana); seguivano Friuli Venezia Giulia, Lombardia Liguria, Piemonte, Veneto, Umbria e Marche. Le regioni meno civiche risultavano Campania, Calabria e le altre regioni del Sud (cfr Putnam 1993: 115) Nel tempo il lavoro di Putnam è stato riproposto evidenziando conclusioni molto simili, anche portando l’analisi a un livello provinciale (cfr Cartocci 2007; Foderà, Pavolini 2014; Accetturo, De Blasi 2014). Nei paragrafi che seguono proporremo una ulteriore mappa regionale delle virtù civiche degli italiani, che trova la sua originalità rispetto agli studi precedenti affiancando ai consueti indicatori aggregati la fiducia generalizzata, rilevata a livello individuale. Capitale sociale: definire il concetto La solidarietà è una delle dimensioni in cui si estrinseca la nostra umanità. Essa è uno dei tre moventi che orientano tutte le nostre azioni e i nostri comportamenti, accanto agli altri due: - l’interesse individuale da perseguire in competizione con gli altri; - Il rispetto delle regole formali che ci vengono imposte da una gerarchia di potere, in grado di sanzionare chi le infrange. A parte quest’ultimo criterio, che àncora le azioni a un vincolo esterno (le sanzioni probabili da parte di un’autorità politica), noi siamo in grado di orientare liberamente il nostro comportamento sulla base di due differenti registri, che ci servono per dare un senso a noi stessi e alla nostra vita e, di conseguenza, per orientarci nel mondo. Da un lato contrapponiamo il nostro interesse personale a quello degli altri, ponendoci in competizione; dall’altro lato consideriamo gli altri non come rivali con cui competere ma sodali nella lotta dell’esistenza: con essi sentiamo di condividere una identità indissolubile, che ci trascende e ci rende reciprocamente corresponsabili. Se non può esistere una società in cui domina solo l’uno o l’altro di questi due criteri, esistono comunque profonde differenze tra le varie società sui termini in cui gli orientamenti culturali tracciano i confini che separano la (legittima) sfera degli interessi individuali da quella della solidarietà con gli altri, così come è sempre la cultura che stabilisce l’ampiezza dell’orizzonte che delimita la sfera del “noi”, tracciando il confine entro il quale ci sentiamo obbligati e responsabili verso gli altri. E’ proprio sullo sfondo di queste considerazioni che la nozione di capitale sociale da un lato trova la sua potenzialità euristica, dall’altro richiede di essere analiticamente precisata e chiarita, riducendone l’ambiguità che essa mantiene finché la manteniamo ad un elevato livello di generalità. In questi ultimi due decenni il concetto è stato utilizzato da studiosi della società, della politica e dell’economia per riferirsi in modo sintetico a una varietà di fenomeni capaci di influenzare sia il benessere dei cittadini, sia la qualità del nostro vivere associato, sia l’efficienza dell’economia. La metafora del capitale è trasparente: il capitale sociale è una risorsa capace di generare ricchezza e benessere, e in questo è affine alle forme canoniche di capitale riconosciute dagli economisti. Abbiamo testé visto come Putnam consideri il capitale sociale come una risorsa collettiva, un orizzonte culturale definito anche come “comunità civica” (Putnam 1993, cap. VIII), contiguo alle categorie proposte da Almond e Verba trent’anni prima. Attraverso la nozione di capitale sociale così definita si istituisce dunque un preciso nesso micro-macro. Il nesso micro-macro, tuttavia, è particolarmente opaco rispetto alla nozione di capitale sociale. La definizione di Putnam mette in evidenza come il capitale sociale si costruisca a partire da un vincolo per gli individui, attraverso il riferimento alle norme informali di convivenza tipiche della civicness. Rispetto all’antinomia richiamata all’inizio del paragrafo (il perseguimento degli interessi individuali in contrapposizione alla solidarietà con coloro cui siamo legati da vincoli di identità e di responsabilità) il capitale sociale trova la sua collocazione più utile nella cornice del secondo registro, quello dei valori e delle solidarietà. Sono le “ragioni del cuore” che secondo Pascal non danno ascolto alla ragione, quelle che caratterizzano la “razionalità rispetto al valore” di Max Weber (1922) e il “simbolico” di Tullio-Altan (1992). Costruire capitale sociale diventa un beneficio piuttosto che un costo se e in quanto il singolo individuo è inserito in un orizzonte di moralità che trasfigura gli altri come valori. Detto in altri termini: la natura normativa del capitale sociale consiste nell’implicare obbligazione e responsabilità verso gli altri, vissute come tratti del Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 51 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 repertorio di normalità codificate in una cultura, “assunti dati per scontati” (Schein 1988) che non sono limitati a un empireo impalpabile.Tali assunti, al contrario, orientano l’azione individuale in modo così cogente da diventare condotte che non richiedono decisioni consapevoli, agendo by default. La precisazione suona pedante ma è necessaria, in quanto in letteratura non mancano autorevoli definizioni alternative del capitale sociale, secondo le quali esso rappresenta una dotazione individuale. Per Pierre Bourdieu (1980) il capitale sociale è una delle varie risorse cui un individuo può attingere, accanto agli altri tipi di capitale economico, simbolico e culturale - per realizzare gli obiettivi che si prefigge. Gary Becker condivide con Bourdieu la prospettiva individualista del capitale sociale ma ne cambia il segno: non risorsa preziosa che aumenta le opportunità di chi ne dispone ma vincolo dovuto agli investimenti in relazioni sociali di un individuo che finiscono per limitarne la libertà d’azione: «gli individui perdono il controllo sulla produzione del proprio capitale sociale, che è essenzialmente determinato dall’azione degli altri» (2000: 29). Considerare i valori come materia prima del costrutto del capitale sociale offre il vantaggio di risolvere in via analitica il paradosso dell’azione collettiva. Gli individui entrano in relazioni cooperative gli uni con gli altri quando si riconoscono reciprocamente come fini e non come mezzi, giusta la “banale” capacità dei valori di orientare gli individui nella loro pratica quotidiana. E’ utile, inoltre, una seconda puntualizzazione analitica rispetto a una delle pattern variables di Parsons (1951; Parsons, Shils 1962). La dimensione universalismo-particolarismo differenzia tra chi agisce «sulla base di una norma generale o invece sulla base della particolare relazione che lo lega a qualcuno» (Wallace,Wolf 2006: 34). Si tratta, in sostanza, di tener conto dell’ampiezza del vincolo morale dei singoli verso gli interessi collettivi. Anche gruppi ristretti e molto coesi sono ricchi di capitale sociale: municipalismi e familismi, collusioni corporative e solidarietà mafiose sono forme di capitale sociale, tra le più dense e cogenti. Ma queste solidarietà di corto raggio sono più un ostacolo che una risorsa per una società avanzata, in cui gli individui sono mobilitati e valorizzati sia dallo stato sia dal mercato. Questo rilievo impone quindi una contestualizzazione decisiva: il capitale sociale fondato su una prospettiva universalista è l’unico orizzonte culturale congruente con gli assetti istituzionali di una democrazia e di un mercato efficienti; schematizzando, il capitale sociale come comunità civica consta dei seguenti tratti: - un senso di corresponsabilità interpersonale ad ampio raggio, - un diffuso rispetto delle norme formali e, soprattutto, informali, - un certo grado di informazione e competenza politica, - identificazione con l’assetto istituzionale. Un capitale sociale con questi contenuti di valore, che alimenta la condivisione della responsabilità verso gli altri, la lealtà verso le istituzioni e la partecipazione agli elevati costi della cittadinanza sociale, designa qualità antitetiche rispetto a quelle del free rider e costituisce l’accezione aggiornata di processi macro di integrazione topdown che la letteratura sullo sviluppo politico rubrica come nation-building, adeguandolo alla fase matura delle democrazie del welfare, che esigono da parte dei cittadini un tipo di adesione più leggero, meno visibile ma non meno responsabile dell’ “amor di patria” ottocentesco. Con questi tratti, un elevato capitale sociale non può che riflettersi con effetti positivi anche sulla qualità delle relazioni di mercato, poiché il tessuto etico in cui avvengono le transazioni economiche viene caratterizzato da affidabilità degli attori, rispetto delle regole, ridotta incidenza di comportamenti opportunistici. In una prospettiva di sistema, il capitale sociale dotato di questa curvatura universalista rappresenta il terzo indispensabile pilastro - quello culturale - per tenere in equilibrio una società democratica avanzata, in cui stato e mercato - gli altri due pilastri - sono, ciascuno nel suo ambito, efficienti: il primo è in grado di assicurare sicurezza, ordine e diritti di cittadinanza; il secondo è in grado di garantire lavoro e produrre profitti - e dunque anche entrate fiscali per lo stato. 52 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci Capitale sociale: un indice in base a dati aggregati La rilevazione della dotazione di capitale sociale pone da un lato l’esigenza di ricorrere a una pluralità di indicatori validi e affidabili, capaci di costruire una mappa della comunità civica in Italia. Di solito si prediligono i dati aggregati (Cartocci 1990, 2007; Putnam 1993)5. Gli indicatori di capitale sociale individuati a livello territoriale sono quattro: - la partecipazione elettorale - la diffusione della stampa quotidiana - la diffusione del volontariato - la diffusione delle donazioni di sangue Con i primi due indicatori si è inteso rilevare due aspetti della partecipazione politica: il voto come forma di partecipazione visibile ed esplicita, oltre che istituzionalmente rilevante, e la diffusione dei giornali, intesa come partecipazione “invisibile” alla vita sociale, manifestazione concreta di interesse e di ricerca di informazioni a un livello più approfondito di quanto viene veicolato dalla televisione. La diffusione del volontariato nelle organizzazioni di assistenza sociale e delle donazioni di sangue permette di affiancare alla partecipazione politica la dimensione della solidarietà e della corresponsabilità, che rileva della comunità civica la componente oblativa che travalica i confini della famiglia e della parentela. Tutti i dati presentati nella tabella 1 - che riporta la distribuzione regionale di ognuno dei quattro indicatori - si riferiscono al periodo 2008-2013. Nella decisione di ricorrere alla partecipazione elettorale si è tenuto conto anche della sua ineliminabile ambiguità rispetto alle caratteristiche della comunità civica. Infatti il voto presuppone anche motivazioni particolaristiche e forme di protesta antisistema - entrambe presenze consolidate della nostra storia elettorale. Tuttavia si è ritenuto che la partecipazione al voto sia in larga misura dovuta a quella che tecnicamente è una decisione irrazionale per il singolo elettore, dal momento che il suo contributo all’esito finale del voto è di fatto nullo. Pertanto le ragioni della partecipazione elettorale da parte dei cittadini vanno cercate nel mondo dei valori: quello che in termini di utilità personale è un costo - l’andare a votare - diventa dal punto di vista soggettivo un modo per manifestare la propria identità, sia per l’elettore di appartenenza, che si identifica con una specifica scelta politica, sia per quello d’opinione, per usare la nota tipologia di Parisi e Pasquino (Parisi e Pasquino 1977). La partecipazione elettorale, oltre le singole motivazioni politiche, è dunque da considerare una forma di legittimazione delle istituzioni, un riconoscimento - consapevole o meno - del regime democratico, soprattutto considerando una pluralità di consultazioni, dunque un valido indicatore di capitale sociale, inteso come comunità civica. Sul piano empirico, la partecipazione elettorale a livello regionale è stata analizzata calcolando la media di partecipazione alle tre più recenti consultazioni nazionali: le elezioni della Camera del 2008 e del 2013 e le europee del 2009 (tab. 1, prima colonna). I valori massimi di partecipazione elettorale sono registrati, nell’ordine, in Emilia-Romagna (81,7%), Umbria, Veneto, Lombardia, Marche e Toscana, con Veneto e Lombardia che superano alcune regioni di tradizione politica “rossa” come Marche e Toscana. La partecipazione più bassa si rileva in Calabria e Sicilia, con valori medi vicini al 63%, dunque staccate di circa diciotto punti percentuali rispetto alle prime posizioni della graduatoria sopra richiamate. Nel complesso tutte le regioni a sud della cintura costituita da Toscana, Marche e Umbria presentano un livello di partecipazione elettorale inferiore alla media. Il gradiente Nord-Sud è agevolmente riconoscibile, con l’eccezione della Liguria, unica regione centrosettentrionale con una partecipazione inferiore alla media nazionale. 5 Questo paragrafo riprende i dati presentati nel saggio Una mappa del capitale sociale e della cultura civica in Italia (Cartocci,Vanelli 2014). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 53 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 Tab. 1 - Distribuzione dei quattro indicatori di capitale sociale. Analisi per regione, media nazionale, valore minimo, valore massimo e coefficiente di variazione. REGIONI Partecipazione elettorale (media elezioni politiche ed europee 2008-2013) Copie di quotidiani vendute ogni 1.000 residenti. (media 2009-2010) Donazioni di Volontari ogni sangue ogni 1.000 1000 residenti. residenti. (anno 2011) (anno 2008) Piemonte 76,4 62,1 8,4 50,8 Valle d’Aosta 71,7 86,4 5,5 46,5 Lombardia 79,2 76,6 9,9 47,7 Liguria 72,7 130,4 7,6 44,6 Trentino-Alto Adige 75,1 133,5 12,9 44,7 Veneto 79,7 74,8 8,9 51,2 Friuli Venezia Giulia 74,2 113,3 8,2 57,4 Emilia-Romagna 81,7 92,9 10,2 57,8 Toscana 78,6 84,1 9,8 44,7 Umbria 80,5 55,7 6,1 46,0 Marche 78,9 62,3 7,6 47,4 Lazio 73,9 73,5 7,1 31,1 Abruzzo 73,0 55,5 5,5 37,1 Molise 73,2 31,8 4,8 44,6 Campania 69,4 27,1 3,2 24,7 Puglia 71,5 34,8 4,0 38,4 Basilicata 70,9 36,5 5,5 35,5 Calabria 63,5 44,0 4,5 30,7 Sicilia 62,9 52,0 3,7 34,6 Sardegna 60,5 103,4 7,2 41,9 MEDIA ITALIA 73,4 71,5 7,0 42,9 minimo 60,5 27,1 3,2 24,7 massimo 81,7 133,5 12,9 57,8 Coeff. Variazione Italia 21,2 106,4 9,7 33,1 Note: Il dato medio di copie di quotidiani vendute per il biennio 2009-2010 è stato diviso per la popolazione residente al 1° gennaio 2010. I dati relativi al volontariato sono relativizzati alla popolazione residente al 1 gennaio 2012. Fonte: Elaborazioni su: dati ministero dell’Interno, dati Ads (Associazione diffusione stampa), dati tratti dal 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi dell’Istat, dati del Centro nazionale sangue. Se la partecipazione elettorale è da considerarsi come una forma di partecipazione visibile, leggere i giornali ricade fra le forme invisibili, al pari delle discussioni tra amici e conoscenti che si svolgono tra le mura di casa, al bar o per strada. Nella decisione di acquistare e leggere un quotidiano, oltre a tante specifiche motivazioni, c’è, soprattutto, l’elemento preliminare della relazione con il mondo al di fuori della ristretta cerchia delle reti primarie: l’interesse e la ricerca di informazioni non direttamente attingibili. Questo indicatore presenta alcune peculiarità che non possono essere ignorate: in Italia la diffusione della stampa quotidiana soffre di problemi strutturali dell’offerta, come la carenza di grandi editori “puri”, con la conseguente assenza di una stampa indipendente dai grandi gruppi industriali e finanziari, o non sovvenzionata dai fondi pubblici. C’è, soprattutto, l’agguerrita concorrenza della televisione, che da un lato sottrae alla stampa gran parte dell’indispensabile mercato pubblicitario, e dall’altro lato canalizza la maggior parte dell’informazione che arriva ai cittadini. Come infatti 54 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci attestano concordemente tutte le ricerche condotte negli ultimi decenni sul tema, è attraverso la televisione che la maggior parte della gente si tiene informata sull’attualità, anche politica. Lo squilibrio tra televisione e stampa è in Italia particolarmente grave: domanda e offerta si intrecciano mantenendo un’opinione pubblica complessivamente poco informata, esposta alle semplificazioni unilaterali dei telegiornali e di sguaiati dibattiti televisivi. Proprio per questi limiti del mercato italiano, la diffusione differenziale della stampa quotidiana nelle diverse aree del Paese può essere letta come indicatore di apertura, interesse e partecipazione ai problemi della comunità e del mondo. Se non rileva direttamente il senso di obbligazione e responsabilità verso gli altri, il senso di compartecipazione ai destini della propria comunità, la lettura della stampa quotidiana rileva quantomeno la diffusione di un’attiva esposizione a flussi di informazione meno superficiale di quella veicolata dalla televisione, e quindi una più elevata probabilità che si formi un’opinione informata e consapevole, in grado di farsi opinioni e convinzioni più meditate e consapevoli, nella ricchezza della varietà delle preferenze politiche. Si può obiettare che negli ultimi anni la vendita dei quotidiani risenta della progressiva diffusione di internet come strumento di informazione Nonostante i limiti (crescenti) di questo indicatore, esso non perso ancora la sua validità, per cui teniamo a mantenerlo, anche in continuità con la ricerca di Putnam e collaboratori (1993). La diffusione media nel biennio 2009-2010 dei quotidiani ogni 1.000 abitanti evidenzia differenze regionali particolarmente rilevanti, con tre regioni che esibiscono una diffusione particolarmente elevata: Trentino-Alto Adige, Liguria e Friuli-Venezia Giulia; in queste tre regioni circolano circa 130-140 copie al giorno ogni 1.000 abitanti. All’opposto, le regioni con la media più bassa di quotidiani diffusi sono, in senso decrescente, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Campania, le sei regioni più meridionali della Penisola, con una diffusione media che è anche tre-quattro volte minore di quella delle regioni con le medie più alte (tab. 1, seconda colonna). La diffusione del volontariato come indicatore della comunità civica ci impone l’obbligo di esplicitare alcune cautele per evitare una visione idealizzata del mondo del Terzo settore . In primo luogo esso comprende soggetti di natura assai eterogenea, dai donatori di sangue alle cooperative sociali cui i comuni appaltano servizi educativi e sanitari, dai circoli del tennis dei quartieri alti alle mense parrocchiali per poveri e clochard. La dimensione oblativa a favore di, svantaggiati e sofferenti è distribuita in modo tutt’altro che equo in questa variegata tipologia, la cui eterogeneità è stata oltretutto favorita dai vantaggi fiscali e contributivi riconosciuti dalla legge a cooperative, onlus e fondazioni (Moro 2014). Peraltro, in una dimensione diacronica, la storia del Terzo settore in Italia è profondamente intrecciata con i processi di costruzione delle subculture politiche territoriali cui si è fatto un rapido riferimento nel primo paragrafo (sul punto, si confronti in particolare Trigilia 1987 e Almagisti 2009). Poste queste riserve, tuttavia, non minano il rilievo sistemico del terzo settore come ambito privilegiato di generazione, espressione e riproduzione dell’azione oblativa, disinteressata, verso gli altri, ben al di là dei vincoli posti dai legami primari e ascrittivi. Per cercare di disegnare in modo più netto il mondo dell’oblazione e della solidarietà, si è deciso di considerare soltanto le istituzioni operanti nel settore di attività dei servizi di assistenza sociale (offerta di servizi reali alla collettività o a categorie di persone),. In questo modo si sono selezionate 29.550 unità locali, pari all’8,5% delle circa 347mila unità censite dall’Istat nel Censimento delle istituzioni del terzo settore del 2011. Il numero di volontari attivi per regione è stato relativizzato alla popolazione residente. Il nostro indicatore, dunque, rileva il numero di volontari delle istituzioni del non profit attive nel settore dell’assistenza sociale ogni mille residenti. I valori assunti sull’indicatore dalle venti regioni italiane sono presentati in tabella 1 (terza colonna). Anche rispetto a questo indicatore si può cogliere nitidamente un certo divario lungo la direttrice Nord-Sud. Basti evidenziare che nelle undici regioni del Centro-Nord in media operano nelle istituzioni non profit dell’assistenza sociale più di nove volontari ogni mille residenti, mentre nelle nove regioni del Centro-Sud tale quoziente è pari alla metà esatta (4,8 per mille residenti). L’altruismo disinteressato e il dono del sé trova forse la sua più limpida espressione e manifestazione nella donazione del sangue. Proprio per questa sua specificità, la donazione di sangue è da tempo oggetto di rilevanti riflessioni teoriche (tra le altre si veda Titmuss 1970) che ne hanno messo in evidenza la particolarità rispetto alle caratteristiche generali del dono e dei circuiti della reciprocità, anche perché la donazione di sangue costituisce Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 55 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 l’esempio più noto e diffuso di dono anonimo. La donazione di sangue costituisce un indicatore di capitale sociale non solo in quanto caso paradigmatico di oblazione e responsabilità verso gli altri ma anche perché esso si attua quasi sempre attraverso una rete di associazioni, che implicano attivisti, forme di promozione, risorse organizzative e strumentali (anche se è possibile la donazione diretta presso le strutture sanitarie). In Italia sono attive molteplici associazioni che si occupano del reperimento del sangue, come Avis, Fidas, Advs, Fratres, Adsint e altre ancora, spesso distribuite geograficamente non in modo non uniforme sul territorio, con un particolare deficit di strutture nel Sud del Paese. I dati relativi alle donazioni di sangue in Italia pubblicati dall’Istituto superiore di sanità sono riferiti al 2008. La tabella 1 (quarta colonna) indica l’Emilia-Romagna al primo posto per numero di donazioni ogni 1.000 residenti (57,8), che supera di poco il Friuli-Venezia Giulia (57,4). Seguono Veneto, Piemonte e Lombardia, che superano nella classifica delle donazioni Marche, Valle d’Aosta, Umbria, Trentino Alto Adige, Toscana e Liguria. Le prime regioni centro-meridionali che si incontrano in classifica sono il Molise - dodicesima con 44,6 donazioni ogni 1.000 abitanti - e la Sardegna. Se si esclude il Lazio, al terz’ultimo posto, tutti gli ultimi posti della graduatoria sono occupati dalle regioni più meridionali della Penisola: Puglia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia e, agli ultimi due posti, Calabria e Campania. Quest’ultima, con un numero di donazioni pari a 24,7 per mille abitanti, fa registrare un quoziente molto inferiore alla metà di quello delle regioni collocate ai primi posti della graduatoria, con valori vicini a 58. In sintesi, è emersa una notevole sovrapposizione della distribuzione territoriale dei quattro indicatori, con geografie che presentano tutte una marcata differenza tra regioni centro-settentrionali e meridionali. Questa affinità può essere meglio apprezzata osservando la tabella 2, che riporta la matrice dei coefficienti di correlazione r, che esprimono in termini statistici la congruenza tra i quattro indicatori. I coefficienti sono tutti positivi e superiori a 0,50, fino al +0,74 calcolato fra numero di volontari e diffusione dei quotidiani. In un solo caso il coefficiente è nettamente più basso: +0,17 calcolato fra partecipazione elettorale e lettura dei quotidiani. Ciò è dovuto al caso peculiare della Sardegna, sopra richiamato, in cui si è osservata un’elevata partecipazione invisibile (la diffusione dei quotidiani) e una bassa partecipazione visibile (l’affluenza alle urne). Tab. 2 - Matrice di correlazione fra i quattro indicatori utilizzati per la costruzione dell’indice finale di capitale sociale su 20 regioni. Valori coefficiente r Diffusione quotidiani Partecipazione elettorale Donazione sangue Partecipazione elettorale +0,17 Donazione sangue +0,54 +0,62 -- Volontari non profit +0,74 +0,59 +0,65 Stabilita la relazione statistica fra i quattro indicatori utilizzati, si può individuare anche una loro differente capacità di discriminazione, difficile da osservare se restiamo ai dati originali raccolti ma di immediata lettura una volta trasformati in numeri-indice, ponendo il valore medio nazionale di ogni indicatore uguale a 100. La trasformazione in numeri-indice permette di individuare le dimensioni su cui le regioni sono più vicine e più lontane, al di là delle analogie geografiche. La partecipazione elettorale risulta così la dimensione che discrimina di meno le regioni, attestando gli effetti omogeneizzanti delle regole democratiche. Ma se da un’ottica di ampio respiro passiamo a una considerazione più attenta alla congiuntura degli ultimi anni, che ha visto una progressiva caduta della partecipazione elettorale, nelle ridotte differenze in termini di partecipazione elettorale si può leggere il segno di un’ondata di disaffezione e di frustrazione degli elettori che ha investito tutto il paese. Più profonda è la frattura che si riscontra nella lettura dei giornali e nella diffusione del volontariato. Su queste dimensioni le regioni del Nord vantano un livello di comunità civica tre o quattro volte superiore a quella delle regioni meridionali - differenze ben più ampie di quelle in termini di redditi procapite. Le donazioni di sangue disegnano due Italie un po’ meno lontane, grazie alla crescita sensibile delle donazioni avvenuta nelle regioni 56 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci meridionali. Accertate queste somiglianze fra gli indicatori, si è deciso di procedere alla costruzione di un indice finale, costituito dalla media dei valori dei indicatori, trasformati in numeri-indice di ciascuna regione, ponendo a 100 la media nazionale, che è anche la media nazionale anche dell’indice finale. Tab. 3 - Numeri-indice relativi ai quattro indicatori di capitale sociale e Indice finale di capitale sociale. Dati per regione, valore minimo, valore massimo e coefficiente di variazione.Trattandosi di numeri indici la media nazionale è pari a 100 per ogni indicatore. REGIONI Partecipazione elettorale (n. indice) Copie di quotidiani (n. indice) Volontari (n. indice) Donazioni di sangue (n. indice) Indice Finale Capitale Sociale (n. indice) Piemonte 104,1 86,9 120,0 118,5 107,4 Valle d’Aosta 97,7 120,8 78,6 108,5 101,4 Lombardia 107,9 107,1 141,4 111,3 116,9 Liguria 99,0 182,4 108,6 104,0 123,5 Trentino-Alto Adige 102,3 186,7 184,3 104,3 144,4 Veneto 108,6 104,6 127,1 119,4 114,9 Friuli Venezia Giulia 101,1 158,5 117,1 133,9 127,6 Emilia-Romagna 111,3 129,9 145,7 134,8 130,4 Toscana 107,1 117,6 140,0 104,3 117,2 Umbria 109,7 77,9 87,1 107,3 95,5 Marche 107,5 87,1 108,6 110,6 103,4 Lazio 100,7 102,8 101,4 72,5 94,4 Abruzzo 99,5 77,6 78,6 86,5 85,5 Molise 99,7 44,5 68,6 104,0 79,2 Campania 94,6 37,9 45,7 57,6 58,9 Puglia 97,4 48,7 57,1 89,6 73,2 Basilicata 96,6 51,0 78,6 82,8 77,3 Calabria 86,5 61,5 64,3 71,6 71,0 Sicilia 85,7 72,7 52,9 80,7 73,0 Sardegna 82,4 144,6 102,9 97,7 106,9 MEDIA ITALIA 100 100 100 100 100 Minimo 82,4 37,9 45,7 71,6 58,9 Massimo 111,3 186,7 184,3 134,8 144,4 Campo di variazione 28,9 148,8 138,6 63,2 85,5 La distribuzione dell’Indice di capitale sociale (ultima colonna della tabella 3) segnala la divisione del Paese in due grandi aree, il Centro-Nord e il Sud, con una sorta di area intermedia costituita dalla fascia centrale di Lazio, Abruzzo e, in parte, Molise. A Nord la regione dotata della maggiore dotazione di capitale sociale risulta il Trentino-Alto Adige, al primo posto per diffusione dei quotidiani e volontari nell’assistenza sociale. Segue l’Emilia-Romagna, prima per partecipazione elettorale e donazioni di sangue. Il Friuli-Venezia Giulia è al terzo posto grazie soprattutto all’elevata diffusione dei quotidiani. Seguono Liguria, Toscana e Lombardia, che precedono altre due regioni del Nord: nell’ordine, Veneto e Piemonte. Da notare il nono posto della Sardegna, che si posiziona davanti a Marche, Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 57 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 Valle d’Aosta e Umbria. A costituire una sorta di cintura mediana, fra la tredicesima e la quindicesima posizione, come abbiamo detto si trovano Lazio, Abruzzo e Molise. Sono tutte collocate a Sud di questa fascia le regioni che fanno registrare i punteggi più bassi, con la Campania all’ultimo posto. In sostanza, la dimensione Nord-Sud si conferma l’unico asse intorno a cui si sviluppano le differenze più sensibili. La fiducia generalizzata: un indicatore difficile da utilizzare La fiducia generalizzata - detta anche fiducia morale o universalista - è quella che nutriamo nei confronti delle persone che non conosciamo. Nasce dalla convinzione di condividere con gli altri un destino comune ed estende il senso di responsabilità al di là delle ristrette cerchie parentali o amicali di appartenenza. Per questo è sistematicamente citata come una delle dimensioni del capitale sociale6. Essa alimenta in particolare il capitale sociale bridging, tipico delle comunità aperte, capace di allargare i confini della solidarietà verso il diverso e favorire meccanismi istituzionali volti all’inclusione. In termini analoghi a quelli visti nel caso del capitale sociale, anche nel definire la fiducia è possibile rintracciare due distinte prospettive interpretative: la fiducia strategica, fondata sul calcolo dell’affidabilità del fiduciario (quindi intesa come una scelta di natura razionale), e la fiducia percepita come affidamento incondizionato. La fiducia strategica è fondamentale per comprendere quella parte del comportamento umano che ha a che vedere con il principio dell’utilità e dell’interesse, mentre il concetto di fiducia identitaria permette di approfondire le azioni connesse a una razionalità rispetto al valore. La fiducia identitaria è l’affidamento tipico del fedele, del missionario, del patriota. Questa fiducia si pone, per Simmel, «al di là della conoscenza e dell’ignoranza… [È quella fiducia che] si chiama fede di un uomo in un altro… [che] non è mediata né da esperienze né da ipotesi, ma è un comportamento primario dell’anima in rapporto all’altro» (1908: 299). Così dunque troviamo anche nel concetto di fiducia la stessa polarizzazione segnalata per il concetto di capitale sociale: una interpretazione fondata sulla responsabilità e, in ultima istanza, in un vincolo per l’individuo rispetto alla comunità si contrappone ad una che ne sottolinea la natura strategica, come strumento utile per il perseguimento di interessi individuali. Come segnalato in precedenza, Putnam e gli altri studiosi del capitale sociale sono concordi nell’inserire la fiducia (interpersonale e istituzionale) fra i tratti del capitale sociale. Questa tuttavia non compare mai nelle indagini territoriale sulla diffusione locale del capitale sociale in quanto i dati relativi alla fiducia sono di solito raccolti con sondaggi, la cui rappresentatività è garantita solo al livello nazionale e non per livelli inferiori, a causa del ridotto numero di casi che ricadono nelle singole partizioni regionali o locali. In questo lavoro noi abbiamo potuto utilizzare i dati tratti , dalle indagini Multiscopo sulle famiglie («Aspetti della vita quotidiana») organizzate dall’Istat tra il 2010 e il 2012, in modo da accedere alle risposte di oltre 142.000 intervistati. Con un campione di soggetti così ampio che ha risposto alle stesse domande si apre dunque la possibilità di confrontare i livelli di fiducia sistemica delle singole regioni, per ciascuna delle quali è disponibile un numero di osservazioni in grado di garantire la rappresentatività statistica dei sub campioni. e poter analizzare i dati secondo la regione di residenza degli intervistati. La domanda impiegata per rilevare la fiducia negli altri è simile a quella usata nelle maggior parte delle indagini internazionali sul tema7: «lei generalmente pensa che ci si possa fidare della maggior parte della gente oppure che bisogna stare molto attenti?» (la risposta prevista è dicotomica). 6 Parte delle considerazioni sul concetto di fiducia presentate in questo capitolo sono tratte da Bordandini 2014 - voce “Fiducia in Italia” Istituto dell’Enciclopedia Italiana. 7 Ci riferiamo ad esempio alle domande proposte nei questionari della World Value Survey, della European Value Study o della European Social Survey, dove però i campioni di italiani intervistati non superano mai le 1000-2000 unità. 58 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci Tab. 4 - Distribuzione di frequenza percentuale e numeri indici relativi alla fiducia generalizzata. Analisi per regione, media nazionale, valore minimo, valore massimo e coefficiente di variazione. REGIONI FIDUCIA GENERALIZZATA % fiduciosi N INDICE Piemonte o Val d’Aosta 24,3 112,0 Lombardia 23,8 109,7 Liguria 27,7 127,6 Trentino-Alto-Adige 36,4 167,7 Veneto 22,2 102,3 Friuli-Venezia Giulia 27,3 125,8 Emilia-Romagna 22,3 102,8 Toscana 22,2 102,3 Umbria 21 96,8 Marche 20 92,2 Lazio 23,9 110,1 Abruzzo 20,2 93,1 Molise 17,3 79,7 Sardegna 22,3 102,8 Campania 15,8 72,8 Puglia 16,6 76,5 Basilicata 15,1 69,6 Calabria 18,3 84,3 Sicilia 14,9 68,7 MEDIA ITALIA 21,7 100 Minimo 15,1 69,6 Massimo 36,4 167,7 Campo di. variazione 21,3 98,2 Fonte: i dati dalle indagini Multiscopo sulle famiglie - Aspetti della vita quotidiana - anni 2010-2012. La tabella 4 mostra le percentuali di italiani che si fidano (e relativi numeri indice) per ogni regione italiana. In media meno del 22% degli italiani si fidano degli altri e questa percentuale scende di oltre cinque punti nelle regioni del Sud. Se in Trentino-Alto Adige il 36% degli intervistati dichiara di potersi “fidare della maggior parte della gente”, nelle restanti regioni del Nord e del Centro Nord i valori si aggirano intorno al 22-27%, mentre nel Sud non superano quasi mai il 16-17%. Si tratta di un esito del tutto coerente con la mappa del capitale sociale fondata su dati aggregati: il coefficiente di correlazione è pari a +0,87, un valore elevato soprattutto considerando l’eterogeneità delle fonti dei dati posti a confronto. E ciò non sorprende. Come suggerisce Putnam (2000), la fiducia generalizzata condiziona tutti quei prerequisiti (dalla partecipazione politica e sociale all’interesse per la «cosa pubblica») che i cittadini dovrebbero avere per cooperare tra loro e valutare in modo adeguato le scelte compiute dai governanti. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 59 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 Fig. 1 - La relazione tra l’indice di capitale sociale e la fiducia generalizzata (Numeri-indice). Il valore 100 su entrambi gli assi corrisponde alla media Italia La figura 1 rappresenta, mediante un diagramma a dispersione, la relazione tra fiducia generalizzata e capitale sociale. Sulla base dei quattro quadranti costruiti partendo dalle medie delle due variabili (essendo numeri-indice si tratta del valore 100), è facile notare come nel secondo quadrante si collochino tutte le regioni del Nord e del Centro-Nord (con la sola eccezione della Sardegna); mentre nel terzo quadrante troviamo principalmente le regioni del Sud e del Centro-Sud. Il quadro che emerge attesta un appannamento delle tradizionali eccellenze che caratterizzavano la “Terza Italia”. Le aree che hanno conosciuto una subcultura politica territoriale forte si sono infatti avvicinate alle altre centro-settentrionali. L’unica regione che veramente si distingue rispetto alle altre del Nord è il Trentino-Alto Adige, in virtù di un’elevata fiducia generalizzata. Dall’analisi della figura 4 esce comunque confermata la frattura fondamentale tra un Nord più dotato di comunità civiche e più aperto a orizzonti di fiducia generalizzata e un Mezzogiorno più chiuso. L’introduzione 60 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci della variabile cruciale che rileva la fiducia generalizzata, riportando le risposte di oltre 140.000 cittadini, rende ancora più preciso il quadro del divario, replicando con variazioni minime l’esito delle rilevazioni con dati aggregati relativi alla partecipazione politica (visibile e invisibile) e al volontariato. E’ un quadro che rende sempre più urgente una riflessione, da parte della politica ma anche degli intellettuali, sulle modalità per cui si possa rigenerare la qualità della nostra etica pubblica e costruire (o ricostruire) una comunità civica nel nostro Paese. Che la frattura in termini di capitale sociale tenda a sovrapporsi con quella economica è di tutta evidenza. Abbiamo misurato questa correlazione utilizzando sia il Pil pro-capite del 2006 (ultimo anno ante-crisi) sia quello del 2012, in modo da tenere sotto controllo l’eventuale effetto della crisi economica (tab.5). I valori dei coefficienti risultano molto elevati sia per l’indice di capitale sociale rilevato con dati aggregati (oltre 0,80), sia per l’indice di fiducia generalizzata rilevato con dati individuali (almeno 0,75). In particolare i coefficienti relativi al 2012 risultano più elevati di appena due centesimi: l’unico flebile indizio che la più grave crisi di questo dopoguerra abbia avuto un ruolo sul divario Nord-Sud in termini di capitale sociale. Tab. 5 - Matrice di correlazione fra indice di capitale sociale,fiducia generalizzata, PIL pro-capite per regione 2006 e Pil procapite per regione 2012.Valori del coefficiente r. Indice di capitale sociale Indice di fiducia generalizzata Pil pro-capite 2006 +0,82 +0,75 Pil pro-capite 2012 +0,84 +0,77 Non è questa la sede per discutere il nodo problematico della direzione della relazione causale tra reddito e capitale sociale. Putnam e collaboratori erano stati forse sbrigativi nel rinvenire la ragione storico-culturale del divario di civicness tra Nord e Sud, ma hanno avuto il merito di escludere ogni plausibilità di spiegazioni economicistiche di quel divario. In questo lavoro non è possibile tematizzare l’interrogativo sulle origini del divario e sulle modalità per cui esso è arrivato fino all’inizio del XXI secolo. E’ possibile però documentare che questo divario è più grave di quello rilevato a livello di Pil. Nella tabella 6 abbiamo affiancato ai nostri due indici i due Pil procapite relativi al 2006 e al 2012. Anche in questo caso il ricorso ai numeri-indice consente di confrontare i campi di variazione di variabili eterogenee: le differenze tra le regioni con valori estremi sono più sensibili in termini di capitale sociale e di fiducia (86 e 99, rispettivamente) che non in termini di Pil pro capite (69 e 72, per il 2006 e il 2012). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 61 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 Tab. 6 - Numeri indici per regione relativi a capitale sociale, fiducia generalizzata, Pil pro-capite 2006 e Pil-pro-capite 2012. REGIONI Indice Finale Capitale Sociale (n. indice Italia=100) Fiducia generalizzata (n. indice Italia=100)) PIL pro capite2006 (n. indice Italia=100) PIL procapite2012 (n. indice Italia=100) Piemonte 107 112 112 109 Valle d’Aosta 101 112 133 135 Lombardia 117 110 127 129 Liguria 124 128 103 106 Trentino-Alto Adige 144 168 126 129 Veneto 115 102 117 115 Friuli Venezia Giulia 128 126 114 114 Emilia-Romagna 130 103 125 124 Toscana 117 102 108 110 Umbria 96 97 95 90 Marche 103 92 102 100 Lazio 94 110 118 115 Abruzzo 86 93 83 85 Molise 79 80 78 75 Campania 59 73 65 63 Puglia 73 77 67 66 Basilicata 77 70 69 69 Calabria 71 84 64 63 Sicilia 73 69 66 64 Sardegna 107 103 75 75 MEDIA ITALIA 100 100 100 100 Minimo 59 69 64 63 Massimo Campo di variazione (Maxmin) 144 168 133 135 86 99 69 72 Per concludere: se le clientele funzionano perché cambiare? Lo scarso senso civico non è un dato genetico che si ripresenta invariato nel tempo. La scarsa fiducia non è ineluttabile. In Italia si è perpetuata perché è sopravvissuta la presenza di reti clientelari, di favoritismi, di eventi sociali e politici in cui la fiducia (negli altri e nelle istituzioni) e il senso di responsabilità nei confronti degli altri non potevano trovare un terreno adatto per crescere. Di fronte alla consapevolezza della profonda mancanza di corresponsabilità sociale e dell’incapacità delle istituzioni di frenare il particolarismo crescente, il comportamento strategico e opportunistico nonché la gabbia della fiducia a corto raggio diventano scelte obbligate, una sorta di 62 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci prontuario di sopravvivenza in un contesto istituzionale che non garantisce diritti e doveri uguali per tutti i cittadini e in un’arena-mercato in cui le regole vengono sovente piegate da corruzione e privilegi politici. Il problema dell’Italia in questa lunga congiuntura politica ed economica è che senza un robusto senso di coesione sociale, e un tessuto di vita quotidiana improntato all’apertura e alla corresponsabilità verso gli altri, una democrazia di qualità non ha alcuna possibilità di imporsi e la stessa ripresa economica diventa problematica - la fiducia è, come noto, una variabile chiave nelle previsioni economiche. Una buona democrazia presuppone una fiducia interpersonale capace di oltrepassare le ristrette cerchie di parenti, amici e clientele oltre che una fiducia istituzionale alimentata da efficienza delle istituzioni e meccanismi efficaci di accountability verticale e orizzontale, in grado di garantire un sostegno diffuso al sistema anche nei momenti difficili, crisi economiche incluse. Su questo sfondo problematico trova piena conferma, poi, il divario di comunità civica che appare cristallizzato. Il congelamento di cui parlava Rokkan in merito ai cleavages interni ai diversi sistemi politici europei appare, nel caso della frattura tra Nord e Sud del nostro Paese, più una perizia tecnica che una metafora suggestiva. Se Putnam e collaboratori avevano semplificato l’origine della frattura rinviandola alla contrapposizione del XII secolo tra civiltà comunale e monarchia normanna, avevano comunque ragione nel guardare indietro sulla scala della lunga durata. Come si è anticipato poc’anzi, non c’è spazio per aprire il problema delle ragioni di questa insanabile frattura, corroborata anche dai dati sulla fiducia interpersonale. Dobbiamo almeno segnalare che - per restare all’Italia repubblicana - le stesse modalità con cui si è sviluppato l’intervento straordinario nel Mezzogiorno hanno finito per creare un gigantesco effetto perverso. A parte la scelta discutibile di puntare sull’industrializzazione per poli di sviluppo, le ingenti risorse destinate a questi investimenti sono state in molti casi gestite in modo da alimentare le clientele politiche tradizionali. In tal modo quella modernizzazione economica che doveva fungere da volano per il cambiamento culturale del Mezzogiorno si è trasformata nel suo contrario: una potente cura rigenerante per i meccanismi clientelari tradizionali, che si sono rivelati la soluzione più efficiente per risolvere i problemi di povertà e disoccupazione distribuendo benefici particolaristici piuttosto che beni pubblici che favorissero lo sviluppo - e tutto ciò grazie al sistema proporzionale con voto di preferenza. Se le clientele funzionano perché cambiare? Tra i molti responsabili di questa dinamica perversa, che è del tutto inadeguato chiamare sperpero, occorre dunque annoverare ai primi posti le classi dirigenti meridionali, a prescindere dalle appartenenze partitiche. E’ ovvio che argomentazioni di questo tipo potrebbero essere sviluppate anche in altre direzioni e per epoche precedenti all’avvento della Repubblica - per non parlare delle causalità circolari relative alla presenza delle mafie. In questo lavoro, tuttavia, l’ottica è metodologica e descrittiva e non ha alcuna pretesa di offrire ricostruzioni storiche. Come si è detto, si tratta semmai di segnalare l’urgenza di soluzioni politiche. Il quadro offerto nei paragrafi precedenti attesta non solo la persistenza della frattura territoriale ma anche l’appannamento del primato delle regioni che hanno goduto per decenni dei benefici delle subculture politiche territoriali. Forse non è un caso che guadagnino il primato della comunità civica le due regioni più periferiche - Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia - le ultime che sono entrate a far parte del Regno d’Italia, meno di un secolo fa. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 63 Paola Bordandini, Roberto Cartocci DOI: 10.1400/228741 Riferimenti bibliografici Accetturo A., De Blasio G. (2014), Il capitale sociale e l’economia, in G. Barone, G. De Blasio, P. Sestito, a cura di, Capitale sociale, economia, politica economica, Banca d’Italia. http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2014-0017/Capitale-sociale-n-17.pdf Almagisti M.(2011), La qualità della democrazia in Italia. Roma: Carocci. Almond G. A., Sidney Verba S. (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton: Princeton University Press. Baccetti C., Caciagli M. (1992), Dopo il PCI e dopo l’URSS: Una subcultura rossa rivisitata, in «Polis» VI, 3: 537-568. Baccetti C., Caciagli M. (1994), Dal divorzio alla caccia. Il declino della subcultura rossa in Toscana, in M. Caciagli, P.V. Uleri (a cura di), Democrazie e referendum, Bari: Laterza. Baccetti C., Messina P. (2009, a cura), L’eredità. Le subculture politiche della Toscana e delVeneto, Padova: Liviana. Bagnasco A. (1977), Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna: Il Mulino. Banfield E.C. (1958), The Moral Basis of a Backward Society, Glencoe: Free Press; trad. it., Le basi morali di una società arretrata, Bologna : Il Mulino, 2010. Becker G. (2000), De gustibus, dal tabagismo al matrimonio: la spiegazione economica delle preferenze, Milano: Egea. Bordandini P. (2014), Fiducia in Italia, in M. Salvati e L. Sciolla (a cura di), L’Italia e le sue regioni (1945-2011), Vol IV, Istituto dell’Enciclopedia italiana. Bordandini P. (2006), Cultura politica e piccola impresa nell’Italia plurale, Acireale-Roma: Bonanno. Bourdieu P. (1980), Le capital social. Notes provisoires, in «Actes de la recherche en sciences sociales». Caciagli M. (1988), Quante Italie? Persistenza e trasformazione delle culture politiche subnazionali in «Polis», II, 3: 429457. Cartocci R. (2011), Political Culture, in B. Badie, D. Berg-Schlosse, L. Morlino (a cura di), International Encyclopedia of Political Science, Vol. 6., Los Angeles: Sage. Cartocci R. (2007), Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Bologna: Il Mulino. Cartocci R., Vanelli V. (2014), Una mappa del capitale sociale e della cultura civica in Italia, in M. Salvati, L. Sciolla (a cura di), L’Italia e le sue regioni (1945-2011), Vol. IV, Roma: Istituto dell’Enciclopedia italiana. Fideli R. (1998), La comparazione, Milano: Franco Angeli. Foderà R., Pavolini E. (2014), Mappe del capitale sociale in Italia, in P.F. Asso, E. Pavolini (a cura di), Collaborare per crescere, Roma: Donzelli. Marradi A. (1980), Concetti e metodi in scienza politica. Firenze, La Giuntina. Messina P. (2001), Regolazione politica dello sviluppo locale.Veneto ed Emilia Romagna a confronto. Torino: Utet. Parisi A., Pasquino G. (1977), Relazioni partiti-elettori e tipo di voto, in Parisi e Pasquino (a cura di), Continuità e mutamento elettorale in Italia, Bologna: Il Mulino. Parsons T. (1951) The social System. Glencoe: the Free Press. Parsons T., Shils E. (1962), Towards a General Theory of Action, New York: Harper & Row. Putnam R.D. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York; trad. it., Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in America, Bologna 2004. Putnam R. D. (1993), Le tradizioni civiche nelle regioni Italiane. Milano, Bompiani. 64 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228741 Paola Bordandini, Roberto Cartocci Putnam R. D., Leonardi R., Nanetti R. (1985), La pianta e le radici. Il radicamento dell’istituto regionale nel sistema politico italiano, Bologna: Il Mulino. Ramella F. (2005), Cuore Rosso?Viaggio politico nell’Italia di mezzo, Roma: Donzelli. Schein E. H. (1988), Organizational Culture, Sloan School of Management, MIT, WP 2088-88, pp. 1-50. Sciolla L. (2004), La sfida dei valori. Rispetto delle regole e rispetto dei diritti in Italia, Bologna:Il Mulino. Simmel G. (1908), Soziologie: Untersuchungen über die Formen derVergesellschaftung, Berlin; trad. it., Sociologia, Milano 1989). Titmuss R. (1970), The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy, London: Allen & Unwin. Trigilia C. (1986), Grandi partiti e piccole imprese. Comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa, Bologna: Il Mulino. Tullio-Altan C. (1986), La nostra Italia, Milano: Feltrinelli. Weber M. (1922), Wirthschaft und Gesellschaft, Tubingen: Mohr; trad. it., Economia e società, Milano, Comunità, 1961. Wallace R. A., Wolf A. (2006), La teoria sociologica contemporanea, Bologna: Il Mulino. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 65 66 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228742 Antonio Floridia [Il cambiamento delle culture politiche in Italia] Note per un programma di ricerca Title: The Changing Political Cultures in Italy: Notes for a Possible Research Program Abstract: The paper proposes, in a non-systematic ways, a discussion of some issues that may be the subject of a new phase of research on the subject of political culture in Italy. First, it addressed the issueof the persistence of territorial differentiation of the political culture in Italy: are still valid those interpretative categories that featured a long period of studies on this issue? The interplay between general and nifying trends and persistence of a territorial political culture is then analyzed, taking as an example the case of the electoral success of the Five Star Movement. Finally, it discusses the transformation of the political culture in Tuscany, one of the “red regions” where the ideal-typical model of “territorial political subculture” has emerged historically in a form almost “pure”. Is this model still valid? and what are the changes that have occurred? Keywords: Political cultures, Participation, Local political subcultures. 1. L’obiettivo di queste note è quello di proporre, in modo non sistematico, alcuni temi di riflessione che possano contribuire ad una nuova stagione della ricerca teorica e empirica sulla cultura politica in Italia e sul senso delle sue trasformazioni. Quelli che vorremmo porre sono alcuni interrogativi radicali sulle “domande giuste” che una ricerca su questi temi oggi riteniamo debba proporsi. Naturalmente, non occorre qui ricordare quanto centrale sia stato questo tema nell’ambito della ricerca sociologica e politologica sul nostro paese. Fino agli inizi degli anni Novanta, il quadro teorico - ma poi anche i discorsi correnti, sulla stampa o nel “senso comune” dei settori più colti dell’opinione pubblica - presentavano una singolare ambiguità. Da una parte, vi era una riflessione che puntava fortemente sull’articolazione territoriale delle culture politiche (al plurale), ed è stato – com’è ben noto - un filone di studi di grande qualità e rilevanza, che ha contribuito non solo alla conoscenza delle subculture politiche territoriali, ma anche a quella del complessivo “equilibrio” (o “squilibrio”) dello sviluppo italiano1. Dall’altra parte, mentre proseguiva una tradizione di analisi, più o meno di maniera, sul “carattere degli italiani”2, su un piano politologico si proponevano analisi fondate invece 1 Testi fondativi di questo filone di studi sulla società e sulle diverse aree regionali italiane sono stati il lavoro di Arnaldo Bagnasco sulle Tre Italie (1977) e quello di Carlo Trigilia su Grandi partiti e piccole imprese (1986). Negli anni successivi, numerosi studi sociologici e politologici si sono misurati su questo terreno, cercando di cogliere i mutamenti che caratterizzavano le due grandi aree “subculturali” del nostro paese, quella “rossa” (o dell’“Italia di mezzo”, come più correttamente la definiva Ramella 2005), con i lavori di Caciagli (1990, 2009) e Caciagli-Baccetti (1992); e quella del Nord-Est, un tempo “bianca”, e a lungo invece segnata dal “verde” dell’egemonia politica e culturale della Lega Nord (Diamanti 1996, 2009, Almagisti 2008, 2009). Altri autori hanno analizzato “l’eredità” due grandi subculture politiche italiane (Baccetti-Messina 2009; Floridia 2009, 2010), mentre nuovo rilievo hanno assunto gli studi sul capitale sociale (Cartocci 2007), dopo che il noto lavoro di Putnam (1993) aveva assunto proprio il tema delle “tradizioni civiche” come chiave esplicativa della diversità dei sentieri storici dello sviluppo tra le regioni italiane e dello stesso “rendimento” differenziato delle loro istituzioni. Uno dei più recenti, e caustici, contributi sulla cultura politica degli italiani è il saggio di Mario Caciagli (2010). Un capitolo della Storia dell’Italia repubblicana, pubblicata da Einaudi (Trigilia 1995) offriva una sintesi delle complementarità che hanno caratterizzato i diversi modelli regionali di sviluppo. 2 Ricordiamo che uno dei testi migliori, in questo genere, fu il saggio di Giulio Bollati (1983). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 67 Antonio Floridia DOI: 10.1400/228742 sulle contrapposizioni ideologiche che attraversavano la cultura politica italiana: un approccio che, nel linguaggio corrente, si richiamava talora alle “due chiese” e che portava al grande successo di formule come quella del “bipartitismo imperfetto” di Giorgio Galli. In sede scientifica, la categoria del “pluralismo polarizzato”, proposta da Giovanni Sartori, si rivelava quella che maggiormente sembrava attagliarsi al sistema politico italiano. I due piani si sovrapponevano, ma non coincidevano: se i due “poli” ideologicamente connotati della cultura politica degli italiani avevano le loro “fortezze territoriali”, d’altra parte erano ben presenti anche nel resto del paese, in forza e in misura diversa. E poi c’era un grande interrogativo: il Meridione, che “cultura politica” esprimeva?… Sin dai tempi in cui apparve il noto lavoro di Banfield sul “familismo amorale” (1958; nuova ed. it., 2010), la questione è stata sempre controversa, e la debolezza, o l’assenza, di grandi identità collettive nel Sud (o il prevalere di una cultura politica “particolaristica”) sono stati aspetti cruciali nell’interpretazione dei modelli di sviluppo del Mezzogiorno3. Come che sia, la fine della Guerra Fredda e la fine del sistema politico che aveva caratterizzato il primo quarantennio repubblicano, hanno rimesso in discussione tutto, anche le categorie interpretative sulla “cultura politica” degli italiani. Nei due decenni successivi, - nel mentre si consumava una “transizione” del sistema politico italiano dai tempi e dai modi indefiniti, nonostante tutti i tentativi di “chiuderla” - si spostavano i termini del problema. Per quanto riguarda le subculture politiche territoriali, al centro dell’attenzione si poneva ora il tema dell’“eredità”: ovvero, se e in quali termini il lascito delle culture politiche che avevano caratterizzato un quarantennio di storia repubblicana, fosse scomparso del tutto, o sopravvissuto in qualche modo, o si fosse trasformato. Le “mappe” elettorali hanno continuato ad essere uno strumento decisivo nell’interpretazione del sistema politico e delle sue evoluzioni (Diamanti 2009). Certo, “mappe” con colori diversi rispetto al passato, - il verde, l’azzurro…-, ma anche con forti elementi di continuità, in particolare in quelle zone che si è continuato a definire “rosse”. A proposito di queste ultime regioni, il dibattito è stato a lungo caratterizzato da un quesito: il perdurante consenso elettorale alle forze di sinistra, in queste aree, poteva essere attribuito ad un effetto inerziale delle tradizioni di cultura politica del passato, o vi erano elementi di rottura e discontinuità? E se sì, quali? Alcune ricerche condotte in Toscana tra il 2008 e il 2009 (De Sio 2011; Floridia 2011), ad esempio, erano giunte alla conclusione che, sì, non fosse più possibile parlare, propriamente, di una “subcultura rossa”, ossia di una precisa cornice ideologica riconducibile alle tradizioni del movimento operaio e socialista; ma che fosse pur tuttavia rintracciabile un più profondo strato di cultura politica, un insieme di orientamenti diffusi che attingevano ad una civicness, ad uno spirito civico che affonda le proprie radici lontano nel tempo ma che riusciva a riprodursi anche al di fuori delle vecchie coordinate ideologiche entro cui, per una lunga fase storica, era stato incastonato. Vedremo, più avanti, se - a distanza di pochi anni - questa lettura si sia rivelata adeguata o sufficiente. Su un piano più generale, emergevano invece interrogativi più radicali: nel 1993, Gian Enrico Rusconi pubblicò un libro dal titolo inquietante, Se cessiamo di essere una nazione: vent’anni dopo, appare ancor più evidente come gli italiani non abbiano una base condivisa di cultura politica, e quanto fragili siano i legami di identificazione tra gli italiani e le istituzioni democratiche. Chissà, forse, senza nemmeno essercene accorti, abbiamo già cessato di essere una nazione. A dispetto degli insistenti richiami alla coesione nazionale (particolarmente vistosi in occasione delle recenti celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità), le varie culture politiche in cui si riconoscono gli italiani hanno molto poco in comune tra loro, e le fratture territoriali continuano ad essere parte costitutiva di questa frantumazione. E rimangono forti, nonostante quel che si dice sulla cosiddetta “fine delle ideologie”, anche le fratture ideologiche: solo, bisogna oggi cercare di capire su quali linee esse si producano e si alimentino. Il tema dell’“eredità” e delle sue trasformazioni, comunque, resta rilevante: non si può pensare che i cambiamenti, anche quelli più radicali, non si pongano comunque in una qualche relazione con il passato. Individuare le metamorfosi delle culture politiche resta un tema cruciale, foss’anche solo per giungere alla conclusione che invece 3 Non possiamo qui, ovviamente, ricordare neanche solo i più recenti contributi all’analisi della “questione meridionale”: è utile però sottolineare come Carlo Trigilia (2012a, 2012b) abbia posto al centro della sua analisi, come chiave esplicativa del persistente divario Nord-Sud, non tanto l’assenza o la carenza di “capitale sociale”, ma fattori specificamente politici, legati al modo di essere e di operare dei sistemi politici locali in connessione con il sistema politico nazionale. 68 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228742 Antonio Floridia alcune loro forme siano “collassate”. Ma occorre anche, crediamo, ripensare anche il quadro teorico con cui si affronta la questione: occorre “azzerare”, per così dire, le categorie interpretative e porsi il problema della loro adeguatezza. Anche quando si dichiari chiusa un’epoca, continuare a pensare il presente solo in relazione a ciò che, di un modello trascorso, non c’è più, rischia comunque di far perdere di vista il mutamento che, magari per altre vie, si è intanto prodotto. 2. Occorre ripartire dal concetto stesso di “cultura politica”: e qui può essere utile riprendere la definizione che ne ha fornito Roberto Cartocci (2011): un «repertorio relativamente coerente di modelli valutativi e cognitivi che permettono ai membri di una comunità politica di dare un senso al proprio ruolo come attori politici». Questa definizione, naturalmente, nella sua sinteticità, solleva alcuni interrogativi radicali, se solo proviamo a trasferirla, qui ed oggi, al nostro paese. In primo luogo: l’Italia, si può propriamente definire una “comunità politica”? Non si può forse dire, paradossalmente, che la fine della Guerra Fredda, che avrebbe dovuto superare le fratture del passato, le abbia visto invece riemergere e trovare nuovo alimento? E che anzi di nuove ne siano sorte? Vent’anni della cosiddetta “Seconda Repubblica” hanno fatto riemergere il sostrato profondo di una cultura politica antidemocratica, antiparlamentare, mai veramente identificatasi con le basi antifasciste della Repubblica. Un sostrato che è rimasto a lungo sommerso, occultato in parte dalle contrapposizioni della Guerra Fredda e riassorbito e, in un certo senso, “depurato” dal filtro che esercitava un partito come la DC. Ed è stata una cultura che ha sempre osteggiato il ruolo dei partiti, ben prima e al di là delle colpe di cui i partiti si sono macchiati (Lupo 2004; Mastropaolo 2000: 45-8). Ma accanto a ciò, non sono mai mancate e oggi riemergono anche forme di ribellismo anarchico, di protesta populista, di rancori diffusi; ed emerge anche il sostanziale fallimento, o tout court l’assenza, di quella che avrebbe dovuto essere una borghesia capitalistica moderata, europeista, modernamente conservatrice… Questo fondo di qualunquismo e di populismo, e questo fallimento delle presunte élite, sono una costante della storia politica italiana, che solo per una fase i grandi partiti democratici di massa sono riusciti a contenere e controllare. Il crollo di questi partiti non è stato sostituito da qualcosa di nuovo e di diverso, ma che riuscisse a mantenere, in qualche modo, il senso di appartenenza ad una “comunità politica”. Come ben sappiamo, al loro posto è subentrato un processo che, generalmente, viene definito di “personalizzazione della leadership”: ma anche questa categoria rischia di rivelarsi ambigua. Anche in passato, non sono certo mancati fenomeni di forte identificazione “popolare” nei maggiori leader politici: da De Gasperi a Nenni e a Togliatti, fino a Berlinguer (l’ultimo esempio di una “personalizzazione” legata a un’identità politica collettiva), la ”cultura politica” degli italiani era fortemente segnata anche da un’identificazione simbolica con un “capo”. Ma ciò avveniva in un contesto in cui, per moltissimi italiani, era normale “sentirsi”, innanzi tutto, parte di una delle famiglie di cultura politica che avevano le proprie radici nella storia nazionale: e il “capo” era amato in quanto sapeva esprimere al meglio quello che tu sentivi di essere, sulla base di una forte identificazione simbolica ma anche politico-culturale. Se, per un quarantennio, - vivendo in un paese e nel quartiere di una città - era normale sapere che quella famiglia era “democristiana” o “comunista”, o che quel rispettabile professionista era un vecchio “repubblicano” o “liberale”, o quell’artigiano fosse socialista, e magari si sapeva anche chi fossero i “nostalgici” del passato regime fascista…beh, oggi, quest’esercizio sembra davvero impossibile… Possiamo cogliere qui un distacco profondo dal passato: le forme e le tradizioni di cultura politica, e le identità collettive in cui si esprimevano, distinguevano e dividevano gli italiani; ma erano anche un fattore di integrazione e di riconoscimento reciproco. Erano il conflitto e il confronto che, nello stesso tempo, creavano un tessuto connettivo e circoscrivevano un terreno comune. Oggi, proprio l’assenza (o il radicale indebolimento) delle appartenenze collettive contribuisce al generale sfarinamento dell’assetto politico e istituzionale del paese4. Quindi, un primo terreno di analisi è il seguente: l’assenza di un “consenso di sfondo”, di un’etica civile, che possa far sentire gli italiani membri di una comunità politica. E quindi, l’interrogativo: se non vi è una “cultura 4 Oggi, quando appare oramai chiara l’indefinitezza e l’inconcludenza della cosiddetta “transizione” dalla “prima” alla “seconda” repubblica, andrebbero riconsiderate le interpretazioni politologiche e storiografiche che rivalutano il ruolo storico, e il ruolo nazionale (coesivo in quanto conflittuale ed aggregante) svolto dai due grandi partiti di massa della storia repubblicana: si veda, per una lettura di questo tipo, Mastropaolo 1996. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 69 Antonio Floridia DOI: 10.1400/228742 politica” che offra una cornice condivisa al cui interno si possa manifestare il conflitto politico, quali sono le forme di cultura politica con cui gli italiani pensano oggi il loro rapporto con la politica, il loro modo di essere “cittadini”? Nell’ambito della teoria e della filosofia politica contemporanea, il tema di un possibile ethos della democrazia è cruciale: basti pensare al grande dibattito che si è sviluppato intorno a John Rawls (1993, ed. it. 2012) e al suo modo di concepire un possibile overlapping consensus (“consenso per intersezione”) come risposta al “fatto del pluralismo”, alla radicale diversificazione di credenze e visioni del mondo (oltre che di interessi) che caratterizza la società contemporanea. Con tutte le opportune mediazioni, non ci si può non interrogare, radicalmente, sull’assenza (o sull’estrema debolezza? o c’è ancora qualche segno di vitalità?) di un’etica della democrazia, oggi, in Italia; ovvero, sulla presenza o meno di un nucleo di valori condivisi (un “riconoscersi” nelle istituzioni democratiche) che accomuni, - anche partendo da visioni del mondo diverse - segmenti diversi dei cittadini italiani. Non solo: l’insistente battage che accompagna (e ha accompagnato da molto tempo) il dibattito sulle riforme costituzionali, i termini stessi con cui viene giustificata la necessità di queste riforme, contribuisce fortemente a delegittimare le istituzioni. Si accredita così l’idea che siano le istituzioni repubblicane la causa dell’“ingovernabilità”, “scaricando” così ogni responsabilità dalla politica, dalla qualità dei gruppi dirigenti (non solo quelli politici), dall’assenza di cultura civica degli italiani stessi…Un comodo alibi, per molti, senza dubbio5. Cominciano ad esserci lavori che studiano il “berlusconismo” da un punto di vista che si sottrae alle contingenze della cronaca politica (Gibelli 2011; Orsina 2013), e sembra oramai condivisa la tesi secondo cui una delle radici del successo di questa forma anomala e inedita di “partito-personale” o “partito-azienda” vada ricercata proprio nella sua capacità di ereditare, riattivare e alimentare alcune linee di frattura ideologiche che hanno attraversato la cultura politica degli italiani. Da una parte, l’“anticomunismo” (come paura atavica nei confronti di tutto ciò che minaccia la proprietà); dall’altra, un misto di anarchismo, diffidenza verso lo Stato, “anti-politica”, privatismo e particolarismo (insofferenza verso le “regole”, la “libertà” intesa come libertà di fare quel che ci pare). E’ stata questa la chiave del successo ideologico del berlusconismo. Dall’altra parte, a distanza di venticinque anni dalla Caduta del muro, appare chiaro come la sinistra italiana non abbia saputo opporre a questi fenomeni se non un atteggiamento difensivo che solo in alcuni momenti (con Prodi e il primo “Ulivo”) è sembrato poter riprendere e rilanciare le migliori tradizioni della cultura politica democratica italiana. Per il resto, con il senno di poi, appare evidente come la “svolta” che ha portato alla fine del PCI, per un verso, era tardiva e, per altro verso, improvvida nei modi: era mancato, prima, un processo di rinnovamento della cultura politica diffusa degli italiani “di sinistra” e della stessa cultura politica dei gruppi dirigenti di quel partito6; mentre poi la “rottura” sarebbe avvenuta su un piano esclusivamente simbolico e identitario, provocando un trauma organizzativo da cui la sinistra italiana non si è più ripresa, contribuendo così ad una destrutturazione complessiva del sistema politico che non ci sembra abbia ancora trovato modo di essere frenata o arrestata. 3.Uno dei temi su cui occorre aprire un “supplemento di indagine” è quello del rapporto tra l’articolazione territoriale del sistema politico e gli orientamenti e le caratteristiche di ciò che possiamo definire in generale come la sfera pubblica, ovvero il luogo con cui si formano e si trasformano gli orientamenti politici e in cui si plasmano gli schemi (i frames cognitivi e valutativi) attraverso cui i cittadini guardano a se stessi come possibili attori politici. La questione può essere anche affrontata da un altro punto di vista: esiste una nuova geografia elettorale italiana? esiste ancora la possibilità di leggere in chiave territoriale i comportamenti elettorali degli italiani (un termometro tra i più “sensibili”, evidentemente, della loro “cultura politica”)? Il dato saliente delle elezioni politiche del 2013, ma anche delle Europee del 2014, va visto nella crescente “volatilità” dell’elettorato: si stima che circa il 40% degli elettori nel 2013 abbia cambiato voto e un dato simile 5 Mastropaolo, già in suo testo del 2000 (p. 44-52), notava come il precipitare della crisi, nel biennio 1992-94, fosse dovuto anche alla dominante narrazione “antipolitica”, che ha pervaso il senso comune e il discorso pubblico, e che era in primo luogo alimentata dagli stessi attori politici (vecchi e nuovi), con una rincorsa auto-distruttiva: una spirale di auto-delegittimazione che ha contribuito ad affossare l’immagine del primo quarantennio di vita repubblicana, denigrata come una “repubblica dei partiti” consociativa e partitocratica, ben oltre i suoi effettivi demeriti (o anzi, annullando i meriti che i partiti della “prima Repubblica” potevano pur vantare). 6 Su questo tema si vedano le osservazioni di Tocci 2013. Sulle ragioni profonde della crisi del PCI, e sulla loro lunga “incubazione”, la ricostruzione storica che rimane più convincente è quella di Pons (2006). 70 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228742 Antonio Floridia caratterizza il successivo voto europeo (considerando naturalmente anche il passaggio dal voto all’astensione e viceversa, come confermato da ultimo dall’impressionante dato delle elezioni regionali in Emilia Romagna, nel Novembre 2014). Non solo: come emerge da numerose indagini, una fetta consistente degli elettori decide se e come votare negli ultimi giorni, o addirittura nel momento stesso in cui entra nella cabina elettorale7. Ci sono due diverse scuole di pensiero, su questo punto: ci sono i cantori della politica “post-ideologica”, secondo cui questo elettore “volatile” sarebbe un prototipo di un cittadino oramai svincolato da logiche ideologiche, che vota sulla base delle idee e delle proposte che trova “sul mercato”, che si muove libero da ogni pastoia. Altri, invece, ritengono (e chi scrive condivide questo giudizio) che la spiegazione della “volatilità” elettorale vada ricercata in tutt’altra direzione (e da qui potrebbero venire anche molte concrete ipotesi di ricerca): siamo di fronte ad un’opinione pubblica senza oramai stabili riferimenti, dis-orientata, esposta alle più svariate e improvvise suggestioni. La chiave per comprendere l’esito del voto, insomma, si può racchiudere in una sorta di equazione: partiti dalla debole (o inesistente) identità politica e culturale, sommati ad elettori senza più appartenenze stabili, producono una miscela esplosiva di volubilità e aleatorietà. Si può esaltare questo fatto e pensare di essere oramai entrati trionfalmente nell’era della politica “post-moderna”, e che in futuro avremo a che fare solo con elettori dalla soggettività contingente e mutevole; si può pensare invece che tutto ciò non sia affatto un dato rassicurante per la nostra democrazia. Più specificamente, un terreno su cui indagare il rapporto tra articolazione territoriale delle culture politiche e gli effetti di una sfera pubblica priva di attori e soggetti in grado di strutturarla stabilmente, è quello relativo al dato che certamente ha caratterizzato il voto politico del 2013 e che continua a condizionare l’evoluzione del sistema politico, ovvero il successo elettorale del M5S. Il fatto che alle successive europee il M5S abbia perso voti, ma conservando una notevole forza elettorale (intorno al 20%) e che, invece, nelle elezioni amministrative e regionali abbia incontrato notevoli difficoltà (pur in presenza di alcuni successi rilevanti, come a Livorno), obbliga certamente ad elaborare un quadro più complesso, ma riteniamo non alteri le linee di fondo dell’interpretazione che qui intendiamo abbozzare. L’analisi del voto al M5S in occasione delle Politiche del 2013 ha messo in luce una elevata omogeneità territoriale: la lettura più immediata sembra dunque suggerire che questo risultato (non dimentichiamolo: di proporzioni inedite storicamente e in chiave comparata, per un partito che si presentava per la prima volta alle elezioni) possa essere interpretato come un’ondata di opinione che non registra rilevanti differenziazioni regionali. Sembrerebbe, dunque, possibile avanzare un’ipotesi che potrebbe essere addirittura di portata storica per il nostro paese: una forte tendenza all’omologazione, il prevalere di orientamenti elettorali che si lasciano alle spalle le storiche, radicate linee di frattura territoriale della politica italiana. Come spiegare altrimenti alcuni dati, ad esempio il fatto che il M5S sia stato il primo partito nelle province venete come in quelle siciliane? cosa accomuna questo fenomeno, se non appunto il fatto che le differenze territoriali sembrano non contare più? Riteniamo che una tale risposta non sia soddisfacente e che, al di là di quelle che appaiono come tendenze omogenee che attraversano l’intera società italiana, proprio il voto al M5S mostri come permangano radicali fratture territoriali, e che anzi il voto degli italiani - per quanto possa sembrare paradossale - continui ad esprimere una profonda diversità, se non proprio una divaricazione, proprio nella cultura politica che caratterizza le diverse aree del paese. L’ipotesi a cui crediamo si possa lavorare è che le culture politiche degli italiani rimangano radicalmente divergenti lungo linee che, certo, non sono solo territoriali, ma che da questa dimensione continuano ad essere fortemente caratterizzate. E il paradosso di queste elezioni, appunto, è che una tale divaricazione ha trovato modo di esprimersi proprio attraverso il voto ad una forza politica, il M5S, che ha raccolto un’elevatissima mole di consensi proprio in virtù della propria capacità di catalizzare e incanalare le più diverse e le più disparate ragioni di protesta e risentimento, - motivazioni generali, ma anche differenziate territorialmente. Il voto al M5S nasce dal combinarsi di un consenso d’opinione, - che nasce cioè da orientamenti che caratterizzano il clima d’opinione formatisi nel paese, gli umori prodotti e/o alimentati dai grandi mezzi di comunicazione, il “senso comune” che si stratifica e si consolida, ecc… - e un consenso, invece, che nasce da specifiche radici territoriali. Dal primo punto di vista, la ragione prima del successo elettorale del M5s va individuata nella strategia dell’offerta di questo movimento: il suo essersi collocato in una posizione che eludeva l’asse destra-sinistra per valorizzare 7 Chiaramonte, De Sio 2014; Diamanti 2013 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 71 Antonio Floridia DOI: 10.1400/228742 invece una tipica pulsione populista, propria di ogni populismo, ossia la contrapposizione tra il “noi” e il “loro”, tra il cittadino “comune” e le élite, siano esse quelle politiche, economiche o intellettuali. Questo “posizionamento” (come si dice nel gergo degli esperti di marketing) ha permesso al M5S di porsi come il collettore delle più diverse, e anche contraddittorie, domande politiche: ad esempio, raccogliendo molti voti di ex-elettori di sinistra, ma anche una quota non irrilevante di elettori di estrema destra8; o anche di intercettare, come ha notato Ilvo Diamanti (2013, p. xvii) “quel distacco dalla politica, ma anche dalla cultura civica, che ha radici profonde e di lunga durata in Italia”. Dal secondo punto di vista, possiamo cogliere un fenomeno interessante, che potrebbe sollecitare anche una riflessione di natura teorica, sulle “fonti” genetiche della “cultura politica”, ovvero il confluire e l’interagire di sollecitazioni “dall’alto” e la loro traduzione o re-interpretazione “dal basso”9. E’ accaduto infatti che, nel Veneto già “bianco” e poi “verde”, il M5S abbia “svuotato” in larga misura l’elettorato leghista: e non si può non pensare alle violente battute contro Equitalia che il comico genovese ha saputo sapientemente lanciare al momento giusto, o alle sue generiche difese della piccola impresa; o alla violenza verbale della contrapposizione contro “i politici”, molto simile a quella che investiva vent’anni fa “Roma ladrona”. Ma, nel contempo, in Sicilia, il M5S è ovunque divenuto il primo partito, con l’eccezione della provincia di Messina: e qui Grillo raccoglie una grande parte del voto “in uscita” dal centrodestra e dall’area centrista e autonomista. La Sicilia non è nuova ad improvvise fiammate populiste, o all’esplosione di forme di ribellismo sociale10; ma il voto al M5S si è alimentato di una serie ben precisa di circostanze: ovvero, il “combinato disposto” di una gravissima crisi economica e il pressoché totale essiccarsi di tutti quei canali di spesa pubblica che, direttamente e indirettamente, hanno sostenuto fin qui reddito e occupazione. Da ciò, anche, l’esaurirsi delle tradizionali forme di offerta politica, e il rapido svuotarsi di partiti che sul controllo dei flussi della spesa pubblica avevano fondato il proprio radicamento e che non possono certo contare (men che meno, oggi) su una “riserva” di lealtà costruita su una qualche base di cultura politica o di identità collettiva11. Dall’ottica che stiamo seguendo, è evidente che, nel Veneto, una persistente cultura politica anti-statalista ha trovato un suo nuovo canale (provvisorio?)12 di espressione; mentre, in Sicilia, una altrettanto persistente dipendenza della società dalla politica ha provocato un fenomeno di rigetto e di distacco…In nessuno dei due casi, la categoria del “voto di protesta” è sufficiente: appare invece plausibile che nel voto al M5S abbiano confluito sia un “clima” generale d’opinione che una specifica continuità della “cultura politica” territoriale e delle forme che essa assume (in primo luogo, il tipo di “domanda politica” che viene rivolta alla politica, i modi con cui una fetta consistente della popolazione concepisce il proprio rapporto con lo “Stato”). Ma se a Nord e a Sud possiamo, in fondo, individuare ragioni e motivazioni plausibili che possono spiegare il voto “grillino”, molto meno immediate e scontate sono le possibili spiegazioni che ci possono aiutare a capire il senso di questo voto nelle regioni “rosse”; o ancor prima, il fatto stesso che il M5S abbia trovato i suoi primi clamorosi successi e abbia visto una sorta di primogenitura proprio in una regione come l’Emilia Romagna. L’analisi, a questo punto, deve farsi più articolata e ripartire dalle riflessioni teoriche che oggi la scienza politica contemporanea ci può suggerire sulle linee di crisi, evoluzione, trasformazione e/o adattamento dei partiti. Ed 8 Rimandiamo, a questo proposito, alle analisi dei flussi condotta dall’Istituto Cattaneo di Bologna e dal CISE, disponibili sui rispettivi siti. Sul M5S si vedano, Corbetta, Gualmini 2013; Biorcio, Natale 2013; Baccetti 2013; Bordignon, Ceccarini 2013. Alla “filosofia di Beppe Grillo”, ma prima dell’exploit elettorale, è dedicato il libro di Greblo, 2011. 9 Un rilevante contributo sui processi di formazione dell’opinione pubblica è quello di Diamanti 2012, dove si sottolineano le discrasie temporali tra i “messaggi” che provengono dal “centro” del sistema politico-mediatico e le sedimentazioni del “senso comune”. 10 Da ultimo, nel 2012, la Sicilia, aveva visto il rapido insorgere del “movimento dei forconi”, una forma di jacquerie che era stata alimentata in primo luogo dalle proteste degli autotrasportatori e dalla fine dei sussidi per il costo del gasolio. 11 Va peraltro ricordato che le elezioni regionali siciliane, nell’autunno del 2012, oltre a segnare un notevole successo del M5S (14,9% la lista; 18,2% il candidato presidente), sono state caratterizzate da un’altissima astensione (47% di votanti): un sintomo evidente, non solo e non tanto di una “protesta”, quanto del fatto che i vari partiti non sono stati più in grado di esercitare una qualche capacità di “presa” sugli elettori, neanche quella del più tradizionale voto di scambio…. 12 La ripresa di consensi della Lega alle Europee, la sua netta ricollocazione a destra, e l’appeal che sembra esercitare la nuova leadership di Matteo Salvini, rendono particolarmente interessante la prossima verifica delle elezioni regionali in Veneto, nella primavera 2015. 72 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228742 Antonio Floridia è possibile concentrarsi, per l’aspetto che in questa sede più ci interessa, sulla dimensione territoriale di questi processi. Ebbene, tra i modelli teorici che, in anni recenti, sono stati proposti vi è una categoria di partito, quella del partito in franchising (Carthy 2006), che sta rivelando una crescente capacità esplicativa delle dinamiche che caratterizzano il nostro sistema politico. Non occorre spendere qui molte parole su questo modello politicoaziendale: da una parte, la registrazione di un marchio e la centralizzazione delle strategie produttive e distributive (le “linee” dei prodotti, le campagne pubblicitarie, ecc.); dall’altra, la concessione in uso di questo brand alle “filiali” locali, che godono di una certa autonomia gestionale. Questo modello, riteniamo, si applica perfettamente al caso del M5S (e non solo)13: un movimento, da un lato, fortemente accentrato, caratterizzato da marcati tratti di personalizzazione leaderistica e carismatica, fondata su un flusso comunicativo top-down; e dall’altro lato, un’organizzazione segnata da una diffusa rete di gruppi locali, indipendenti l’uno dall’altro, a cui il “centro” concede l’uso del marchio. Una coesistenza difficile, naturalmente, quella tra questi due livelli, come mostrano le cronache politiche dell’ultimo anno, con le frequenti fratture che hanno caratterizzato la vita interna al M5S: e che tuttavia, non pare abbia incrinato sostanzialmente i livelli di consenso al M5S14. E’ attraverso questo rapporto tra nazionale e locale che, sotto l’etichetta delle “cinque stelle”15, gruppi, associazioni e singole persone hanno trovato un canale di mobilitazione e partecipazione politica, e un canale di accesso alle istituzioni, che, evidentemente, non hanno trovato altrove. La forza del M5S non è solo data dalla potenza comunicativa di Grillo: è data anche dal fatto che, sotto la copertura di questo marchio, si sono messe in moto (anche attraverso il web) reti locali di attivismo civico che, in tutti questi anni, hanno agito nella società civile, e che non avevano visto - evidentemente - nei partiti e nelle istituzioni degli interlocutori credibili. E’ proprio questo modello politico-organizzativo che, a nostro avviso, può spiegare come mai il M5S abbia attecchito proprio in alcune regioni, come l’Emilia Romagna, la Toscana o le Marche, dove è sempre stato forte, e rimane forte, il tessuto associativo e il potenziale di mobilitazione civica dei cittadini. Anche per queste regioni, si può ipotizzare una combinazione tra una “mobilitazione” di opinione “dall’alto” e la sua traduzione in uno specifico contesto territoriale. E ci troviamo qui di fronte ad un altro possibile “modello” di tale combinazione: se nei primi due esempi (Veneto e Sicilia) una cultura politica territoriale e contestuale stratificatasi nel tempo (ovvero un particolare insieme di aspettative rivolte alla politica, e una particolare concezione del rapporto tra i cittadini, lo Stato e la politica) trovava il suo punto di “fusione” con un messaggio politico che viene dai “piani alti” e dal “centro” del sistema politico e del sistema delle comunicazioni di massa, nel terzo caso (le regioni “rosse”) questo messaggio dal “centro” incontrava una domanda insoddisfatta che era maturata in “periferia”. E che aveva un segno diverso: non solo la protesta “anti-politica”, e non tanto un senso di estraneità nei confronti dello “Stato”, ma una mobilitazione civica che non ha trovato più, come in passato, una sponda e un interlocutore nelle istituzioni locali. Questa “fusione” trova un preciso corrispettivo nella particolare “ibridazione” che caratterizza la “cultura politica” implicita nella prassi e nei discorsi del M5S. Da una parte, alcuni classici topoi delle narrazioni populiste (in primo luogo, come detto, la contrapposizione tra “noi”, cittadini comuni, e “loro”, le elite politiche ed intellettuali), e l’interpretazione plebiscitaria che ne dà Grillo (l’uso top-down della Rete); dall’altra, la cultura “partecipativa” che caratterizza le aggregazioni locali, e la biografia stessa di molti militanti. Una tensione che ha 13 Ma forse anche al nuovo PD di Renzi, con alcune specificità: anche in questo caso, infatti, abbiamo una leadership nazionale che in virtù anche dei meccanismi sregolati delle primarie - contratta il sostegno delle leadership e del notabilato locali ai vari spezzoni correntizi del “centro”. Ne deriva una dimensione stratarchica, e non gerarchica, dell’organizzazione del partito, con ampi margini di autonomia locale e scarsi strumenti di controllo e intervento dall’alto. Se a ciò si aggiunge la fine del finanziamento pubblico dei partiti, e il progressivo esaurirsi delle classiche fonti di auto-finanziamento, non possono sorprendere i vari casi di degenerazione, che stanno chiamando in causa il lavoro della magistratura. 14 I sondaggi, peraltro, continuano a dare il M5S intorno al 20%. (cfr., da ultimo, il sondaggio curato da Ilvo Diamanti, su “Repubblica” del 21 dicembre 2014). I mass-media stanno enfatizzando le spaccature interne, l’inefficacia e il vuoto di proposta politica del M5S; ma gli elettori, evidentemente, non misurano su questo metro le ragioni del loro perdurante consenso al movimento di Grillo. 15 In fondo, le “cinque stelle” sono un simbolo del tutto anonimo, privo di una qualsiasi connotazione politico-culturale, un marchio che potrebbe essere adatto ad un qualsiasi prodotto. E pochi sanno che la scelta di questa denominazione richiama “cinque” principi che furono fissati nella carta di Firenze, in occasione del “I° incontro nazionale delle liste civiche a cinque stelle” (Firenze, 8 marzo 2009): le cinque stelle sono quelle che evocano cinque valori fondativi e obiettivi politici: acqua, ambiente, energia, trasporti e sviluppo. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 73 Antonio Floridia DOI: 10.1400/228742 già trovato molte occasioni per esprimersi e che trova la sua cartina di tornasole nelle idee (e nelle pratiche) di democrazia che il M5S propugna: una peculiare combinazione tra un rilancio della democrazia diretta - in forme anche un po’ mitologiche, contando sulle possibilità aperte dalle nuove tecnologie della comunicazione; ma anche con la ripresa di alcuni suoi classici istituti (il recall, il mandato imperativo, la rappresentanza come mera delega funzionale) -, e un approccio che è invece sensibile alle più recenti versioni della “democrazia partecipativa” (come mostra, ad es., la presenza del “bilancio partecipativo” in molti programmi amministrativi del M5S)16. Se questa ipotesi è plausibile, bisogna allora chiedersi cosa sia cambiato, in queste regioni dell’“Italia di mezzo”, e proprio nella “cultura politica” che è implicita nella prassi di queste istituzioni locali (e negli attori politici che la esprimono). Una prima possibile interpretazione chiama in causa la cultura politica e istituzionale dominante in questi anni. Se, in passato, la mediazione tra società e istituzioni era affidata ai partiti e alle strutture della rappresentanza sociale, la crisi e l’esaurimento dei tradizionali canali che assicuravano una tale mediazione ha alimentato, in gran parte del ceto politico e amministrativo, una sorta di scorciatoia leaderistica e decisionistica, o l’illusione che si potesse supplire alla rarefazione degli strumenti di mediazione e di rapporto con la società con il ricorso alle nuove e più sofisticate tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Così, ad esempio, a fronte dei conflitti che quotidianamente esplodono, si reagisce con fastidio o supponenza al proliferare dei vari “comitati” di protesta: letti solo come l’espressione di una endemica sindrome estremistica e/o localistica di gruppi ristretti, senza comprendere che se questi “comitati” riescono a frapporre efficaci poteri di veto, evidentemente tanto “ristretti” non sono, o comunque esprimono orientamenti reali ben presenti nell’opinione pubblica17. E così, in molti decision-makers, sembra che si sia smarrita la consapevolezza di un principio fondativo della politica democratica: quello che i cittadini vanno persuasi, convinti, sulla bontà di una decisione. E che una decisione efficace va in qualche modo costruita, discussa con tutti coloro che da essa verranno toccati, valutata in tutte le sue implicazioni. E sembra che si sia smarrito un altro elementare principio: che esiste un qualcosa, impalpabile empiricamente, ma ben presente ed oggettivo, decisivo nel farsi delle politiche pubbliche, qualcosa che si chiama consenso, o anche legittimazione, ossia riconoscimento e accettazione sociale delle decisioni assunte dalle istituzioni. E invece, proprio quel che si dice comunemente un diffuso deficit di legittimazione ha prodotto le pre-condizioni di una mobilitazione politica contro e al di fuori dei tradizionali canali istituzionali, che poi ha trovato uno sbocco politico-elettorale. E’ questa l’ipotesi che ci sembra può spiegare le ragioni di un particolare radicamento “militante” del M5S nelle regioni dell’”Italia di mezzo”: segmenti significativi di cittadini con un’elevata propensione all’impegno civico, hanno trovato nel M5S una sorta di canale di accesso privilegiato alle istituzioni e uno strumento per esprimere una cultura politica che assegna comunque un valore positivo alla partecipazione e alla “militanza”. Le elezioni di Livorno suonano come una conferma di questa diagnosi, che naturalmente ha bisogno di ulteriori indagini e verifiche18. Un secondo ordine di spiegazioni rimanda ad uno sfondo generale, ad un “clima di opinione” creatosi anche in una regione come la Toscana (ed in questo vi è certamente una soluzione di continuità rispetto al passato), che si esprime in una diffusa insofferenza rivolta all’establishment politico dominante: una crisi di fiducia di dimensioni inedite, o anche - possiamo dire - una mancata “impermeabilità” di queste regioni al clima generale di risentimento 16 Per una più compiuta analisi sui modelli di democrazia cui si ispira il M5S, cfr. Floridia-Vignati (2014); mentre considerazioni sull’uso della Rete si trovano in Urbinati, 2013. 17 Se si guarda alla biografia politica di molti militanti e “quadri” del M5S si nota che in moltissimi casi la loro formazione politica affonda le proprie radici nelle numerose esperienze di mobilitazione politica locale contro inceneritori e depuratori, strade e autostrade, grandi opere, ecc. La cultura politica di questi militanti è un impasto originale di ambientalismo vecchio e nuovo, mitologie della decrescita, di ingenuità e mitologie sull’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma è fatta anche da una cultura della cittadinanza attiva e della partecipazione, dalla cultura del consumo critico, e da molto altro ancora. Sul profilo politico e la provenienza dei parlamentari del M5S, molti dei quali con un “album di famiglia” decisamente di sinistra, cfr. Baccetti 2013, p. 55-58. 18 Va ricordato che, all’esito delle elezioni a Livorno, ha concorso in modo decisivo il notevole consenso (16%) raccolto al primo turno da una lista civica che aveva, chiaramente, un pedigree di sinistra e che esprimeva una cultura partecipativa, contrapposta alla chiusura pseudo-decisionista delle ultime amministrazioni targate PD. 74 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228742 Antonio Floridia populista che ha investito tutto il paese: in questo senso, si può dire, la perdita di una “diversità” 19. Dunque, la chiave del successo elettorale del M5S, e della sua stessa entità, sta nel sovrapporsi e nel confluire di una pluralità di piani culturali e, insieme, territoriali. Questo dato può rappresentare un fattore di debolezza, per il futuro di questa formazione politica; ma anche questa instabilità e precarietà si inscrive pienamente nel quadro generale che abbiamo sopra tratteggiato: una politica, e una cultura politica, priva oramai di solidi ancoraggi, volatile, esposta alle più improvvise folate. Per comprendere meglio come tutto ciò sia potuto accadere, è opportuno lanciare uno sguardo più ravvicinato ad una di queste regioni, la Toscana: crediamo tuttavia che gli elementi che possiamo trarre da questa analisi siano generalizzabili o che, in ogni caso, possano costituire l’oggetto di una nuova agenda della ricerca. 4. “Cultura politica” non è solo quella degli individui e dei cittadini: è anche quella che si esprime nelle pratiche politiche e istituzionali e che ispira l’azione e i comportamenti degli attori politici e istituzionali. E una domanda essenziale da porsi riguarda le idee e le immagini della democrazia e l’idea di partecipazione politica che vivono implicitamente (o più o meno consapevolmente) nella prassi degli attori politici, nel “senso comune”, nella cultura diffusa. La Toscana è stata - per tutto il Dopoguerra - una terra di forti passioni politiche e ideologiche, con elevati livelli di partecipazione politica: non è un luogo comune, è un dato storico. Tutto ciò avveniva dentro le coordinate tipiche della “subcultura rossa”, ma più in generale, - si pensi alla ricchezza e alla varietà della cultura politica cattolica -, erano tutti i partiti ad organizzare le forme della partecipazione politica ed erano le maggiori tradizioni di cultura politica a offrire ai cittadini le risorse cognitive e simboliche con cui leggere e vivere il proprio rapporto con le istituzioni, specie quelle locali. Quella che possiamo definire come la circolarità comunicativa tra istituzioni e sfera pubblica, era dominata dai partiti: erano i partiti, con l’insieme delle associazioni più o meno direttamente da essi orientate, a “strutturare”, “articolare” e mediare, le domande sociali, le “voci” che emergevano dalla società. Ed i partiti erano anche attori che sollecitavano la partecipazione dei cittadini (quel che si dice mobilitazione), la esigevano persino, diffondevano una cultura e producevano un “senso comune”, in cui all’”impegno civico” si conferiva un valore positivo, socialmente apprezzato. L’idea che fosse “giusto” e “bene” occuparsi di politica, e di tutto ciò che riguardava la vita di una comunità, e partecipare attivamente ad essa, era comunque un valore diffuso tra i cittadini, anche tra coloro che magari, queste virtù civiche, le potevano esercitare solo a tratti e parzialmente. Tutto ciò è noto, ma qui va sottolineata una particolare implicazione di questo contesto politico e culturale: i processi di formazione e selezione dei gruppi dirigenti e del ceto politico locale. Quella circolarità comunicativa, strutturata e alimentata soprattutto dai partiti, era anche un formidabile canale di formazione e selezione di un ceto politico che concepiva, potremmo dire naturaliter, un’idea della politica e del proprio ruolo di “rappresentanti del popolo” in cui alla partecipazione dei cittadini, al loro protagonismo sociale, si affidava un grande ruolo. E ciò accadeva perché questo ceto politico si era formato, aveva mosso i primi passi, e si metteva alla prova, proprio all’interno di questa profonda dimensione partecipativa della politica. I circuiti dell’accountability e della responsiveness erano vitali, incanalati entro e dai partiti, ma vissuti fortemente da una cittadinanza attiva. Con le forme tipiche della politica nell’epoca dei partiti di massa, e dentro questo quadro, la partecipazione era un dato obiettivo, e un’esigenza vissuta e sentita da questo ceto politico. E si 19 I primi segnali di una crisi del tessuto fiduciario erano stati colti da un’indagine svolta nella seconda metà degli anni Novanta: Ginsborg, Ramella 1999. Qualche anno dopo, un’indagine condotta per Confindustria Toscana, coglieva un dato diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche (Diamanti, Ramella 2008): la Toscana, scriveva Diamanti nella Prefazione, ha rappresentato fino ad oggi, «un raro caso di equilibrio virtuoso fra quantità e qualità della crescita», ma proprio perciò esprime una domanda sociale e politica particolarmente “esigente” che, se insoddisfatta, può produrre contraccolpi negativi. A distanza di alcuni anni, si può forse cominciare a rispondere che lo scarto è venuto aumentando, e con ciò il livello di distacco e di sfiducia. D’altra parte, non si possono non considerare gli effetti della crisi economica: alla fine del 2008, commentando le elezioni di quell’anno, si poteva ancora scrivere che, per la Toscana, «il segno dominante è proprio quello di fattori tradizionali che sanno in modo molecolare adattarsi alle novità e di fattori innovativi che attingono e si alimentano di radici lontane. Il segno dominante è quello di una politica e di istituzioni che, nel complesso, non senza fatica e contraddizioni, hanno però saputo governare le trasformazioni sociali» (Floridia, 2009, p. 12); ma si introduceva una nota di prudenza: «fin qui, almeno: perché la crisi economica iniziata alla fine del 2008 certo metterà a dura prova quei meccanismi di regolazione sociale che, fino ad un recente passato, hanno mostrato di funzionare» (ivi). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 75 Antonio Floridia DOI: 10.1400/228742 possedevano tutte le “antenne” per cogliere tempestivamente quando, in una comunità, sorgeva un conflitto, o quando emergeva un “problema” di consenso e di condivisione; e si discuteva, eccome… nelle piazze, nelle case del popolo, e anche dentro i partiti. E poi i partiti svolgevano anche pienamente una loro classica funzione, quella del coordinamento strategico inter-istituzionale, ovvero vi erano costanti discussioni e decisioni che coinvolgevano rappresentanti eletti in istituzioni diverse, e a livelli istituzionali diversi. E quando, tra questi diversi livelli, sorgeva un conflitto, vi erano i luoghi in cui comunque si mediava e si giungeva a soluzioni condivise. Tutto ciò è cambiato, e molto rapidamente, a partire dai primi anni Novanta; ma di questo complesso processo di mutamento qui occorre solo sottolineare un particolare versante. Venuto meno quel modello di partecipazione politica, è rimasto intatto, naturalmente, il problema di come assicurare consenso e legittimità al sistema politico. Quella circolarità tra rappresentanza politica e partecipazione civica, poteva essere ricostruita e pensata in altro modo, senza più la centralità che i partiti avevano in passato? La risposta che, nei fatti, si è affermata sembra aver rimosso questo problema: è una risposta - ben presente sulla scena politica nazionale e internazionale, ma che, per la Toscana, ha segnato una netta discontinuità con la propria storia - che conduce ad un radicale ridimensionamento del ruolo e dello spazio della “partecipazione civica”: le forme di investitura elettorale diretta delle cariche di governo, in questo modello, rendono inutile e costosa una costruzione delle politiche che contempli la mediazione, - una qualsiasi mediazione, quella stessa dei partiti, innanzi tutto; ma poi anche quella della tradizionale “concertazione” neo-corporativa, o quella di altri corpi intermedi, o anche quella costituita da possibili nuovi istituti partecipativi. Consenso e legittimità, in questa visione, sono assicurati dalle procedure elettorali che si fondano sull’investitura diretta e personale dei detentori di una carica di governo; ma poi sono alimentati soprattutto dalla comunicazione top-down, come strumento di formazione e orientamento dell’opinione pubblica, oggi arricchita dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi strumenti del web e dei social networks. Scompare la sfera pubblica, intesa come una pluralità di voci che partecipano attivamente e interagiscono con le istituzioni, e subentra, appunto, l’opinione pubblica, qualcosa di vago e informe, che può essere “sondato”, ma che non gioca alcuna partita discorsiva e deliberativa. La partecipazione politica, dentro questo schema, non è, prioritariamente, cittadinanza attiva, espressione di una competenza politica diffusa; ma quella che si esprime al massimo attraverso un cittadino che segue quel che accade, si informa, valuta; magari può inviare una mail o un post di commento. Beninteso, dentro questo schema, ci possono poi essere accentuazioni diverse, e possono ben esserci anche forme di consultazione dei cittadini, e possono esserci “interpretazioni” diverse di questo canovaccio. Ma conta molto lo “stile”, anche personale, del governare: da una parte, possiamo avere toni più marcatamente decisionisti e dirigisti e/o più o meno ammantati di una retorica populista; dall’altra parte, possono esserci anche casi in cui questa logica di accentramento e personalizzazione nasce da una sincera e acuta percezione di un effettivo deficit di legittimazione, dal sentir “montare” attorno a sé ondate di sfiducia e di antipolitica, dal senso di una responsabilità politica che incombe e che pesa; a cui si risponde però con una sorta di angosciosa frenesia del “fare”, con una sindrome iper-decisionista, che porta a sentire come un intralcio la complessità delle policies e come un fastidio insopportabile le costrizioni imposte dalle necessarie mediazioni. Insomma, si sbaglierebbe molto se si cadesse nello stereotipo di una “classe politica” autoreferenziale, che non si pone il problema del consenso e delle “fonti” della propria legittimità. Anche queste interpretazioni (potremmo dire, “schumpeteriane” malgrè soi..) del proprio ruolo di governo sentono fortemente il problema dei canali interrotti, opachi, ostruiti, tra governanti e governati. Ma cercano una risposta accentuando la dimensione personalizzata della leadership, costruendo meccanismi di comando gerarchico o valorizzando soprattutto i “messaggi” lanciati all’opinione pubblica, più che la faticosa ricostruzione di relazioni e mediazioni. Sono queste le tendenze che sembrano essersi affermate, anche in una regione come la Toscana, a fronte delle difficoltà crescenti che la politica e le istituzioni si trovano a fronteggiare. Ma, naturalmente - se resta tutta da valutare l’efficacia di questa visione sostanzialmente èlitistica della democrazia: una questione su cui lasciamo sospeso il giudizio -, va anche aggiunto che sono stati pur presenti altre visioni, e altre pratiche, del governare e del decidere. La vicenda - molto contrastata - della legge regionale toscana sulla partecipazione (che abbiamo raccontato e analizzato altrove: Floridia 2008, 2012 e 2013) resta, da questo punto di vista, emblematica di un conflitto che attraversa il mondo politico e istituzionale: un conflitto intorno al ruolo che la partecipazione civica 76 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228742 Antonio Floridia può svolgere all’interno dei processi di decision-making. In termini teorici, l’alternativa esiste: si tratta di una risposta che valorizza una concezione della rappresentanza come processo politico, che muove da, ma non si esaurisce in, un atto di autorizzazione elettorale, e che si fonda su un’interazione propriamente deliberativa tra istituzioni e sfera pubblica20. Esula dai fini che qui ci possiamo proporre sviluppare le implicazioni teoriche di questo modello: ci importa vedere se ve ne siano stati e ve ne siano segni in Toscana (ma crediamo che questo “caso” possa andare ben oltre uno specifico sistema politico regionale). Un solo dato: negli ultimi anni, sono stati circa un centinaio i Comuni toscani che, avvalendosi delle risorse e delle procedure messe a disposizione dalla legge regionale sulla partecipazione, hanno promosso processi partecipativi che hanno in qualche modo sperimentato nuovi modelli di coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. L’esito di questi processi è stato vario, ma nel complesso si è rivelato positivo, tanto che si sono create le condizioni politiche per una nuova approvazione della legge (che, proprio in chiave “sperimentale”, era una legge con una “scadenza”, fissata al 31 Dicembre 2012). E pur tuttavia, il “clima” politico intorno a questa legge è rimasto, in gran parte, - nell’establishment politico-istituzionale - se non di aperta ostilità, di diffidenza o di indifferenza: un segno evidente che la visione egemone del “governare” rimane quella che si ispira ad una logica “decisionistica” e ad un’interpretazione personalizzata della leadership, che confida in un consenso prodotto e riprodotto attraverso canali sostanzialmente plebiscitari. Questa “cultura politica”, - l’idea che i politici hanno di se stessi come “decisori” - segna una radicale soluzione di continuità con il passato, in una regione come la Toscana. Ma, come dimostrano le vicende politiche ed elettorali, non è poi così scontato che si riveli “vincente”, o che non produca contro-tendenze, reazioni, effetti imprevisti. Se un tessuto civico e associativo non trova gli strumenti di un dialogo con le istituzioni, si apre la via del conflitto, che può trovare poi anche canali elettorali di espressione (come mostrano i numerosi casi di “liste civiche” che hanno conquistato varie amministrazioni locali). L’esaurirsi di un “vecchio” modello di partecipazione politica, in Toscana, non poteva comportare un tracollo verticale e repentino del sostrato di cultura politica di cui quel modello si alimentava. Non è plausibile una visione “catastrofista” della caduta di un complesso modello politico, culturale e istituzionale, quale è stato quello della “subcultura rossa”: i tempi del mutamento politico sono diversi da quelli, molto più complessi e lenti, che toccano una cultura politica e i valori di cui si sostanzia. La realtà delle cose, spesso, si rivela ostinata: e il farsi delle politiche non può essere efficace se viene concepito come un’azione dall’alto, patrimonio di un ristretto nucleo di decisori - politici, tecnici o burocrati -, che “si impone” ad una società sostanzialmente inerte o passiva, o riottosa. Al contrario, proprio la perdurante tradizionale ricchezza del tessuto civile e associativo della Toscana, oramai disancoratosi dai vecchi quadri “ideologici”, pienamente autonomo e pluralista, rende necessaria (e, di fatto, molto più efficace) una concezione e una pratica di governo fondata sulla partecipazione diffusa, e su una concezione delle istituzioni della democrazia rappresentativa che presuppone e implica un largo protagonismo sociale. L’interrogativo che ci consegnano le vicende più recenti può essere dunque così formulato: il ceto politico e le classi dirigenti (o almeno una loro parte) sono consapevoli che quella toscana rimane comunque una società “attenta” ed “esigente”, che esprime una larga “riserva” di spirito civico, che non attende passivamente, e spesso non accetta, le decisioni “dall’alto”? o prevale una scorciatoia decisionista, ovvero un’idea del governo come “riduzione della complessità”, o un’idea della democrazia come circuito “immediato” e populistico di rapporto tra governanti e governati? Ritornando al nostro tema, alla nostra possibile agenda per un programma di ricerca, ecco un possibile argomento: come sono cambiati, concretamente, i meccanismi del policy-making, in una regione come la Toscana, che storicamente è stata certamente una di quelle regioni in cui il modello idealtipico della “subcultura politica territoriale” ha corrisposto molto da vicino alla realtà dei processi sociali, politici e istituzionali? e quale è, oggi, il modello di governance che ha sostituito quello precedente, che vedeva il partito dominante come centro di una costellazione associativa, politica ed istituzionale? 20 Sul tema delle nuove forme di un policy-making deliberativo (che si ispiri cioè al paradigma teorico della democrazia deliberativa) rinviamo a Floridia 2012. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 77 Antonio Floridia DOI: 10.1400/228742 5. Nelle conclusioni di una ricerca di pochi anni fa sulle trasformazioni della cultura politica dei cittadini toscani (De Sio 2011; Floridia 2011), si giungeva ad una provvisoria conclusione. Assumendo il concetto di “subcultura politica territoriale” come un modello idealtipico, che conserva le proprie capacità di proiezione analitica, in chiave comparata, anche quando i fenomeni sembrano discostarsi dal paradigma originario, si sottolineava la natura complessa di un sistema “subculturale”, ovvero la coesistenza al suo interno di una molteplicità di elementi e di fattori che conservano una propria relativa autonomia e che, soprattutto, possono avere una differente capacità di “tenuta” e di “resilienza”, e una diversa scansione temporale. In particolare, nel caso della Toscana, si sottolineava una possibile distinzione tra la componente più direttamente politico-ideologica della subcultura “rossa” (oramai residuale), e un sostrato storico di cultura politica (una civicness diffusa, sostenuta da un’alta dotazione di capitale sociale), che preesisteva alla fase storica di “incapsulamento” entro la cornice ideologica della cultura politica socialista e comunista, e che da essa si era disincagliata, trovando nuove forme si espressione e mostrando un’elevata capacità di persistenza, nel mutato quadro storico e politico. La tesi era che la subcultura “rossa” in Toscana si potesse dire “eclissata” solo in riferimento alla sua dimensione ideologica, ma che molte sue componenti, in realtà, avessero vissuto una complessa fase in cui si erano combinati elementi di crisi e declino, ma anche di trasformazione, adattamento, articolazione. Non solo quindi un’eredità dispersa o dilapidata, o una rendita destinata lentamente a spegnersi, ma un patrimonio ereditario che sembra riuscire ad essere molto di più che una mera sopravvivenza residuale: piuttosto, un insieme di risorse (politiche, istituzionali, sociali e culturali) che continuano a caratterizzare fortemente la realtà regionale. Tuttavia, si ricordava come decisiva, per il futuro, come lo era stata in passato - se non vogliamo trasmettere un’immagine deterministica del concetto di “cultura politica” - restava la capacità strategica degli attori politici, la loro capacità di innovazione, la loro strumentazione di idee e conoscenze con le quali interpretare e guidare i processi in atto; e come un punto critico, e dirimente, fosse dunque quello del ruolo dei partiti e della loro funzione democratica. Un ruolo, quest’ultimo, tanto più essenziale, quanto più forti sono il mutamento economico, le linee di tensione e di frattura che allontanano il presente dalle condizioni che avevano potuto far parlare, in passato, di un vero e proprio “modello sociale” delle regioni “rosse” (sviluppo delle piccole imprese, alti livelli di welfare locale, associazionismo diffuso, alti livelli di partecipazione politica…): trasformazioni che esigono dalla politica una visione strategica e una capacità innovativa che, a dire il vero, oggi sembrano una risorsa piuttosto scarsa (ma anche questo è un possibile tema di indagine e di ricerca). Sfide che, in ogni caso, non possono essere affidate soltanto alle capacità di governo delle istituzioni locali e regionali (anch’esse in costante affanno). Quello del passato era un “modello” che presupponeva un’elevata qualità della democrazia e si fondava su una forte dimensione partecipativa: ed oggi, in condizioni molto diverse, il compito della politica potrebbe tornare ad essere quello di far sentire i cittadini, in forme molto diverse dal passato, partecipi delle scelte che li coinvolgono, offrire luoghi e strumenti perché il potenziale di partecipazione attiva e critica (sempre elevato) possa esprimersi ed essere valorizzato. Ma è possibile, tutto questo, senza partiti che sappiano essere fattori di innovazione? 21 Ed è questo, forse, il passaggio più critico e l’interrogativo che questa nostra riflessione ci consegna: potranno essere contrastati i segnali vistosi di erosione e di logoramento nel rapporto fiduciario tra i cittadini e le istituzioni (anche quelle locali e regionali), e tra i cittadini e la politica, - in regioni come la Toscana che, storicamente, sono state un’eccezione nel panorama della cultura politica italiana - senza che i partiti ritornino ad esercitare una propria funzione, certo diversa da quella del passato, ma oggi, non meno di ieri, necessaria ad una buona qualità della democrazia? Le risposte che oggi sembrano prevalenti vanno in tutt’altra direzione: verso l’idea, cioè, che questo rapporto 21 Merita di essere citato il giudizio di Anderlini (2009: 207) sulle tendenze in atto, in generale, nelle regioni “rosse”: «le tensioni che incombono sulle regioni rosse hanno essenzialmente a che vedere con incrinature e scollamenti nelle funzioni di integrazione. Il capitale sociale non può surrogare, da sé, l’assenza di un centro ordinatore come il partito politico: sorta di banca centrale delle reti fiduciarie. Le tendenze in atto, infatti, restituiscono l’idea di un tessuto partecipativo imponente, ma vieppiù frammentato e auto-referente». E’ dubbio che il partito politico possa tornare ad essere un “centro ordinatore”; ma è vero che le reti fiduciarie, senza interlocuzione con la politica, rischiano di frammentarsi e di “chiudersi”. Ed è vero che il partito politico potrebbe anche proporsi, in forme rinnovate, non tanto di tornare ad essere il “perno”, ma certamente lo “snodo” di una complessa rete di relazioni associative, una sorta di crocevia attraverso cui il tessuto associativo incontra il mondo della politica e delle istituzioni. 78 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228742 Antonio Floridia tra i cittadini e la politica possa e debba ricostituirsi contando su un rapporto “empatico” e plebiscitario tra il leader e le masse. I fatti ci diranno se questa “soluzione” si rivelerà efficace e, soprattutto, se la democrazia del nostro paese ne uscirà migliorata. Riferimenti bibliografici Almagisti M. (2008), La qualità della democrazia in Italia. Capitale sociale e politica, Roma: Carocci. Almagisti M. (2009), Istituzioni locali, capitale sociale e corpi intermedi, in Baccetti-Messina (a cura di), L’eredità. Le subculture politiche della Toscana e del Veneto, Padova: Liviana. Anderlini F. (2009), Il partito liquido e la durezza del territorio, in «Il Mulino», 2:199-210. Baccetti C. (2013), Uno contro Tutti. La sfida del Movimento 5 Stelle, E-book, Goware edizioni, settembre, Firenze. Baccetti C., Caciagli M. (1992), Dopo il PCI e dopo l’Urss. Una subcultura rossa rivisitata, in «Polis», 3:537-568. Baccetti C., Messina P. (2009, a cura di), L’eredità. Le subculture politiche della Toscana e delVeneto, Padova: Liviana. Banfield E.C. (2010), Le basi morali di una società arretrata, Bologna: Il Mulino. Biorcio R., Natale P. (2013), Politica a 5 stelle. Idee, storia e strategie del movimento di Grillo, Milano: Feltrinelli. Bollati G. (1983), L’italiano : il carattere nazionale come storia e come invenzione, Torino: Einaudi. Bordignon F., Ceccarini L. (2013), «Tsunami» a 5 stelle, in I. Diamanti (a cura di), Un salto nel voto, Roma-Bari: Laterza. Caciagli M. (1990), Il declino della cultura rossa, in P. Feltrin, A. Politi (a cura di), Elezioni regionali del ’90: un punto di svolta?, Venezia-Mestre: Fondazione Corazzin, Documenti n. 2:15-22. Caciagli M. (2009), Che resta?, in C. Baccetti, P. Messina (a cura di), L’eredità. Le subculture politiche della Toscana e del Veneto, Liviana: Padova. Caciagli M. (2010), Fra Arlecchino e Pulcinella. La cultura politica degli italiani nell’Età di Berlusconi, Trapani: Di Girolamo editore. Cartocci R. (2007), Mappe del tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia, Bologna: Il Mulino. Cartocci R. (2011), Political Culture, in B. Badie, D. Berg-Schlosser, L. Morlino, (a cura di), International Encyclopedia of Political Science, London: Sage. Carty R.K. (2006), I partiti come sistemi di franchising. L’imperativo organizzativo stratarchico, in L. Bardi (a cura di), Partiti e sistemi di partito, Bologna: Il Mulino. Chiaramonte A., De Sio L. (2014, a cura di), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche del 2013, Bologna: Il Mulino. Corbetta P., Gualmini E. (2013), Il partito di Grillo, Bologna: Il Mulino. De Sio L. (2011, a cura di), La politica cambia, I valori restano? Un’indagine sulla cultura politica dei cittadini toscani, Firenze: Firenze University Press. Diamanti I. (1996), Il male del Nord. Lega, localismo, secessione, Roma: Donzelli. Diamanti I. (2009), Mappe dell’Italia politica. Bianco, rosso, verde, azzurro e…tricolore, Bologna: Il Mulino. Diamanti I. (2012), Gramsci, Manzoni e mia suocera, Bologna: Il Mulino. Diamanti I. (2013, a cura di), Un salto nel voto. Ritratto politico dell’Italia di oggi, Roma-Bari: Laterza. Diamanti I., Ramella F, (2008, a cura di), Uno sviluppo esigente. Società, economia ed istituzioni in Toscana, indagine Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 79 Antonio Floridia DOI: 10.1400/228742 Demos & Pi, Confindustria Toscana, Firenze. Floridia A. (2008), Democrazia deliberativa e processi decisionali: la legge della Regione Toscana sulla partecipazione, in «Stato e Mercato», 1: 83-110. Floridia A. (2009), Nuove e vecchie fratture: il voto della Toscana nelle elezioni politiche del 2008, in «Quaderni dell’osservatorio elettorale», 61: 5-36. Floridia A. (2010), Le subculture: epilogo o trasformazione, in C. Baccetti, S. Bolgherini, R. D’Amico, G. Riccamboni G. ( a cura di), La politica e le radici, Padova: Liviana. Floridia A. (2011), Tramonto, sopravvivenza, trasformazione? Oltre la ‘subcultura rossa’, in L. De Sio (a cura di), La politica cambia, I valori restano? Un’indagine sulla cultura politica dei cittadini toscani, Firenze: Firenze University Press. Floridia A. (2012), La democrazia deliberativa: teorie, processi e sistemi, Carocci: Roma. Floridia A. (2013), Le “buone ragioni” di una legge: dilemmi e argomenti sul senso della partecipazione (e sui modi del governare), in M. Morisi, C. Perrone (a cura di), Giochi di potere. Partecipazione, piani e politiche territoriali, Torino: UTET. Floridia A., Vignati R. (2014), Deliberativa, diretta o partecipativa?Le sfide del Movimento 5 stelle alla democrazia rappresentativa, in «Quaderni di sociologia», 65: 51-74 Gibelli A. (2011), Berlusconi passato alla storia, Roma: Donzelli. Ginsborg P., Ramella F. (1999, a cura di), Un’Italia minore: famiglia, istruzione e tradizioni civiche inValdelsa, Firenze: Giunti. Greblo E. (2011), Filosofia di Beppe Grillo. Il Movimento 5 stelle, Milano: Mimesis. Lupo S. (2004), Partito e antipartito. Una storia politica della prima Repubblica (1946-1978), Roma: Donzelli. Mastropaolo A. (1996), Il castello dei destini incrociati. Saggio su cinquant’anni di democrazia in Italia, Firenze: La Nuova Italia. Mastropaolo A. (2000), Antipolitica all’origine della crisi italiana, Napoli: L’ancora del Mediterraneo. Orsina G. (2013), Il berlusconismo nella storia d’Italia, Padova: Marsilio. Putnam R. (1993), Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press (trad. it., Le tradizioni civiche nelle regioni italiane, Milano: Mondadori). Pons S. (2006), Berlinguer e la fine del comunismo, Torino: Einaudi. Ramella F.(2005), Cuore rosso?Viaggio politico nell’Italia di mezzo, Roma: Donzelli. Rawls J. (2012), Liberalismo politico, Torino: Einaudi. Rusconi G.E. (1993), Se cessiamo di essere una nazione, Bologna: Il Mulino. Urbinati N. (2013), Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza, Feltrinelli: Milano Tocci W. (2013), Sulle orme del gambero. Ragioni e passioni della sinistra, Roma: Donzelli. Trigilia C.(1986), Grandi partiti e piccole imprese. Comunisti e democristiani nelle regioni a economia diffusa, Bologna: Il Mulino. Trigilia C. (1995), Dinamismo privato e disordine pubblico. Politica, economia e società locali, in Storia dell’Italia Repubblicana, Vol.2, Torino: Einaudi. Trigilia C. (2012a), Non c’è nord senza sud. Perché la crescita dell’Italia si decide nel Mezzogiorno, Roma-Bari: Laterza. Trigilia C. (2012b), Why the Italian Mezzogiorno did not Achieve a Sustainable Growth: Social Capital and Political Constraints, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 4, Dicembre. 80 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228743 Lorenzo Bernini [Uno spettro s’aggira per l’Europa…] Sugli usi e gli abusi del concetto di “gender” Title: A Spectre is Haunting Europe…On the Uses and Abuses of the Concept of “Gender” Abstract: In its most common understanding, the term “gender” primarily refers today to the complementarity of femininity and masculinity, understood in turn as psychosocial identities; and so it has been used also by large sectors of feminism. This article aims to provide a synthetic overview of the effects produced by its diffusion in medicine, psychiatry, academic knowledge production, the public sphere and social movements. The point of departure will be the ongoing debate in Europe and Italy, where the category of gender coagulates the hostility of Vatican elites and catholic integralist movements toward the achievements of civil rights for lesbian, gay, bisexual, transsexual/transgender, queer and intersex people. This contrast is a clear example of the semantic complexity of gender, a concept or better a conceptual device, which has in short time produced numerous political cultures, often in conflict with each others. Keywords: Queer teories, Gender studies, “Theory of gender”, Synod on the family, Pope Bergoglio, LGBTQI rights. L’intento di questo articolo è di dar conto, sinteticamente, degli effetti prodotti dalla diffusione del termine “gender” nella medicina, nella psichiatria, nei saperi accademici, nella sfera pubblica, nei movimenti sociali. Punto di partenza sarà l’acceso dibattito in corso in Europa e in Italia, in cui attorno al lemma si coagula l’ostilità delle gerarchie vaticane e dei movimenti tradizionalisti cattolici alle conquiste dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali/transgender1, queer2, intersex3 (d’ora in poi LGBTQI). Questa contrapposizione è un chiaro esempio della complessità semantica del gender, concetto o meglio dispositivo concettuale che in breve tempo 1 Il termine di origine medica “transessuale” indica quei soggetti che sviluppano una definita identità di genere (maschile o femminile) opposta al sesso di nascita e adeguano il proprio corpo alla propria identità con uso di ormoni e chirurgia estetica. Il termine “transgender”, entrato in uso dopo la pubblicazione del pamphlet Transgender Libertation (Feinberg 1992) indica invece quei soggetti che, pur avendo un’identità di genere non conforme al sesso di nascita, non aderiscono pienamente al genere opposto, ma trovano più adatta a sé una collocazione intermedia tra il maschile e il femminile: di conseguenza essi intervengono con terapie ormonali e operazioni chirurgiche per modificare soltanto alcuni caratteri sessuali del proprio corpo, e non altri. In seguito utilizzerò l’abbreviazione “trans” per indicare entrambe le condizioni. 2 “Queer” (traducibile in italiano con “strano”, “bizzarro”, ma anche con “checca”, “frocio”) è un termine polisemico, la cui ricchezza consiste nel dover essere definito a ogni suo uso, o al contrario nel poter essere utilizzato senza essere compiutamente definito. Da un punto di vista politico, caratterizza pratiche radicali volte a contrastare non solo maschilismo, eterosessismo, omotransfobia, ma anche bifobia, omotransnormatività (Duggan 2003), omonazionalismo e pinkwashing (Puar 2007, Fassin 2010b, Colpani, Habed 2014a, 2014b). Da un punto di vista teorico, indica l’atteggiamento critico di quegli autori e quelle autrici che fanno del sessuale un motivo di ricerca infinita, sfidando le convenzioni del senso comune e oltrepassando talvolta i limiti del politicamente corretto. Sulle teorie queer e il loro rapporto con il femminismo e gli studi gay e lesbici, tra i testi italiani si vedano almeno: Pustianaz 2011, Arfini, Lo Iacono 2012, Bernini 2013. 3 Il termine “intersex” e l’acronimo “dsd” (disorder of sexual development) sono sinonimi e si riferiscono a una varietà di condizioni fisiche in cui una persona non rientra nelle caratteristiche “standard” del maschile o del femminile perché nata con un’anantomia sessuale o un corredo genetico atipici, o perché le sue ghiandole producono quantità atipiche di ormoni sessuali. Sull’argomento si vedano, almeno: Laqueur 1990, Fausto-Sterling 1992, Dreger 1998, Crocetti 2013. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 81 Lorenzo Bernini DOI: 10.1400/228743 ha prodotto molteplici culture politiche, spesso in conflitto tra loro. Tanto rumore per nulla: Si è fatto un gran parlare, sulla stampa nazionale e internazionale, dei “rivoluzionari” articoli sull’omosessualità contenuti nella Relatio post disceptationem che Papa Bergoglio avrebbe imposto alla discussione del recente Sinodo straordinario sulla famiglia per bocca del Relatore generale Cardinale Péter Erdő (2014), e della resistenza che essi avrebbero incontrato nei Padri sinodali4. Nella Relatio Synodi definitiva (Sinodo dei Vescovi 2014), nulla è in effetti rimasto dei riferimenti alle «doti e qualità» che le persone omosessuali potrebbero «offrire alla comunità cristiana», al «mutuo sostegno fino al sacrificio» di cui in alcuni casi i partner omosessuali darebbero prova, alla «attenzione speciale» che la Chiesa dovrebbe rivolgere ai «bambini che vivono con coppie dello stesso sesso». Il documento cita invece le Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali redatte nel 2003 dalla Congregazione per la dottrina della fede, quando Ratzinger ne era il prefetto e Wojtyla era papa. L’articolo 55 stabilisce infatti che «gli uomini e le donne con tendenze omosessuali» debbano essere «accolti con rispetto e delicatezza», evitando loro «ogni marchio di ingiusta discriminazione», e assieme ricorda che per la Chiesa cattolica «non esiste fondamento alcuno per assimilare e stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia5». Non che il testo proposto da Erdő difendesse i matrimoni lesbici e gay: anch’esso affermava anzi che «le unioni fra persone dello stesso sesso non possono essere equiparate al matrimonio fra uomo e donna». E le analogie non finiscono qui: l’articolo 56 della Relatio Synodi è stato tratto quasi alla lettera dalla Relatio post disceptationem. Esso recita, infatti che «è del tutto inaccettabile che i Pastori della Chiesa subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso6», laddove il documento iniziale riportava che «non è nemmeno accettabile che si vogliano esercitare pressioni sull’atteggiamento dei Pastori o che organismi internazionali condizionino aiuti finanziari all’introduzione di normative ispirate all’ideologia del gender» (corsivo mio). La sezione dedicata all’omosessualità della prima Relatio si apriva chiedendo se la Chiesa possa essere per le persone omosessuali una «casa accogliente», «senza compromettere la dottrina cattolica su famiglia e matrimonio». La domanda poteva sembrare retorica, ma non lo era, e ha trovato una chiara risposta: no. Non del tutto chiara all’opinione pubblica, perché occultata dal sensazionalismo giornalistico, è invece la posizione di Bergoglio e del suo entourage - di cui quel testo era evidentemente espressione. La “teoria del gender” Per cercare di comprendere meglio quanto è stato dibattuto dai Padri sinodali, può essere utile ripercorrere le vicende della campagna di educazione contro la discriminazione delle minoranze sessuali che l’UNAR (l’Ufficio Nazionale Anti-discriminazioni Razziali italiano) ha sviluppato sotto il governo Monti7. Nel marzo 2014, Gabriele Toccafondi, il nuovo sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del governo Renzi, ha bloccato la diffusione degli opuscoli Educare alla diversità a scuola che secondo i programmi dell’UNAR avrebbero dovuto essere distribuiti capillarmente agli insegnanti italiani. Pochi giorni prima, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana cardinale Angelo Bagnasco era intervenuto contro la trasformazione delle scuole pubbliche in «campi di rieducazione e indottrinamento». E pochi giorni dopo, nel corso dell’udienza all’associazione The International Catholic Child Bureau, sull’argomento è tornato lo stesso Bergoglio per affermare che «i bambini hanno il diritto di crescere con un padre e una madre», e «i genitori hanno il diritto di impartire ai propri figli 4 La Relatio post disceptationem è stata letta da Erdő il 13 ottobre 2014, a una settimana dall’inizio dei lavori; la La Relatio synodi conclusiva è stata resa pubblica il 18 ottobre. 5 L’articolo 55, come quelli relativi alla comunione ai divorziati risposati, non è stato approvato dalla maggioranza qualificata dei due terzi (ha ricevuto 118 “placet” contro 62 “non placet”). Come ha dichiarato il Direttore della Sala stampa vaticana padre Federico Lombardi, questo significa che sull’argomento non si è trovato un consenso largo e che esso resta quindi «aperto». 6 L’articolo 56 ha invece ricevuto 159 “placet” e 21 “non placet”, ed è stato quindi approvato a maggioranza qualificata. 7 In ottemperanza alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec(2010)5. 82 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228743 Lorenzo Bernini un’educazione religiosa». Le aperture del Papa verso le persone omosessuali vanno quindi comprese come un tentativo di aggiornare l’agenda di una Chiesa in calo di popolarità rispetto a mutamenti epocali che le restano estranei e con cui tuttavia deve fare i conti: il Sinodo non ha discusso una proposta di riforma dottrinale (Romandini 2014), ma piuttosto una “strategia di marketing”. Le pratiche omosessuali restano per Bergoglio, come per i suoi predecessori, un peccato da cui chi ha desideri omosessuali dovrebbe astenersi, ma dal momento che donne e uomini omosessuali stanno ottenendo sempre maggiore riconoscimento e visibilità sociale, a suo avviso la Chiesa deve dichiarare pubblicamente la sua disponibilità a perdonare anche loro, al pari di tutti gli altri peccatori pentiti, come Gesù lasciò che la prostituta penitente gli lavasse i piedi (Luca 7: 36-50). «Chi sono io per giudicare un gay?», ha chiesto il papa nel luglio 2013; un po’ come dire: «chi è senza peccato, scagli la prima pietra» (Giovanni 8: 7). In alcun modo questo atteggiamento di misericordia deve essere confuso con la promozione di nuovi modelli di famiglia o con un impegno attivo contro la discriminazione. Al contrario, la Chiesa di Bergoglio difende come un diritto dei genitori l’educazione tradizionalista in materia di etica sessuale e si oppone alle campagne volte a contrastare omofobia, transfobia e bifobia a partire dal bullismo scolastico. Pochi giorni dopo la conclusione del Sinodo della famiglia, Bagnasco ha rilasciato un’intervista alla Radio Vaticana in cui ha puntualizzato che il proposito maturato nelle discussioni dell’assemblea dei Vescovi è stato quello di contrastare il «pensiero unico» dell’«antropologia occidentalista» che «ormai ruota attorno alla cosiddetta teoria del genere», e di difendere i genitori cattolici dalla «violenza autoritaria» delle istituzioni. Il sintagma “teoria del genere” era già stato utilizzato da Bagnasco in occasione della sospensione della distribuzione degli opuscoli antidiscriminatori dell’UNAR nelle scuole; come si sarà notato, nella Relatio post disceptationem ne compariva invece un altro, “ideologia del gender”. Le espressioni si equivalgono, e hanno una terza variante, “teoria del gender”. Questa è stata coniata negli anni 2000 dal Pontificio Consiglio per la Famiglia (2003), e in una decina d’anni ha ispirato un’ampia fioritura editoriale (Galeotti 2010, Montfort 2011, Anatrella 2012, Peeters 2013). A utilizzarla è stato anche Ratzinger, quando ancora era papa, nel discorso prenatalizio alla Curia romana del dicembre 2012 - mentre in Francia si discuteva del disegno di legge sul “mariage pour tous” che sarebbe stato poi approvato nell’Aprile 2013. Da allora ha acquisito una crescente popolarità nell’opinione pubblica cattolica e nella cultura politica europea: negli ultimi due anni contro la teoria/ideologia del gender sono stati organizzati conferenze e convegni8 volti a informare capillarmente i fedeli; contro di essa in tutta Europa, ma soprattutto in Francia e in Italia, hanno manifestato movimenti avversi alla promozione dei diritti e alla riduzione della discriminazione delle persone LGBTQI; contro di essa, infine, alcuni comuni italiani hanno votato delibere in difesa della famiglia naturale. Come ha illustrato Sara Garbagnoli in un recente articolo pubblicato sulla rivista «AG - AboutGender», la crociata contro «la misteriosa “teoria”» è «un blob di slogan senza alcun senso teorico e di pregiudizi sessisti e omofobi» che forniscono una caricatura degli studi di genere e delle teorie queer, riducendo a una unità incoerente (la teoria de gender, al singolare) due ampi campi di sapere all’interno dei quali si confrontano posizioni differenti (Garbagnoli 2014b: 395)9. Emblematica è l’opinione del sacerdote e psicoanalista Tony Anatrella - redattore, tra l’altro, delle voci Omosessualità e omofobia e Riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali nel Lexicon del Pontificio Consiglio per la Famiglia (2003) -, secondo cui la teoria del gender è un’ideologia anticristiana che dopo il crollo del muro di Berlino ha preso il posto del marxismo, ma che a differenza di questo ha raggiunto una posizione egemonica nell’ONU e nell’Unione Europea. Egli scrive, ad esempio, che: 8 Ad esempio il convegno che si è tenuto a Verona il 21 settembre 2013 – due soli giorni dopo che alla Camera è stata approvata una controversa legge contro l’omotransfobia (che non è poi stata discussa in Senato) –, ed è poi stato riproposto, con qualche variante, in altre città italiane. Intitolato La teoria del gender: per l’uomo o contro l’uomo?, esso ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Verona, si è aperto con i saluti del vescovo (Giuseppe Zenti) e del sindaco (Falvio Tosi), ed è poi proseguito con interventi la cui finalità era di difendere il diritto di affermare che l’omosessualità è una malattia. I relatori erano: Roberto de Mattei, Mauro Palmaro, Luca Galantini, professori rispettivamente in Storia della Chiesa, Filosofia del Diritto e Storia del diritto moderno all’Università Europea di Roma; Dina Nerozzi, professoressa in PsicoNeuroEndocrinologia all’Università Tor Vergata di Roma; Chiara Atzori, infettivologa all’ospedale Luigi Sacco di Milano, Matteo D’Amico, docente di Filosofia a Storia ad Ancona. Si vedano gli atti: Famiglia Domani, Movimento Europeo Difesa della Vita 2014; e anche il mio commento in Bernini 2014. 9 Di Garbagnoli si veda anche 2014a; un suo ulteriore articolo sull’argomento, in inglese, è di prossima uscita. Un giudizio analogo al suo si trova anche in: Bereni, Trachman 2014, Fassin 2010a, Fassin, Margron 2011, Fillod 2014, Scott 2013. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 83 Lorenzo Bernini DOI: 10.1400/228743 1. La teoria del genere afferma che non esiste una natura umana poiché l’essere umano sarebbe unicamente un risultato della cultura. Essa cerca di dimostrare che la mascolinità e la femminilità non sono che costruzioni sociali, dipendenti dal contesto culturale di ogni periodo. 2. Questa teoria afferma che […] il compito della legge civile dei paesi democratici è quello di favorire la presa di potere da parte delle donne per liberarsi dal potere maschile. […] La legge deve altresì colmare i difetti della natura che pongono la donna in posizioni impari rispetto all’uomo, particolarmente nel caso della maternità, portata avanti unicamente dalla donna, oppure dell’ingiustizia nei confronti degli uomini, privi del seno per allattare i bambini. […] L’uomo viene così escluso dalla procreazione che diventa proprietà della donna. In questo gioco di poteri, l’uomo viene spesso presentato dalle femministe come un aggressore e violentatore. […] 3. La sfida radicale consiste nel negare la differenza sessuale, che non sarebbe quindi una realtà strutturale, assecondando in questo modo i vari orientamenti sessuali, tra cui l’omosessualità (Anatrella 2012: 36-37). E poi conclude: La teoria del genere sviluppa così una concezione che cerca di estraniarsi dal corpo, desessualizzando la coppia e la famiglia ed eliminando i legami di carne nella filiazione. Si tratta di una teoria che ignora il significato del simbolismo umano della mascolinità e della femminilità. […] È piuttosto strano constatare come si rivendichi sempre più un diritto alla differenza mentre, nello stesso tempo, si distruggono le basi della differenza sessuale, presentando peraltro l’omosessualità come una differenza o un’alternativa all’eterosessualità, cosa che collide con la realtà. Al contrario, la teoria del genere rappresenta la negazione di tutte le differenze. Si sostiene così che la differenza sessuale non ha alcuna importanza nella coppia e nella famiglia, e perfino per l’educazione dei bambini, mentre invece tale differenza è essenziale. Sempre in quest’ottica, si sostiene che la differenza sessuale debba essere presente nella vita professionale e politica, arrivando così a votare in favore di quote del 40% di presenza femminile nelle istituzioni in nome della parità. […] Si tratta di una visione slegata dalla realtà che prepara il terreno a questioni inquietanti per il futuro (Anatrella 2012: 37-38). Di fronte a tanta “inquietudine” espressa da una Chiesa che, è bene ricordarlo, nel nome della differenza sessuale continua a negare alle donne l’accesso al sacerdozio, ci si sarebbe potuti aspettare una presa di posizione forte e unitaria da parte del femminismo italiano. Invece, come ricorda Garbagnoli, i movimenti LGBTQI sono stati lasciati soli a protestare contro i convegni omotransbifobici10 e le veglie delle Sentinelle in piedi11, e addirittura nel marzo 2014 Luisa Muraro, leader storica di quel “pensiero della differenza” che vanta un’indiscussa egemonia nel femminismo italiano, ha scritto a «il manifesto» una lettera in cui ha plaudito al «tradivo buon senso» del Presidente della Repubblica Francese François Hollande che «davanti alle vivaci proteste delle famiglie musulmane e cattoliche (e forse anche altre)» ha ritirato la proposta di legge «per una riforma educativa ispirata alla teoria di genere e finalizzata contro il sessismo, il razzismo, l’omofobia, fin dall’infanzia»12. A restare per 10 Ad esempio a Verona, al convegno del 21 settembre 2013 La teoria del gender: per l’uomo o contro l’uomo? (nota 8, supra) ha fatto seguito, il 9 novembre 2013, un contro-convegno, organizzato dalle associazioni LGBTQI, intitolato ironicamente Contro natura? Lesbiche, gay, biessuali, asessuali, trans*, intersex/dsd si interrogano sul loro posto nel creato. 11 Il movimento delle Sentinelle in piedi ha importato in Italia la modalità di protesta contro i disegni di legge contro l’omotransfobia e per il riconoscimento giuridico delle coppie lesbiche e gay dell’analogo movimento francese Les Veilleurs debout. I manifestanti occupano una piazza, disponendosi a crica due metri di distanza l’uno dall’altro, rivolti tutti verso la stessa direzione, e per un’ora leggono in silenzio testi di ispirazione cattolica. Dal settembre 2013, in seguito all’approvazione alla Camera del disegno di legge contro l’omotransfobia (nota 8, supra) eventi di questo genere si sono verificati in molte città italiane, tra cui Arezzo, Bologna, Ivrea, Lecce, Milano, Napoli, Reggio Emilia, Roma, Torino, Treviso, Varese, Verona. Ogni volta le Sentinelle in piedi sono state contestate dalle associazioni LGBTQI, talvolta supportate da movimenti studenteschi e centri sociali. 12 La posizione di Muraro ricalca quella di Luce Irigaray ed è ampiamente condivisa all’interno del pensiero della differenza e ai movimenti che a esso si ispirano. Al convegno La soggettività politica delle donne, tenutosi a Verona il 25 ottobre 2014, Serena Sapegno, leader del movimento “Se Non Ora Quando”, ha ad esempio affermato che «La differenza fondamentale del genere umano è quella tra maschi e femmine» e che il soggetto queer è «isolato, autosufficiente, tipico dell’ideologia neoliberista, titolare di diritti individuali, in grado di automodellarsi e autodefinirsi ricorrendo anche alla tecnologia se necessario, senza storia, senza inconscio, senza limiti, senza legami: un delirio» (si veda la registrazione del suo intervento: http://www.politesse.it/dspbis.php?s=news&lng=e&id=62, ultimo 84 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228743 Lorenzo Bernini lo più in silenzio è stato anche il mondo universitario italiano, che del resto si è sempre dimostrato restio a riconoscere dignità accademica a studi di genere e teorie queer. L’unica eccezione è stata quella del Direttivo della Società Italiana delle Storiche che nell’Aprile 2014, quando è stata bloccata la distribuzione degli opuscoli UNAR nelle scuole, ha prontamente indirizzato una lettera alla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini per denunciare quanto grave sia stata la capitolazione delle istituzioni di fronte alle pressioni delle gerarchie ecclesiastiche. La lettera affermava la necessità di avviare nelle scuole programmi di educazione al genere che possano contribuire allo «sviluppo di una società più giusta e tollerante» attraverso la «riflessione sugli stereotipi sessuali», «nel segno di un approccio critico alle idee e ai saperi, di una lotta più consapevole contro le discriminazioni sessuali e l’omofobia». E, tra l’altro, precisava: Non esiste […] una “teoria del gender”. Con questa categoria, usata in modo fecondo in tutta una serie di discipline che ormai costituiscono l’ambito dei gender studies, non si introduce tanto una teoria, una visione dell’essere uomo e dell’essere donna, quanto piuttosto uno strumento concettuale per poter pensare e analizzare le realtà storico-sociali delle relazioni tra i sessi in tutta la loro complessità e articolazione: senza comportare una determinata, particolare definizione della differenza tra i sessi, la categoria consente di capire come non ci sia stato e non ci sia un solo modo di essere uomini e donne, ma una molteplicità di identità e di esperienze, varie nel tempo e nello spazio. Proprio per la sua notevole capacità analitica e il suo carattere non prescrittivo il gender ha aperto nuove e importanti direttrici di ricerca che nella comunità scientifica e nell’insegnamento superiore di molti paesi sono ormai riconosciuti e sostenuti, a differenza di quanto accade nel nostro Paese: del resto, la disinformazione di cui stiamo avendo prova in queste settimane conferma ampiamente il ritardo cumulato13. Il documento della Società Italiana delle Storiche insiste, quindi, sulla natura critica ed euristica, non dogmatica né normativa, del concetto di gender all’interno del settore disciplinare degli studi di genere. Non per dar loro torto, ma anzi per rafforzare ulteriormente ciò che esse sostengono, sarebbe però più opportuno considerare “gender” non come un concetto dotato di una natura stabile e di un significato univoco, ma come un significante fluttuante. Ancor meglio, come un dispositivo concettuale che in breve tempo ha prodotto configurazioni teoriche, soggettività politiche e posizionamenti strategici differenti e spesso discordanti - tra cui la campagna anti-gender del Vaticano e i movimenti cattolici tradizionalisti che a essa si ispirano, e la presa di parola nella sfera pubblica della Società Italiana delle Storiche. Senza pretese di esaustività, il terzo e ultimo paragrafo di questo articolo tenterà di restituire al lemma la sua ricchezza e complessità, fornendo una schematica ricostruzione della storia delle sue variazioni di significato e delle culture politiche che queste hanno generato. Un campo di sapere vasto e variegato Ne La volonté de savoir, primo volume della Storia della sessualità, Michel Foucault (1976) sostiene che il concetto di omosessualità sia stato coniato nel 1870 dal sessuologo tedesco Karl Friedrich Westphal; ma Westphal introdusse il concetto di “sexual inversion”, che non faceva distinzione tra quelle condizioni che oggi chiamiamo “omosessualità” e “transessualità/transgenderismo”, e interpretava entrambe come “inversione” tra gli elementi maschili e femminili della personalità (Bernini 2010). In realtà, soltanto l’introduzione della categoria di gender ha permesso ai medici di distinguere omosessualità e transessualità. La prima formulazione del nuovo concetto si trova negli studi sull’intersessualità e la transessualità elaborati a metà degli anni cinquanta del XX secolo dal gruppo di ricerca del Johns Hopkins Hospital di Baltimora, guidato dallo psicologo John Money (1955). La sua funzione è, inizialmente, distinguere la dimensione sociale e psicologica della differenza sessuale (identificarsi accesso 15 novembre 2014). La pedagogista Anna Maria Piussi, membro della comunità filosofica femminile Diotima, intervenendo dal pubblico ha poi ripreso le parole di Sapegno per esprimere la sua preoccupazione per la diffusione di progetti educativi che mettono in discussione la differenza sessuale. In seguito all’uscita della lettera a «il manifesto» di Muraro, a prenderne le distanze sui social network sono state invece per lo più esponenti di collettivi femministi vicini ai movimenti LGBTQI. 13 Il testo è consultabile all’indirizzo http://www.immaginiamicheravenna.it/wp-content/uploads/2014/05/LetteraSIS_genere.pdf (ultimo accesso, 15 novembre 2014). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 85 Lorenzo Bernini DOI: 10.1400/228743 come uomo o donna a seconda dei modelli di mascolinità e femminilità della propria cultura) da altre componenti della sessualità: il sesso biologico (maschile o femminile) e l’orientamento sessuale (omosessuale o eterosessuale)14. Dalla sessuologia, il concetto di gender si diffonde poi nelle scienze sociali e nel pensiero politico, dove produce un intenso dibattito. Negli anni settanta è utilizzato dal femminismo di “seconda ondata” (Friedan 1963) per denunciare la naturalizzazione dei ruoli culturali che perpetuano la subordinazione delle donne agli uomini nelle società patriarcali (Chodorow 1978, Gilligan 1982)15. Ma quasi subito, in polemica con l’insistenza del femminismo sulla sola differenza sessuale tra uomini e donne, alcune pensatrici lesbiche iniziano a proporre un uso del concetto al di fuori del suo significato originario. Già nei tardi anni settanta, Monique Wittig (1980) sostiene che «la lesbica non è una donna», ma un genere a sé stante, argomentando che in una cultura eterosessista in cui l’identità femminile è definita dalla sua complementarietà con quella maschile, il sentimento di appartenenza della lesbica all’identità femminile non può che essere parziale. Nei primi anni novanta, Judith Butler rielabora le riflessioni sulla storia della sessualità di Foucault (1976, 1984a, 1984b) e le intuizioni del pensiero lesbofemminista a lei precedente e rivendica la priorità logica della discriminazione per orientamento sessuale sulla discriminazione delle donne. A suo avviso è l’“eterosessualità obbligatoria” (Rich 1980) a imporre ruoli stereotipati alle donne e agli uomini nelle società patriarcali, e non può quindi esserci liberazione definitiva delle donne eterosessuali dal regime patriarcale senza liberazione delle donne e degli uomini omosessuali e trans. Per queste tesi Butler è considerata, assieme a Eve Kosofsky Sedgwick (1990) e Teresa de Lauretis (1991) l’iniziatrice delle teorie queer, e infatti i suoi libri Gender Troubles (1990) e Undoing Gender (2004) propongono di “queerizzare” il gender sostenendo che le sperimentazioni identitarie delle comunità LGBTQI rendano pensabile una proliferazione dei generi oltre il binarismo donna/ uomo. Altre pensatrici femministe e lesbofemministe hanno ipotizzato addirittura che nel mondo globalizzato del capitalismo avanzato il genere, se inteso esclusivamente come distinzione e complementarietà del maschile e del femminile, stia per diventare un concetto obsoleto perché la diffusione di chirurgia estetica, riproduzione assistita, protesi sessuali, realtà virtuale sta conducendo l’umanità in un’era «post-gender» e «post-umana» in cui le identificazioni sessuali tradizionali risulteranno per sempre decostruite e riconfigurate in modi imprevisti (Firestone 1970, Haraway 1991, Braidotti 1993, Braidotti 2013). È comprensibile che questa diagnosi del presente, condotta con toni di entusiastica adesione e accompagnata dal plauso per il supposto definitivo sgretolarsi dell’ordine patriarcale, generi preoccupazioni presso una Chiesa il cui Papa continua a essere chiamato “Santo Padre”. Meno lo è che il conservatorismo cattolico trovi sponda, in Italia, in un certo femminismo16. In ogni caso, ciò a cui qui occorre almeno far cenno, al fine di testimoniare la pluralità di voci che partecipano a quel dibattito che viene frettolosamente e approssimativamente unificato sotto l’etichetta di “teoria del gender”, è che se in Europa oggi sono per lo più movimenti reazionari a opporsi agli effetti sociali e giuridici della diffusione del concetto di gender, nell’America del Nord a contestarne alcune interpretazioni (ma non certo l’educazione al genere intesa come educazione al rispetto delle minoranze sessuali) nel nome di autorità teoriche del passato sono stati esponenti delle stesse teorie queer. Già nei primi anni novanta la pensatrice lesbofemminista Teresa de Lauretis (1991) ha messo in luce che intersecando gli assi di sesso, genere e orientamento sessuale, i fattori “razza” e “classe” impediscono di pensare donne, lesbiche, gay, trans come soggetti politici unitari. In anni più recenti sono stati invece soprattutto alcuni teorici gay e transgender 14 John Money (1921-2006) era uno strenuo assertore della tesi secondo cui ogni essere umano nasce con identità di genere “neutra” che viene poi plasmata come maschile o femminile esclusivamente dai condizionamenti educativi. Tristemente celebre è il caso di David Reimer (1965-2004), un bambino a cui poco tempo dopo la nascita fu amputato accidentalmente il pene durante un’operazione di circoncisione. Money convinse i genitori a crescerlo come una bambina, e pubblicò articoli in cui lo presentava come il “caso clinico” che dimostrava definitivamente la sua teoria. Il sessuologo Milton Diamond (1997) scoprì, in seguito, che durante l’adolescenza David si era ribellato alla sua femminilizzazione e aveva riacquistato identità maschile. Una volta adulto, lo stesso Reimer rese pubblica la sua storia, affinché fosse nota l’infondatezza della tesi di Money. All’età di 39 anni, si tolse la vita. Questa tragica vicenda è spesso utilizzata dagli studi di genere e dalle teorie queer (ad esempio: Butler 2004) per denunciare i pericoli della medicalizzazione della sessualità e affermare il diritto soggettivo all’autodeterminazione del genere. 15 Sulla storia delle filosofie femministe, si vedano almeno, tra i testi italiani: Cavarero, Restaino 2002, Guerra 2008, Missana 2014. 16 Si torni alla nota 12, supra. 86 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228743 Lorenzo Bernini a denunciare che l’inclusione sociale promossa dal concetto di identità di genere (se astratto dalle dimensioni materiali delle pratiche sessuali) comporta l’adeguamento delle minoranze sessuali a stili di vita che le società liberali statunitensi ed europee già prevedono per le persone eterosessuali e provoca l’esclusione di chi non può o non vuole uniformarsi agli standard di rispettabilità di tali società. José Esteban Muñoz (1999, 2009) ha ad esempio mostrato che il tempo in cui vivono docenti universitarie angloamericane o nordeuropee che hanno accesso alle tecniche di riproduzione assistita e frequentano ambienti progressisti coesiste con quello in cui vivono soggetti appartenenti a minoranze sessuali di livello culturale meno elevato e di ceti meno abbienti, costretti a confrontarsi con l’omotransbifobia ancora ben radicata nei loro ambienti di vita; e che la percezione di sé di questi soggetti, lungi dall’essere “post-gender”, è talvolta informata da schemi interpretativi che provengono da prima che la distinzione sesso-genere-orientamento sessuale divenisse senso comune. Autori come Leo Bersani (1987, 1996; Bersani, Phillips 2008), Lee Edelman (2004; Berlant, Edelman 2014), Judith “Jack” Halbestam (2006, 2011, 2012) hanno invece contestato la visione disincarnata della sessualità prodotta dagli studi di genere e hanno proposto un ritorno delle teorie queer a un’analisi materialistica della sessualità effettuata con gli strumenti interpretativi della psicoanalisi (soprattutto di Lacan e Laplanche)17. Infine, James Penney (2014), seguendo la scia della “Marx renaissance” che ha fatto seguito alla crisi economica del 2008, ha proposto di abbandonare le teorie queer, gli studi di genere, Foucault e tutto il post-strutturalismo per recuperare non soltanto il pensiero di Lacan, ma anche le tesi della Scuola di Francoforte, e quindi di Freud e - appunto - di Marx. La sua tesi è che anziché politicizzare genere e desiderio sessuale, pensandoli minoritariamente come due sfere di oppressione accanto alle altre (razza e classe), occorra riprendere il progetto di sessualizzare la totalità della sfera politica riattivando la «battaglia emancipativa genuinamente universale» (Penney 2014: 2) avviata negli anni settanta da Guy Hocquenghem (1972) e Mario Mieli (1975). Ma naturalmente, neppure quella di Penney è l’ultima parola: in molte e molti, tra cui l’autore di questo articolo, restano convinti che le minoranze sessuali non abbiano bisogno di giustificare le loro rivendicazioni facendo appello a quella idea di totalità che è sempre stata utilizzata per discriminarle ed escluderle. Lungi dall’essere stati definitivamente liquidati, gli studi di genere e le teorie queer continuano a essere praticati nelle università e nella società, e le fluttuazioni del significante gender continuano a turbare chi, in nome di quel Dio che nel pensiero occidentale dell’universale è diventato archetipo, vorrebbe imporre un ordine stabile alla sessualità. Conclusione - Timeo Danaos…: In quei campi di sapere vasti e variegati che sono gli studi di genere e le teorie queer, il gender è quindi un operatore discorsivo che nel corso di poco più di mezzo secolo, lungi dall’essersi irrigidito in un’ideologia dogmatica, ha suscitato una vivace discussione critica, capace talvolta, ancora oggi, di acquistare i toni di un’accesa polemica. A farne un feticcio ideologico, negli ultimi anni, è stato piuttosto quel discorso cattolico - il cui scopo non è la ricerca teorica ma la persuasione retorica - che costituisce la cornice all’interno della quale attualmente vengono discusse anche le possibili “aperture” della Chiesa di Bergoglio alle donne e agli uomini omosessuali. «Timeo Danaos et dona ferentes» (Eneide II, 49), disse il povero Laocoonte di fronte al cavallo di Troia. Nessuno, sfortunatamente, lo ascoltò. 17 Bersani (1987, 1996) afferma, ad esempio, che né Foucault né Butler hanno descritto il sesso nei suoi spetti perturbanti e disfunzionali, e che entrambi hanno cercato di redimere il sesso politicizzandolo e quindi desessualizzandolo. Foucault in effetti ne La volonté de savoir (1976) non parla di sesso, ma di sessualità intesa come un dispositivo biopolitico che plasma il soggetto; e Butler in Gender Trouble (1990) non parla di sesso ma di gender. In entrambi i casi, al soggetto della sessualità o della performance di genere è affidato il compito di resistere creativamente e consapevolmente al potere che lo costituisce e che lo opprime. Si tratta quindi di soggetti politici tradizionalmente intesi – “soggetti liberali”, nella terminologia di Bersani –, che cercano benessere e riconoscimento sociale, e non di soggetti sessuali abitati da quella pulsione sessuale che, come insegna Freud, è al di là del principio di piacere (Freud 1977). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 87 Lorenzo Bernini DOI: 10.1400/228743 Riferimenti bibliografici Anatrella T. (2012), La teoria del “gender” e l’origine dell’omosessualità, Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo. Arfini E.A.G., Lo Iacono C. (2012), La cosa queer, in Ead. (a cura di), Canone inverso: Antologia di teoria queer, Pisa: Edizioni ETS. Bereni L., Trachman M. (2014, a cura di), Le genre, théories et controverses, Parigi: Puf. Berlant L., Edelman L. (2014), Sex, or the Unbearable, Durham and London: Duke University Press. Bernini L. (2010), Maschio e femmina Dio li creò!? Una critica transmodernista del binarismo sessuale, Milano: Il Dito e La Luna. Bernini L. (2013), Apocalissi Queer: Elementi di teoria antisociale, Pisa: Edizioni ETS. Bernini L. (2014), Futuro: (E)scatologia del tempo della crisi, in L. Coccoli, M. Tabacchini, F. Zappino (a cura di), Genealogie del presente: Lessico politico per tempi interessanti, Milano-Udine: Mimesis. Bersani L. (1987), Is the Rectum a Grave?, in «October», 43. Bersani L. (1996), Homos, Cambridge: Harvard University Press. Bersani L., Phillips A. (2008), Intimacies, Chicago and London: The University of Chicago Press. Braidotti R. (1993), Gender and Post-Gender:The Future of an Illusion?, in Corona M., Lombardo G. (a cura di), Atti dell’undicesimo convegno biennale “Methodologies of Gender”, Roma: Herder. Braidotti R. (2013), The Posthuman, Cambridge: Polity Press. Butler J. (1990), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London-New York: Routledge. Butler J., (2004), Undoing Gender, London-New York: Routledge. Cavarero A., Restaino F. (2002, a cura di), Le filosofie femministe, Milano: Bruno Mondadori. Chodorow N. (1978), The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender, Berkeley-Los Angeles: The Regents of the University of California. Colpani G., Habed A.J. (2014a), What is European about Homonationalism? Thinking through the Italian Case, in D. Olivieri, K. Leurs (eds), Everyday Feminist Research Praxis: Doing Gender in the Netherlands, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Colpani G., Habed A.J. (2014b), In Europe it’s Different: Homonationalism and Peripheral Desires for Europe, in Ph.M. Ayoub, D. Paternotte (eds), LGBT Activism and the Making of Europe: A Rainbow Europe?, Basingstoke: Palgrave Macmillan. Congregazione per la dottrina della fede (2003), Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, Cinisello Balsamo: Edizioni San Paolo. Crocetti D. (2013), L’invisibile intersex: Storie di corpi medicalizzati, Pisa: Edizioni ETS. De Lauretis T. (1991), Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities: An Introduction, in «Differences», 3. Diamond M. (1997), Sex Reassignment at Birth: Long-term Review and Clinical Implications, in «Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine», 3. Dreger A.D. (1998), Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex, Cambridge: Harvard University Press. Duggan L. (2003), The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy, Boston: Beacon Press. 88 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228743 Lorenzo Bernini Edelman L. (2004), No Future: Queer Theory and the Death Drive, Durham and London: Duke University Press. Erdő P. (2014), Relatio post disceptationem del Relatore generale, Card. Péter Erdő, in «Bollettino sala stampa della Santa Sede», http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/13/0751/03037.html, ultimo accesso 15 novembre 2014. Famiglia Domani, Movimento Europeo Difesa della Vita (2014), La teoria del gender: per l’uomo o contro l’uomo? Atti del Convegno,Verona, 21 settembre 2013, Chieti: Edizioni Solfanelli. Fassin É. (2010a), Les “forêts tropicales” du mariage hétérosexuel: Loi naturelle et lois de la nature dans la théologie actuelle duVatican, in «Revue d’éthique et de théologie morale», 261. Fassin É. (2010b), National Identities and Transnational Intimacies : Sexual Democracy and the Politics of Immigration in Europe, in «Public Culture», 22. Fassin É., Margron V. (2011), Homme, femme, quelle différence?, Paris: Salvator. Fausto-Sterling A. (1992), Myths of Gender: Biological Theories aboutWomen and Men, New York: Basic Books. Feinberg L. (1992), Transgender Liberation, New York: World View Forum. Fillod O. (2014), L’invention de la théorie du genre: Le mariage blanc duVatican et de la science, in «Contemporary French Civilization», 3. Firestone Sh. (1970), The Dialectic of Sex:The Case for Feminist Revolution, New York: William Morrow & Co. Foucault M. (1976), La volonté de savoir: Histoire de la sexualité I, Paris: Gallimard. Foucault M. (1984a), L’usage des plaisirs: Histoire de la sexualité II, Paris: Gallimard. Foucault M. (1984b), L’usage des plaisirs: Histoire de la sexualité II, Paris: Gallimard. Freud S. (1977), Al di là del principio di piacere, trad. it. in Id. Opere, vol. 9, Torino: Boringhieri. Friedan B. (1963), The Feminine Mystique, New York: W.W. Norton & Co. Galeotti G. (2010), Gender. Genere, Roma: Vivere In. Garbagnoli S. (2014a), LeVatican contre la dénaturalisation de l’ordre sexuel: Structure et enjeux d’un discours institutionnel réactionnaire, in «Synergies Italie», 10. Garbagnoli S. (2014b), “L’ideologia del genere”: l’irresistibile ascesa di un’invenzione retorica vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine sessuale, in «AG AboutGender, International Journal of Gender Studies», 6. Garbagnoli S. (in uscita), Performance and Performativity of theVatican’s Gender Theory: National Imprints of a Transnational Crusade (France-Italy), in «Religion and Gender». Gilligan C. (1982), In a DifferentVoice: Psychological Theory andWomen’s Development, Cambridge: Harvard University Press. Guerra E. (2008), Storia e cultura politica delle donne, Firenze: Archetipo libri, 2008. Kosovsky Sedgwick E. (1990), Epistemology of the Closet, Berkeley: California University Press. Halberstam J.J. (2006), The Politics of Negativity in Recent Queer Theory, in «PMLA», 3. Halberstam J.J. (2011), The Queer Art of Failure, Durham and London: Duke University Press. Halberstam J.J. (2012), Gaga Feminism: Sex, Gender and the End of Normal, Boston: Beacon Press. Haraway D. (1991), A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-feminism in the Late Twentieth Century, in Id. (ed), Simians, Cyborgs andWomen:The Reinvention of Nature, New York: Routledge. Hocquenghem G. (1972), Le Désir homosexuel, Paris: Éditions Universitaires. Laqueur T. (1990), Making Sex: Body and Gender from Greeks to Freud, Cambridge: Harvard University Press. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 89 Lorenzo Bernini DOI: 10.1400/228743 Mieli M. (1975), Elementi di critica omosessuale, Torino: Einaudi. Missana E. (2014), Donne si diventa: Antologia del pensiero femminista, Milano: Feltrinelli. Money J. (1955), Hermafroditism, Gender and Precocity in Hyperadrenocorticism: Psychologic Findings, in «Bullettin of the Johns Hopkins Hospital», 96. Montfort E. (2011), Le genre démasqué: Homme ou femme? Le choix impossible, Valence: Éditions Peuple libre. Muñoz J.E. (1999), Disidentifications: Queers of Colour and the Performance of Politics, Minneapolis: University of Minnesota Press. Muñoz J.E. (2009), Cruising Utopia:The Then and There of Queer Futurity, New York: NYU Press. Muraro L., Sasso A. (2014), Luisa Muraro e Alba Sasso, ma che genere di scuola?, in «il manifesto», 31 marzo 2014. Peeters M.A. (2013), The Gender Revolution: A Global Agenda. A Tool for Discernment, Bruxelles: Dialogue Dynamics. Penney J. (2014), After Queer Theory:The Limits of Sexual Politics, London: Pluto Press. Pontificio Consiglio per la Famiglia (2003), Lexicon: Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna. Puar J. (2007), Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times, Durham and London: Duke University Press. Pustianaz M. (2001, a cura di), Queer in Italia: Differenze in movimento, Pisa: Edizioni ETS. Rich A. (1980), Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence, in «Sign», 5. Romandini F.L. (2014), Papa Francesco e l’avanguardia omosessuale, trad. it. in «Le parole e le cose.it», http://www. leparoleelecose.it/?p=16543, ultimo accesso 15 novembre 2014. Scott J.W. (2013), Genere, politica, storia, trad. it. Roma: Viella. Sinodo dei Vescovi (2014), Relatio Synodi della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo deiVescovi: Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione, in «Bollettino sala stampa della Santa Sede», http://press.vatican.va/ content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/10/18/0770/03044.html, ultimo accesso 15 novembre 2014. Westphal K.F. (1870), Die Konträre Sexualempfindung, in «Archiv für Psychiatrie und Nervenkrenkheiten», 1. Wittig M. (1980), The Straight Mind, in «Feminist Issue», 1. 90 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Lorenzo Bruni DOI: 10.1400/228744 [Il partito-paradosso] Il modello teorico di Fabrizio Barca come tentativo di riconciliazione tra sfera sociale e oggettivazione partitica Title: The Party’s Paradox: Fabrizio Barca’s Theoretical Model as an Attempt to Reconcile the Social Sphere and the Object of the Political Party Abstract: The aim of this article is to reflect on the party-form, starting with a sociological analysis of Fabrizio Barca’s policy document entitled A new party for a good government. Political Memory after sixteen months of government. At the time of its drafting and within the Italian context, this document was the sole theoretical work on parties that was issued moving from a politician perspective rather than from the civil society. The article that we propose is structured in three parts. A first one follows a descriptive approach and reconstructs the content and argumentative structure of Barca’s document. A second part follows an analytical approach and looks at the document on four analytical levels: (i) the redefinition of the relationship between representation and representativeness; (ii) the pre-eminence of today’s social sphere on the political sphere (as it emerges from the document); (iii) the political dialectic as a relationship between strong and weak identity; (iv) the relationship between the political party and the network. The third and final part follows a critical approach and will try to highlight the strengths and weaknesses of the proposal. The thesis that will support this last part is the one according to which the strengths of the writing of Fabrizio Barca seem to paradoxically overlap and entangle with its weaknesses.The political sphere seems to have lost the ability to produce global visions and effective forms of social aggregation. Nonetheless, efforts aiming at defining social bonds, conflicts, socially relevant values (such as justice, equality, etc.) are still active. In fact, these efforts passed from the level of traditional political parties onto a different one, with social and relational networks that are becoming the privileged places for the elaboration of values, ideas, and social/individual identities.Following the lines of such analysis of the current situation, one cannot state that citizens lack interest in associated life; quite differently, there is a strong “participatory ferment”, although this ferment is mainly on the level of social participation. Within this framework, there seems to be an almost complete and paradoxical antithesis between the very idea of participation and the political/institutional system. Keywords: Party, Social partecipation, Democracy. I. L’obiettivo di questo saggio è quello di proporre una riflessione sulla forma-partito muovendo da un’analisi sociologica del documento politico di Fabrizio Barca dal titolo Un partito nuovo per un buon governo. Memoria politica dopo sedici mesi di governo. La principale fonte di legittimazione dell’interesse allo studio analitico e critico di tale documento è fornita dal fatto che esso, all’interno del panorama italiano, ha rappresentato almeno al momento della sua stesura - l’unica elaborazione teorica sulla forma-partito proveniente dall’interno della sfera politica piuttosto che dall’ambito della società civile. Fabrizio Barca è infatti esponente del Partito Democratico ed è stato Ministro per la Coesione Territoriale nel Governo Monti. La proposta di Barca conserva nell’attualità una sua propria vitalità, come elaborazione teorica che dibattuta all’interno della sfera pubblica - continua ad ispirare una visione politica della forma-partito. Che tale visione permanga all’interno del Partito Democratico o che altrimenti possa ispirare, anche solo parzialmente, nuovi soggetti politici sarà la realtà empirica degli eventi futuri a suggerircelo. Certo è che lo stesso Barca ha recentemente più volte dichiarato che l’elaborazione della sua proposta non è affatto alternativa alla versione Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 91 Lorenzo Bruni DOI: 10.1400/228744 leaderistica incarnata dal neo-segretario Matteo Renzi, ma si tratta di un insieme di contenuti validi per chiunque ad essi voglia attingere e con essi voglia politicamente confrontarsi. L’elaborazione di Barca appare a tutti gli effetti come espressione di una particolare cultura politica, ma - al tempo stesso - mostra caratteri di intuizione e originalità che le consentono di tornare riflessivamente su di essa con la possibilità di modificarne i confini dati, ampliandone i contorni. L’articolo si struttura in tre parti. In una prima, seguendo un approccio descrittivo, si ricostruiranno i contenuti e la struttura argomentativa del testo di Barca. In una seconda parte, seguendo un approccio analitico, si guarderà al documento attraverso quattro criteri: il primo è relativo alla ridefinizione del rapporto tra rappresentanza e rappresentatività; il secondo intende far emergere quanto il documento tenga conto della preminenza odierna della sfera sociale rispetto alla sfera politica; il terzo riguarda la dialettica politica come relazione identità forte/ identità debole; il quarto è dato dal rapporto tra il partito politico e la rete. Nella terza ed ultima parte, attraverso un approccio critico, si cercherà di far emergere i punti di forza e i punti di debolezza della proposta. La tesi che si sosterrà in questa ultima parte è quella secondo cui i punti di forza dello scritto di Fabrizio Barca sembrano al tempo stesso confondersi paradossalmente con i suoi punti di debolezza. Il documento di Fabrizio Barca si sviluppa come una sorta di replica implicita ad una questione paradossale. In una fase in cui si riscontra un alto livello di consenso scientifico sulla crisi della rappresentanza, dei canali di partecipazione politica tradizionale e - all’interno di essi, in modo particolarmente marcato - dei partiti politici, si fa da più parti riferimento ad una conseguente emersione di centralità, in forme in parte nuove e multiformi, della sfera sociale e del tessuto della società civile; forme spesso non ancora chiaramente tracciabili e definibili. In un quadro in cui la sfera politica sembra aver perso la capacità di produrre visioni del mondo e forme di aggregazione, le possibilità di definizione del legame sociale e le forme del conflitto - lontano dallo sparire - si trasferiscono presso un livello differente, in un tessuto sociale e relazionale che è luogo privilegiato di elaborazione di idee, valori e immagini di sé (Santambrogio 2013). Lungi dal poter decretare un disinteresse dei cittadini per la vita associata, assistiamo oggi ad un grande fermento partecipativo inteso nel senso di partecipazione sociale (Pizzorno 1966). L’idea stessa di partecipazione, all’interno di questo quadro, sembra essere quasi in antitesi con il riferimento al sistema politico e istituzionale, il quale - essendo percepito come luogo caratterizzato da una sorta di separatezza rispetto alla vita dei cittadini e da autoreferenzialità - non viene assunto come riferimento concreto della partecipazione, ma è più spesso interpretato nell’ottica di mera riproduzione del potere e come luogo di gestione tecnica dell’esistente (Revelli 2013). In estrema sintesi, nel nostro Paese sembra piuttosto evidente una divaricazione sempre più ampia tra canali della rappresentanza e sistema dei partiti, da un lato, e fenomenologia delle esperienze di confronto intersoggettivo critico e partecipazione alla vita associata, dall’altro. Se, dunque, la partecipazione sociale sembra essere una fonte di senso in sé per chi la pratica e la vive, senza che ci si ponga necessariamente il problema della traducibilità politica e istituzionale (Inglehart 1998), il documento di Barca si muove proprio nella direzione di una riconciliazione tra produzione sociale delle idee sul vivere comune, partecipazione civile e forma-partito. Tale ambizione di riconciliazione - questa la tesi centrale dell’articolo - si intreccia però con una sorta di questione paradossale. Paradossale proprio perché nell’immagine normativa del partito nuovo proposta da Barca, esso stesso è il luogo privilegiato in cui si configurano possibilità di ricomposizione di queste due realtà, percepite ormai come antitetiche ed escludentesi. Il partito, nella versione di Barca, diventa invece l’ambito elettivo in cui il fermento sociale multiforme, pratico, dialogico, deliberativo e riflessivo trova il proprio esito, se non addirittura la propria genesi e sviluppo. Paradossale perché uno di quelli che possono essere assunti come elementi di crisi della mediazione partitica, ovvero il progressivo incremento riflessivo di esigenze di democrazia allargata e inclusiva, diventa il cuore stesso dello sperimentalismo democratico che ispira la visione di partito di Barca. Il documento si sviluppa, a nostro parere, come una sorta di replica ad una contraddizione. Il complesso contesto riflessivo della contro-democrazia (Rosanvallon 2012) rappresenta una modalità di partecipazione che non è il contrario, quanto piuttosto una particolare interpretazione e continuazione, della democrazia, attraverso la quale la società civile svolge sia un ruolo autonomo attivo che una funzione di controllo 92 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228744 Lorenzo Bruni e di stimolo nei confronti delle istituzioni, partiti compresi. Una democrazia della sfiducia organizzata attivamente in forme autonome e in termini positivi e propositivi. Ciò che emerge dall’analisi proposta è che uno tra gli elementi di maggiore criticità della forma-partito, se non il principale, viene recuperato da Barca proprio come momento centrale della costruzione ideale del nuovo partito della sinistra. Per quanto l’intento del presente articolo sia eminentemente critico, tale critica non ambisce a smontare in maniera forse fin troppo ingenua il ruolo di mediazione del partito politico in favore di una sorta di mistica esaltazione dello spontaneismo sociale, quanto piuttosto - finalità ben più circoscritta - vorrebbe contribuire a fornire elementi utili a capovolgere il punto di vista logico adottato da Barca. Se l’ex Ministro muove dal ruolo istituzionalizzato dell’organizzazione partitica per poi giungere a sussumere al suo interno le pratiche partecipative che innervano l’agire sociale, l’articolo vuole invece partire dalla radicalizzazione della crisi della rappresentanza che attraversa la società mediante pratiche vive ed innovative senza dover necessariamente giungere all’esito prefigurato da Barca. Lo svolgimento di questo scritto non ha dunque la pretesa di esaurire la folta pluralità di intenzioni e tematiche della memoria politica, ma promuove una particolare interpretazione della stessa alla luce del rapporto non sempre armonioso ed armonizzabile tra forma-partito e pratiche democratiche dal basso. Proprio sulla base del particolare taglio interpretativo proposto - che pur muovendo dai contenuti del documento di Barca tende a trascenderli - la riflessione assume la veste del saggio scientifico, a differenza della maggior parte delle considerazioni analitiche e critiche del documento, le quali si trovano per lo più in veste di note informali o testi giornalistico-divulgativi. II. Il documento in questione segue una struttura argomentativa divisa in una pars destruens e in una pars costruens. Il primo paragrafo viene dedicato alla enunciazione della tesi secondo cui l’Italia è sprovvista da un lungo periodo di un buon governo, latitanza che affonda le proprie radici proprio nel sistema dei partiti. In questa prima parte, la critica di Barca individua come bersaglio privilegiato il rapporto perverso tra cattivo governo da una parte e legame tra macchina dello Stato arcaica e partiti Stato-centrici dall’altra. Gli elementi esplicativi della crescente e dilagante diffusione di sentimenti di sfiducia e disaffezione nei confronti dei partiti sono connessi all’intreccio morboso che Barca individua tra Stato arcaico e partiti Stato-centrici. Per Stato arcaico si intende una burocrazia inefficiente, lenta, incompetente e in definitiva riluttante verso gli strumenti tipici della democrazia deliberativa, strumenti che a parere di Barca «si stanno affinando nel mondo contemporaneo» (Barca 2013: 8). La questione dei partiti Stato-centrici ha invece a che fare soprattutto con il problema del finanziamento pubblico e della gestione centralizzata del partito, per cui i gruppi dirigenti e i capi-cordata controllano i flussi di risorse ed intrattengono un rapporto tendenzialmente diretto con la base, senza attraversare la mediazione delle articolazioni territoriali e locali. La fratellanza siamese tra i due processi radicalizza comportamenti abusivi del ruolo pubblico e soprattutto incentiva la tendenza al perseguimento di beni particolari anziché del bene pubblico. Il cattivo governo è proprio l’esito di questi due fenomeni patologici. I partiti tendono a scavalcare il confronto aperto e acceso sui contenuti e sul metodo dell’azione pubblica ed escludono il riferimento all’esperienza di chi opera e vive nei territori del Paese. Disintermediazione sociale, sradicamento territoriale e indifferenza verso pratiche dialogiche sono all’origine non solo del mantenimento dello status-quo delle logiche personalistiche, ma anche di mera conservazione degli assetti di potere stabilito all’interno della dinamica partitica. La pars destruens prosegue con una rassegna critica dei due principali filoni di gestione della macchina pubblica: quello minimalista o liberista e quello social-democratico. Le politiche pubbliche socialdemocratiche hanno ispirato conquiste progressive soprattutto in rapporto a incrementi graduali di autonomia individuale e qualità della vita; al contempo hanno ridotto la capacità soggettiva di sviluppare risposte autonome, incidendo sui processi di responsabilizzazione dei cittadini destinatari di risorse e servizi. Le politiche pubbliche minimaliste hanno affidato al settore privato l’erogazione dei servizi ed hanno attribuito al mercato una capacità di auto-regolamentazione, escludendo l’intervento statale in momenti ciclici. Nell’ambito di tali politiche si è poi alimentato il mito per cui le gradi multinazionali siano in grado di portare a sintesi la Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 93 Lorenzo Bruni DOI: 10.1400/228744 pluralità delle conoscenze e degli interessi di molteplici soggetti, intervenendo così su decisioni di interesse generale. Entrambe le posizioni, socialdemocratica e minimalista, si basano su un assunto comune errato: soltanto un ristretto numero di soggetti con elevate competenze specifiche dispone degli strumenti cognitivi adeguati al fine di assumere decisioni di pubblico interesse. Queste “aristocrazie” sono costituite, nel caso della posizione socialdemocratica, da amministratori e alti tecnici pubblici; nel caso della posizione minimalista da manager privati e dai board delle grandi corporation. La critica a questi due approcci è utile a Braca per introdurre in positivo gli strumenti di correzione dei difetti comuni prodotti dalle due tendenze prevalenti, ovvero gli strumenti della democrazia deliberativa nella versione dello sperimentalismo democratico. Non è affatto vero, sostiene Barca, che la conoscenza indispensabile per le politiche pubbliche sia patrimonio esclusivo di pochi. Questo assunto riecheggerebbe la vecchia concezione secondo la quale solo pochi soggetti dotati di competenze specifiche e tecnico-specialistiche siano in grado di poter produrre decisioni pubbliche. In una società del rischio, come quella in cui viviamo, i saperi tecnico-scientifici caratterizzati da un alto livello di razionalità strumentale non solo spesso non sono in grado di antevedere gli esiti delle proprie applicazioni, ma promuovono lo stesso potenziale di rischio (Beck 2000). Barca non cita Ulrich Beck, ma suggerisce - in sintonia con il sociologo tedesco - come nessun soggetto sia oggi in grado di dominare la conoscenza adeguata per anticipare possibili problemi ed ipotetici esiti nefasti e per prospettare soluzioni di efficacia certa. La conoscenza scaturisce dal conflitto tra portatori di idee, saperi e conoscenze diversi tra loro che si confrontano all’insorgere di problemi e criticità. Il metodo di gestione di tale confronto aperto e conflittuale è quello dello sperimentalismo democratico; il luogo elettivo in cui tale metodo trova svolgimento è il partito non più il partito inteso in senso astratto e generale, bensì il nuovo partito di sinistra. Le funzioni principali del nuovo partito di sinistra sono prevalentemente di due tipi, una tradizionale e una innovativa. La prima risiede nel selezionare la classe dirigente per la partecipazione alle assemblee elettive e per le attività esecutive ai diversi livelli di governo. La seconda è la funzione di mobilitazione cognitiva. La mobilitazione cognitiva «consiste prima di tutto nel raccogliere, confrontare, selezionare, aggregare e talora produrre conoscenza sul che fare dell’azione di governo attraverso un confronto pubblico, informato, acceso, aperto e ragionevole, nei luoghi del territorio, fra iscritti, simpatizzanti e altri singoli o membri di associazioni» (Barca 2013: 36). A questa prima segue l’azione di portare tale conoscenza sia verso il basso che verso l’alto; sia verso gli amministratori locali, per fare in modo che influenzino le decisioni a livello locale, sia verso i rappresentanti di partito eletti nei livelli superiori di governo. III. Nelle righe che seguono si cercherà di avanzare, molto brevemente, una lettura di alcuni passaggi del testo seguendo quattro criteri analitici, evidentemente intrecciati tra loro. Tale lettura ci permette di approfondire aspetti del contenuto del documento tralasciati nella breve sintesi oggetto del paragrafo precedente. La proposta di Barca si muove in direzione di una riconciliazione tra sistema rappresentativo e tendenze partecipative sociali allargate: il documento sembra tracciare proprio un ottimistico circolo virtuoso tra sollecitazioni partecipative di confronto dialogico provenienti dal basso e qualità della selezione della classe dirigente che siede nelle assemblee elettive e nei diversi livelli esecutivi. La direzione del rapporto tra basso e alto del partito non è gerarchicamente univoca, ma ciascuna dimensione agisce e retroagisce sull’altra. Il partito della mobilitazione cognitiva prospettato da Barca vuole costituire una soluzione possibile per il superamento dello scarto tra democrazia e tecnocrazia, tra principio di maggioranza e principio di competenza. I due princìpi entrano in collisione nel momento in cui si assume che soltanto pochi abbiano le competenze per poter procedere in maniera efficace all’azione pubblica e di governo. Se sono solo pochi ad avere il privilegio di poter elaborare una visone consapevole della realtà delle cose, allora le decisioni che pochi assumono devono 94 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228744 Lorenzo Bruni essere preservate dall’impuro contatto con le ingenue opinioni della moltitudine dei cittadini. Si pensi, a tale proposito, non soltanto alle argomentazioni tipiche di alcune posizioni anti-No Tav, ma anche a tutto il discorso portato avanti negli ultimi anni di gestione, mediante austerity, della crisi economica da esponenti di governo e da alti burocrati circa il richiamo alla responsabilità dei cittadini delineata come adesione a scelte che venivano fatte passare come ineluttabili e necessarie, prive di qualunque alternativa possibile perché assunte sulla base delle più elevate conoscenze specialistiche possibili a disposizione. Il così-è-e-non-può-essere-altrimenti è stato il refrain prevalente all’interno del discorso pubblico degli ultimi anni. In modo particolare, il riferimento al vincolo di necessità ad una sorta di realtà auto-evidente è stato la cifra ideologica del Primo Ministro Mario Monti. La questione sollevata da Barca ha una sua evidente legittimità. Egli ritiene che - come abbiamo già riportato poco sopra - la conoscenza non solo sia dispersa e diffusa tra la moltitudine dei cittadini, ma che essa stessa sia spesso il prodotto dell’interazione piuttosto che un dato immutabile che preesiste ad essa. Per questo motivo la tecnocrazia entra in tensione non solo con il principio di rappresentanza, ma anche con quello di competenza. Per quanto riguarda una possibile lettura della nuova forma-partito in rapporto alla dicotomia analitica identità forte/identità debole, sembra essere particolarmente interessante tornare ulteriormente sul ruolo della dinamica conflittuale che il partito deve saper stimolare, guidare e riassorbire a livello della sfera partecipativa della società civile. Barca attribuisce un ruolo primariamente creativo alla dinamica conflittuale, una creatività cognitiva che si contrappone ad una visione essenzialistica della conoscenza e delle forme di pensiero. La conoscenza non precede il conflitto come un qualcosa di dato e immutabile, ma si produce attraverso di esso. La conoscenza diventa un processo dialettico tra momenti parziali che si ricostituiscono in sintesi sempre dinamiche ed aperte. La concezione della conoscenza che filtra dalle pagine del documento sembra involontariamente riecheggiare il ruolo e il compito che il sociologo Mannheim attribuiva alla sociologia politica, contrapponendola alle scuole di partito. Secondo Mannheim, «se le scuole di partito si addicono a coloro le cui decisioni politiche sono già state deliberate dai partiti, questo nuovo tipo di analisi (quello della sociologia politica, corsivo mio) si riporta a coloro le cui scelte non sono ancora state decise» (Mannheim 1999: 59). La sociologia politica, secondo Mannehim, avrebbe avuto il ruolo di portare ad una sintesi dinamica tra le concezioni parziali presenti nella sfera politica. D’altra parte, il sociologo tedesco vedeva nei partiti politici i luoghi in cui si riproducevano decisioni già prese in quanto espressione di conoscenze e sistemi di pensiero condizionati da particolari interessi socio-economici e da una loro puntuale collocazione all’interno della struttura sociale. Se facciamo riferimento alla citazione di Mannehim sopra riportata, è piuttosto interessante vedere come Barca leghi invece alle scuole di partito - al partito come scuola, o meglio come palestra - la possibilità di creare una sintesi attraverso un confronto aperto tra punti di vista molteplici e diversi. Nel partito che prospetta Barca, come auspica Mannehim per il destino della sociologia politica che si svilupperà in istituti di cultura indipendenti o nelle università, le scelte non sono ancora state prese: esse non sono l’emanazione di una identità stabile dettata da una dottrina, ma diventano sintesi del confronto aperto tra molteplici identità. Allora, in rapporto al criterio analitico dell’identità, possiamo sintetizzare come nel documento non si trovi il richiamo ad un’ideologia coerente che definisca identità e appartenenze e il partito non è più - e non potrebbe esserlo date le complesse mutazioni storiche intervenute all’interno della struttura delle società contemporanee - il luogo in cui interessi sociali particolari si collocano politicamente ordinati da una dottrina che dà corpo ad identità politiche stabili e definitive. L’identità del partito è il momento di sintesi sempre provvisorie tra identità sociali diverse e molteplici. Il partito di Barca diventa un luogo di continua costruzione culturale e politica, la cui identità è incessantemente in balìa delle dinamiche di discussione conflittuale democratica che esso stesso è in grado di promuovere e intercettare al proprio interno. In ultima analisi la questione del rapporto con la rete prende corpo a partire da un quesito netto e radicale. Può internet sostituire i partiti? La risposta di Barca è, come ci si potrebbe aspettare, negativa. L’autore ritiene che la rete offra straordinarie occasioni di informazione e di controllo sulle azioni pubbliche delle élite da parte dei cittadini. In questo senso la rete viene vista come una base funzionale dello lo sperimentalismo democratico. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 95 Lorenzo Bruni DOI: 10.1400/228744 La procedura del confronto che anima lo sperimentalismo democratico può trarre un impulso informativo dalla rete, ma non può che svolgersi fattivamente in luoghi e spazi fisici radicati sul territorio. In controtendenza rispetto a quanto rilevato da più parti circa il destino del rapporto tra nuove forme comunicative legate alla rete e ruolo del partito politico, Barca sembra propendere per una inevitabile e necessaria rivalorizzazione del secondo, seppur riconoscendo le potenzialità positive della rete e delle nuove forme comunicative ad essa legate. La diffusione di nuovi media ha stabilito una inedita forma di interazione tra uomo politico, leader e cittadini. L’uomo politico si muove in una dimensione di relativa autonomia comunicativa dalla struttura partitica riuscendo a rivolgersi direttamente alla platea che intende raggiungere, senza alcuna mediazione. Si pensi al ruolo di twitter e alla tesi di un progressivo superamento delle agenzie di stampa. La comunicazione politica sembra oggi procedere in una direzione che va dalla rete ai media tradizionali. L’uomo politico ricorre all’uso diretto ed immediato della tecnologia comunicativa, piuttosto che rivolgersi ad una mediazione giornalistica ormai costretta a “rincorrere” il flusso di comunicazione della rete. Il ruolo della rete viene amplificato dalla logica che attraversa quello che Andrew Chadwick ha chiamato «sistema ibrido». Sistema che segnala il rapporto di rimando tra rete e media tradizionali, dove questi ultimi - seppur conservino ancora un ruolo centrale (Itanes 2013) - riecheggiano contenuti che si sono prevalentemente sviluppati in internet (Chadwick 2013). Questi aspetti sono stati letti come elementi centrali del mutamento del ruolo del partito nello scenario politico italiano più recente, arrivando addirittura a stabilirne il ruolo sempre più superfluo (Bentivegna 2014). L’idea di Barca vorrebbe provare a muovere in una direzione opposta: non il superamento della forma di intermediazione dei partiti politici, ma un loro radicale rinnovamento al fine di recuperare all’interno del partito nuovo le dinamiche comunicative che invece si vorrebbero fluidamente disperse all’esterno di esso. Quanto questi desiderata abbiano possibilità effettive di realizzarsi nella pratica politica di una rinnovata vita di partito è piuttosto difficile stabilirlo oggi, certo è che rispetto alla forza e alla capacità di diffusione delle forme comunicative più recenti questa proposta appare come una sfida carica di problematicità. L’opinione di Barca sembra essere in sintonia con chi ritiene che un aumento delle possibilità di potere dal basso non comporta sempre e comunque una maggiore dose di democrazia del processo. Le strategie di controllo che l’uso della rete può consentire «non prefigurano necessariamente una maggiore apertura/democratizzazione della società e la condizione che più facilmente si determina continua ad essere quella di una competizione diseguale tra partecipanti al processo» (Bosco 2013: 152). I tempi immediati dell’interazione on line e della mobilitazione in rete potrebbero determinare un deficit di riflessività circa contenuti e obiettivi, favorendo la dimensione emotiva della comunicazione. Per questa ragione Barca ritiene che affrontare problemi e criticità in maniera aperta, critica e costruttiva richieda i tempi lunghi della discussione condotta in luoghi concreti e debba inevitabilmente interessare la fisicità dei partecipanti. L’ambizione è dunque quella di recuperare l’attivismo comunicativo, riconciliandolo con una mediazione partitica nuova, più flessibile e dinamica, ma comunque fermamente ancorata alla sua vocazione di socializzazione politica. IV. La sfera pubblica informale e la relazionalità civile che si situano in un ambito precedente alle procedure argomentative del dibattito pubblico formale - tracciabili già di per sé come dimensioni di incremento della riflessività individuale e collettiva - sono sempre eccedenti rispetto alla pretesa di venire intercettate, se non proprio ricomprese, dall’organizzazione partitica, per quanto nuova, fluida e flessibile essa possa essere. L’ampia fenomenologia della partecipazione sociale, culturale e relazionale non può che eccedere la pretesa che essa venga accolta o riassorbita - anche se in forme aperte, contingenti e provvisorie - all’interno dell’alveo dell’organizzazione partitica. L’effervescenza del mondo della vita, per impiegare un noto lessico habermasiano, è irriducibile alla ambizione della nuova forma-partito di inquadrarla partiticamente, e in parte anche strumentalmente, all’interno del proprio perimetro. La tesi che si vuole qui brevemente sostenere è quella secondo cui i punti di forza dello scritto di Fabrizio Barca sembrano essere al tempo stesso coincidenti con i punti di debolezza. Lo si può sostenere in una duplice direzione: la prima riguarda una considerazione generale circa gli effetti di diffusione e divulgazione della elaborazione ideale; 96 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228744 Lorenzo Bruni l’altra si addentra nel cuore sostanziale dei contenuti del documento e riguarda la questione dello sperimentalismo democratico. In ordine alla prima direzione, da un lato, la proposta di Barca sembra essere un tentativo isolato, se non esclusivo - e per questo di certo apprezzabile - di elaborazione ideale e di sforzo di immaginazione circa una nuova forma-partito. Quanto maggiore è la distanza tra la realtà fattuale in cui ci troviamo e l’immagine di realtà altra che si prospetta, tanto maggiore è la portata critica del discorso che si promuove. In questo senso Barca immette linfa critica vitale all’interno del dibattito sul tema. Dall’altro, lo sforzo immaginativo e normativo assume spesso le sembianze, i toni ed il registro di un atteggiamento eccessivamente intellettualistico. Espressioni come mobilitazione cognitiva, sperimentalismo democratico, logica catablepista - per citarne soltanto alcune - tradiscono una sorta di tentazione narcisistica. L’aristocraticismo etico rischia di riconfermarsi cifra caratterizzante la sinistra italiana, fenomeno al quale Franco Cassano ha dedicato il suo libro dal titolo L’umiltà del male. Tale fenomeno replica quel vizio particolare che consiste nell’escludere la possibilità di rivolgersi a recuperare una maggioranza silenziosa e scarsamente riflessiva, spesso liquidata come inutile e irrilevante (Cassano 2011). Il rischio, oltre che di strategia comunicativa, è anche fortemente sostanziale. Esso intrattiene un rapporto decisivo, cioè, con i contenuti e con il senso più profondo del documento. Il punto di forza dello sperimentalismo democratico di Barca consiste senza esitazioni nella valutazione positiva che è possibile esprimere circa la genuina aspirazione all’incremento deliberativo e partecipativo all’interno delle dinamiche strumentali e organizzative che innervano, con le dovute differenze, i due più grandi partiti italiani, ancora oggi a tutti gli effetti legati rigidamente a gruppi di potere e oligarchie statiche che gestiscono in maniera semiprivatistica le dinamiche di produzione delle decisioni. Su aspetti specificamente relativi alla problematizzazione della dimensione deliberativa e di quella della democrazia interna si sono soffermati importanti contributi analitici e critici forniti da prestigiosi interpreti del testo, ospitati all’interno del blog ufficiale di Fabrizio Barca «Viaggio in Italia» (Urbinati 2013, Ignazi 2013, Floridia 2013). Il campo teorico della democrazia deliberativa si è nel corso degli anni sviluppato fino ad essere, allo stato attuale, un ambito piuttosto complesso e diversificato (Habermas 1995, Rawls 1995, Fishkin 1995, Elster 1998, Sabel 2013). A questo dibattito Barca inevitabilmente si rivolge ed attinge. In particolare, il riferimento teorico prevalente sembra essere fornito dalla declinazione di deliberazione proposta da Charles Sabel. La deliberazione in Sabel, autore fortemente influenzato dal pragmatismo di Dewey, è caratterizzata dall’ideale del problem solving. La democrazia è riconducibile, in definitiva, ad un metodo mediante il quale incrementare il livello di riflessività inerente il rapporto tra fini e mezzi nella soluzione di problemi che coinvolgano la collettività. Sterile ed inutile, a detta del filosofo statunitense, pretendere di fissare principi ultimi e regole definitive della prassi democratica, poiché in essa il rapporto tra conoscenza e agire collettivo rivolto alla soluzione dei problemi è una dinamica incessantemente aperta: deve appunto essere sempre messa sperimentalmente alla prova (Prandini 2013). Il punto fermo dell’impostazione sperimentale democratica di Barca sembra essere quello per cui, ribadita l’inaggirabilità della decisione finale che spetta alle istituzioni e ad esse soltanto poter prendere, la legittimazione della decisione ha proprio a che fare con il confronto pubblico, discorsivo e razionale che contribuisca a costruirla. All’ipotesi dello sperimentalismo democratico bisogna riconoscere di essere congruente con una visione che può essere autenticamente definita - senza esitazioni - di riformismo progressista, universo politico al quale, d’altronde, il documento di Barca si richiama con chiara nettezza. Nonostante assorba il difetto proceduralista proprio di tutte le articolazioni della matrice deliberativa - è un metodo, guarda al come sarebbe meglio affrontare i problemi e non alla posta in gioco dei contenuti e dei valori delle questioni - esso indica indubbiamente una direzione, a prima apparenza, politicamente netta e puntuale. La debolezza del suo discorso, invece, è tale poiché gli si possono attribuire due limiti: un limite verso il basso e un limite verso l’alto. Vediamo per primo il limite verso il basso. La tesi che qui si vuole provare solo ad abbozzare è che il conflitto partecipativo cui Barca si riferisce quando parla di confronto e interazione tra soggetti sociali è un conflitto diffuso e molteplice, in definitiva irriducibile ad un’ambizione di ricomprensione partitica. Tale conflitto mantiene un margine di autonomia. Barca sembra ignorare l’esistenza empirica di una partecipazione che, nelle sue forme e manifestazioni più Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 97 Lorenzo Bruni DOI: 10.1400/228744 recenti, o non è interessata affatto ad una traduzione partitica del proprio agire, o rivendichi una autonomia politica in vista di un progressivo allargamento delle opzioni di democrazia diretta e di autogestione (il movimento Occupy, su tutti), completamente in alternativa al sistema dei partiti. Esiste un’eccedenza partecipativa che è irriducibile al partito politico, un ethos partecipativo che incorpora pratiche e vissuti in un senso non esclusivamente procedurale: si conquista un ambito sostanziale di autonomia, ci si incontra unendosi e dibattendo, facendo esperienza di pratiche in una molteplicità di sfere relazionali che sono fonti di senso e di innovazione sociale a prescindere dalla interlocuzione con articolazioni della sfera politica. Tale eccedenza partecipativa sembra mostrare la propria consistenza in particolar modo all’interno della attuale contingenza storica, economica e sociale. La crisi del capitalismo neo-liberista ha segnato una forte discontinuità nelle dinamiche di partecipazione sociale rispetto a quanto aveva caratterizzato il trentennio di crescita economica precedente la crisi stessa. La crisi del neo-liberismo ha comportato l’emersione di una sorta di nuova questione sociale, all’interno della quale si danno espressioni e indicazioni relative a nuove forme di attivismo, creatività, conflitto, effervescenza e partecipazione sociale. Nella fase di crescita economica che aveva caratterizzato il fordismo, un welfare assistenziale solido e politiche redistributive sembravano sufficienti a garantire correzioni dell’ingiustizia sociale e a stabilizzare forme di integrazione sociale e di consenso politico (Magatti 2012). Il vero e proprio elemento centrale della nuova questione sociale che la crisi del neo-liberismo apre sembra essere la progressiva destrutturazione del lavoro salariato, fenomeno che aveva garantito nei decenni precedenti integrazione sociale, definizione di identità collettive e una piuttosto immediata dinamica di connessione tra identità sociale e rappresentanza politica. L’avvento, e la successiva crisi, del neo-liberismo hanno dato luogo ad una progressiva destrutturazione e svalutazione del tradizionale lavoro salariato in favore di una sua sempre più marcata flessibilizzazione e precarizzazione, di un impoverimento complessivo dei redditi, di un incremento del lavoro autonomo e indipendente privato progressivamente di tutele e garanzie; meccanismo al quale si sono accompagnati fenomeni contigui quali quelli legati alla interruzione di una prospettiva di ascesa sociale, il radicalizzarsi di difficoltà di convivenza inter-culturale, l’incremento di forme di insicurezza legate all’ambiente e altri ancora. La tesi che si vuole qui condensare è che gli effetti sociali della crisi si inverano anche in un conseguente spostamento dell’integrazione, del conflitto e dell’innovazione sociale dall’ambito della produzione materiale a quello della più ampia riproduzione sociale. Se l’ambito sociale del lavoro ha perso la sua unità e frammentandosi non assolve più al ruolo tradizionale di integrazione sociale mediante l’attribuzione di identità parzialmente stabili e omogenee, è proprio nelle conseguenze della frammentazione e disarticolazione del lavoro che si rintracciano le più interessanti dinamiche di riproduzione sociale. All’interno del mondo della vita - costituito da tessuti solidali, realtà associative e del volontariato, bisogni di espressività e di socialità immediata, nuove pratiche di condivisione, legami sociali cooperativi, conflitti per i beni comuni, etc. - si rintracciano originali e innovative esperienze che attraversano il tessuto sociale ai tempi della crisi. Il mondo della vita sembra essere il luogo privilegiato della riproduzione sociale: fare società, non fare politica. O meglio, fare politica nel fare società; fare politica poiché si è fatta società. Ci troviamo in presenza di una ampia fenomenologia “dal basso” che ricomprende economie collaborative e pratiche di condivisione, reti di vicinanza e prossimità, pratiche di credito reciproco, di auto-costruzione e co-working, pratiche sempre più diffuse di autofinanziamento e azionariato popolare in vista della realizzazione di progetti e avvio di attività, dinamiche di tutela lavorativa alternative al sindacato tradizionale consistenti prevalentemente in nuove forme di mutualismo, gruppi di acquisto solidali, formule aggregative e autoorganizzative intorno ai beni comuni (la vicenda del teatro Valle a Roma su tutte), movimenti ambientalisti e di tutela del consumatore, movimenti contro la discriminazione sessuale e di genere, movimenti che si battono per il diritto all’abitare, e tante altre esperienze ancora. In questo senso non è più la sfera politica a dettare i ritmi dell’integrazione sociale, quanto piuttosto l’eterogeneità e l’incoerenza della partecipazione sociale ad eccedere le pretese di riassorbimento in rigide oggettivazioni identitarie politiche (Santambrogio 2013). Non sono più dottrine, teorie e appartenenze identitarie ormai dissolte a garantire l’integrazione sociale, quanto l’effervescenza e l’eterogeneità della riproduzione sociale 98 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228744 Lorenzo Bruni a conquistarsi spazi di forte autonomia dalla sfera istituzionale e partitico-politica. Questa ampia partecipazione sociale non agisce in vista del soddisfacimento di una domanda mediante le istituzioni, non alimenta l’aspettativa di servizi e beni che giungano dall’alto delle istituzione pubbliche, ormai del tutto impossibilitate dalla drastica riduzione della spesa pubblica dettata dall’austerity. La questione che si lega alle nuove forme di partecipazione sociale sembra proprio concentrarsi in un avvicendamento tra rivendicazioni e richieste rivolte “verso l’alto” e creazione comune di pratiche e attività. Prassi concrete all’interno delle quali si sperimentano soluzioni creandole, senza attendere che qualche soggetto istituzionale o partitico-politico vi provveda in senso stretto. Tutta questa ampia fenomenologia sociale, già operante ed esistente per quanto ancora magmatica, si muove su un terreno di autonomia, orizzontalità ed effettività pratica per cui, come detto, si promuovono, già in seno alle attività e alle prassi, esiti e risposte a problemi e bisogni. Queste esperienze di partecipazione sociale, inoltre, non coincidono con le prerogative tradizionali della cosiddetta società civile. Si tratta di esperienze e pratiche affini a quella che Chatterjee chiama politica della società (Chattarjee 2006). Per fare un esempio di come la politica della società non sia assimilabile alla vecchia idea di società civile, Chattarjee propone un caso emblematico: negli anni Quaranta del Novecento contadini poveri del Bengala arrivarono a Calcutta in fuga dalle carestie. Non trovando possibilità di accoglienza e sistemazione i contadini si insediarono in terreni pubblici a ridosso della ferrovia nel sud della città, costruendo una baraccopoli. Le amministrazioni stimolarono per via giudiziaria diverse azioni di sgombero al fine di procedere all’estensione della ferrovia. Per difendersi da tali azioni i contadini occupanti si costituirono in associazione, cercando di difendere così il diritto ad avere una dimora ed una esistenza dignitosa e riuscendo ad ottenere alcuni risultati e successi, tra i quali l’allaccio all’elettricità. Ora, per Chattarjee, l’associazione dei contadini occupanti non può essere assimilata ad una articolazione della società civile, poiché viola la legge civile a tutela della proprietà. Gli stessi abitanti abusivi hanno consapevolezza della loro attività illegale, ma al tempo stesso lottano attraverso pratiche non mediate per il soddisfacimento di diritti di base costituendosi in associazione, dichiarandosi pronti a rinunciare all’occupazione non appena si proponga loro una valida alternativa abitativa. Per quanto locale e situata, l’esperienza riportata da Chattarjee può aspirare ad una universalità sui generis in virtù del suo carattere esemplare. Essa mostra cioè una capacità di imporsi oltre i propri confini geografici e culturali non avanzando pretese di validità forti e definitive, ma dando espressione ad una concretezza particolare che ambisce tuttavia ad avere un carattere trans-contestuale in virtù del suo mostrarsi come esperienza esemplarmente riuscita (Ferrara 1999). In questo senso, per quanto lontano nello spazio e nel tempo, l’esempio sembra intrattenere un certo rapporto di affinità con le numerose esperienze di mobilitazione e di pratica abitativa dei movimenti per la casa attivi in Italia in tempi attuali, una delle testimonianze più avanzate delle dinamiche che attraversano in questa fase i movimenti e la partecipazione sociale. La rivendicazione, nel caso proposto, apre lo spazio di un’azione a tutti gli effetti politica. Come riconosce Chatterjee, ogni volta si raggiungono equilibri fragili che dipendono dalla capacità dei gruppi sociali di organizzarsi. Equilibri fragili e precari che sono soggetti a continuo riassestamento. Ma, come abbiamo già detto, la frammentarietà e l’eterogeneità sono caratteristiche tipiche del tessuto sociale al quale abbiamo fatto rifermento. Certo, il pericolo è che «l’immanentismo sociale, con pratiche spesso più tattiche che strategiche e incessanti negoziazioni rischia di privare le soggettivazioni emergenti della conflittualità politica, risucchiandole nel sistema che contribuiscono a rinforzare» (Bazzicalupo 2014: 76-77). Ma, al tempo stesso: i movimenti e le sperimentazioni di autogoverno a lungo risolti nella non-mediata testimonianza di se stessi, hanno rivendicato spinozianamente la vitalità delle forme pre- o non-politiche della moltitudine rispetto al popolo democratico e alle sue aporie; questi agenti […] si sono a lungo sottratti all’eterno impotente gioco democraticorappresentativo, provocandolo per destrutturarlo […] Ebbene oggi sono proprio queste esperienze di democrazia diretta a interrogarsi sulla funzione “politica” della organizzazione, non certo per tornare al passato, ma per sondare modalità di espressione politica che non tradiscano quell’incessante oscillare tra forma e movimento che è la democrazia, rimanendo fedeli all’istanza che ci dice che la democrazia si pratica, non si affida, e che alla crisi di democrazia si risponde con più democrazia (ivi, 77). Condividendo le parole di Bazzicalupo, se oggi sono proprio queste esperienze di democrazia diretta a Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 99 Lorenzo Bruni DOI: 10.1400/228744 interrogarsi sulla funzione “politica” della organizzazione, esse lo fanno non di certo per un regressivo ritorno al passato; se il cuore della partecipazione sociale si situa al livello che abbiamo brevemente abbozzato, allora risulta davvero problematico risituare un rapporto armonioso e pacificato con la sfera della soggettività partitica, come è nelle ambizioni di Barca. Assumendo come indubbiamente apprezzabile in termini di potenziamento democratico l’apertura che Barca prospetta verso certe dinamiche partecipative e deliberative, esse appaiono riduttive, se non proprio paradossali, in confronto ad una porzione di partecipazione sociale oggi piuttosto significativa ed effettivamente operante. Per questo motivo l’espressione partito-paradosso non è una formula ermeneutica estendibile ad ogni formapartito, al di là di un seppur minimo riferimento ad identità e culture politiche, ma è un tratto caratteristico, quello della paradossalità, di un soggetto che si riproponga intenzionalmente di allargare l’inclusività democratica - ambizione di per sé generalizzabile come progressiva e genericamente di “sinistra” - sussumendola, però, nel perimetro della nuova ipotetica organizzazione partitica di riforma del Partito Democratico. La paradossalità, ad esempio, non sarebbe in alcun modo riferibile ad una forma-partito apertamente autoritaria ed accentratrice che non faccia il minimo riferimento intenzionale a meccanismi di democrazia partecipativa. La paradossalità si dà in presenza di una qualche condizione di possibilità di relazione, non certo in una dimensione di incommensurabile distanza. Seguendo una nota definizione, un paradosso è «una conclusione apparentemente inaccettabile che deriva da premesse apparentemente accettabili per mezzo di un ragionamento apparentemente accettabile» (Sainsbury 1988). Il partito di Barca è allora paradossale proprio perché, tematizzando apertamente la “questione democratica”, si pone inevitabilmente in una qualche modalità di relazione, di interlocuzione, con i soggetti e le pratiche che tale questione radicalizzano, per quanto essa si risolva in una dialettica di contraddizione. La conclusione inaccettabile, rimanendo alla definizione di Sainsbury, coincide con l’elezione del partito a motore unico e serbatoio di riassorbimento del conflitto sociale, partendo da premesse accettabili che sono appunto quelle riconducibili all’allargamento dell’orizzonte di inclusività democratica. La paradossalità è caratteristica peculiare del partito-nuovo proposto da Barca, il quale entra in contraddizione con pratiche di attivismo e mobilitazione che oggi sembrano radicalizzare la dimensione del conflitto partecipativo. Queste pratiche, seppur perfettamente in linea con diritti fondamentali - ad esempio all’abitare, alla salute, alla cultura, etc. -, sono di certo meno allineate ad obiettivi delle istituzioni pubbliche e a modalità di loro realizzazione rispetto a quanto non siano istanze come quelle cui Barca sembra riferirsi nel contesto del suo sperimentalismo democratico (Marella 2014). Abbiamo dunque provato a tratteggiare i possibili connotati di un limite della proposta di Barca “verso il basso”, verso la sfera sociale. Per quanto riguarda il limite “verso l’alto” - verso la sfera politica, questa volta - Barca sembra sottovalutare, se non proprio dimenticare, alcuni elementi costitutivi del politico. Nel politico permane inevitabilmente una componente inaggirabile che è quella della disarmonia, della volontà di potenza e dello spazio della decisione sovrana (Freund 1978). Una certa sensibilità verso tali componenti del politico non è - come probabilmente ci si aspetterebbe che fosse - patrimonio esclusivo di una weltanschauung conservatrice. Il pensiero politico conservatore, come noto, si è tradizionalmente orientato al rimarcare i limiti di un agire politico inteso come mera procedura di adeguamento a norme razionalmente stabilite. Muovendo da un tale orientamento, veniva indicato come elemento caratteristico del politico quello di una sovranità fondativa-creativa svincolata da “costrizioni” formali. All’interno della teoria critica - atmosfera culturale del tutto alternativa alla tradizione conservatrice - il filosofo francofortese Albrecht Wellmer ha individuato nella decisione politica uno dei limiti del potere discorsivo della razionalità comunicativa (Honneth 2012). Nella sfera politica deve essere sempre ricompresa e mai sottovalutata l’ipotesi di una indisponibilità a che il punto di vista discorsivo qualitativamente migliore emerga in un ambito di confronto comunicativo non distorto. Fare riferimento alla persistenza degli elementi costitutivi del politico sopra richiamati non sancisce la rassegnazione all’esistente o la rinuncia a favorire sempre più ampi livelli di inclusività democratica e di sperimentazione partecipativa, ma presenta esso stesso una valenza critica. Tale persistenza ci suggerisce che la strada migliore per affrontarla non è quella della sua ingenua rimozione, ma piuttosto che la si interpreti come elemento inaggirabile, come un limite che - una volta riconosciuto - amplia 100 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228744 Lorenzo Bruni le nostre possibilità di azione. Il rischio, altrimenti, è che tale rimosso si ripresenti assumendo forme radicalizzate e imprevedibili. Proprio se si accetta tale carattere tragico del politico, si può cercare di affrontarlo nei suoi possibili esiti regressivi. Quindi, sia i limiti verso il basso, la forse eccessivamente ottimistica prospettiva di riassorbimento di dinamiche intersoggettive, sociali e partecipative diffuse ed innovative, sia il limite verso l’alto, la sottovalutazione di alcuni tratti inaggirabili del politico, sembrano rendere difficoltosa l’ipotesi di Barca di una nuova saldatura, di un’auspicata riconciliazione, tra il politico, mediato prevalentemente attraverso la soggettività partitica, e il sociale, declinato prevalentemente come cooperazione solidale. Riferimenti bibliografici Barca F. (2013), Un partito nuovo per un buon governo. Memoria politica dopo sedici mesi di governo, disponibile su http:// it.scribd.com/doc/135523966/Fabrizio-Barca-Un-partito-nuovo-per-un-buon-governo#scribd Bazzicalupo L. (2014), Democrazia. Crisi e ricerca di altri modi di essere democratici, in F. Zappino, L. Coccoli, M. Tabacchini (2014, a cura di), Genealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, Milano-Udine: Mimesis. Beck U. (2000), La società del rischio, Roma: Carocci Editore. Bentivegna S. (2014, a cura di), La politica in 140 caratteri.Twitter e spazio pubblico, Milano: Franco Angeli. Bosco N. (2013), Non si discute. Forme e strategie dei discorsi pubblici, Torino: Rosenberg & Sellier. Cassano F. (2011), L’umiltà del male, Bari: Laterza. Chadwick A. (2013), The Hybrid Media System. Politics and Power, Oxford: Oxford University Press. Chattrejee P. (2006), Oltre la cittadinanza. La politica dei governati, Roma: Meltemi, 2006. Elster J. (1998), Deliberative Democracy, Cambridge: Cambridge University Press. Ferrara A. (1999), Autenticità riflessiva. Il progetto della modernità dopo la svolta linguistica, Milano: Feltrinelli. Fishkin J. S. (1995), TheVoice of the People, New Haven:Yale University Press. Floridia A. (2013), Un’idea di partito: cosa può dirci la democrazia deliberativa?, in «Viaggio in Italia» - Blog ufficiale di Fabrizio Barca. Disponibile all’indirizzo: http://www.fabriziobarca.it/viaggioinitalia/wp-content/ uploads/2013/07/Unidea-di-partito-cosa-pu%C3%B2-dirci-la-Democrazia-deliberativa-Antonio-Floridia.pdf Freund J. (1978), Qu’est-ce que la politique ?, Paris: Seuil. Habermas J. (1995), Reconciliation through the Public Use of Reason: Remark on John Rawls’s Political Liberalism, «The Journal of Philosophy», 92. Honneth A. (2012), Dissonanze della razionalità comunicativa, in A. Honneth (2012, a cura di), Patologie della ragione. Storia e attualità della teoria critica, Messina: Pensa Multimedia. Ignazi P. (2013), Sul partito. Prime idee, in «Viaggio in Italia» - Blog ufficiale di Fabrizio Barca. Disponibile all’indirizzo: http://www.fabriziobarca.it/viaggioinitalia/wp-content/uploads/2013/06/Sul-partito_Primeidee_Piero-Ignazi.pdf Inglehart R. (1998), La società postmoderna, Roma: Editori Riuniti. Itanes - Italian National Elections Studies (2013), Voto amaro. Disincanto e crisi economica nelle elezioni del 2013, Il Mulino: Bologna. Magatti M. (2012), La grande contrazione. I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto, Milano: Feltrinelli. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 101 Lorenzo Bruni DOI: 10.1400/228744 Mannheim K. (1999), Ideologia e utopia, Bologna: Il Mulino. Marella M. R. (2014), Bene comune. E beni comuni: Le ragioni di una contraddizione, in F. Zappino, L. Coccoli, M. Tabacchini (2014, a cura di), Genealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, Milano-Udine: Mimesis. Pizzorno A. (1966), Introduzione allo studio della partecipazione politica, in Quaderni di Sociologia, XV, 3-4: 235287. Prandini R. (2013), Esperimenti di (nuova) democrazia: come salvare l’esperienza democratica nell’epoca della sua crisi, in C. Sabel, Esperimenti di nuova democrazia.Tra globalizzazione e localizzazione, Roma: Armando Editore. Rawls J. (1992), Reply to Habermas, «The Journal of Philosophy», 92. Rosanvallon P. (2012), Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, Roma: Castelvecchi. Sabel C. (2013), Esperimenti di nuova democrazia.Tra globalizzazione e localizzazione, Roma: Armando Editore. Sainsbury R. M. (1988), Paradoxes, Cambridge: Cambridge University Press. Santambrogio A. (2013), Utopia senza ideologia. Prospettive per la critica e l’emancipazione sociale, in F. Crespi, A. Santambrogio (2013, a cura di), Nuove prospettive di critica sociale. Per un progetto di emancipazione, Perugia: Morlacchi Editore. Urbinati N. (2013), Che fisionomia ha il partito nella società matura, in «Viaggio in Italia» - Blog ufficiale di Fabrizio Barca. Disponibile all’indirizzo: http://www.fabriziobarca.it/viaggioinitalia/wp-content/uploads/2013/08/ Che-fisionomia-ha-il-partito-politico-nella-societ%C3%A0-democratica-matura_-Nadia-Urbinati.pdf 102 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Eliasian themes Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 103 104 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228745 Angela Perulli [Production and Reproduction of Social Inequalities] The Role of Group Charisma and Group Disgrace Abstract: The paper deals with production and reproduction of social inequalities in Elias’ sociology. For him, the key for any sociological approach to these issues is the use of the concept of social figuration and of the asymmetrical dynamics of «disposition» which drive it. In this essay we will try to decipher these themes (and the more general approach underlying them), starting from the reading of a little known text by Elias which was published only partially; i.e. the speech on the concept of charisma which he gave at the conference organized by the German Sociological Association on the occasion of the centenary of Max Weber’s birth. Starting from the discussion of this peculiar text the papers underline the eliasian position respect to the very famous weberian category. The Eliasian key thought is revealed in all its heuristic potentiality because of its ability to stimulate - in a processual way static and ideal-typical patterns of analysis. The paper is articulated in three main points. The first concerns the leadership and the role it can play, not only as a source of change but also as a mechanism of social reproduction. Elias purifies the concept of charisma from its metaphysically magical and irrational components - emphasizing the mechanisms of institutionalization of the revolutionary force to which that concept refers - showing the dynamics of construction, protection and waterproofing of the boundaries of power groups made possible by the action of the leader and his followers. The second point concerns the processes of stigmatization and labeling that «crystallize» the system of inequalities, giving them an ideological appearance of normality and incontrovertibility.The third point concerns the contribute to the development of a thought capable of going beyond traditional conceptual dichotomies. The discussion on charisma and inequalities allow us to merge rational and emotional, individual and collective, natural and social aspects of social life in the way how practically they are revealed and can be studied. Keywords: Social inequalities, Charisma, Elias. The first problem when tackling the issue of production and reproduction of social inequalities in Elias’ work is deciding where to start from. On the one hand it is difficult to find a text where the author addresses this issue per se, while on the other it is a theme which pervades his entire work. From the well-known The Civilizing Process to unpublished or recently published works, the author continually wrestles with what can be defined the problem of sociology. Class stratification and functional differentiation appear as central themes in The Court Society, The established and Outsiders, The Germans and various essays. They also play a fundamental role in Elias’s magnum opus, The Civilising Process (Loyal 2004: 125). In these texts, as underlined by Loyal, Elias confronts the concepts of class, rank and social stratification, analyzing and discussing Marx and Weber’s ideas on the genesis of modern society. However, in line with the approach used throughout his intellectual journey, he argues for the abandonment of static conceptual categories such as those mentioned above, in favour of a more dynamic reading of social processes, through which inequalities arise and are transformed. And he does so by using concepts which are typical of his epistemological approach, and which attempt to bring together different elements which make up the concrete existence of human beings. This approach is very clear when the author addresses the issue of social stratification and the emergence of new social positions related to new professions, as, for example, in The Genesis of Naval profession, as well as when he tackles the issue of gender inequality (Elias 1987, cfr. Brinkgreve 2004). It is also present when he tackles racial Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 105 Angela Perulli DOI: 10.1400/228745 inequalities, as, for example, in the theoretical essay in the second edition of The Established and the Outsiders (1994, cfr. Dunning 2004). In all these cases, the dimension of power is central, i.e. differences in the distribution of power between individuals and groups, and the resulting different possibilities/ability to influence the actions and lives of others. At the root of stratification systems there is a shifting balance in authority which can manifest itself in different ways, historically and geographically, but which always has a relational character. For Elias, the key for any sociological approach to the issue of inequality is the use of the concept of social figuration and of the asymmetrical dynamics of «disposition» which drive this. From this angle, the disparity in resources that distinguishes different actors and their different ability to reciprocally influence each other’s behavior, stems not only from their different situations and the given circumstances or context in which they act strategically (the «macro» perspective); and not only from their unilateral ability (rooted in the presumed irreducible intentionality of the individual) to use the constraints and opportunities of belonging to networks to carry out their projects (the «micro» perspective). Rather they stem from the complex of social mechanisms through which individuals present themselves to each other, the environment in which they operate, and which shapes their mutual expectations, decisions on how and what to improve in their fortunes, or to what extent to maintain or defend their positions1. In a complex meso-analytical interplay between psycho-socio-genesis of collective phenomena (the manner in which the morphology of a historically-determined social figuration marks individual actors’ character and perceptions, and re-produces itself by way of processes set in motion by them), Elias identifies in an original way (original compared to the sociological tradition of that time but also compared to our current tradition) both the rational and emotional components of behaviour. These latter are less predictable and more rooted in forms of life or «belonging», which shape desires, priorities, utility functions and motivations of which we are more or less immediately conscious. Stratification, inequality, up- and downward mobility are - from this point of view - the result of considered choices, complex decisions, more or less complex costs/benefit analyses; but, at the same time, of introspective and instinctive needs for recognition, acceptance, social inclusion, conflicting communication with the groups and their members, to which one is bound in everyday interaction. This result can never be taken for granted and is never final (but is also neither «disordered» nor unintelligible). In this essay we will try to decipher these issues (and the more general approach underlying them), starting from the reading of a little known text by Elias which was published only partially; i.e. the speech on the concept of charisma which he gave at the conference organized by the German Sociological Association on the occasion of the centenary of Max Weber’s birth. At first glance, our choice may seem rather unusual. In Weber’s work, charisma refers to an essentially «irrational» component of action, which rises in times of institutional crisis, social and cultural decline in order to radically put into question frameworks of the established order, and to disrupt the stranglehold of bureaucratic organization and its codification of balances of power. It represents, in short, a source of change rather than a factor contributing to stratification and reproduction of social inequality. Yet, a key part of Elias’ thinking is revealed - with all its heuristic potential - in his ability to add a dynamic element to the static and ideal-typical patterns of analysis, by referring to processes in an authentically sociological way; and to use - drawing on Simmel›s work - the principle of reciprocal causation, which means not only revealing the interdependence of social phenomena, but also the unveiling of symmetrical and opposite meanings in the same historical events. Three points will emerge in the discussion, which we summarize here to help guide the reader. The first concerns leadership and the role it can play, not only as a source of change but also as a mechanism of social reproduction. Through a selective and highly original reinterpretation of some pages of the Sociology of Religions by Weber, Elias underlines both the fully relational nature of the phenomenon of charisma, as well 1 All individual purposes give birth to society in an unplanned way. In the determination of individual goals central is the idea of quest for survival. It occurs not only in biological terms (although these have not an irrelevant importance) but also with regard to the survival of communities, workplaces, social groups, cultures, lifestyles, customs. It is precisely in response to the different needs of survival that historically people have generated changing «unit of survival», meaning by this expression all forms of social unions between individuals (families, tribes, states, etc. …). People therefore react and act also under the fear that our world disappears, that there is a risk in relation to our survival. (Giovannini, Perulli 2012: 138-142). 106 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228745 Angela Perulli as its role of «closure» and reproduction of class interests and ruling elites. This latter occurs exactly due to its social «constitution» and the power dynamics which inevitably underpin it. Elias is never satisfied with the largely unilateral and mutually exclusive interpretations of social inequalities offered by the Marxian, Elitist and Actionalist schools of thought. Our author rather purifies the concept of charisma from its metaphysically magical and irrational components - emphasizing the mechanisms of institutionalization of the revolutionary force to which the concept refers - and shows (with the category of Gentilcharisma) the dynamics of construction, protection and «waterproofing» of the boundaries of group power, which are made possible by the action of the leader and his followers. Years later, the distinction between personal charisma and group charisma - which stems from the distinction between a creative/innovative and a reproductive/routine leadership - echoes not just some analyses of the sociology of organizations (the difference between formal leadership of line management and the informal leadership of staff, made by Amitiai Etzioni); but also helps to highlight the relationships between characteristics of economic and cultural classes, and to delve deeper into the problem of the (lack of) turnover of elites, which Mosca considered the main factor explaining change (or dysfunctional reproduction) of the ruling class. The second point - more immediately linked to power dynamics and how they are re-enforced - concerns the processes of stigmatization and of labeling that «crystallize» the system of inequalities, endowing them with an ideology of normality and making them non-controversial. Anyone who re-reads the labeling theorists will find in this example of Elias’ work, approaches which are as relevant as ever to understand the reasons – which are on the whole still under-investigated - behind the creation of prejudices and stereotypes, and their transformation and accreditation as simplifying, fungible, marginalizing cultural frameworks; and above all of the more or less conscious mechanisms through which these distinguishing features are «legitimized» by those at whom they are directed.The Eliasian study of Winston Parva - quoted several times in the following pages - dilutes the reified logic of power relations (always historically determined by the boundaries of interdependencies within which uneven balances occur) and looks at the complex sequences of actions, reactions, images and counter-representations that find their raison d’être on the one side in the attempt of the Established to preserve their collective identity cultivated over the long term; and on the other in the symmetric need (which is not less strategic, defensive, and orientated at a gradual acquisition of authority), for acceptance, inclusion and (more existentially) recognition on the part of the outsiders. Overall - the last point to which we draw the reader’s attention - all of Elias’ analysis seems to be driven by his constant concern - epistemological and theoretical - to contribute to the articulation of an approach capable of going beyond the traditional conceptual dichotomies which classical sociology (but also to a large extent contemporary sociology) has nurtured and continues to draw on. «Individual and Society», «nature and culture», «global» manifestations of social phenomena and the local nature in which they manifest themselves and can be studied: all of these combinations which for Elias are the result of distorted reasoning. (For him they are also certainly sociologically understandable as they stem from historically determined forms of social figurations). Only a vivid scientific imagination can help to disperse and to overcome such distorted reasoning. Imagination is needed - as we are trying to do in this essay - to study the order and structures of inequalities, starting, paradoxically, from one of the main analytical categories traditionally used to analyze social change. Towards a sociological definition of charisma It is broadly accepted that we owe to Weber the most articulate study of the charisma concept in sociological thought (Cavalli 1981, in particular the first part). And for his essay2 Elias starts with Weber’s work. The first part 2 The year 1964 marked the centenary of Max Weber’s birth. For its celebration the Sociological German Association organized the annual congress in Heidelberg. Elias participation was his first appearance in the sphere of German sociology since 1933, when he left Germany owing to the racial persecutions against Jewish intellectuals. The paper was called Group Charisma and group disgrace and it represented for him the opportunity to reflect, starting from the author to which the conference was dedicated, to the concept of charisma in order to read mechanisms of social exclusion found in a small English working-class community. The contribution was not included in the «transactions of the conference» (Stammer 1971 in Mennel›s introduction to Elias essays, 2009: xii) for reasons that have to be brought back both to Elias›s marginality within the German academy and to the paper’s characteristics, for its length and style «it Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 107 Angela Perulli DOI: 10.1400/228745 contains a detailed discussion of the Weberian concept of charisma representing «a rather rare example in Elias›s writings of a long textual critique and interpretation of another sociologist» (Mennel in Elias 2009: xii)3. The points raised by Elias can be substantially reduced to three, and they are all aimed at strengthening his own strictly sociological approach and use of the charisma concept. The first point is semantic4, and concerns the nature of the qualities evoked by the use of this term. Elias stresses its limits for sociological analysis due to the fact that this expression is understood as a pre-social, innate quality of exceptional individuals. He recognizes the enormous potential opened up by Weber’s discussion of charisma, both individual and group charisma, but he argues that this potential is limited: Max Weber’s usage of the concept has acquired some highly personal implications connected with his own transient partisan ideas in the struggles of his own time. One cannot proceed with the use and development of the concept charisma as a general sociological concept without glancing at some of the older magical associations which Max Weber himself was not able to cast aside (Elias 2009: 77). At first glance it may seem surprising that an author such as Elias - attentive to the socio-historical dimension of all phenomena and ways of living together, from specific sociologically visible forms of human beings, including social scientists - emphasizes this kind of limit to Weber’s analysis. In fact, Elias raises two issues which are dear to him. The first is the relationship between sociology and social phenomenon. This particular interweaving between involvement and inevitable necessity of detachment is typical for the social scientist. From this point of view Elias underlines how the difficulty to lose the ambiguity of the concept can be connected to the excessive involvement and the resulting lack of detachment showed by Weber (Elias 1987). This meant that he placed limits on the heuristic and analytical capacity of the concept which he put forward5. The second problem is related to the scientific concept.The criticism is not so much directed at the presence of emotional factors6 in Weber’s approach, but at the fact that the author does not put them in historical context, and does not consider those aspects as the result of a clear social and historical development and the particular position of the individual- Weber - in the society of his time. But we will come back to this theme later. Elias considers the motivations behind Weber’s involvement, and considers them to be to a certain extent unavoidable. This consideration of the inevitability of ambivalence due to the involvement of the observer, allows Elias to stress a methodological aspect which is typical of his theoretical approach. This is the need to overcome the dichotomous approach in sociological analysis through the consideration of relations and the mutual influence of different aspects of lives of human beings, and the relationship between observed reality and analytical tools. was not easy to accommodate in a volume of conference proceedings» (Mennel in Elias 2009: xii). Such paper has long been unpublished, and it appeared in the collection of essays edited by R. Kilminster and S. Mennell (ibidem).Yet, despite the provisional character of this writing, its disorganicity, its polemical tone, it contains some features of Elias›s thought on which I think it might be worth dwelling. Particularly for the relationship that Elias emphasizes between the charismatic dimension and the mechanisms, which underlie social inequalities, through a unique interweaving of individual and collective, emotional and rational, theoretical and empirical elements, that are characteristic for this author. Different versions of the paper can be found in the Marbach Archive. I wish to thank The Norbert Elias Foundation for giving me the permission to consult the typescripts and the Deutsches Literaturarchive in Marbach a.N. for the Norbert Elias Stipendium that allowed me to spend some weeks in Marbach deepening my study. 3 It is well-known that Elias is moderate in the use of notes and explicit references to other authors. 4 Elias’s sociology is characterized by the analysis of words meanings, in their common sense and for the scientific reflection. 5 «MaxWeber in his attachment to the ideal of a great leader was thus an individual representative of a specific social and National tradition. The attachment had strong emotional roots; it was closely associated with his patriotism, with his overriding concern for Germany’s fate, particularly in the years just before and after the end of the 1914-18 war. This specific emotional involvement undoubtedly provided the driving force for Weber’s interest in the problems of great leader figures. That he could gradually detach himself from the emotional core of his experience» (Elias 2009: 79), which, as we shall see later, it will decrease during the development of Weber’s thought. See also the long footnote where Elias tries to connect some of Weber’s personal affairs for which he proposes analytical elaborations. 6 In Elias «emotions are embedded […] in the theory to show the connection between natural and cultural aspects of human existence and the idea that the individual and society […] are not two separated data» (Corigliano 2001: 33). 108 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228745 Angela Perulli The concept of charisma as presented by Max Weber was bound to be ambiguous, since it combined pre-scientific and almost mystical features stemming from Weber›s involvements, with more impressive scientific views resulting from his strenuous efforts at greater detachment. This shows how illusory are the traditional static and absolute polarities such as «ideology» and «truth», «subjectivity» and «objectivity», «value judgment» and «value-free judgment». On the basis of such absolute priorities one is compelled to ask: if Weber›s concept of charisma was «socially conditioned», if it was the elaboration of a social ideal and part of a political ideology, how can it be «true» or objective? How can it have any scientific function and relevance? The answer is simple: it would be obvious enough if our habits of thinking did not enjoin us to expect an answer in terms of exclusive and static alternatives, and did not block as almost irrelevant the perception of what occurs in actual fact - of what could be observed and demonstrated if our traditions of thinking allowed it - the fact that, under certain conditions, people can improve the appropriateness of their thinking and the correspondence of their concepts to observable data.Weber›s introduction of the term «charismatic» as a sociological term for a specific type of leadership was such a step. He developed a magical-theological [concept] into a scientific concept. But, as he remained to some extent a captive of one of the social religions of his time, his concept in turn remained an hybrid - it remained magical-scientific in character. One has to go beyond him; one can improve the concept still further. (Elias 2009: 79-80)7 As is well-known, Weber puts forward different definitions of the term «charisma» in his work (Bendix 1960, Cavalli 1981, Eisenstadt 1968). Elias points to three of them, emphasizing an interpretation which is in a certain sense an evolution of Weber’s thought: gradually transforming the concept of charisma from a magic-theological to a scientific concept, as is mentioned in the passage quoted above. The first refers to the definition proposed by Weber on the studies of Indian society which refers to «a personal qualification ... which originally was thought to be purely magical and was generally regarded as extraordinary, or at least not universally accessible to human beings» (Weber in Elias 2009: 76). According to Elias, this definition - and the whole excerpt from which it is taken - «shows clearly the initial ambiguity of Weber›s concept» (Weber in Elias 2009: 77) and therefore he asks: Is charisma, in point of fact, an extraordinary, unexplainable and somewhat mysterious gift of certain individuals which Max Weber himself accepted as such and which we are meant to accept in the same way? Or does the concept refer to the fact that in certain situations the followers or individuals who play, or aspire to [play], a leading role in their group - and perhaps these individuals themselves - believe that they have been graced with a special gift which cannot be explained in the way in which one explains the faculties of ordinary men? In other words: does the concept «charisma» refer to a specific - not, however, explainable - quality of people, or to a certain social configurations within which people who are able to possess these qualities assume or perform the role of leader and exercise authority? (Elias 2009: 77). Elias states that such questions cannot be resolved in the references above, and even in the definitions that Weber puts forward in other works, such as in the introduction to The economic ethic of world religions, where he writes «In the studies that follow, charisma shall mean an extraordinary quality of a person regardless of whether it is real or supposed or imagined» (Weber in Elias 2009: 78). This definition represents the second quotation reported by Elias, and it is followed by a third one in which «the question of the magical or psychological reality of the charisma disappeared from view» (Elias 2009: 78), with only the sociological dimension remaining. In Economy and Sociology Weber defines charisma as a quality «evaluated as something out of the ordinary on account of which a person is assessed as having super-natural or super-human, or at any rate extraordinary powers or properties not accessible to any other person» (Weber in Elias 2009: 78, italics by Elias). Together with the downsizing of the magical-psychological dimension, there is an insistence on what we could define as the relational aspect of the charismatic dimension. It is just this aspect that Elias interprets as a sign of the new prevalence of the sociological dimension. Charisma changes from being a «possessed» quality to a «recognized» quality. This 7 Further on he clarifies his thinking «The relationship between ideological and scientific, fantasy-centred and reality-centred, involved and detached ways of thinking is not an «either-or» relationship; it has not the form of a static polarity between two opposites of which one can apply in any particular case only to the complete exclusion of the other, but that of a process of changes in a specific direction - of a development with many transitional stages. At present such stages can be diagnosed only as blends or alloys of polar conceptual structures from which a concept moves away, or towards which it moves, at a given stage of its development and which blend or amalgamate at different stages in different forms and degrees» (Elias 2009: 80). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 109 Angela Perulli DOI: 10.1400/228745 presupposes a social relationship between those who have it, and those who acknowledge ownership of the quality, and leads to a shift in the dynamics of social interactions or, in Elias words, in social interdependencies. Individual charisma and group charisma The second point discussed by Elias – which is also designed to highlight the sociological nature of the concept of charisma - is the possibility that charisma is attributed to a single individual not because of his particular qualities, but because he belongs to a certain group. Weber himself points out that charismatic qualities can be transmitted by inheritance and through the institutionalization of charisma. Elias moves on from Weber’s concept of Gentilcharisma to propose the use of the term «group charisma»8. In the section dedicated to The role of kinship group and casts Weber emphasizes how the social order is based on what we may call Gentilcharisma. He writes: This means in this context that a personal qualification - a «charisma»- which originally was thought to be purely magical and was generally regarded as extraordinary, or at least not universally accessible to human beings, was attributed to members of a clan as such and not only, as it initially was, to a particular person. We have remnants of the sociologically very important conception above all in the hereditary rights of our dynasties to rule by «the grace of God». To a lesser extent every legendary tale about the special quality of the «blood» of all kinds of aristocracies which regard themselves as pure, whatever their origin, belongs to the same type. This conception is one of the ways in which the initially purely actual and personal charisma becomes routinised. The warrior king and his followers were heroes who distinguished themselves from other men by purely personal magical qualifications which had been demonstrated by their success; the authority of the war leader itself, just as that of the sorcerer, was initially based on a strictly personal charisma alone. The successor too, claimed authority initially on the strength of a purely personal charisma (Weber in Elias 2009: 76). There are thus modalities which mark the transition from individual to group charisma. According to Weber these are essentially three (we can find them also in other parts of the same work): the designation of a qualified successor by the current holder of charisma; the determination of a successor by the followers (princes, cardinals); and, particularly important for the line of thought developed by Elias: the victory of the obvious belief that the charisma was the property of a kinship group as such, that the qualified person or persons had to be found within this group. This formed the transition to the hereditary character of the Gentilcharisma with which it originally had nothing to do ... In that way it became possible to evaluate as rooted in a magical group a charisma not only heroic and priestly - ritual qualifications ... but positions of authority of many kinds... (Weber in Elias 2009: 76). In Weber, as later in Elias, the possession of noble charismatic qualities is linked directly to a dimension of power and authority: All groups within that society who claimed for themselves an elevated rank (by comparisons with others) were induced to model themselves on the highest group … and the principle of the heredity of social position, ritual duties, way of life and occupation gave to the group charismatic principle as an attribute of every position of authority its final and decisive sanction (Weber in Elias 2009: 77). Weber also points out that in Western European feudalism kinship groups played a minor role compared to class membership.9 Actually Elias refers to this passage, and develops the idea that charisma can exist not just 8 See what Bendix writes about «Familial and Institutional Charisma» (1960: 308-318). Elsewhere, the parallels between Elias’s and Bendix’s intepretations of Weber’s thought should be deepened, as some letters found in the Deutsche Literatur Archive suggest (DLA 32.6.3 Bendix R.). 9 Weber instead stresses the fact that in India unlike in the West, in many cases a charismatic usurper with his followers could blow up the strong team of old kinship groups, however the development always led again on the way to the Gentilcharisma organization of noble lineages and kinship groups. As Gentilcharisma was the basis of the caste, so in turn the caste supported the charisma of kinship group. 110 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228745 Angela Perulli in exceptional personalities, but also in ordinary individuals who acquire it not because they are endowed with special qualities, but simply because they belong to certain social groups, be these families, clans, classes or other groups. Elias searches out those passages in Weber’s work where use of the term refers not only to kinship groups (family, clan charisma, sib- charisma), but also to the wholeness of a caste or aristocracy of blue blood groups: in short, groups of people united by bonds which are not kinship bonds. He concludes: What he [Weber] has to say about Gentilcharisma is, in some respects, of such a general nature that one does not stretch his concept unduly if one speaks of «group charisma»; and as I wish to stress the general nature of the phenomenon, that is the term I propose to use here (Elias 2009: 73). Charisma and disgrace in the figurational game The third point raised by Elias regarding Weber’s concept of charisma concerns the so-called separate use made of this category.We have just dealt with the different approach regarding the owner of the particular quality. But we must remember that Elias distances himself from Weber in two ways. Firstly, as we have seen, Elias stresses the sociological and not «natural» of what are considered exceptional qualities. These are not qualities which in themselves are «good», but qualities which in order to be able to be translated into significant sociological effects must be recognized as such10. They are a source of authority: they assign, strengthen, empower people to keep certain positions within different social figurations involving different actors. Charisma is both the result and driver of social relationships, and not an inherent quality on the basis of which social relations are forged. Secondly, what is considered charismatic cannot be understood without considering at the same time the quality with which it is contrasted11. In other words, we find here the insistence on relational aspects of the analytical concepts used, which is typical of Elias’ approach. Elias underlines the need to use the term «charisma» along with its opposite, without leaving in the shadow, as in his opinion Weber also does, «the other side of the coin, such as group contempt, ostracism, disgrace and denigration, which to this day have attracted relatively little attention as sociologically significant phenomena» (Elias 2009: 74). Too often, Elias argues, these are treated in contemporary sociology in separate compartments, attributed to different categories, sometimes classified as «group prejudices», «and in that case, they on their part are usually explored without reference to the charismatic claims of the «prejudiced» groups. They may be studied under such names as «racialism» or «nationalism» (Elias 2009: 74). The same applies to studies of the stigmatization of groups or individuals. In order to understand why certain features can be perceived in charismatic terms and transformed into actions and have potential influence on the perceptions of others, we need to consider the interdependencies between those who are invested with these qualities and those who are excluded, including those who hold on the basis of these qualities a position of relatively greater power, and those who - by recognizing this superiority - serve to reinforce it. In other words, we need what Elias defines a figurational approach, which can capture all the elements which mutually influence each other. With the concept of figuration the interdependencies among individuals are placed at the center of sociological analysis, as well as their mutual influence on each other, within a framework of action limited by the spatial-temporal conditions in which the interdependencies and mutual influence occurs. The figuration is presented as an interconnection of actions performed by a group of individuals in dynamic interdependence, always in a specific historical and social context. Actions are observed as they take place in practice. In figurations in fact real people come into play (with their specific biological, cultural, social, psychological characteristics, with their backgrounds and their aspirations) - and not individuals conceived in the abstract - acting within rules more or less formalized, which they interpret and help to strengthen or change. Every 10 This idea is strongly supported by Elias. 11 «Without some sense of the unity of the structure in the variety of relationships such as those, and of the corresponding attitudes and beliefs – which, at present, are usually classified under a multitude of separate headings, often as if they had nothing to do with each other – the study of each of them must suffer. Sooner or later, one will have to develop a unified theoretical framework, a unified model or, to use Max Weber’s own term, an “ideal type” of ‘“stablished-outsider relationships” - with their concomitants, group charisma and group disgrace – probably in the form of a continuum extending between two poles» (Elias 2009: 75). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 111 Angela Perulli DOI: 10.1400/228745 individual pursues his/her own goals, and acts within boundaries that are shaped by historical, geographical, social conditions, of where he/she was born. The (individual and collective) past inevitably influences him/her, as does the future toward which the individual strives. These boundaries are also represented in the social habitus, which connects different individuals within the figuration. It represents the common space that different individuals share together12, as well as the shared norms and rules that individuals make their own. Moreover, with the idea of figuration, Elias focuses on the dimension of power, which is also conceived in relational terms (Heiland, Ludemann 1991, Perulli 2011). Within the figuration there is in fact a shifting distribution of power, conditioned by the changing ability to influence (facilitate/hinder) the choices, actions and desires of others. Multiple tools can be used for this purpose, but an important role is played by the dynamics of belonging to one’s own group, which in turn influences the creation of one’s personal identity. Here, according to Elias, the individual oscillates between an I-identity and a we-identity, between the need to differentiate oneself within the group, and a need to belong to a collective group. (Elias 1991, in part. Chapter 3). In these dynamics an important role can be played by group charisma and group disgrace. This is the search of the individual for the approval of others within the figuration, and the attempt to avoid disapproval. This is also one of the ways used by those who are in a position of relative power in relation to others in the group to establish and maintain boundaries, to retain and strengthen existing power differentials. The relational approach theorized by Elias offers the possibility of placing the problem of charisma and group disgrace within the broader reproduction of social inequality. It is not a coincidence that the use of the categories of group charisma and group disgrace form part of a research that questions the mechanisms of social inequality within an apparently homogenous community. Reproduction mechanisms of social differences In the last part of The Civilizing Process Elias starts to develop a series of ideas about the relations between social inequalities, power chance, the structure of personality, life styles and cultural expressions which found a more extended and articulated study in the research on the community of Wiston Parva, a fictitious name for a suburb of Leicester in England (Elias, Scotson 2004). Looking at the elements which mark the emergence and decline of social groups which hold a position of relatively greater power, Elias refuses to adopt both the Weberian and Marxist approach (Mennel 1992, in part. Chapter 5). He explicitly rejects the premise that everything can be reduced to issues of control over economic sources of power. Implicitly he also rejects the concept of class, status and party as three factors or dimensions of the distribution of chance of power. Rather the mutual influence of creation processes of meaning and power are considered central13. For Elias power, as noted above, is a property generated by figurations of all social interdependencies. The study on the small community of Winston Parva looks precisely at how to understand the mechanisms that generate and explain the power differentials at the community level and, more generally, what might explain the forms of differentiation and social segregation. It is here that adopting analytical categories such as group charisma and group disgrace are found to be particularly useful. What Weber noticed in his studies of the Indian caste system turned out to be an extreme form of a type of relation that can be found in many other societies. If one looks only at Indian cases, and in particular those related to the ratio of Brahmin castes and pariahs in order to prove the existence of group charisma and group disgrace, the phenomena can be considered foreign and unusual, although they are actually part of the reality in which we live (Elias 2001). To deal with them on a smaller scale, Elias says, offers several advantages: first, we have empirical observation of the ways and pace in 12 As it is well- known the habitus for Elias is the social structure of personality. It leads to what is acquired during a process of socialization and which is common to most individuals who live in certain social groups. Although every individual is different from the other, he/she bears, however, specific marks with other people who belong to his/her group. «This make-up, the social habitus of individual forms, as it were, the soil from which grow the personal characteristics through which an individual differs from other members of his society» (Elias 1994: 54). 13 Heinrich (1997: 78) underlines how Elias rejects the use of the term «élite» for qualifying the dominant group as, for him, it refers to static qualities. 112 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228745 Angela Perulli which a group matures and consolidates a desire for group charisma, accompanied by the parallel imposition of a mark, a sort of collective blame on the antagonist group, and secondly, the deepening of the links between group charisma and group disgrace. From this point of view the study on Winston Parva can be seen as a step towards considering group charisma group and group disgrace as two poles of a single continuum that reflect the degree of approval/disapproval in the figurational game. In the figuration of group established/outsiders, group charisma and group disgrace are complementary and they are one of the most significant features of such a figuration.14 Such complementarities provide: a clue to the emotional barrier against closer contact with the outsiders set up by this kind of figuration among the established. Perhaps more than anything else, this emotional barrier accounts for the often extreme rigidity in the attitude of established groups towards outsider groups – for the perpetuation of this taboo against closer contact with the outsiders for generation after generation, even if their social superiority or, in other words, their power surplus diminishes. (Elias 1994: xxii). This is what calls «emotional rigidity», examples of which can be found in the perpetuation of the exclusion of untouchables in India even after the formal abolition of castes, or the exclusion of blacks in America after the abolition of slavery (Mennel 1992: 129-131). The use of the dimension group charisma- group disgrace allows Elias to emphasize the close relationship between holding a certain position of power within the figurational game, and considering the holder of this position in terms of good/ bad, better/worse. And this qualification becomes so obvious, especially when it is reified through the use of distinctive concretely observable signs, which can obscure the power relationship that supports it.15 Thus one encountered here, in the small community of Winston Parva, as it were in miniature, a universal human theme. One can observe again and again that members of groups which are, in terms of power, stronger than other interdependent groups, think of themselves in human terms as better than the others. The literal meaning of the term «aristocracy» can serve as an example. It was a name which Athenian upper class of slaveowning warriors applied to that type of power relation in Athens which enabled their own group to take up the ruling position. But it meant literally «rule of the best». To this day the term «noble» retains the double meaning of high social rank and of a highly valued human attitude, as in «a noble gesture»; just as «villain», derived from a term that applied to a social group of low standing and, therefore, of low human value, still retains its meaning in the latter sense – an expression for a person of low morals. It is easy to find other examples. This is the normal self-image of groups who in terms of their power ratio are securely superior to other interdependent groups. Whether they are social cadres, such as feudal lords in relation to villains, «whites» in relation to «blacks», 14 Van Krieken (1998: 147-153) identifies among typical dynamics of relations: 1) the status distinctions between established and outsiders are rooted in an uneven balance of power between them. 2) group power differentials generate a polar contrast between group charisma and group stigma and a particular «socio-dynamics of stigmatization». Although both groups may display a similar range of behaviour, the established group›s greater social cohesion and control over flows of communication enables it to organize its public image in terms of its best members, and to construct the identity of the outsiders in terms of its «worst» members. 3) It is difficult for members of the outsider group to resist internalizing the negative characteristics attributed to it by the established. Members of the outsider group «emotionally experience their power inferiority as a sign of human inferiority» and incorporate the stigmatizing judgments of the established group into their own personality structure. 4) A «we» identity based on a shared history by the established group is a crucial element in the power relationship with the outsiders- role of gossip.5) Established present themselves as more «civilized» and outsiders as more «barbaric». 15 «The social stigma that its members attach to the outsider group transforms itself in their imagination into a material stigma – it is reified. It appears as something objective, something implanted upon the outsiders by nature or the gods. In that way the stigmatizing group is exculpated from any blame: it is not we, such a fantasy implies, who have put a stigma on these people, but the powers that made the world - they have put the sign on these people to mark them off as inferior or bad people. The reference to a different skin colour and other innate or biological characteristics of groups which are, or have been, treated as inferior by an established group has the same objectifying function in this relationship as reference to the imaginary blue stigma of the Burakumin.The physical sign serves as a tangible symbol of the assumed anomie of the other group, of its lower worth in human terms, of its intrinsic badness; like the blue-stigma fantasy, the reference to such «objective» signs has a function in defense of the existing distribution of power chances as well as an exculpatory function» (Elias 1994: xxxiv). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 113 Angela Perulli DOI: 10.1400/228745 Gentiles in relation to Jews, Protestants in relation to Catholics and vice versa, men in relation to women (in former days), large and powerful nation states in relation to others which are small and relatively powerless, or, as in the case of Winston Parva, an old-established working-class group in relation to members of a new working-class settlement in their neighborhood – in all these cases the more powerful groups look upon themselves as the «better» people, as endowed with a kind of group charisma, with a specific virtue shared by all its members and lacked by the others. What is more, in all these cases the «superior» people may make the less powerful people themselves feel that they lack virtue – that they are inferior in human terms. (Elias 1994: xv-xvi). As is well-known, the starting point of this research is represented by the fact that residents belonging to some local families considered themselves better human beings compared to those who lived in the more recent part of the community, and the newcomers themselves appeared to accept the fact that they belonged to a less-respected group. Although similar in social composition and employment structure, the inhabitants treated the others as pariahs and often talked about them in terms of great disapproval. How is all this possible? How does the creation and reproduction of mechanisms make it possible and acceptable? Our author manages to create a veritable theory of social segregation on the basis of information gathered, and testimonies from Winston Parva inhabitants’ daily lives. His research involves reconstructing networks of neighborhood relations, observing who spoke with whom, with whom people went to the cinema and to watch what, which were the youth groups, the allowed and not allowed love affairs, association activities and local policies, the reconstruction of those who held significant positions in public life community, the family networks. From all this there emerges an exquisitely sociological dynamic. It is the social relations, the length of residence in the place, with everything that this implies in terms of belonging and sharing16, which determine the separation between insiders and outsiders. In this particular figuration of established/outsiders, power is acquired through social cohesion, by having a shared and consolidated network of relationships, shared patterns of living and the pride and principles arising from such sharing. The perception that this may be threatened by outsiders means that the insiders seek to maintain the boundaries between the two different groups through the strengthening of specific traits, emphasizing the good qualities of one group - group charisma - and the lesser qualities of the other - group disgrace. The insiders cut themselves off from outsiders, and stigmatize them as persons with inferior traits, and treat them as people deprived of superior human qualities – i.e. the charisma that distinguishes their own group, and which is attributed only to those in the dominant group. To preserve what they felt to be of high value, they closed ranks against the newcomers, thus protecting their identity as a group and asserting its superiority. The situation is familiar. It shows very clearly the complementarity of the superior human worth – the group charisma – attributed by the established to themselves and the bad outsiders17 (Elias 1994: xxii). While group charisma thus represents an element of power for the dominant group, which uses it to claim such superiority over others, it also comes at a certain cost to the members of the dominant group. «Participation in a group’s superiority and its unique group charisma is, as it were, the reward for submitting to group-specific norms» (Elias 1994, p. xxiii). The closing of ranks also serves to avoid possible «contamination» deriving from close contact with members of the outsider groups. «That has all the emotional characteristics of what has been called the «fear of pollution» (Elias 1994, p. xxiv). Any contact with those who are considered «anomics» would 16 «The two groups […] were not different with regard to their social class, their nationality, their ethnic or racial descent, their religious denomination or their educational level. The principal difference between the two groups was precisely this: that one was a group of old residents established in the neighbourhood for two or three generations and the other was a group of newcomers. The sociological significance of this fact was a marked difference in the cohesion of the two groups. One was closely integrated and the other was not» (Elias 1994, p. xxi-xxii). 17 Here we find what Elias defines as «pars pro toto distortion»: «an established group tends to attribute to its outsider group as a whole the ‘bad’ characteristics of that group’s worst section – of its anomic minority. In contrast, the self-image of the established group tends to be modeled on its exemplary, most ‘nomic’ or norm-setting section, on the minority of its ‘best’ members» (Elias 1994: xx) 114 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228745 Angela Perulli threaten a member of the established group with «anomic infection». Hence contact with the outsiders threatens an «insider» with the lowering of his/her status within the established group. He or she might lose its members’ regard – might no longer seem to share the higher human value attributed to themselves by the established (Elias 1994, p. xxiv). Among the tools used for this purpose, the role given to gossip is significant, through which the roles of different actors are defined and significance is given to the values and behavior (actual or alleged) of the stigmatized group. 18 Gossip can be of two types: approval or disapproval. Often we tend to think to this form of communication as a marginal phenomenon, without significant social consequences. However, Elias argues that: phenomena similar in structure and function to this types of “gossip” can be found on other social levels apart from those of neighborhoods and communities, for instance as stereotypes of collective self-praise and collective abuse of castes or classes on a national [level], or of nations on an international level. One may not immediately recognize their affinity to forms of gossip in a small community. But the difference is more one of degree than one of kind. Final observations We have seen how the re-visiting of Weber’s concept of charisma begins with Elias’s attempt to understand the particular dynamics of exclusion observed in Winston Parva What Max Weber observed when he studied the Indian caste system with its firmly established charismatic groups, especially the priestly castes, on the one hand, and its various outsider groups, with the pariahs at the bottom, on the other hand, appeared in the light of this small-scale enquiry as an extreme form of a type of relationship which - with varying degrees of complexity and exclusivity - can be found in many societies besides old India. The fact that one came across a variant of it even in a small European community made it seem worthwhile to re-examine Max Weber’s concept of group charisma in the light of the additional evidence. (Elias 2009: 74) This re-visiting focuses on those elements that make this concept a heuristically useful sociological tool. In this concluding section I would like briefly to recall them. As you will recall, we started with the criticism made by Elias of the pre-social-religious magic components that run through Weber’s definition, and which give the concept some ambiguity, limiting its usefulness for sociological analysis. Such criticism does not stem from any denial of the emotional components that the concept evokes, and even less from a belief that they should be excluded from scientific analysis. On the contrary, Elias gives sociological citizenship to the emotional sphere, to feelings that move and sustain the actions of human beings in their figuration game. However, the ideal of rationality in the conduct of human affairs still bars access to the structure and dynamics of establishedoutsider figurations and to the magnifying group fantasies thrown up them, which are social data sui generis, neither rational nor irrational. At present group fantasies still slip through our conceptual net. They appear as protean historical phantoms that seem to come and go arbitrarily. At the present stage of knowledge one has got so far as to see that affective experiences and fantasies of individual people are not arbitrary – that they have a structure and dynamics of their own. One has learned to see that such experiences and fantasies of a person at an earlier stage of life can influence profoundly the patterning of affects and conduct at later stages. But one has yet to work out a testable theoretical framework for the ordering of observations about group fantasies in connection with the development of groups. (Elias 1994: XXXVI) Knowledge develops according to the weight that those experiences acquire if they are made in the first stage of life, childhood, influencing development at subsequent stages. «But one has yet to work out a testable 18 Like charisma cannot be understood if observed just as an individual phenomenon, also stigmatization doesn’t concern just the individual. It is connected to the fact how individuals show a deep aversion to other people and how this is related to the formation of a real «prejudice». However it is interesting to analyze the relationship between group stigmatization and individual prejudice, unveiling how the uneven power balance and the relative tensions within figurations is central in the process of stigmatization. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 115 Angela Perulli DOI: 10.1400/228745 theoretical framework for the ordering of observations about group fantasies in connection with the development of groups» (ibid.). In other words, we must ensure that sociology takes possession of issues left to the exclusive realm of other disciplines, in particular psychology. We must overcome the dualism that sees the individual set against society, and psychology set against sociology. In this reconstruction, we have seen on the one side a kind of «trivialization» of charisma - both in the sense that it is finally released from the aura of mysticism which characterized it for a long time, and also in the sense that it has become attributable in part to ordinary people solely because they belong to certain social groups. But on the other side, we have seen that the effects of group charisma are anything other than banal. And it is the reminder of the relational components of social life that can show the full extent of the effects of acquisition and maintenance of a position within a group endowed with charisma. Elias transforms group charisma and disgrace into heuristic categories which can be applied to a broad range of sociological analysis, particularly regarding the interpretation of the relational dynamics between individuals and groups, of the production and re-production of social inequalities. They are categories which must be understood by observing their mutual influence, their links and interpenetration. The criticism of Weber’s category of charisma, therefore, is far from being a call for the abandonment of this concept for the sociological discipline, but is rather presented as an opportunity to re-launch, and in a certain sense, strengthen it. References: Bendix R. (1960), Max Weber. An Intellectual Portrait, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1977. Brinkgreve C. (2004), Elias on Gender Relations:The Changing Balance of Power between the Sex, in S. Loyal, S. Quilley (2004, eds), The Sociology of Norbert Elias, Cambridge: Cambridge University Press: 142-154. Cavalli L. (1981), Il capo carismatico, Bologna: il Mulino. Corigliano E. (2001), Emozioni al lavoro, Roma: Carocci. Dunning E. (2004), Aspects of Figurational Dynamics of Racial Stratification: A Conceptual Discussion and Developmental Analysis of Black-white Relations in the United States, in S. Loyal, S. Quilley (2004, eds), The Sociology of Norbert Elias, Cambridge: Cambridge University Press:75-94. Eisenstadt (1968, ed.), MaxWeber. On Charisma and Institution Building, Chicago, The University of Chiacago Press. Elias N. (1987), The Changing Balance of Power Between the Sexes, in «Theory, Culture and Society», 4, 2-3: 287-316. Elias N. (1983), The Court Society, Oxford: Blackwell. Elias N. (1987), Involvement and Detachment, London: Blackwel. Elias N. (1991), The Society of Individuals, New York, London: Basil Blackwell. Elias N. (1994), Reflections on a Life, Cambridge: Polity Press. Elias N. (1994), The Civilizing Process, Oxford: Blackwell. Elias N. (1996), The Germans. Power and Struggles and the New Development of Habitus in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge: Polity Press. Elias N. (2007), The Genesis of Naval Profession, Dublin: UCD Press. Elias N. (2008), The Charismatic Ruler, in Essays. On Civilising Processes, State Formation and National Identity, vol. II, 116 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228745 Angela Perulli Dublin: UCD Press. Elias N. (2009), Group Charisma and Group Disgrace, in Essays. On Sociology and the Humanities, vol. III, edit by R. Kilminster and S. Mennell, Dublin: UCD Press. Elias N., J. L. Scotson (1994), The Established and the Outsiders, London: Sage Publications Ltd. Giovannini P., Perulli A. (2012), Living and Surviving. For an Eliasian Theory of Human Beings Acting in the Nuclear Age, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 3: 137-149, DOI: 10.1400/202885. Heiland H.G., Ludemann C. (1991), Configurazioni di potere e conseguenze non pianificate dell’azione, in «Rassegna Italiana di sociologia», XXXII, 4: 443-463. Heinich N. (1997), La sociologie de Norbert Elias, Paris: La Decouverte. Loyal S. (2004), Elias on Class and Stratification, in S. Loyal, S. Quilley (2004, eds), The Sociology of Norbert Elias, Cambridge: Cambridge University Press: 122-141. Mennel S. (1992), N. Elias. An Introduction, London: Blackwell. Perulli A. (2011), Beyond Dichotomous Thinking. The Society of Individuals, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», 1: 6-22, ISSN 2239-1118. Sennett R. (1974), The Fall of Public Man, Cambridge: Cambridge University Press; ed. it. Il declino dell’uomo pubblico, Milano: Bruno Mondadori, 2006. Van Krieken R. (1998), Norbert Elias, London: Routledge. Weber M. (1993), Sociology of Religions, Boston: Beakon Press. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 117 118 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228746 Norbert Elias [Lo Stato Giano Bifronte] Traduzione di Angela Perulli Ludes: Ha detto che lo Stato è un Giano Bifronte, che in certe condizioni serve da cornice a un lungo e continuo processo di pacificazione, e che in altre condizioni può costituire lo strumento attraverso il quale si compie una rottura nella civilizzazione, un ritorno alla barbarie1. Ma nel suo libro Il processo di civilizzazione metteva maggiormente l’accento sul ruolo dello Stato come monopolizzatore della forza fisica, che conduce a un decremento della violenza fisica. Così, in un certo senso, enfatizzava maggiormente una delle due facce del Giano. Ma le esperienze del XX secolo - principalmente nella Germania Nazista, in Unione Sovietica o nei paesi dell’America Latina – non mostrano che il pericolo potrebbe venire proprio dal lato dello Stato, che il terrorismo di Stato diventi più violento e costi più vite rispetto agli atti violenti di individui o gruppi all’interno di società meno altamente organizzate, in cui non sia stato stabilito il monopolio della forza legittima da parte dello Stato? Nel mio libro non enfatizzavo questo. Ero solo interessato al problema di come in uno Stato fosse possibile il controllo della violenza. Penso sia una questione legittima, un problema sul quale si debba investigare: come sono possibili gli avanzamenti nei livelli di civilizzazione? La sua domanda mi trasmette la preoccupazione saliente della sua generazione: il suo nome è Hitler. Mi chiede: e Hitler? Non mi chiede come è possibile che Hitler non sia più lì. Hitler avrebbe potuto vincere? Non è caratteristico del nostro secolo che ci sia oggi una Germania libera da Hitler? Esiste una ragione per pensare che il nostro secolo sia più violento di altri perché c’è stata una enorme vampata, davvero da spiegare e non ancora pienamente spiegata? Il fatto che il fenomeno Hitler non sia stato ancora pienamente compreso, rappresenta, credo, una delle grandi lacune delle nostre scienze sociali2. Ludes: Ma non crede ci sia stata molta più violenza, molti più assassinii nel XX secolo in Germania e in Russia che non nei due secoli precedenti? Se così fosse, dovremmo porci il problema del perché di tali esplosioni. Ma dovremmo anche chiederci come mai gran parte del mondo abbia cospirato per farle cadere e perché ci sia riuscita. Piccone: Ma Brezhnev è sempre lì3. Brezhnev, Stalin – non sono stati rovesciati. Stalin era violento almeno quanto Hitler, se non di più e i suoi successori sono ancora al potere. Non metterei Stalin e Brezhnev più o meno allo stesso livello. Penso che questioni di questo tipo abbiano un carattere emozionale, rispetto alle quali non ho né un particolare desiderio di rispondere né particolari capacità per farlo. Anche rispetto a Stalin, porrei la questione di come si possa spiegare il fatto che egli assassinò così tante persone, che lasciò patire la fame a così tanti contadini. Muovere un’accusa non è sufficiente. E’ necessario investigare. Allo stesso tempo, vorrei realmente avere una spiegazione del perché in America Latina esistano così tanti regimi para-fascisti. Perché non si riesce a fronteggiarli? Possiamo dare una risposta solo avendo una chiara idea di quali condizioni rendano possibili i sistemi multipartitici, nei quali gli oppositori politici non si uccidono l’un l’altro. Cerco di essere più chiaro. ———— Quella che qui presentiamo è la traduzione italiana di una parte della discussione tenutasi a Bloomington, Indiana, il 25 aprile 1982 tra Norbert Elias, Peter Ludes, Franklin Adler e Paul Piccone e pubblicata per la prima volta in The Collected Works, vol 17, Dublin: University College Dublin Press. © 2013 Norbert Elias Foundation, Amsterdam. Desideriamo ringraziare i colleghi del Norbert Elias Stitching per il permesso di tradurre e pubblicare questo scritto in CAMBIO [ndt]. 1 Elias fa questa affermazione in risposta a una precedente domanda, nella parte di conversazione non inclusa in questo estratto. [ndc] 2 Questa intervista ebbe luogo 7 anni prima della pubblicazione del maggior contributo dato da Elias alla comprensione del «fenomeno Hitler». Vedi Elias, I tedeschi, apparso per la prima volta in Germania nel 1989 [ndc]. 3 Leonid Brezhnev (1906-1982), Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, e di fatto capo di Stato e capo del governo dell’URSS, 1964-1982 [ndc]. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 119 Norbert Elias DOI: 10.1400/228746 Di fatto, noi viviamo in un secolo meraviglioso, perché questa cosa incredibile, questa pianta fragile che chiamiamo democrazia è fiorita – che vuol dire che gli oppositori politici possono vivere insieme e avere standard comuni che permettono persino di cambiare governo in base a certe norme. E’ un sistema talmente difficile da mantenere da far considerare una sua scomparsa del tutto possibile. Perché le dittature sono sistemi più semplici: sono sistemi relativamente più primitivi. C’è un uomo al vertice, tutti gli altri obbediscono. Ciò che chiamiamo sistemi multipartitici – le democrazie – sono difficili da mantenere, ma se affrontiamo tali problemi con un atteggiamento emozionale partigiano non abbiamo alcuna possibilità di aiutare i sistemi multipartitici ad andare avanti in quei (relativamente) pochi paesi avanzati in cui esistono. Questo è realmente il problema: come possiamo rendere più sicuro di quanto non sia oggi il fatto che i sistemi multipartitici dove gli oppositori politici non si uccidono l’un l’altro possano continuare ad esistere? E la sua domanda, in altre parole, trova risposta nel seguente modo: non vede quanto miracoloso sia il fatto che questo tipo di sistema si possa mantenere in una serie di paesi? Il nostro compito come sociologi è di affermare con molta più forza quali siano le condizioni che renderebbero possibile il suo affermarsi in altri paesi. Perché, ad esempio, sia così difficile per un tale sistema affermarsi in molti paesi dell’Africa. Dunque, perché non inverte la sua domanda, perché non chiede: non è strabiliante quanti siano oggi gli stati relativamente non violenti? Ludes: No, non penso. Se si guarda al XX secolo, e se legge per esempio Solzhenitsyn4, si rimane sbigottiti di fronte al fatto che nel XX secolo fosse possibile che venissero assassinate più persone rispetto ai secoli XIX e XVIII. Sebbene lei, per esempio, sottolinei il fatto che c’è una diminuzione … Il mio interrogativo non è questo. Nel XVII e XVIII secolo, non vennero uccise molte persone perché si avevano delle monarchie assolute; e noi non vogliamo avere come garanti della non violenza né monarchie assolute né dittature. Lei suggerisce in realtà un ritorno a una qualche forma di assolutismo. Ludes: Certamente no. Ma questa è una risposta alle nostre questioni. Lei vorrebbe dire che nel XX secolo ci sarebbe stata più violenza perché, tra le altre cose, vi era un potere meno assoluto; perché i detentori del potere erano meno minacciati e dunque usavano più violenza per difendere le proprie posizioni, posizioni che erano piuttosto fragili rispetto ai secoli precedenti? Penso che la sua domanda sia tendenziosa. Non mi è chiaro se vi fosse più violenza sotto il regime bolscevico rispetto a quello dello Zar. Certamente quest’ultimo era un regime piuttosto violento, in cui prosperavano servitù della gleba e altre cose. Perciò non condivido i suoi parametri. La servitù della gleba in Russia non c’è più. Quando afferma che c’era meno violenza nel XVIII o XIX secolo lei offre un quadro fortemente fuorviante, perché anche nella vita quotidiana dei nobili, dato che avevano più potere, c’era probabilmente molto spesso più violenza verso gli altri strati. Ludes: Può approfondire la sua definizione della nozione di Stato? La distingue dalle monarchie assolute, ha detto che ci possono essere delle dittature, che ci può essere un sistema multipartitico, e che la caratteristica principale dello Stato è certamente il monopolio della violenza fisica. Può chiarire cos’altro pensa sia caratteristico dello Stato? Penso, e l’ho spiegato chiaramente ne «Il processo di civilizzazione», che esso debba essere visto come un grande passo avanti nell’organizzazione degli esseri umani – un cambiamento tecnico, socio-tecnico: persone che vivono insieme sotto un governo centrale dotato di risorse di potere centralizzate sia sul monopolio della forza fisica che sulla tassazione. Forza fisica e tassazione sono inseparabili. Ma questo – il possesso e l’amministrazione di tali monopoli centralizzati- può essere privo di controllo o al contrario controllato dai governati. E ancora, il fatto che l’amministrazione centrale di questi monopoli arrivi ad essere sottoposta a un qualche controllo dei governati rappresenta un enorme passo avanti.Temo che non si tenga conto di quanto siamo fortunati: solo coloro che sanno cosa vuol dire vivere sotto una monarchia assoluta possono sapere quanto il non vivere sotto di essa sia uno stato di grazia. D’altra parte, così come Marx aveva sottolineato che a un certo stadio le classi borghesi erano ciò che egli definiva progressive, così in una certa misura lo sviluppo verso lo Stato assoluto aveva a quei tempi una funzione progressiva, poiché nei fatti rappresentava una notevole pacificazione, un avanzamento nella pacificazione. Ma 4 Alexaner Solzhenitsyn (1918-2008), scrittore e dissidente sovietico sotto il Comunismo, vincitore del Nobel per la letteratura nel 1970 [ndc]. 120 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228746 Norbert Elias poi è necessario andare oltre e smantellare tale controllo, portare coloro che hanno il monopolio del potere fisico sotto il controllo della massa dei governati. Ora io non penso assolutamente che questa norma così come la conosciamo oggi - ovvero la tutela che si riceve attraverso il fatto che un partito debba competere con altri partiti per ottenere i voti - sia la forma finale ed ultima della democrazia: non penso niente del genere. Ma ritengo che questa invenzione socio-tecnica rappresenti un meraviglioso progresso rispetto all’autocrazia monarchica del signore assoluto. Così dobbiamo lavorare - nei suoi termini Signor Ludes - per ulteriori «alternative» allo Stato multipartitico, ma credo si dimentichi quanto sia una conquista fragile, con quanta facilità uno Stato multipartitico possa ritornare alla forma di uno Stato a partito unico. E’ un pericolo che si deve sempre tenere a mente. Ma d’altra parte dovremmo essere consapevoli della nostra fortuna e tenerla sempre presente; non limitarsi a pensare semplicemente in che tempi terribili viviamo mentre di fatto viviamo in questa forma assai avanzata di Stato multipartitico. Le sue domande sono sempre formulate come se questo non fosse un enorme vantaggio rispetto alle generazioni precedenti. Ludes: Vede anche altre innovazioni socio-tecniche oltre allo Stato che favoriscano il processo di civilizzazione e la diminuzione della violenza? No, no. Adler: Che pensa del mercato? Che non sia possibile senza la protezione dello Stato. Il pacifico scambio di beni sul mercato non è possibile senza il monopolio della forza fisica. Questo è ciò che differenza la mia teoria da quella marxiana. Adler: Eppure i mercati si sono sviluppati nelle città medievali prima che divenissero Stati nazione. Sì, ha ragione a porre la questione. Lei parla di Stati nazione, ma essi non si sono sviluppati prima di essere Stati. Infatti, può investigare in dettaglio i meccanismi con i quali i mercanti portavano le proprie merci al mercato cercando di ottenere protezione dagli Stati attraverso i quali dovevano transitare - dalle autorità degli Stati. Senza ciò nell’epoca medievale, nessun mercato sarebbe stato possibile. Adler: Ma tali città erano autonome dal potere statale dato che erano abilitate giuridicamente a sviluppare le proprie leggi, a sviluppare certi princìpi operanti solo nelle città, e non nelle zone rurali. Erano città-stato. Esse stesse avevano il carattere dello Stato con il loro monopolio del potere fisico e delle tasse. Erano città-stato, e può ben chiedere perché, in particolare nell’impero Romano, le città-stato mantenessero una certa autonomia rispetto ai principi e agli imperatori. Solo perché vivevano come stati erano in grado di negoziare con autorità la possibilità di portare le proprie merci in mercati lontani con gli altri stati, e potevano riportare indietro il denaro senza essere derubati. Norimberga, Regensburg, Firenze, erano tutte città-stato. Ludes: Così vorrebbe dire che ciò altri chiamerebbero invenzioni socio-tecniche, come il mercato, i gruppi religiosi, o l’istruzione, non avrebbero potuto avere luogo all’interno di società statali di tipo diverso? Penso che teoricamente si abbia una visione unilaterale attraverso la quale le strutture economiche sono considerate indipendentemente da ciò che oggi chiamiamo «strutture politiche» o «strutture statali» (sebbene personalmente non uso quei termini). Ma non è possibile. Fin dall’inizio, si possono vedere mercanti [poter commerciare attraverso certe distanze] solo in connessione con lo sviluppo degli stati. Che si tratti dell’antica Sumer, dell’Egitto, di Roma o di altro. Nei nostri argomenti questo viene dimenticato per determinate ragioni. Ciò non significa che io adori lo Stato: siamo lontani. Non significa che io sia «a favore» dello Stato. Sono semplicemente uno scienziato sociale le cui affermazioni devono semplicemente basarsi sui risultati delle proprie ricerche. E lì io credo si sia sottostimata l’importanza dello Stato. E penso anche che in termini politici agiremmo più realisticamente se prendessimo in considerazione i problemi del monopolio della violenza e della tassazione. Ludes: Voglio citarle un brano di una intervista che rilasciò nel 1974 a Le Nouvel Observateur … Oh! I mei peccati tornano a me Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 121 Norbert Elias DOI: 10.1400/228746 Ludes: … che è stata tradotta in «Theory and Society». Cito dalla traduzione inglese: «siamo dei bambini rispetto ai nostri predecessori. Parlo, ovviamente, di violenza tra persone private, all’interno delle società, non di violenza tra stati, che è cambiata enormemente da quando scienza e tecnologia e la mobilitazione delle masse l’hanno dotata di mezzi giganteschi». La mia domanda è se si abbia bisogno di ri-comprendere e ridefinire il concetto di violenza. La violenza non ha un significato diverso nel XX sec. rispetto al Medio Evo, o al XVII e XVIII secolo? Intende dire che ha un significato diverso o che è diversa? Ludes: Entrambe - E se prendiamo in considerazione queste differenti esperienze, possiamo allora parlare oggi di diminuzione della violenza? Non è piuttosto un cambiamento, ad esempio, nella terminologia? Sì. E se si nega, credo sia in gran parte dovuto all’ignoranza. La maggior parte delle persone della nostra epoca è semplicemente incapace di immaginare come ci si possa sentire a vivere in una città medievale. Esse semplicemente muovono dal sentimento di quanto sia terribilmente violenta la nostra epoca, e traducono tale sentimento nella convinzione che nessuna epoca possa essere stata così cattiva come la nostra. E poiché non hanno nessuna conoscenza reale di come fosse nei periodi precedenti - si difetta di conoscenza storica - questo sentimento, di quanto sia terribilmente violenta la nostra epoca, si traduce nella affermazione: questa è decisamente l’epoca più violenta, non c’è mai stata prima una violenza analoga a quella odierna. A causa di questo sentimento-pensiero, oggi dominante, è molto difficile, molto raro, trovare persone, anche scienziati sociali, che tenendo sotto controllo il proprio sentimento e il proprio pensiero, vadano sobriamente ai fatti, adattando ad essi le proprie idee. Così, se mi chiede se la nostra esperienza di violenza sia diversa da quella del Medioevo, la mia risposta è: sì. Mai prima così tante persone hanno avuto una così alta soglia di sensibilità in relazione agli atti violenti, atti di violenza fisica, come nel nostro tempo. Mai prima le persone sono state così sensibili agli atti di violenza fisica come nel nostro tempo. Questo è ciò che ritengo, e ciò che le mie conoscenze mi dicono. Ludes: Abbiamo appena sottolineato che nel XX secolo ci sono nuovi tipi di violenza, e che il compito delle generazione attuale sia quello di diminuire quello specifico tipo di violenza. Non siamo più nella situazione del Medio Evo, dove uno specifico tipo di violenza era minacciare le vite di concreti esseri umani. Noi oggi siamo di fronte a problemi diversi, e come possiamo affrontarli? Questa è la nostra domanda. Sono in disaccordo con lei quando dice che non viviamo più nel Medio Evo. Penso infatti che noi viviamo nel Medio Evo, siamo meno lontani da esso di quanto potrebbe sembrare. E ciò che è accaduto nel Medio Evo ci riguarda. Questa sorta di fiero atteggiamento, secondo il quale oggi nel XX secolo ciò che è accaduto nei secoli XIII e XIV non ci riguardi più - ci preoccupa molto se vogliamo vedere lo sviluppo dell’andamento violento. Ludes: Sono completamente d’accordo, ma questo non … Quindi non dica con una tale disprezzo che non viviamo più nel Medio Evo … Adler: Ma in alcuni casi, per esempio nell’Europa Occidentale, si può parlare di una certa tensione tra Stato e società civile, così che a un certo punto - nel XIX, nel XX secolo - la società civile possa almeno essersi differenziata dallo Stato. Nei paesi del Terzo Mondo, o nell’Europa Orientale, non c’è mai stata la reale opportunità per la società civile di autonomizzarsi relativamente dallo Stato, con l’eccezione della Polonia. La precisione dell’espressione società civile non mi soddisfa. E’ un espressione del XVIII secolo5. Ciò che si aveva a quei tempi era stratificazione sociale – e cioè accessi ad opera dei differenti strati al centro di quella monopolizzazione del potere. Ciò che si ha attualmente è un piccolo accesso della borghesia e della classe operaia ai monopoli centrali attraverso i proprietari terrieri agrari. Adler: Mi faccia essere più preciso. Quando parlo di distinzione tra Stato e società civile, intendo anche la distinzione tra pubblico e privato. E con ciò intendo che nell’Europa occidentale si ha uno senso del privato molto sviluppato - qualcosa che 5 L’idea di «società civile» emerse nel XVIII secolo. Il termine è tornato in auge verso la fine del XX secolo e gli inizi del XXI quando i promotori del «Washington consensus» lo hanno usato in occasione dell’opposizione ideologica allo Stato. Più o meno in contemporanea è ricomparso nel discorso sociologico come quasi sinonimo di ciò che J. Habermas ha definito «sfera pubblica». Vedi Habermas (1962). 122 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228746 Norbert Elias non è pubblico, qualcosa che è diverso dal pubblico - che è molto diverso dall’Europa orientale o dal Terzo Mondo. Non direi che questo sia più preciso. E’ un’imprecisione equiparare la relazione tra società civile e Stato alla distinzione tra privato e pubblico. Penso che si collochino su dimensioni diverse. Ciò che chiamiamo società civile è solitamente una società borghese in relazione alla società dominata dall’aristocrazia. E’ soltanto un’espressione filosofica per indicare qualcosa che sociologicamente possiamo determinare assai più precisamente. La distinzione tra pubblico e privato è di per sé in larga misura una distinzione di tipo borghese. E’ assai meno reale, ad esempio, nelle società di corte (cfr. Elias 1969, ndc). Adler: Ma non è divenuta universale come risultato delle rivoluzioni borghesi? Potrebbe essere proprio la borghesia ad essere emersa come classe sociale … Intende l’abolizione delle corti dalle vincenti rivoluzioni borghesi? Adler: Sì Sì, è così. Adler: Ma allora possiamo parlare di società nelle quali il senso del privato diventa un fenomeno generalizzato come opposto a quelle società nelle quali la nozione del privato semplicemente non è mai nata da una classe sociale, dove non c’è una rivoluzione borghese, e perciò non è mai stata generalizzata. Così possiamo sociologicamente distinguere le società, almeno, sulla base … Possiamo distinguere in termini generali, non solo rispetto a un aspetto, una società pre-statale da una società statale. Voglio dire [possiamo, per esempio, distinguere] una società pre-statale africana da una società statale, o una società statale ai primi stadi di sviluppo - come lo Stato nigeriano - da una società statale unificata altamente sviluppata. Tutto ciò può essere fatto con una grande precisione. Adler: Stavo cercando di spostare la discussione su un aspetto diverso … L’ho notato. Adler: Ciò che intendevo con «società civile» e «privato» erano mutamenti che emergono da una società come controllo sulle tendenze centralizzanti dello Stato. E’ sempre una questione del potere all’interno dello Stato. Ciò che lei chiama società civile, che vuole affermare come agenzia non statale - queste sono tutte nozioni di una epoca precedente. Adler: Quindi per essere precisi, secondo lei, la distinzione tra società civile e Stato è priva di senso E’ ideologica. Piccone: Ma in tal caso, come affronterebbe il caso di istituzioni come Solidarność6 o la chiesa cattolica in Polonia, la cui principale funzione è chiaramente quella di fornire uno scudo alle persone che si oppongono allo Stato? Come li affronterebbe nei termini della sua analisi? Ho sempre pensato che all’interno dello Stato possano esserci forze che si oppongono alla attuale distribuzione del potere al suo interno, ma tali forze sono esse stesse tese a affermarsi o ad avere un peso maggiore nella gestione di tali monopoli centrali del potere. Il caso Solidarność è abbastanza chiaro: ciò che volevano era un maggiore accesso ai mezzi di comunicazione monopolizzati dallo Stato. Così come Lenin voleva alla fine occupare i monopoli statali - era lo scopo della rivoluzione. Il fatto che Marx avesse dato allo Stato la mera funzione di una sovrastruttura nasconde il fatto che la rivoluzione fosse tesa a occupare i monopoli centrali dello Stato da parte dei rivoluzionari e ad avere un esercito. Lo stesso vale per Solidarność. Piccone: Ma, ad esempio di fronte ai mass media, Solidarność stava semplicemente chiedendo allo Stato di fare un passo 6 Solidarność era un’organizzazione sindacale polacca emersa dagli scioperi del 1980 nei cantieri Gdansk sotto la leadership di Lech Walesa e, finanziata clandestinamente dagli USA, che si sviluppo negli anni ’80 in un movimento indipendente più generale in e di opposizione al governo comunista polacco [ndc]. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 123 Norbert Elias DOI: 10.1400/228746 indietro. Gettarsi alle spalle lo Stato di oggi - ma per guadagnare a proprio vantaggio una quota maggiore del potere che il governo guadagna dalla sua gestione dei monopoli centrali dello Stato. Voleva diventare una delle agenzie centrali dello Stato, che nei momenti di transizione significa sbarazzarsi del controllo dello Stato attuale. Piccone: O indebolirlo … Si, diminuirlo. Ma allora, fintanto che il monopolio era così forte, significava estendersi al di fuori del monopolio. Nel lungo periodo significava diventare esso stesso il sindacato centrale del popolo polacco. Significava avere il monopolio dell’organizzazione sindacale nell’intera Polonia. Essi volevano il monopolio di tale organizzazione della Polonia intera. Piccone: Mi pare che ci sia una enorme differenza tra, ad esempio, la situazione di collettivismo burocratico dell’Est, nella quale lo Stato penetra direttamente in ogni istituzione, e una situazione in cui si ha di fatto uno Stato corporativo. In uno Stato corporativo ci sono istituzioni autonome relativamente indipendenti che lo Stato coordina e regola solo successivamente. Per quanto ne ho discusso con amici e colleghi polacchi, a loro piacerebbe un regime più pluralistico nel quale il sindacato sia uno dei corpi con eguali potenzialità di potere. Che significa che loro e nessun altro avrebbero potuto organizzare il lavoro del sindacato. Avrebbero voluto essere fuori dal governo ma esercitando continuamente pressioni su di esso, senza che il governo stesso potesse interferire. Così si sarebbe trattato di un movimento non verso un controllo più pluralistico dei monopoli centrali del potere, essi stessi lo vedono - e io non sono in disaccordo - come un passo oltre i mezzi attuali per contrastare i pericoli del centralismo. Un nuovo tipo di istituzione emergerebbe dalla Polonia, è questo ciò che immaginavano. La Polonia diventerebbe la pioniera di un nuovo tipo di società: non rinuncerebbe al comunismo, ma priverebbe il comunismo del suo carattere non pluralistico. Piccone: Ma dato questo tipo di analisi, perché rifiuta di considerare le istituzioni quali Solidarność, la Chiesa o i mezzi di comunicazione in termini di società civile? La questione sembra essere puramente terminologica. Forse non proprio terminologica. Chi è la «società civile»? Che cosa è? Piccone: Bene, c’è una differenza tra lo Stato come autorità centralizzata e quelle persone che sono assoggettate all’autorità centrale. Possiamo differenziare l’uno come Stato e quelle persone controllate dallo Stato come società civile. Disporre di una tipologia non è abbastanza: qua la società civile, là lo Stato. Si deve anche parlare del loro equilibrio di potere. Piccone: Certamente. Certamente, lei dice, certamente. Allora, quali sono le risorse di potere di ciò che lei chiama società civile? Piccone: Il volere autonomo delle persone … Non posso ulteriormente ragionare in termini così ideologici … Piccone: Va bene, usiamo altri termini. Chiamiamola soggettività, chiamiamolo sistema di bisogni delle persone. Non è una risorse di potere, la soggettività delle persone. E’ un’espressione vaga. Ludes: Nel caso della Polonia, la solidarietà dei lavoratori che possono controllare … Quella è un’organizzazione. Ma individui liberamente fluttuanti dotati di un proprio volere, che si coordinano forse con una volontà collettiva - questi sono concetti appartenenti a un’epoca passata che oggi non si possono più adoperare. Adler: Nei termini del suo linguaggio scientifico, come si riferisce a questi altri, a coloro che non sono all’interno dello Stato? 124 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228746 Norbert Elias Chi sono questi altri? Piccone: Questi soggetti, la gente, le masse … Non vedo alcun essere umano vivere al di fuori del regno dello Stato. Non li vedo. Può definirli chiaramente classe media, classe operaia … Adler: Posso parlare di collettività che non sono direttamente legate agli apparati statali. Non li vedo. Pagano le tasse, la loro sicurezza dipende dallo Stato. Adler: Ma in termini di controllo sulle decisioni che riguardano la loro organizzazione interna, la loro attività, non ci si può riferire ad esse come facenti parte dello Stato. Certamente possiamo riferirci a loro in questi termini. Ogni momento, come ho detto, esse pagano tasse [allo Stato], la loro sicurezza [è fornito dallo Stato], le loro organizzazioni di affari operano all’interno delle cornice legale dello Stato, i loro denari sono coniati dallo Stato - come può pensare che siano in un qualunque modo indipendenti? Adler: Userei la distinzione che essi sono all’interno dello Stato ma non dello Stato. Frase carina, ma … Adler: No, le dico perché, con precisione terminologica: senza avere alcun concetto di attività e forze non statali, non è possibile distinguere sociologicamente tra i sistemi dell’Europa orientale e i sistemi pluralistici occidentali. Traduciamolo concretamente. Prendiamo in considerazione un uomo che conduce i propri affari o lavora in un fabbrica, come ho detto, i soldi che possiede, le tasse che paga, lo rendono parte di uno Stato. Le scuole dei suoi figli vengono organizzate dallo Stato … Adler: Ma consideri un imprenditore occidentale, che possiede la propria fabbrica, e consideri anche un dirigente dell’Europa orientale. Lei è certamente consapevole dell’enorme grado di autonomia del primo … Certamente. Ma ciò non significa che non ci sia alcun livello decisionale superiore, e questo è ciò per cui le classi medie hanno lottato, la propria decisione sulla propria fabbrica. Adler: Come lo chiama? Sociologicamente, quali termini ha per descriverlo? Non lo vedo come esterno allo Stato. Il termine che uso attualmente è «società statale». Certamente non è lo Stato. L’intero insieme è formato da esseri umani - è un’organizzazione di esseri umani. E questo tipo di organizzazione lascia qua e là spazi, più o meno grandi, alle decisioni individuali delle persone. Ma non è un punto zero, in cui essi siano indipendenti dalla sovrastante organizzazione della società statale. Infatti, a ben vedere, i sociologi hanno sempre compiuto un errore usando il termine stesso di «società (cfr. Elias 1, cap.8, ndc). Lo hanno sempre [usato per intendere] società che hanno il carattere dello Stato. Si ha solo la società francese, la società tedesca, la società svedese - che sono tutte società organizzate in forma di Stato. Al suo interno, naturalmente, si può decidere per se stessi se avere questo o quell’arredo. E i denari coniati sono coniati dallo Stato, lei non può decidere su questo - può [solo] prenderli e così trovarsi in relazione funzionale con lo Stato. Se il valore del denaro diminuisce, anche il valore delle monete che ha in tasca diminuisce. Così attraverso queste catene invisibili si è legati gli uni agli altri, a dispetto del fatto che in certe aree si disponga di un ambito più o meno grande per le decisioni individuali. Non c’è alcuna contraddizione. Adler: No, ma penso solo che, sociologicamente parlando, un tale concetto dello Stato sia così vasto, così monolitico da non permetterci di compiere distinzioni comparative più specifiche Questo solo perché lei immagina una Stato fascista, uno Stato organizzato in modo tale in cui tutte le decisioni siano dirette dal centro. Ho deliberatamente affermato che lo Stato britannico è uno Stato. C’è, certamente, una grande difficoltà per quanto riguarda gli USA, perché il significato del termine «Stato» in America è qualcosa di Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 125 Norbert Elias DOI: 10.1400/228746 diverso dall’Europa. Molte persone non realizzano che gli Stati Uniti siano, dopo tutto, uno Stato unificato. Così molte persone in America sono solo consapevoli di una specifica amministrazione, ma non sono concettualmente consapevoli di appartenere a uno Stato unificato. Riferimenti bibliografici Elias N. (1969), The Court Society, Collected Works, vol. 2, Dublin: UCD Press, 2006 [ed. it. La società di corte, Bologna: il Mulino, 2010]. Elias N. (1970), What is Sociology?, Collected Works, vol. 15, Dublin: UCD Press, 2012 [ed. it. Che cos’è la sociologia?, Torino: Rosenberg & Sellier, 2000]. Elias N. (1989), Studies on Germans, Collected Works, vol. 11, Dublin: UCD Press, 2013 [ed. it. I tedeschi, Bologna: il Mulino, 1991]. Elias N. (2013), Interviews and Autobiographical Reflections, Collected Works, vol. 19, Dublin: UCD Press. Habermas J. (1962), The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquire into a Category of Bourgeois Society, Cambridge Ma.: MIT Press, 1989. 126 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Essays and researches Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 127 128 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Vanesa Lio DOI: 10.1400/228747 [The Urban Panopticon] Abstract: In recent years, the use of closed circuit television (cctv) for surveillance, historically restricted to the private sector, has shown a shift towards the public sector, being implemented in the framework of public policies on crime prevention and social control. This paper analyzes how the presence of video cameras and the diffusion of its images through the mass media impact on the construction of a particular geography of the city and its inhabitants. Keywords: Social control, CCTV, Surveillance, Panopticon. Introduction Since the beginning of the new century, the battle against crime has become central to Latin America policy agendas and political campaigns, both in central and local levels. In 2008, urban safety and crime were considered the main social concern by citizens, for the first time overpassing unemployment (Lagos, Dammert 2012). A survey carried out by Latinobarometro Corporation in 18 Latin American countries indicates that in 2011 28% of the interviewees identified “urban safety and crime” as the most important problem faced by their own country. If the category “violence and gangs” is added, the level increases to 32% (Latinobarómetro 2011). Crime and unemployment have dominated the agenda in Latin America during the last decade; however, they have recently switched their respective places in the agenda. The importance of crime has shown a sustained increase, reaching its highest level in 2011 (one point higher than in 2010) while unemployment has tended to diminish. In 2011, it dropped to 16%, three points lower than in 2010. In this context, politicians’ discourses and practices have been focused on proposals and policies to solve the “insecurity” issue. As a consequence, social control mechanisms aimed at crime prevention were intensified, together with a growth of State interventions in the public spaces, such as increased lighting in streets, squares and parks or the setting of close circuit television (cctv) to monitor the city 24 hours a day. The mechanisms of power that operated within the control institutions during disciplinary societies were recently applied to the whole society and, particularly, public spaces. The intervention on the bodies, turned into «docile bodies» through discipline, extends to all individuals, training them for continuous surveillance (Foucault 1975). In contemporary societies, where crime appears as part of a series of probable events, official answers to this phenomenon involve a cost-benefit analysis. In this regard, management of risks is described as a new and powerful mechanism of control linked to bio-power. A technology of power exercised positively on life (it can be understood as the sole prerogative of the modern nation state to «make live and let die»), management of risks involves precise controls and general regulations of entire populations (Foucault 2006). As a result, the biopolitical apparatus would not aim at penalizing infringements but at controlling hazards. The use of cctv in the urban space leads us, in some way, to the dystopian reality described by George Orwell in 1984, where everything could be seen by Big Brother’s eye. It seems to be, in a socially enlarged scale, the Panopticon of modern disciplinary institutions, which keeps a constant eye on the whole population and, in this way, regulates their actions. «He is seen, but he does not see. (…) Hence the major effect of the Panopticon: to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power» (Foucault 1975: 200-201). By this watchful gaze, the government exerts its power over citizens. Nowadays we can say we are living in the so-called «societies of control»: the crisis of institutions has led us to a type of control applied systematically in ——— The author wishes to thank Prof. Alberto Marradi for his careful and critical reading of this essay. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 129 Vanesa Lio DOI:10.1400/228747 open spaces (Deleuze 1990), with workers in monitoring centers that are able to see, in theory, everything that happens in the city. The cctv systems of La Plata (Monitoreo Público Urbano - MOPU) and Tigre (Centro de Operaciones tigre - COT) reproduce the experiences of large capitals and urban centers from the whole world. This kind of systems are responsible for monitoring public spaces twenty-four hours a day, visualizing and controlling the images captured by cameras distributed all over the city but specially located in places that are considered as the most dangerous ones. These cameras are constantly watched by workers in the monitoring centers that notify the police of the occurrence of accidents, crimes or suspicious events. Since 1980, surveillance has become increasingly globalized, as populations become more mobile and social relations have stretched more elastically over time and space. Mainly in Europe and North America, it expanded with increasing rapidity after computerization from the 1970s onwards. The globalization of surveillance is directly connected with doing things at a distance. We no longer see, let alone know, many with whom we make exchanges or interact. They are geographically apart from us. As social relations are stretched, courtesy of the new communication technologies, so more and more interactions and transactions become abstract and disembodied, which jeopardizes the sorts of trust that once depended upon the face-to-face and the copresent (Lyon 2004: 139). Surveillance has also become much more visible after the events of 11 September 2001. A new range of activities and processes was developed and intensified: what they have in common is that, for whatever reason, people are under scrutiny. Such forms of visibility were new in the twentieth century, for although people have for centuries had to identify themselves or have been under observation, this has usually been for highly specific, limited, purposes and at particular times. Surveillance of all became routine during the twentieth century. Visibility became a social and a political issue in a new way (Lyon 2002: 2). Therefore, cities have been transformed into a huge Panopticon and the «gaze without eyes» has modified the very nature of public spaces. As Koskela argues, the question here is not about crime control but rather about control in a wider sense: «Surveillance has become a mechanism with the aims of guaranteeing purity and the exclusion of feared strangers: “the Other” in a literal as well as metaphorical sense» (2000: 260). Images, news and media How social consensus about the kind of crimes that must warn the public is built? Who decides which facts and people should the gaze focus on? In recent times, a new phenomenon has significantly grown and has become relevant: the public diffusion of certain images captured by the cameras distributed all around the city.This process could be thought as parallel to - or maybe a consequence of - the implementation of CCTV surveillance policies. In the Argentine context, it is nowadays possible to verify that some images - mainly what Cardoso (2012) called the «caught in-the-act surveillance scenes» - are exhibited in the media and circulate through new channels of information. On the one hand, some local governments publish the videos through their web sites and social networks institutional fan-pages. On the other hand - and maybe more importantly - these images have taken an increasingly central role in the mass media. Furthermore, in the Argentine case, the exhibition of the images captured by public monitoring systems has resulted in a special TV show on surveillance cameras being broadcasted. Local authorities and police forces come to be the main information providers; hence, political communication strategies driven by local governments become central. As Ferrer (2005) proposes, media and computer networks can guide our vision and operate as wills to power (voluntades de poder) seeking to establish an overall matrix in which a way of thinking and living is framed and from which the world is presented to us. New visual technologies are increasingly embedded in everyday life. This way, they regulate our will to see, 130 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228747 Vanesa Lio guide our visual attention and show us convenient perspectives. Thus, as Ferrer says, «visible truths that are exposed in this context are not images of the world but a world graspable only in the form of an image» (2005: 29; author translation). Power institutions and authorities have used the visual machine to enhance its momentum and to skew it with a certain ideological intent. «The visual machine is an assembly of lighting knowledge metaphors, institutional and architectural spaces and display technologies, whose articulation reveal an existential space where a period truth is unveiled» (Ferrer 2005: 33; author translation). Consequently, public cctv systems have a direct impact on social life and can be used in order to organize people’s way of life. While it is true that we can access a growing number of images of the city, we are not allowed to get them all: we are just entitled to see a selection made by someone else – the local government, the police or the media. Editors and image designers working for media companies (or the government itself) perform political rather than aesthetic functions. «Controlling perception means to found a political sovereignty» (Ferrer 2005: 116). That has always been the challenge of rulers. The special feature that we can find in contemporary societies, according to Ferrer (2005), is that the individual corrected and tamed body of the panoptic society is being replaced by the collective body of the informational society. In this new context, «what today is referred to as reality should be legitimized and believed as a visible truth» (ivi: 121). Within this process, the surveillance camera could be the current template where contemporary practices of control are inserted. Moreover, video-cameras and monitoring software could be the frame in which the older forms of control are introduced. Adopting a Hobbesian perspective, if there is fear there is potential government: fear and sovereignty are closely related concepts. As the author explains: A commonwealth by acquisition is that where the sovereign power is acquired by force; and it is acquired by force when men singly, or many together by plurality of voices, for fear of death, or bonds, do authorize all the actions of that man, or assembly, that hath their lives and liberty in his power. And this kind of dominion, or sovereignty, differeth from sovereignty by institution only in this, that men who choose their sovereign do it for fear of one another, and not of him whom they institute: but in this case, they subject themselves to him they are afraid of. In both cases they do it for fear: which is to be noted by them that hold all such covenants, as proceed from fear of death or violence, void: which, if it were true, no man in any kind of Commonwealth could be obliged to obedience (Hobbes 1651: 122). Following this way of thinking, we can say that every action a man performs, for fear of the law, is an action which the doer had liberty to omit. «Fear and liberty are consistent (…) So a man sometimes pays his debt only for fear of imprisonment, which, because nobody hindered him from detaining, was the action of a man at liberty» (Hobbes 1651: 129-130). Fear, in the context of this kind of societies, is a key element for domination, control and governance. This perspective gives us an interesting point of view to analyze the particularities of our times: in Latin America, electoral campaigns and political debates are laden by the theme of insecurity. In recent decades, the battle against the phenomenon of urban crime became one of the most used governmentality1 strategies, that is to say, the ensemble formed by institutions, procedures, analyses and reflections through which subjects are governed (Foucault 1997). The discursive battle is focused around the definitions of risk and how to intervene against latent fear in cities. This process is fed, at the same time, by the mass media interventions. The emergence of the phenomenon of insecurity as a key topic in the media does nothing but deepens the potentiality of hazards by staging a series of preventive measures that individuals should take in self-defense, such as driving on well-lit places, providing themselves with monitoring equipment, keeping in constant contact with others or leave nothing to chance. 1 The concept of governmentality «offers a view on power beyond a perspective that centers either on consensus or on violence; it links technologies of the self with technologies of domination, the constitution of the subject to the formation of the state; finally, it helps to differentiate between power and domination» (Lemke 2000: 3). When Foucault analyses the aspects of the formation of a political governmentality, he focuses on «the way in which the behavior of a set of individuals became involved, more and more markedly, in the exercise of sovereign power» (Foucault 1997: 68). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 131 Vanesa Lio DOI:10.1400/228747 At this point, a process of continuous feedback can be observed: «The plausible statements built by newspapers legitimate its sources in this ‘reality’ to which society usually access through the speeches of the same media, that, in time, become sources for other social and institutional discourses» (Martini, Pereyra 2009: 23; author translation). According to constructivist approaches to communication studies, subjects’ knowledge of reality is influenced by the media, as well as the nature of insecurity; the symbolic scheme about order and morality is delimited, determining as well what is right and wrong (Barata 2003). The consideration of the specific places and subjects in which the gaze of the watchers stares is a central component of the analysis. It has been observed that policies on crime control that are implemented by local governments through the monitoring of public spaces focus on minor offenses, specifically aiming to what was defined as «incivilities» (Wilson, Kelling 1982). It is assumed that criminal types of greater impact to safety are those related to property crimes, such as thefts, vandalism and street robberies. The fear does not focus only on the possibility of being a victim of crime but also includes the anxiety about being bothered by «unruly» people. In this sense, these policies aim at increasing the level of law and order in the neighborhoods (Wilson, Kelling 1982). The numerous references in these kind of projects to «dangerous or suspicious situations», together with the wider category of «crimes», inevitably leads us to the question about what the «suspicious circumstances» are and how are they defined by the video-cameras in the public spaces. At the same time, the community plays a key role since its contribution to the fight against crime is considered indispensable. In this way, informal control mechanisms and the interaction of police forces with the local community are strengthened. Whereupon cctv systems seems to recognize two groups of subjects, that are presented as mutually exclusive: on the one hand, criminals or disturbers of public order, on which cameras should focus their attention; on the other hand, neighbors or citizens, whose cooperation is required for these systems to work. The emergence of neoliberalism entailed a rethinking of what it means governing the insecurity. One of the changes that characterize this period is the shift from defending the society to managing focused on the insecurity levels in communities. As a result, local, punctual and situated interventions have emerged (De Marinis 2004). Thus, a heterogeneous mosaic of areas characterized by different levels of security is delineated; each of them requires the implementation of specific policies. The huge growth in cctv coverage has modified the nature and experiences of space, generating the fear of unwatched places: «The more cctv coverage becomes the norm, the more excluded areas will fight to gain coverage» (Graham, 2002: 239). The incorporation of digital and algorithmic techniques enables cctv systems to automatically search for «abnormal» or «unexpected» events, behaviors or even people. By linking digital cctv with image database technology, algorithmic cctv would systematize processes of exclusion and discrimination. Thus, the use of video-surveillance can arguably be said to change the ways in which power is exercised, modify emotional experiences in urban space and affect the ways in which «reality» is conceptualized and understood (Koskela 2000). Two case-studies, one single project The issue of urban is a central element of the agenda setting: «In general, government policies and the media basically centralize the issue of insecurity in the issue of street crime» (Daroqui et alii 2003: 2). The prevalence of this kind of uncertainty and the marginalization of the other kinds can be also perceived through the media’s approach to this subject. «The word insecurity is a signifier that comes from the journalistic discourse on crime, which ended replacing metonymically to crime (...) Other insecurities have become invisible or overlooked» (Martini, Pereyra 2009: 13-14; author translation). In this context, new mechanisms for the surveillance of public spaces emerged as a central instrument to reduce minor crimes.While the installation of cctv was historically restricted to the private sphere, in recent years a shift towards the public sector was the result of situational crime prevention policies (Sozzo 2009). In Argentina, the use of public cctv started during the first decade of this century. The town of Tigre was the 132 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228747 Vanesa Lio first to adopt them as a public policy and nowadays still owns the largest expansion and diffusion of video cameras in urban spaces. Surveillance systems have found the greatest growth within the province of Buenos Aires after the implementation in April 2009 of a security policy (Programa Integral de Protección Ciudadana) that emerged from an agreement signed by the National Government and the Ministry of Security of the province of Buenos Aires. In the context of this arrangement between national and provincial states, cctv has reached our second case-study, i.e. the city of La Plata. The use of technological tools for urban monitoring is particularly widespread in the Province as a response to rising crime and the consequent public concern over this problem. According to the National Criminal Information System, from 1999 to 2003 the number of reported crimes at national level has increased, to remain stable in the following years. In the province of Buenos Aires, registered property crimes and homicides have grown since 1997, also reaching their peak in 2002. As a result – although concern over the issue had been increasing since the early 90s – insecurity has become the first national problem in 2004.However, fear of crime has shown to be relatively independent from actual crime. It tends to grow along with victimization, but once installed as a social problem, it no longer diminishes even if crime rates go down2 (Kessler 2009). In this context, and according to the widespread preventive discourse on security policies evidenced in the same period (Hener, Niszt Acosta 2004), the application of technology in this field has led to new mechanisms of social control. This essay analyzes how the presence of video cameras and the playback of images captured by them in the mass media influence the construction of the particular geography of the city, as well as its inhabitants. We have chosen the cases of Tigre and La Plata for our analysis due to various reasons. With about 370,000 inhabitants, Tigre is a middle-sized town among what is called Greater Buenos Aires3; it has been showing a remarkable growth in the last ten years. It has been a pioneer in implementing video surveillance systems in public space within Argentina. Its municipal monitoring plan was created in March 2008, one year before the launch of the agreement between National State and the province of Buenos Aires referred above. The system has expanded and diversified as any other in the country. Currently the city has 1300 video cameras and has moved towards the integration of public and private cctv systems in the area. It also includes the active participation of the community: the use of cctv is considered as one of the communication axes of the local government. La Plata, capital city of the province of Buenos Aires, has a population of approximately 650,000. The implementation of the cctv in public spaces has been framed in the province-wide programme designed for this purpose. The peculiarity in the case of La Plata is that the geography of the city has been a central aspect of the government’s strategy, defining risky areas from the placement of the video cameras. In the communication level, this element has become particularly relevant during the 2011 campaign, in which the Mayor ran for a new election. Our analysis was developed during the first half of 2011. The corpus included municipal plans and policies on public space video surveillance as well as communicational pieces related to the subject distributed by local governments through two main channels: official websites and social networks. It also included articles published by one nation-wide newspaper and three local media, in their printed and online versions. In order to analyze the spread of the videos captured by security cameras in public spaces, we used as main sources official websites, 2 The usual definition of the expression fear of crime is an emotional response to fear or anxiety in the face of crime, or of symbols that people associate with crime. We prefer what Kessler (2009) described as «a feeling of insecurity», on the premise that although references to fear still play a central role, this concept includes other relevant emotions, like anger, indignation, or impotence, and it includes political concerns, stories about their causes, and the actions that make up insecurity management. In the Argentine context, according to Kessler (2009), the particular characteristic of insecurity is the randomness of danger. Insecurity is described as a threat – to property and especially to human beings – which could swoop down on anyone. 3 Greater Buenos Aires (in Spanish, Gran Buenos Aires; GBA) is the urban agglomeration comprising the 24 municipalities of the province of Buenos Aires that are located close to the Federal Capital, extending southward, westward and northward. It does not constitute a single administrative unit. The «Metropolitan Area of Buenos Aires» (Área Metropolitana Buenos Aires, AMBA), including Buenos Aires City and the Greater Buenos Aires, has reached, according to 2010 National Census, almost 13 million inhabitants, a third of the total population of Argentina. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 133 Vanesa Lio DOI:10.1400/228747 YouTube and Facebook official accounts, and the TV show Cámaras de Seguridad4. We used a non-standard research design, addressing the problem mainly through discourse and document analysis. Quantitative tools were only used in order to control some regularities within the corpus. The extension of video surveillance shows the kind of crimes in which policies on security designed by Buenos Aires Province are focused on. As Governor Daniel Scioli said during the inauguration of a local cctv system in October 2010, the main objective is to «identify hazards with the help of the technological eyes». The attention is concentrated on the «key areas», which are considered as the risky ones.Therefore, the State should «use measures in order to prevent crimes» with the aim of «caring for people’s lives». We shall analyze what is considered as a dangerous situation and where are located the hazards within the city. The intent of controlling youth, targeting drugs and alcohol as major problems, and focusing the attention on situations that «disturb the public order» are some of the elements that allow us to relate these mechanisms to the concept of incivilities described by Wilson and Kelling (1982). On the one side, video cameras are designed to monitor and control entire cities and populations. This fact seems to evidence the end of the division between clearly defined safe and unsafe zones and an extension of distrust towards anyone, reinforcing the feeling of a random and omnipresent threat. However, on the other side, the use of cctv also helps in the identification of the figures of fear: the most stigmatized images are supplied by young people from marginalized groups. Video cameras mostly focus on social groups considered «undisciplined» - a category including beggars, drunks, addicts, rowdy teenagers, prostitutes, homeless and mentally disturbed people. Another interesting concept for our analysis is the one of deviant subjects. According to Becker (1963), deviance is a «publicly labeled wrongdoing». Deviance is always the result of enterprise. Before any act can be viewed as deviant, and before any class of people can be labeled and treated as outsiders for committing the act, someone must have made the rule which defines the act as deviant. Rules are not made automatically. Even though a practice may be harmful in an objective sense to the group in which it occurs, the harm needs to be discovered and pointed out. People must be made to feel that something ought to be done about it. Someone must call the public’s attention to these matters, supply the push necessary to get things done, and direct such energies as are aroused in the proper direction to get a rule created. Deviance is the product of enterprise in the largest sense; without the enterprise required to get rules made, the deviance which consists of breaking the rule could not exist (Becker 1963:162). What is labeled as deviant, and therefore requires more attention from operators in the monitoring centers, is the result of a process of social interaction. For deviance to exist the rule must be previously defined; the latter is always created and applied by someone following its own interest. Then, the State develops mechanisms to respond to the issue recognized as a public problem, while the video cameras seems to construct the image of a normal subject and help install fear inside society. Security is understood, by the Municipality of Tigre, as a right; citizen protection is presented as everyone’s value. In this sense, the official discourses appeal to the active participation of the community, which is given a central role. Several techniques for community involvement are used, aimed at showing a shared responsibility in the fight against crime. Through the official website, the local government stated: «The community of Tigre designed, during the last three years, a local citizen protection system to help the government of the province of Buenos Aires, who is responsible for the safety of its inhabitants». The local government and the residents of Tigre are presented as pairs; both members of the community that created the plan and contributes through its actions with provincial police forces. The municipality provides the network through the installation of cameras, the setting up of a monitoring center, the provision of operators, the purchase of automobiles for patrolling the zone and providing new channels for the citizens to make complaints. Neighbors, meanwhile, are responsible for initiating the flow of information, sending alerts through their POS system in stores, text messages from cell phones, the website of the COT or panic buttons located in buses and schools. 4 Cámaras de Seguridad is a TV programme broadcasted on a weekly basis by the Argentine TV channel América TV since May 2011. For our analysis, we used the five issues of June 2011. 134 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228747 Vanesa Lio Government and citizens are included in the same group, which is assigned a role associated with the State power in the fight against crime. However, it is clear that not all residents are members of the community. There is also a large focus on the description of the citizen as a victim (Calzado 2009), a term that appears always opposed to ‘offender’. Any possibility for the delinquent to be also considered a victim is excluded. The meanings that emerged from this concept refer only to a type of victim, associated to the concept of insecurity as crime that we mentioned above. At the same time, cctv videos broadcasted on TV help to build a certain geography of the city, which is determined by fears, risks and hazards. This construction regulates the use of public spaces, which are classified as safe or unsafe according to the presence or absence of the video cameras. In the case of Tigre, cctv images are distributed both through mass media and Municipality’s own channels: the official web site and the Facebook and Youtube accounts. Among the videos that show thefts, police chases and car crashes, it is also possible to find rather peculiar situations that «disturb the public order», such as the arrest of two young men for carrying a goose in one’s backpack. A newcomer to the city, who decided to bathe himself in a public fountain located at the entrance to the town of Tigre, was shown as adding an element out of place in the desired tourist postcard5. By analyzing the videos spread through mass media, we can find regularities in the style of editing, music composition, subtitles, graphic inscriptions and the use of highlighting tools over the image. This permits us confirming that the municipal government delivers videos already edited and ready for playback. As we mentioned, the public diffusion of images captured by municipal monitoring centers led to the making off of a special TV show, aimed almost exclusively at reproducing the audiovisual material caught by video cameras in public spaces. Only 21.8% of the videos we checked in either towns displayed cases of robberies or thefts on public roads.The rest can be classified as between street fights (21%), drunk people (9.2%), car accidents (7.6%), exhibitionism (6.7%), young people in the night life (3.4%), «suspicious situations» (2.5%), domestic violence (1.7%) and varied situations that can be gathered into the category «other» (21%), among which dissimilar events such as the presence of stray animals, illegal motorcycles races, people doing stencils, graffiti or painting on public walls, fires or people sleeping on the street6. The videos from the Tigre cctv system characterize the subjects and build the urban space around the safeunsafe opposition. On the one hand, an image of a good neighbor who is threatened by crime and committed to citizen participation in surveillance and social control issues is presented. On the other hand, threatening groups from social minorities or marginal areas that must be kept under scrutiny in order to avoid public order disturbances. The unruly and violent offenders are placed on one side. The residents, workers and citizens, on the other. The polarity that characterizes the social roles forces the viewer to decide which side represents him/her: watched or watchmen. The images help build the image of a city and regulate social relations. In the case of La Plata, the plan has been described, from the very beginning, with the aim of monitoring the most conflicting areas of the city. One of the initial axes on which the MOPU was based is the use of security cameras to control institutional or governmental buildings and its surroundings, in order to «keep under observation spaces that remain beyond human capabilities». In addition, the attention of the cameras is focused on the city center. The level of vehicular and pedestrian traffic in these areas turns them into «risky zones» requiring governmental control. Aiming at this objective, commercial corridors were created in La Plata city, giving special attention to «monitoring these consumption places to provide security for sellers and buyers». For the same reason, these corridors are also selected for the installation of emergency devices or anti-panic buttons, which are presented as a complement to surveillance cameras. Following the same line of reasoning, in April 2011 the city council of La Plata adopted the public entertainment, 5 All the videos and texts are available at: www.youtube.com/user/policialestigre 6 The percentages were obtained on the basis of observation and classification of the videos included in the five issues of the television program Cámaras de Seguridad that were included in the corpus of our analysis. For the purposes of this essay, the term ‘video’ refers to an audiovisual composition generated from editing images captured by security cameras in public spaces which, by its characteristics and its space and time delimitations, can be considered a narrative unit with a specific beginning and end. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 135 Vanesa Lio DOI:10.1400/228747 recreation and nocturnal activities code, which establishes that video cameras should be installed at the entrance of night clubs and restaurants, with the aim of reinforcing safety measures for the audience. A month later, the School Board of the same city announced the creation of a Safety Committee in order to study vandalism cases that occur inside educational establishments and install cameras in schools in order to draw a map of scholar insecurity. Consequently, video cameras began to be used in 26 schools of La Plata city7. In addition, in June 2011, the local government announced that security cameras would be placed in the surroundings of several schools, in response to a series of clashes between students from different schools held on public roads. As a result, the distribution of video cameras in public spaces helped to trace a map of the riskiest areas. The local plan for video surveillance states that the location of the cameras was strategically determined based on a study of existing crime rates and a crime map. Within the document, the term ‘crime’ is often metonymically replaced by expressions such as ‘suspicious activities’, ‘dangerous conditions’ or ‘vandalism’. This means that the cameras are viewed not only as a tool for crime prevention but also as a mechanism of control for what are defined as strange or unusual situations. The cctv system seems to play a particularly relevant role in the construction of a specific geography and in the characterization of the subjects that inhabit it. The placing of the security cameras appears fully connected to the dangers that are attributed to each zone. Thus, crowds and commercial areas raise the thermometer of risk and, therefore, they should be closely monitored. Furthermore, the crime maps constructed with the data recovered from cctv installation are used repeatedly to show many issues related to crime and policies on security. Institutional communication and press coverage during the placing of new video camera are also very important elements for the local government. Conclusions The social panopticon seems to be aimed at watching entire populations, putting everyone under suspicion and generating, as a consequence, a deterrent effect: while people know that are being watched, they cannot identify when or by whom. By a watchful gaze, local governments extend their power over citizens and apply a systematic social control in open spaces. Everyone is under the observation of these technological eyes placed across the city. However, at the same time, the use of these tools exhibits that the gaze is focused on certain places and social groups. These devices are intended for the pursuit of street riots and incivilities. The type of crime caught by cctv systems shows that video surveillance is dedicated to maintaining public order, seeking not only to prevent crimes but also to control certain social irregularities as begging, alcoholism, addiction and prostitution, all of them labeled risky situations. In addition, young people are described as potential disturbers of public order, and therefore they must be closely observed, as a strategy to prevent them from becoming criminals. This paper is inserted in the line of several authors who have questioned the fairness of urban surveillance. Martinais and Betín (2004), for example, have describe the ways in which security cameras contribute to the social construction of deviance. Norris and Armstrong (1999) examine how target selection in cctv control rooms is socially differentiated by age, race and gender and ask whether this leads to discrimination. Finally, Lomell (2004) discusses, from a case study, whether video surveillance may be seen as a factor contributing to the increasing exclusion of unwanted categories of people from city centers. Cctv systems can be considered as a material and symbolic mediator that modifies interpersonal social relationships between the watchers and the watched as well as their relationship to public spaces. Since sociospatial relationships of social players may be considered as an inherent part of public space, their transformation directly affects the public space’s qualities (Klauser 2004). Neoliberal politics, that have promoted an ideology of self-responsibility within a climate of moral indifference to increasingly visible inequality, have also generated changes in the public space. As Coleman (2003) argues, the agents and agencies of the neoliberal State are constructing the boundaries and possibilities of the new urban 7 While initially the cctv systems in schools were run by private companies, both the school board and the local government wanted it to be centralized in the MOPU. 136 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228747 Vanesa Lio frontier while simultaneously engaging in a project of social control that will have far-reaching consequences for how we understand the meanings of public space, social justice and the parameters of State power. In this context, «surveillance cameras are part of a social control strategy that seeks to hide the consequences of neoliberalisation in creating a particular ambience and exclusivity regarding ‘public’ spaces» (Coleman 2004: 293). In addition, the public diffusion of the videos captured by public cctv systems plays an important role in the process of building the geography of the city and its inhabitants. The use of these control devices has an inevitable consequence on the delimitation of the city and the way in which subjects assume their roles. The diffusion and automation of cctv, and it linkage to digital image databases, however, means that the normative assumptions about the value and risk associated with particular individuals moves from the discretion of human practice to be embedded within the opaque codes of computer systems. Such a development would mean a tremendous change in our society’s conception of a person. It would have dramatic implications for the nature of places, politics, planning and democratic practice, as automated, opaque systems start to inscribe complex normative ecologies of ‘acceptable’ people behavior into the fabric of urban places on a continuous and largely unknowable basis (Graham 2002: 241). Public access to the certain cctv images holds a central role for various reasons. On the one hand, we access to a view of the city where we live in a way that pretends to be complete and which, mediated by the technological eyes that emulate our own eyes, tries to be transparent. On the other hand, as Ferrer (2005) states, the visual technologies, introduced in our everyday life, modify the way in which we see, regulating our will to see and orienting our attention. Controlling perception means founding a political sovereignty. In this sense, the ones that vie for power would pay particular attention to control our gaze and to place their own «visible truth» as the legitimate one. In our case-study, the power is in the hands of municipalities, that own the images and decide what (and in which form) should be shown. At the same time, as we saw, the placement of video cameras defines the safe and the unsafe areas within the city. The crowds and the youths seem to suggest higher levels of risk and, therefore, the spaces that they usually occupy are privileged by the watchful eye of the State. The insistence on the demarcation of certain areas as dangerous places raises the feeling of insecurity, generating a vicious circle. Are crime statistics the factor that define certain areas as dangerous and, consequently, object of surveillance? Or the placement of the video cameras helps to define a place as risky, increasing the feeling of insecurity in that area? Although they are difficult to answer conclusively, these questions triggered some interesting reflections. First, as we have seen, the installation of these public cctv systems has delimited a specific map of cities where cameras suggest, at the same time, higher levels of risk and of protection. Secondly, another question that arises from the above is whether these devices contribute to the reduction of perceived fear of crime or not. As Bruno Latour (2007) notes, objects play a central role in stabilizing social relations, which by definition fluctuate. Certain devices, such as security cameras, allow delegating the insecurity management to a third party, either an object or a person. However, these elements may contribute to raise the feeling of security as well as increase the fear of crime, as they help people remember the existence of hazards (Kessler 2011). The study of the relationship between people and objects is, then, a central axis in the analysis of the use of cctv for video surveillance in public spaces. References Barata F. (2003), Los mass media y el pensamiento criminológico, in R. Bergali, Roberto (ed.) Sistema penal y problemas Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 137 Vanesa Lio DOI:10.1400/228747 sociales, Valencia: Editorial Tirant lo Blanch. Becker H. (1963), Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York: The Free Press. Coleman R. (2003), Images from a Neoliberal City:The State, Surveillance and Social Control, in «Critical Criminology», 12: 21-42. Coleman R. (2004), Reclaiming the Streets: Closed Circuit Television, Neoliberalism and the Mystification of Social Divisions in Liverpool, UK, in «Surveillance & Society», 2 ( 2/3): 293-309. Calzado M. (2009), Ciudadanos de bien.Víctimas de la inseguridad y discurso político, in «Iberoamerica Global», 2 (2): 25-39. Cardoso B. (2012), The Paradox of Caught-in-the-act Surveillance Scenes: Dilemmas of Police Video Surveillance in Rio de Janeiro, in «Surveillance & Society», 10 (1): 51-64. Daroqui A., Kaminsky G., Pergoraro, J. (2003), Inseguridad. Conversaciones entre Alcira Daroqui, Gregorio Kaminsky y Juan Pegoraro, in «Revista Argumentos», 3: 1-25. De Marinis P. (2004), In/seguridad/es sin sociedad/es: cinco dimensiones de la condición postsocial, in I. Muñagorri, J. Pegoraro (eds.), La relación seguridad-inseguridades en centros urbanos de Europa y América Latina. Estrategias, políticas, actores, perspectiva y resultados, Oñati: Dykinson. Deleuze G. (1990), Posdata sobre las sociedades de control, in C. Ferrer (comp.), El lenguaje libertario: antología del pensamiento anarquista contemporáneo, La Plata: Terramar, 2005: 115-121. Ferrer C. (2005), Mal de Ojo: el drama de la mirada, Buenos Aires: Colihue. Foucault M. (1975), Discipline and Punish.The Birth of the Prison, New York: Vintage Books, 1979. Foucault M. (1997), Ethics: Subjectivity and Truth. EssentialWorks of Michel Foucault. 1954-1984. Vol. 1, NewYork: New Press. Foucault M. (2006), Seguridad Territorio y Población, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Graham S. (2002), CCTV:The Stealthy Emergence of a Fifth Utility?, in «Planning Theory and Practice», 3: 237-241. Hener A., Niszt Acosta F. (2004), La gestión preventiva del delito en el contexto de las nuevas racionalidades políticas neoliberales, in «Actas V Congreso Nacional de Sociología Jurídica», La Pampa: Universidad Nacional de La Pampa y Sociedad Argentina de Sociología Jurídica Argentina. Hobbes T. (1651), Leviathan or the Matter, Forme & Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civil, London: Andrew Crooke. Kessler G. (2009), El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito, Buenos Aires: Paidós. Kessler G. (2011), La extensión del setimiento de inseguridad en América Latina: Relatos, acciones y políticas en el caso argentino, in «Revista de Sociologia e Politica», 19 (40): 83-97. Klauser F. (2004), A comparison of the impact of protective and preservative video surveillance on urban territoriality: The case of Switzerland, in «Surveillance & Society», 2 (2/3): 145-160. Koskela H. (2000), The gaze without eyes: video-surveillance and the changing nature of urban space, in «Progress in Human Geography», 24 (2): 243-265. Lagos M., Dammert, L. (2012), La Seguridad Ciudadana.El problema principal de América Latina,Lima: Latinobarómetro. Latinobarómetro (2011), 2011 Report, Santiago de Chile: Latinobarómetro. Latour B. (2007), Changer de société, refaire de la Sociologie, Paris: La Decouverte. Lemke T. (2000), Foucault, Governmentality, and Critique, in «Rethinking Marxism Conference», Massachusetts: University of Amherst. 138 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228747 Vanesa Lio Lomell H. (2004), Targeting the Unwanted: Video Surveillance and Categorical Exclusion in Oslo, Norway, in «Surveillance & Society», 2 (2/3): 346–360. Lyon D. (2002), Editorial. Survillance Studies: UnderstandingVisibility, Mobility and the Phenetix Fix, in «Surveillance & Society», 1 (1): 1-7. Lyon D. (2004), Globalizing Surveillance. Comparative and Sociological Perspectives, in «International Sociology», 19 (2): 135-149. Martinais E., Bétin, C. (2004), Social Aspects of CCTV in France: The Case of the City Centre of Lyons, «Surveillance & Society», 2 (2/3): 361–375. Martini S., Pereyra M. (2009, eds.), La irrupción del delito en la vida cotidiana. Relatos de la comunicación política, Buenos Aires: Biblos. Norris C., Armstrong G. (1999), CCTV and the Social Structuring of Surveillance, in «Crime Prevention Studies», 10: 157-178. Sozzo M. (2009), Gobierno local y prevención del delito en la Argentina, in «Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana», 6: 58-73. Wilson J., Kelling G. (1982), Ventanas Rotas. La policía y la seguridad en los barrios, in «Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales», 15-16, 2001: 67-79. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 139 140 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228748 Simona Miceli [La capacità di aspirare] Immagini di futuro di figli e figlie di migranti a Reggio Calabria Title: The Capacity to Aspire. Second-generation Immigrants’ Future Images in Reggio Calabria Abstract: The article discusses the second-generation immigrant’s capacity to aspire in Postcolonial Italy, starting from a research which took place in Reggio Calabria. After defining some key concept such as “Postcolonial Italy” and “capacity to aspire”, I present the main hypothesis, which consist in considering the capacity to aspire as a way of resistance to Italian colonial unconsciousness. The qualitative methodology applied to the research involved carrying out some in-depth interviews. Therefore, in the last paragraphs the empirical data are presented by quoting some of the interview extracts. The main issues concern: second-generation immigrants’ approach toward their future as young people; their specific life experiences as people with foreign origins; the role played by the southern context in their future projects. This exploratory research suggests that capacity to aspire is a mode of agency, because who aspires to something is also someone who wants to change his/her current condition. This behaviour seems to be quite common among the people interviewed. Keywords: Second-generation immigrants, Aspirations, Future, Post-colonialism, South of Italy. Giovani di origine straniera nell’Italia postcoloniale La tendenza alla dicotomia, così radicata nella cultura occidentale (Said 1978), è uno dei motivi per cui ‹‹grazie a meccanismi sociali di etichettamento e di esclusione impliciti ed espliciti, l’umanità viene divisa tra persone e non persone›› (Dal Lago 2004: 9), ovvero tra “cittadini” e “immigrati”. Esistono però delle realtà difficilmente collocabili in una delle due “categorie”. Si pensi ai figli dei migranti: Figli e figlie che crescono qui, frequentano le scuole qui, parlano fin da piccoli la nostra lingua. Ma sono persone che noi ci ostiniamo a chiamare “immigrati di seconda generazione”, anche se non sono mai immigrati. Se il vivere “non più” nel paese d’origine e “non ancora e mai definitivamente” nel paese di arrivo segna profondamente l’identità dei migranti, per la cosiddetta “seconda generazione” la mancanza di riconoscimento di una integrazione pone problemi di qualità nuova (Siebert 2003:103). Il tema su cui il presente contributo invita a riflettere - anche attraverso la discussione di materiale raccolto empiricamente - è la capacità di aspirare dei figli e delle figlie dei migranti nell’Italia postcoloniale. Prima ancora che all’Italia postcoloniale, è necessario pensare all’Europa postcoloniale, il che significa considerare il colonialismo un elemento chiave per la comprensione della modernità europea (Chambers 2003) e individuare le radici storiche dei flussi migratori, in quanto ‹‹una sorta di ritorsione coloniale sui vecchi centri metropolitani›› (Mellino 2009). Esistono però diversi postcolonialismi europei (Ponzanesi 2012). L’Italia è cronologicamente una società postcoloniale. Lo stesso non si può dire per l’immaginario collettivo. Secondo Triulzi (2011), il mancato confronto con il proprio passato coloniale ha fatto sì che in Italia non ci sia stata né una totale rimozione dell’esperienza coloniale, né una sua elaborazione. L’autore parla di una latenza della memoria coloniale che ha alimentato la costruzione di un sistema percettivo razzista silenzioso e pronto ad emergere nei momenti di crisi. Furono le caratteristiche dell’imperialismo italiano - breve durata (sessant’anni); dimensioni relativamente piccole dell’Africa orientale italiana; bassi profitti ricavati; perdita delle colonie al termine della seconda Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 141 Simona Miceli DOI: 10.1400/228748 guerra mondiale e conseguente mancato confronto col processo di decolonizzazione - a favorire la circolazione dell’immagine di un “colonialismo straccione” e assolutamente inoffensivo rispetto a imperi europei di durata secolare (Labanca 2002). Sebbene il mito degli “Italiani brava gente” (Del Boca 2005) sia circolato ampiamente in epoca coloniale, i regimi coloniali italiani erano basati su un vero e proprio sistema di segregazione razziale1. Il colonialismo italiano si caratterizzò anche per una forte aggressività nel corso delle guerre di conquista che vide l’Italia protagonista di tristi pagine di storia, fatte di massacri e atti genocidari. Tutto ciò ha portato al silenzio della sfera pubblica e alla mancata trasformazione del colonialismo italiano in trauma culturale (Jedlowski, Siebert 2011), ovvero una costruzione collettiva di senso che porta ad identificare un certo fenomeno come il male assoluto. In Italia, e più in generale in Europa, non si è verificata un’operazione di questo genere rispetto ai crimini coloniali. Le peculiarità dell’esperienza coloniale italiana sono alla base della particolare condizione postcoloniale che l’Italia sta attraversando. Solitamente il termine “postcoloniale” viene utilizzato per indicare i flussi dalle excolonie alle ex-metropoli. L’Italia, che non perseguì alcuna politica di integrazione durante la propria permanenza in Africa, si caratterizza per la varietà dei paesi d’origine dei flussi migratori di cui è meta (Albania, est Europa, Nord Africa, Sud America, Sud Asia), rispetto ai quali le migrazioni dalle ex-colonie sono solo una minima parte2. Il posizionamento dell’Italia nel Mediterraneo e il suo essere diventata tardivamente postcoloniale, sono motivo di potenzialità: Its critique has made possible the sharing of a sense of belonging for postcolonial migrants of diverse origins. This belonging is not linked to legal status but rather to new ways of being Italian, whether by virtue of being born in Italy, through everyday experiences and practices, or through participation in the educational system and a dynamic use of the national language (Lombardi-diop, Romeo 2012: 9-10) L’Italia postcoloniale è quindi un’Italia conflittuale. La possibilità per i migranti postcoloniali di creare un “senso di appartenenza comune” convive con l’eredità di un’Italia che ha partecipato al colonialismo e se ne è servita per amplificare il senso di appartenenza nazionale attraverso la diffusione di stereotipi razzisti sulle popolazioni colonizzate (cfr. Triulzi 2005) e la promulgazione di un sistema legislativo razziale. Il mancato confronto critico con questa parte di storia nazionale ha degli effetti che danno forma alle modalità presenti con cui l’Italia si relaziona al mondo dell’immigrazione3. Nelle ambiguità dell’Italia postcoloniale nascono e crescono i figli dell’immigrazione, una realtà estremamente eterogenea e al cui interno vengono inclusi anche casi molto diversi: ‹‹i giovani nati in Italia, quelli che sono giunti prima della scolarizzazione primaria, quelli che sono arrivati dopo aver frequentato per alcuni anni le scuole del paese d’origine (…), bambini e giovani che parlano perfettamente la lingua italiana e quanti la ignorano totalmente›› (Bertani, Di Nicola 2009:5). A fronte di tale eterogeneità, è possibile considerare i giovani di origine straniera come una generazione? Mannheim riteneva che non solo l’essere nati nello stesso momento storico fosse il collante tra i membri di una generazione, ma ancor più la collocazione generazionale, intesa come la possibilità di assumere comportamenti, modi di pensare e di sentire comuni, ovvero di diventare una generazione sociale che partecipa agli stessi contenuti di vita (Mannheim 1952). L’elemento comune non è tanto, in questo caso, la possibilità di partecipare agli stessi avvenimenti storici e di sviluppare delle reazioni comuni, quanto la condivisione di quel particolare contenuto di vita che è la scelta 1 A partire dal 1937 si prevedeva la reclusione per chiunque avesse relazioni coniugali con donne africane ed era vietato il riconoscimento di figli di coppie miste. Fu costruito un sistema di apartheid, con una netta separazione nei quartieri, al cinema, nel commercio, nei trasporti (Labanca 2002). 2 Mentre al termine della seconda guerra mondiale, con l’avvio dei processi di decolonizzazione, Francia e Inghilterra divennero in maniera consistente meta delle migrazioni dalle rispettive ex-colonie, l’Italia era ancora un paese i cui cittadini emigravano verso il Nord Europa e si caratterizzava per una cospicua migrazione interna: i migranti meridionali erano de veri e propri “internal colonial migrants” (Lomabrdi-diop, Romeo 2012:5). 3 Un interessante esempio sul parallelismo tra le leggi razziali coloniali e l’attuale legislazione nazionale in materia di migrazione si trova in Palermo 2011. 142 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228748 Simona Miceli dell’esperienza migratoria da parte della famiglia d’origine. Sebbene l’esperienza individuale possa essere molto diversa da un caso all’altro, il fatto di vivere la propria esistenza in sospeso tra due realtà culturali, quella del paese d’origine e quella del paese in cui si vive, costituisce, a mio avviso, l’elemento a partire dal quale è possibile individuare una unità generazionale. Vorrei infine richiamare una questione terminologica, relativa all’opportunità di utilizzare l’espressione “seconde generazioni”. Rispetto al caso della Francia la si considera un ‹‹nome che esclude›› (Wihtol de Wenden 2004: 108). L’espressione sembra lasciare intendere che la seconda generazione riproduca perfettamente la prima, quella dei genitori emigrati da adulti, i quali sono spesso disposti all’accettazione di un modello di integrazione subalterna (Ambrosini 2004). Granata, a sua volta, afferma che ‹‹un nome non basta›› (Granata 2011: 29), in quanto ogni espressione coglie alcuni aspetti e non altri: “seconde generazioni di immigrati” e “figli dell’immigrazione”, pongono l’accento sull’eredità della migrazione ricevuta dai genitori; “giovani di origine straniera” o “nuove generazioni”, segnalano un maggior legame con il paese in cui si vive. Si potrebbe pensare a questi giovani come alla prima generazione di italiani, figli di migranti. La parola “prima” permette di affermarne la differenza rispetto ai genitori. Mi sembra opportuno mantenere il termine “generazione” proprio perché, come detto poco sopra, è utile ad individuare un soggetto collettivo che, per quanto fortemente differenziato al proprio interno, mantiene delle importanti caratteristiche comuni, come “italiani” e “figli di migranti”, espressioni utili a richiamare contemporaneamente la doppia appartenenza culturale e il fatto che essa sia legata ad una esperienza migratoria (vissuta in prima persona o solo indirettamente) collocata in una dinamica familiare. La capacità di aspirare: una forma di resistenza all’immaginario coloniale? Quando ci si accosta a tematiche inerenti il futuro, non potendo prevedere con certezza gli esiti di processi in atto, una possibilità può essere quella di partire dalle immagini di futuro che circolano nel presente, nell’ipotesi che se anche tali immagini non dovessero realizzarsi, esse possano influenzare in maniera non irrilevante il presente, il quale a sua volta agisce incessantemente sull’immaginario collettivo e dunque sui “futuri” ritenuti plausibili. In questa continua tensione tra poli temporali si colloca ciò che Appadurai (2004) ha definito la capacità di aspirare. Secondo l’antropologo l’aspirazione è una capacità culturale: per aspirare a qualcosa è necessario non solo avere un progetto, ma anche individuare il corso d’azione necessario per realizzarlo. L’aspirazione è una capacità per l’aspetto pratico che la contraddistingue. Allo stesso tempo è una capacità culturale perché nel progettare il futuro si prende parte all’immagine che la società, o la parte di essa in cui ci si identifica, ha del futuro, di ciò che è ritenuto plausibile e desiderabile. La capacità di aspirare, inoltre, ha delle forti basi culturali e sociali, per questo motivo essa è distribuita in maniera diseguale tra i membri di una società. Dal momento che è correlata positivamente con le risorse economiche, sociali e culturali, le fasce più deboli della popolazione più difficilmente riescono a svilupparla. L’aspetto problematico di questa situazione è che proprio la capacità di aspirare potrebbe diventare, secondo Appadurai, uno strumento utile per uscire da situazioni di svantaggio. Egli ha elaborato questa teoria a partire dall’osservazione di alcuni gruppi di poveri della città di Mumbai coinvolti in un progetto finalizzato a implementare lo sviluppo di tale abilità, considerata come un vero e proprio strumento di self empowerment, a partire dal quale si mettono in atto nel presente delle azioni orientate al futuro e dunque finalizzate a modificare la propria condizione. L’idea alla base di questo lavoro consiste nel mettere insieme un soggetto circoscritto, i figli dell’immigrazione, e un’abilità specifica, la capacità di aspirare, nel contesto dell’Italia postcoloniale. Un quesito fa da sfondo a quest’operazione: la capacità di aspirare può rappresentare uno degli strumenti attraverso cui resistere all’immaginario e ai discorsi “coloniali” ancora in atto? O tale immaginario è così forte da impedirne lo sviluppo? Dietro tale quesito vi è l’adesione ad un modo di fare critica postcoloniale che non si limita a far luce sulla storia coloniale dell’Europa – cosa assolutamente necessaria - ma che, in aggiunta, si chiede come ‹‹the postcolonial paradigm formulates new epistemologies produced by previously voiceless subjects›› (Lombardi-diop 2012: 2). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 143 Simona Miceli DOI: 10.1400/228748 La prospettiva postcoloniale farà da sfondo a questo discorso perché aiuta, dal mio punto di vista, a rendere meno scontato ciò che spesso appare ovvio. Infatti, se l’esperienza coloniale italiana ha riguardato solo una piccola area del continente africano, ciò che ha prodotto nell’immaginario collettivo italiano è una certa costruzione dello straniero in generale. Per questo motivo in questa sede non ci si occuperà necessariamente di migranti provenienti dai quattro paesi con cui l’Italia ha stretto quel “particolare legame”. In base alla considerazione di Appadurai, per cui la capacità di aspirare è distribuita in maniera diseguale all’interno di una società, l’ipotesi di partenza di questo lavoro è che alcune tendenze contrastanti nella società contemporanea potrebbero far sì che i figli dei migranti intrattengano con la capacità di aspirare un rapporto ambivalente. Scoraggiati per certi versi, potrebbero essere facilitati per altri. Mi spiego meglio. La capacità di aspirare si esercita nel presente: ‹‹Aspirare a qualcosa vuol dire dare un senso al futuro: ma lo si fa nel presente, e il senso del futuro si riverbera così sul senso dell’ora, che dalla presenza dell’aspirazione è modificato›› (Jedlowski 2012: 4). In sostanza per poter nutrire delle aspirazioni è necessario individuare nel presente una ‹‹base minima di possibilità oggettive›› (Mandich 2012). Al contrario, non essere considerati parte della società oggi significa essere esclusi dalle narrazioni collettive (egemoniche) sul futuro. Si può perciò ipotizzare che alcuni fattori sociali inibiscano e altri incoraggino la capacità di aspirare dei figli dell’immigrazione4. Ad esempio, ciò che potrebbe fungere da ostacolo è una sorta di immaginario sociale (anti)multiculturale, basato su una concezione statica della cultura, considerata come un tutto omogeneo, che deve essere preservata da potenziali “contaminazioni” in una situazione di crescente incertezza in cui l’alterità diventa una minaccia (Colombo 2012). Si potrebbe dire che l’immaginario sociale (anti)multiculturale produce dei quadri sociali sul futuro (Jedlowski 2012) con potenziali effetti negativi sulle aspirazioni delle seconde generazioni. Allo stesso tempo la condizione di pluralità culturale in cui i figli dei migranti crescono e formano la propria identità potrebbe essere un fattore positivo. Rampazi (2011) parla di strabismo di appartenenza rispetto all’impatto delle azioni quotidiane in un contesto di crescente interdipendenza globale e alla conseguente diffusione di sistemi di valori transnazionali che attraversano i confini geo-politici e mettono in discussione la persistenza di identità culturali rigide e impermeabili. Sapersi orientare in uno scenario in cui ‹‹lo stato nazionale non rappresenta più l’ambito certo ed esclusivo dell’appartenenza›› (Rampazi 2012: 94) non è per niente scontato. Si può ipotizzare che i figli dell’immigrazione possano muovervisi con meno difficoltà in quanto figure profetiche ed esemplari, tali da ‹‹anticipare una condizione giovanile sempre più immersa in una dimensione globale›› (Colombo, Leonini, Rebughini 2009: 60). Le coordinate della ricerca: contesto e metodologia Le ipotesi di ricerca sono state formulate a partire dal contesto nazionale italiano. Tuttavia il contesto locale ha sempre delle influenze sui fenomeni sociali, i quali pur presentando dei tratti comuni che ne costituiscono le fondamenta, possono assumere poi delle peculiarità in determinate circostanze. Il contesto italiano, del resto, presenta una notevole differenziazione interna, i cui esiti compongono la cosiddetta questione meridionale. La ricerca è stata condotta in una città del sud Italia, Reggio Calabria. Molte ricerche e studi sulle migrazioni si collocano nel centro-nord del paese, vista la maggior concentrazione di popolazione migrante in quelle aree. Tuttavia, proprio la presenza sempre più cospicua delle seconde generazioni lascia intendere un mutamento in questo senso.5 Al di là dei dati statistici, la cui rilevanza invita ad approfondire gli studi sull’immigrazione nel Mezzogiorno, ci sono altre ragioni per condurre una ricerca come questa in una città meridionale. 4 A tal fine ho trovato utile un volume collettivo (De Leonardis, Deriu 2012) di sociologi italiani i quali reinterrogano il concetto di aspirazione, come inteso da Appadurai, per estenderlo ad alcune fasce svantaggiate che vivono in Occidente. In essi non vi è un riferimento esplicito alle “seconde generazioni”, ma vi sono una serie di suggestioni particolarmente adatte al caso che qui si sta esaminando. 5 Al 1° gennaio 2013 la presenza di stranieri regolari sul territorio calabrese è di oltre 74.000 individui (Unar 2013). Il 31,5%, si trova nella provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati forniti dalla Prefettura (http://www.prefettura.it/ reggiocalabria/contenuti/7135. htm), la fascia più rappresentata è quella tra i 18 e i 40 anni, ma si registra una sensibile crescita della fascia più giovane (0-17 anni), per cui i minori stranieri rappresentano oggi il 18,3 % della popolazione straniera. 144 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228748 Simona Miceli Secondo Appadurai per implementare la capacità di aspirare bisogna disporre, tra le altre cose, di uno strumento: la voice (Hirschman 1970), ovvero la capacità di esprimere il proprio punto di vista pubblicamente. Tuttavia, il colonialismo si è legittimato rendendo le proprie vittime voiceless (Said 1978; Spivak 1999). Si potrebbe compiere un’analogia tra quanto accadde nelle periferie coloniali e quanto si verificò durante il processo di unificazione nazionale, per cui il Mezzogiorno potrebbe essere considerato una ‹‹colonial extension of the North of Italy at the time of unification›› (Lombardi-diop, Romeo 2012: 4). Vi è un legame nell’Italia contemporanea tra la condizione postcoloniale e la questione meridionale. I giovani di origine straniera che vivono in una città del Sud Italia devono confrontarsi con l’una questione e con l’altra. Devono fare i conti con un’esperienza di doppia marginalizzazione, legata all’origine migrante e alla residenza in una terra che sembra offrire meno opportunità rispetto al contesto nazionale6. La critica postcoloniale invita a decostruire la visione egemonica della storia e a rivisitarla a partire da punti di vista altri, spesso periferici. Proprio il riferimento a questo tipo di approccio mi ha portato a prediligere una metodologia di tipo qualitativo. Si è scelto di fare uso di interviste in profondità, con l’obiettivo di raccogliere “storie” e di indagare il senso (in termini weberiani) che ciascuno attribuisce al proprio vissuto. Sono state realizzate 18 interviste di tipo semi-strutturato. La traccia di domande è stata utilizzata in maniera flessibile e adattata, di volta in volta, all’impostazione del discorso data dalla persone intervistate. Le domande da un lato stimolavano a raccontare episodi di vita e dunque erano finalizzate ad ottenere dei racconti; dall’altro invitavano ad esprimere riflessioni e opinioni personali sui temi trattati. Sono stati coinvolti giovani di età compresa tra i 16 e i 33 anni. Si è cercato di garantire una certa differenziazione interna al gruppo di persone selezionate attraverso diversi criteri tra cui il genere, l’età e il paese d’origine, ma anche l’età di arrivo (ho ritenuto utile coinvolgere sia persone nate in Italia che arrivate nel corso dell’infanzia o anche dell’adolescenza). In questo modo, a partire dalle esperienze di vita delle persone intervistate, è stato poi possibile reinterrogare concetti e teorie, mettere alla prova le ipotesi, formulare nuovi quesiti. Aspirazioni e strategia del compromesso Appartenere alla fascia giovanile della società significa vivere una fase biografica ‹‹contrassegnata dal rapporto con il futuro››, rispetto al quale i giovani possono manifestare ‹‹sentimenti ambivalenti›› (Bettin Lattes 2001:15). Tuttavia, alcuni cambiamenti in atto nella struttura della società, i cui complessi esiti sono però difficili da prevedere, influenzano il modo in cui si guarda al futuro. Sempre più spesso si parla di Società del rischio (Beck 2000) e di Società dell’incertezza (Bauman 1999) in riferimento alla crisi del concetto di progresso quale ‹‹orizzonte di senso entro cui certe aspirazioni sono state socialmente plausibili e sono state legittimate dall’aspettativa che fosse la società tutta a muoversi “in avanti”, verso un futuro migliore›› (Jedlowski 2012b: 76). Come si inserisce, in tale contesto, la capacità di aspirare? Nel corso delle interviste la percezione di vivere una congiuntura socio-economica sfavorevole è emersa con una certa frequenza. Chi sente questo problema particolarmente pressante in questa fase della propria vita ne parla già durante il primo intervento, relativo alla presentazione di sé: Col lavoro ho sempre trovato difficoltà, come la maggior parte degli italiani. Ricordo che in passato c’era sempre il problema del lavoro, però rispetto a oggi si trovava più facilmente. Oggi proprio non si trova quasi per niente, e quello che si trova non è stabile. In Italia credo troverò soltanto qualcosa per vivere, per fare quello che mi piace probabilmente devo guardare oltre (Ben, 33 anni). Oltre alla preoccupazione per la stabilità un altro aspetto che caratterizza molte interviste è l’importanza 6 La questione dell’internal colonialism è molto complessa e non può essere approfondita adeguatamente in questa sede. In generale il concetto indica la presenza di una “periferia coloniale” all’interno dei confini nazionali. Rispetto al contesto italiano ciò significa che il discorso postcoloniale non riguarda solo le ex colonie, ma anche il rapporto di subalternità che, a partire dall’unificazione nazionale, ha informato la relazione Nord-Sud. La letteratura a riguardo è molto ampia e il modello del colonialismo interno viene utilizzato per descrivere le diseguaglianze interne a moltissimi paesi nel mondo. Per un approfondimento sulla situazione italiana rimando a Verdicchio 1997, Schneider 1998, De Robertis 2012. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 145 Simona Miceli DOI: 10.1400/228748 attribuita al lavoro come mezzo per raggiungere l’indipendenza dalla propria famiglia. Quasi tutti ritengono che lavorare, nell’attesa di capire cosa fare del proprio futuro, o mentre si studia per realizzare i propri obiettivi, sia di fondamentale importanza: Tutti mi dicono: ‹‹Devi continuare a studiare…›› e ho detto: ‹‹Va bene, mi laureo, ho capito…››. Però ho detto anche: ‹‹Mi faccio quest’anno lavorando››. Volevo almeno un minimo di esperienza lavorativa, perché se poi arrivo a 25 anni e non ho avuto nessuna esperienza mi pare di aver perso tempo (Ryan, 21 anni). La consapevolezza delle difficoltà del contesto nazionale e internazionale è presente ed è motivo della ricerca di soluzioni temporanee, finalizzate anche alla possibilità di ottenere una certa indipendenza economica. Questa tendenza non si sostituisce però ad una progettualità più a lungo a termine. La scelta di svolgere dei lavori temporanei, non sempre qualificati, è spesso legata alla ricerca di risorse che possano supportare i propri progetti: Io non mi tiro indietro quando devo fare anche il lavoro più umile, però per me è gavetta: è qualcosa che metto nella mia valigia per arrivare poi a quella che è la mia destinazione (Maisa, 22 anni). Quest’ultima testimonianza è indicativa di un atteggiamento che ho trovato abbastanza diffuso, ovvero aspirare a qualcosa che risponda alla propria personalità, ai propri gusti e competenze.Tra le persone intervistate, solamente quattro hanno affermato di aver scelto di lavorare col solo scopo di sostenere economicamente la famiglia. Tutti gli altri, coloro che lavorano, coloro che studiano o che fanno entrambe le cose, hanno scelto una strada coerente con i propri desideri e progetti e che al tempo stesso considerano realizzabile e “raggiungibile”. Non credo sia utile distinguere tra chi aspira a professioni che richiedono la prosecuzione degli studi universitari e chi ha scelto di lavorare al termine della scuola (i due “percorsi” sono risultati presenti più o meno in egual misura). Obiettivo della ricerca non era quello di approfondire l’oggetto delle aspirazioni, quanto invece cercare di comprendere se quel particolare atteggiamento che è la capacità di aspirare è diffuso tra questa generazione. Il punto dunque è soffermarsi sulle motivazioni che spingono ad una scelta piuttosto che ad un’altra. Si può scegliere di lavorare per sostenere la famiglia. Ma l’atteggiamento con cui lo si fa, fa la differenza: Ho dovuto lasciare lo studio per aiutare i miei a livello economico e mi sono messo subito a lavorare, ma lavorare diciamo sulla mia passione: il ballo. Io ho sempre ballato sin da piccolo. Ora sono maestro di ballo hip-hop, quindi ora tutti i giorni ballo, faccio quello che è la mia passione. Cosa faccio: lavoro. Cosa mi piace fare nel tempo libero: ballare, quindi potrei dire lavorare (Michael, 21 anni). Analogamente, il modo in cui si sceglie quali studi portare avanti riflette la capacità di mediare tra i propri sogni e le concrete possibilità a cui si percepisce di poter accedere. Di questo ho riscontrato diversi esempi: Io vorrei fare la dottoressa perché mi piace aiutare la gente. Però devi fare tantissimi studi ed essere molto bravo. Al giorno d’oggi devi pensare che non c’è abbastanza lavoro. Avrei pensato all’esercito militare, che mi prepara ad un futuro più duro e in cui posso benissimo imparare e avere un lavoro dopo. È difficilissima come cosa, ma almeno sai che avrai la soddisfazione in futuro. Anche solo provarci, se non ce la faccio torno a casa. Però mia mamma dice che sono stata abituata da piccola ai cambiamenti, quindi magari ne sono capace. Lì, se vorrò, potrò benissimo fare la dottoressa o l’infermiera militare (Alexandra, 16 anni). Fisioterapia è stato un punto di incontro, perché mia madre ha sempre voluto che facessi medicina, anche mio padre. Eh… io medicina, di fatto, non mi sono sentita pronta. E ho detto, dai fisioterapia che è sempre una materia di ambito sanitario, però già è di maggiore interesse per me che faccio sport, mi apre più porte (Kayla, 19 anni). Alla luce di ciò che è stato detto finora, le parole chiave per leggere l’immagine che i giovani di origine straniera hanno del loro futuro, potrebbero essere: preoccupazione; confronto con la realtà; progettualità; coerenza con le proprie passioni; responsabilità individuale. Un buon mix che mi porta a pensare che l’atteggiamento prevalente verso il futuro sia una sorta di strategia del compromesso tra ciò che la società offre e ciò per cui si è predisposti. Quando le proprie immagini di futuro non vengano ritenute realizzabili, non si rinuncia completamente ad esse, ma si sposta il proprio raggio d’azione il minimo indispensabile, ovvero si cercano alternative plausibili e quanto più vicine possibile al progetto originario. La capacità di aspirare, del resto, manifesta un certo tipo di atteggiamento verso il futuro che definirei costruttivo/ propositivo, ma ancorato alla realtà. 146 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228748 Simona Miceli Ostacoli e stimoli alla capacità di aspirare Nel paragrafo precedente si è cercato di delineare l’atteggiamento di fronte al proprio futuro in relazione alla condizione giovanile. Adesso si farà riferimento a delle questioni legate alla condizione migrante della famiglia d’origine. L’ipotesi che un immaginario sociale (anti)multiculturale possa provocare delle narrative di esclusione dal futuro ha trovato conferma nell’emersione di due questioni ricorrenti nel corso delle interviste. La prima è relativa all’acquisizione della cittadinanza, disciplinata in Italia dalla datata legge 91 del 1992. L’acquisizione della cittadinanza è strettamente legata alle aspirazioni perché mina, nel presente, le basi del riconoscimento. Essere cittadini, e ancor di più essere considerati dei cittadini, significa sentire legittimata la propria presenza, ottenere una conferma intersoggettiva della propria identità ed essere portatori di diritti, caratteristica irrinunciabile per nutrire aspirazioni (Beccalli 2012). Immaginare il proprio futuro privati di tale risorsa è molto più complicato. Ci si sente “fuori posto” nel luogo che considera casa propria: A un certo punto uno si stanca, e allora io dico: ‹‹Alt! Appena posso me ne vado››. E mi farebbe male andarmene. E io lì mi sentirei un’immigrata, qualora decidessi di andarmene. Dopo 23 anni io ancora vado in giro con il permesso di soggiorno, è una cosa che mi fa sentire non diversa… non mi fa sentire proprio niente, cioè proprio spenta (Zahra 28 anni. Vive in Italia da 23 anni). In situazioni di questo genere, in cui non si è nati in Italia, ottenere la cittadinanza è ancora più complicato, perché a livello giuridico non si rientra perfettamente nelle cosiddetta “seconda generazione”. La legge italiana prevede infatti che solo chi sia nato sul territorio italiano e vi abbia risieduto ininterrottamente fino al compimento della maggiore età, possa a quel punto fare richiesta per la cittadinanza (avendo un anno di tempo, oltrepassato il quale i “requisiti” di cui si è in possesso non vengono ritenuti più validi). Anche per questo motivo, il punto di vista adottato in questa sede è diverso rispetto a quello legislativo e ha portato a includere nella ricerca tanto persone nate in Italia che arrivatevi successivamente. Del resto, la normativa italiana sulla cittadinanza presenta degli elementi di criticità anche rispetto alla generazione 2.0 (nati in Italia): Io sono nata in Italia, ma non ero automaticamente italiana; ho dovuto aspettare il compimento dei 18 anni e presentare al Comune la mia residenza continuativa, il mio stato di famiglia e l’attestato di nascita. Poi i tempi sono molto più semplici, dopo che presenti questi documenti tu firmi e hai la cittadinanza. Però io… cioè io sono nata nel territorio italiano e devo aspettare il compimento dei 18 anni? Devo dimostrarlo dal giorno in cui sono nata… Fino al diciottesimo anno di età io ero una straniera (Maisa, 22 anni). La capacità di aspirare si muove all’interno di quadri sociali, non è svincolata dai futuri ritenuti plausibili dalla collettività. La disciplina giuridica della cittadinanza è uno di tali quadri: il sentimento di esclusione che provoca sul presente si riverbera sul senso del futuro, mostrando come identità e aspirazioni, nella vita di una persona, siano due dimensioni strettamente legate, ma che si muovono su piani temporali diversi. Le aspirazioni potrebbero essere viste come una proiezione della propria identità nel futuro. In qualche modo si ripropone la proliferazione di status giuridici differenti che ha un ‹‹triste precedente storico›› (Palermo 2011: 217) nel sistema legislativo razziale dei regimi coloniali italiani, con la distinzione tra cittadini e sudditi che sembra oggi riproporsi nella più complessa distinzione tra cittadini, migranti regolari, migranti irregolari (“clandestini”). Spesso, dal punto di vista giuridico, i giovani di origine straniera si trovano tra i “migranti regolari”. Si tratta di una contraddizione notevole che invita a riflettere su quali siano i criteri alla base di tale normativa e che riporta alla luce la ‹‹colonialità costitutiva della cittadinanza moderna›› (Mellino 2012: 77). Tanto nell’Italia coloniale quanto nell’Italia contemporanea uno status giuridico di subalternità, creato dallo spartiacque della cittadinanza, opera per confinare una parte dei membri della società in uno stato di non visibilità o di non piena titolarità dei diritti. La seconda questione riguarda l’operare dello sguardo coloniale (Triulzi 2005) nella nostra società. I campi in cui se ne fa esperienza sono molteplici. Può accadere negli uffici in cui ci si reca per rinnovare i documenti, dove: ‹Molte volte si dimenticano che hanno di fronte delle persone umane, con sentimenti, con una testa…›› (Maisa, 22 anni); o nella vita di tutti i giorni, quando ci si rende conto che ‹‹buona parte delle persone ha un’idea Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 147 Simona Miceli DOI: 10.1400/228748 un po’ brutta degli “extra-comunitari”›› (Leila, 16 anni); o quando ci si scontra con i luoghi comuni alimentati mediaticamente per cui ‹‹in Italia il concetto di immigrazione è amplificato: è un’invasione›› (Zahra, 28 anni) . Essere testimoni quotidiani di questi discorsi e atteggiamenti può portare a situazioni di crisi e di straniamento: come collocare queste esperienze nella propria vita? Talvolta percepire, anche inconsciamente, di non essere considerati fino in fondo parte della società in cui si vive da diversi anni, se non da sempre, può produrre anche forme inconsapevoli di auto-esclusione: A volte a messa quando c’è il segno della pace mi dico: ‹‹Ma questo qua mi vorrebbe stringere la mano?››. Ma è un pensiero mio. Questo è il problema: non so perché ce l’ho. Non è che ho mai ricevuto un atteggiamento che uno non mi voleva stringere la mano o quant’altro, però è un riflesso mio. E allora tante volte faccio finta di niente e non stringo la mano a nessuno. Sapere che esistono persone che potrebbero anche non volerti salutare… (Gabriel 28 anni). Rispetto alle società colonizzate si è parlato di oppressione interiorizzata (Siebert 2012). In questo caso potrebbe trattarsi di qualcosa di molto simile, per cui nel relazionarsi con persone che non si conoscono ci si pone inconsciamente un problema iniziale. La cosa interessante è che Gabriel afferma, più volte nel corso dell’intervista, di non essere mai stato vittima di specifici episodi di razzismo. Questo chiedersi cosa pensa chi ha di fronte è il risultato di un’implicita consapevolezza: lo sguardo coloniale è latente e si vive nell’attesa, o nel timore, che si manifesti. Le problematiche presentate in questo paragrafo compongono un vero e proprio glass ceiling che la società impone sui figli dell’immigrazione, abbassandone inevitabilmente il livello delle aspirazioni. Non si tratta però di ostacoli insormontabili. Al contrario, il materiale empirico raccolto mi ha portato a ritenere che alla preoccupazione per il futuro si accompagna una certa capacità di agire nel presente. Come sostiene Rampazi, le incertezze sul futuro sembrano condurre alla fine del tempo lungo, ovvero a un accorciamento della prospettiva temporale o dilatazione del presente. Questo processo può però avere due differenti esiti: la ‹‹presentificazione››, cioè l’incapacità di percepirsi come soggetti in divenire e quindi di immaginare il proprio futuro; la ‹‹rivalutazione del presente››, che stimola invece ad esplorare le prospettive e le esperienze possibili a partire dalla vita quotidiana (Rampazi 2002: 141). La vita quotidiana dei giovani di origine straniera è caratterizzata dall’esperienza del doppio culturale in cui crescono e formano la propria identità. A prescindere che ciò avvenga in maniera indolore o sperimentando piccoli “scontri quotidiani”, i figli dell’immigrazione crescono con l’idea che più culture esistono, e in qualche modo imparano a darlo per scontato. Da ciò deriva la capacità (potenziale, molto dipende del percorso biografico) di orientarsi in universi di senso differenti, di parlare più lingue, di saper vivere nel mondo in più “modi”: Io penso in italiano. Però sono abituata ai miei genitori a rispondere in base alla lingua con cui loro mi parlano. Ci sono dei concetti che per esempio in lingua igbo non riesco a tradurre: è come se ogni volta che andassi a esprimere qualcosa in igbo automaticamente indossassi anche il loro atteggiamento… divento molto più, come dire, nigeriana. Attraverso la lingua entri nei panni delle persone. (Kayla, 19 anni). La lingua è la manifestazione visibile della più profonda e potenziale capacità dei giovani di origine straniera di mettere in atto nella vita quotidiana processi di negoziazione tra sistemi di significato e modelli di comportamento, tra culture. Si tratta di veri e propri atti di multiculturalismo quotidiano (Colombo 2007), attraverso i quali si trova il modo di mediare le differenze e creare delle identità ibride. In un mondo come quello contemporaneo si chiede ai giovani di essere disposti a spostarsi, a cambiare paese non una, ma più volte nel corso della propria vita. Molti lo fanno. Ma avere alle spalle un’esperienza quotidiana di differenziazione culturale può essere una risorsa in più per affrontare questa situazione e per sviluppare la capacità di aspirare nel mondo globale. L’essere cresciuti a cavallo tra più culture può rappresentare un incentivo a spostare il proprio orizzonte progettuale piuttosto che rinunciarvi, qualora si dovessero incontrare degli ostacoli lungo il percorso: Io ora non ci penso due volte a prendere la valigia e partire, non ho paura di viaggiare. Non perché non mi senta legata. Io in questo momento sento il mio paese l’Italia… Io sono figlia di immigrati, ho alle spalle due tipi di cultura differenti. Non mi viene difficile spostarmi, cambiare… (Maisa, 22 anni). Un’altra specificità che a mio avviso rappresenta uno stimolo alla capacità di aspirare dei giovani di origine 148 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228748 Simona Miceli straniera, riguarda l’eredità di una storia famigliare migratoria. Si è già accennato al processo di uncertainization in atto nelle società occidentali (Bauman 1999). Una delle conseguenze è che ‹‹I trentenni e i ventenni di oggi costituiscono le prime due generazioni del XX secolo a non essere in grado di migliorare le proprie aspettative di vita rispetto a quelle delle generazioni da cui discendono›› (Schizzerotto 2002: 19). È così anche per i giovani di origine straniera? Se loro fanno parte del mondo occidentale, perché vi sono nati o cresciuti, non si può dire lo stesso per i genitori, i quali hanno compiuto un’esperienza migratoria verso l’Occidente. Normalmente i genitori hanno delle aspettative sul futuro dei figli, ma nel caso dei migranti si tratta di sancire il successo o il fallimento del proprio progetto migratorio, con la conseguenza che ‹‹i rapporti con i genitori possono essere resi ancor più difficili dalle aspettative che le prime generazioni nutrono nei confronti delle seconde›› (Ambrosini, Caneva 2009:31). Tuttavia, posta in questi termini, la questione viene affrontata dal punto di vista dei genitori. Al contrario, in questa ricerca si è cercato di assumere il punto di vista dei figli. Da un lato i figli dell’immigrazione, come tutti i giovani hanno delle aspirazioni legate alla generazione di cui fanno parte, diverse da quelle dei propri genitori (Leccardi 2012). Dall’altro potrebbe accadere che la consapevolezza da parte dei figli dei costi dell’esperienza migratoria per i propri genitori sia motivo di impegno e fonte di stimolo per le aspirazioni sul proprio futuro (Granata 2011). La comprensione del modo in cui i genitori vivevano nel paese d’origine, accompagnata alla consapevolezza dei costi che tale esperienza ha avuto nella vita dei genitori, rappresentano un elemento importante nella vita di un giovane di seconda generazione. Infatti, molto spesso, parlare dell’emigrazione dei propri genitori ha portato ad anticipare il tema delle aspirazioni e dei progetti per il futuro, le cui domande specifiche erano previste nella seconda parte dell’intervista. Se la migrazione viene percepita dai genitori come un investimento, per i figli ne scaturisce un forte senso di responsabilità e di gratitudine verso la propria famiglia. Questo aspetto è correlato positivamente con la capacità di aspirare, al punto da rappresentare una delle principali motivazioni per ciò che si vuole fare della propria vita: Io spero di fare come hanno fatto i miei: andare fuori per aiutare i propri parenti, quindi cercare un lavoro fuori, dove magari lo stipendio è bello alto; ricambiare tutto quello che i miei stanno facendo adesso (Jayson, 21 anni). Mia mamma quindi è veramente una donna che io stimo perché lei ha saputo affrontare con decisione una situazione critica. Se studio, se faccio tutto quello che faccio è per lei. La mia vita è dedicata a lei in un certo senso, perché voglio veramente che fra qualche anno, quando sarò laureata e avrò un lavoro, lei possa dire: ‹‹Sono fiera dei sacrifici che ho fatto›› (Anna, 18 anni). Uno sguardo a Sud La domanda ‹‹Dove immagini il tuo futuro?›› ha destato una certa dose di problematicità. Ciò che ho trovato particolarmente interessante, ascoltando le risposte, è stata la percezione di trovarmi di fronte a giovani meridionali. Quasi tutti, esattamente come i propri coetanei autoctoni, hanno affrontato, o sanno di dover affrontare, il classico dilemma di chi abita al Sud: ‹‹Restare o andarsene?››. Delle diciotto persone intervistate solamente quattro non prendono in considerazione questa ipotesi e si tratta di persone che sono giunte in Italia in un età compresa tra i 10 e i 15 anni, per cui l’esperienza migratoria è abbastanza vivida nella memoria. Tutti gli altri, invece, si confrontano costantemente con l’ipotesi dell’emigrazione verso il Nord Italia o un altro paese europeo. Si potrebbe dire che i giovani di origine straniera che vivono in una città meridionale rappresentano tanto l’Italia come meta di migrazioni internazionali (questo è stata per i loro genitori), quanto l’Italia delle migrazioni interne o delle migrazioni verso l’estero (ciò potrebbe diventare per loro). Secondo il Rapporto annuale sulle migrazioni interne (Colucci, Gallo 2014), la Calabria è la seconda regione meridionale per saldo negativo tra emigrazione e immigrazione (- 4,1%), e la provincia di Reggio Calabria si colloca al terzo posto (-5,3%). Gli autori notano come una delle principali motivazioni all’emigrazione per i giovani meridionali verso il Nord del Paese sia la ricerca di una migliore qualità della vita (Colucci, Gallo 2014: Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 149 Simona Miceli DOI: 10.1400/228748 X). Di ciò ho avuto diversi riscontri nel corso delle interviste: Qua mi piace il posto, accogliente, solo che poi qua rimani fermo, cioè non è che vai avanti, la mentalità è chiusa… forse al nord si sta meglio. Penso di andarmene da qui sicuramente (Ryan, 21 anni). In un’analisi sulla mobilità dei giovani italiani verso l’estero (Tirabassi, Del Prà 2014), gli autori percepiscono un risentimento diffuso da parte di coloro che sono emigrati e che vedono l’Italia come il paese che non è stato in grado di integrare le loro competenze e capacità nel mercato del lavoro nazionale: Sono amareggiato perché poi non sono riuscito ad integrarmi da un punto di vista lavorativo, ma nemmeno poi a dire: “Ok, non posso fare il pilota, devo guardare gli altri che lo fanno perché conoscono altri, mi trovo un lavoro…” Nemmeno quello, non è possibile nemmeno quello, quindi è ovvio che io abbia dei risentimenti con questo posto (Ben, 33 anni). Rispetto alla possibilità di emigrare verso il Nord o all’estero, le problematiche vissute dalle persone intervistate hanno portato a compiere un’analogia con il documentario Sud Altrove (2012), realizzato dall’Associazione “LiberaReggioLab” per narrare l’emigrazione giovanile dal sud al nord.7 Sebbene in questo caso si parli solamente di giovani calabresi e non siano coinvolti giovani di origine straniera, i dilemmi e le incertezze emersi sono molto simili a quelli rilevati attraverso le interviste. Nel corso del documentario si mette in luce come l’emigrazione giovanile dal Mezzogiorno non sia più quella della valigia di cartone, ma al contrario faccia parte dell’ormai noto fenomeno della “fuga di cervelli”. Alcuni dei giovani intervistati mostrano la stessa tendenza a emigrare per studiare o per intercettare occasioni di lavoro coerenti con gli studi portati a termine.Viesti (2005) parla di “nuove migrazioni” dal Sud al Nord in riferimento ai flussi di giovani che si spostano per motivi di studio o subito dopo la laurea in cerca di occasioni lavorative coerenti con gli studi effettuati. Anche rispetto a questo ho trovato dei riscontri: C’è l’idea di spostarmi, questo sì. Io sono molto legata a Reggio. Quindi ora l’idea di partire mi dà una sensazione strana di malessere. Però, purtroppo, è superiore la volontà di fare qualcosa, di costruire qualcosa. Quindi se a Reggio non ci sarà niente, come purtroppo si prevede, sarò costretta a spostarmi (Farah, 29 anni, laureata in Giurisprudenza a Reggio Calabria). Il senso di malessere scaturisce dalla percezione di essere costretti ad emigrare - e non di fare una libera scelta - per poter realizzare le proprie aspirazioni. Sebbene a livello statistico le seconde generazioni risultino aver meno successo nel campo degli studi,8 anche a causa di una serie di fattori di natura economica, alcune ricerche qualitative mostrano che un certo numero (forse destinato a crescere?) di giovani di origine straniera stia compiendo il “Il passo seguente” (Lagomarsino, Ravecca 2014), ovvero l’accesso all’Università. Si può perciò ipotizzare che alcuni di loro si collochino su un alto livello di aspirazioni e siano disposti a compiere migrazioni analoghe a quelle dei propri coetanei autoctoni. La situazione è complessa perché si è costretti a scegliere tra la realizzazione personale e il radicamento locale. Non credo che questo significhi veder ridotta la propria capacità di aspirare. Talvolta invece le difficoltà legate al contesto nel quale si vive rappresentano un ulteriore stimolo alla riflessività nella progettazione del proprio percorso. In ogni caso mi sembra confermata, anche nel piccolo campione preso in considerazione in questa ricerca, l’ipotesi di Viesti per cui le migrazioni interne si muovono tra due motivazioni opposte, ma compresenti: insoddisfazione per il contesto sociale in cui si vive ed entusiasmo per l’emigrazione; forte radicamento locale e percezione dell’emigrazione come costrizione necessaria (Viesti 2005). I fenomeni migratori hanno la capacità di essere ‹‹specchio dei più generali nodi problematici della società in cui si trovano a crescere›› (Colombo 2007: 65). E così nell’esperienza dei figli dell’immigrazione si incontrano due “Calabrie”: la Calabria terra di immigrazione e la Calabria terra di emigrazione. Una Calabria plurale, ricca di contraddizioni, quella che è possibile osservare con gli occhi dei figli dei migranti: Io ho viaggiato molto. Potevo scegliere di rimanere a Milano, continuare a vivere a Bologna, di continuare a vivere 7 http://terrearse.it/progetto-sud-altrove/. 8 Cfr. relazione Istat disponibile online all’indirizzo http://www.istat.it/it/files/2011/02/Barban.pdf. 150 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228748 Simona Miceli fuori. Ho scelto di vivere qui perché è casa mia, cioè amo il sole, il mare, vuoi o non vuoi la gente. Qui è casa… Per questo quando dicono la Calabria è a parte, cioè non c’entra niente con l’Italia, io dico ‹‹Sì›› con tutto il sorriso e il cuore. Cioè, voi non avete idea cosa vuol dire la Calabria, il Sud in generale. Qui è il Mediterraneo, cioè l’Italia a un certo punto si perde, si ferma… ed è vero… Per quanto possiamo avere problemi con la ‘ndrangheta, il lavoro che non c’è, la spazzatura, i rifiuti chimici, noi abbiamo anche cose che gli altri non hanno. Perché casa mia è qua, purtroppo forse, non lo so… (Zahra, 28 anni). Conclusioni provvisorie La ricerca di cui si è dato conto è esplorativa e di piccole dimensioni. L’obiettivo non era quello di trarre delle generalizzazioni universalizzabili, quanto invece di individuare ulteriori piste di ricerca. Alcuni dei casi presentati in queste pagine suggeriscono di sviluppare una possibile lettura della capacità di aspirare come strumento di resistenza all’immaginario coloniale che, per una serie di motivi brevemente richiamati, opera in maniera più o meno esplicita nella società italiana. Vivere in una società postcoloniale significa fare i conti con le nuove diseguaglianze conseguenti la storia coloniale. Ma la parola “postcoloniale” contiene in sé anche il significato di “anti-coloniale” (Mellino 2009): se nella nostra società si riproducono dispositivi di domino analoghi a quelli dell’epoca coloniale, si sviluppano anche pratiche quotidiane di resistenza che cercano di contrastarli. In questa direzione ho ritenuto che potesse essere interessante applicare il concetto di “aspirazione” alla realtà dei giovani di origine straniera. Se lo sguardo coloniale cerca incessantemente di costruire delle non persone (Dal Lago 2004), aspirare a qualcosa significa affermare la propria identità e la propria soggettività nel presente e proiettarle nel futuro attraverso la progettazione di un percorso plausibile. Come ho cercato di mostrare, un atteggiamento di questo genere mi è sembrato abbastanza diffuso. Alla consapevolezza delle difficoltà presenti per il mondo giovanile si accompagna la capacità di individuare strade percorribili ma anche soddisfacenti (ciò che ho chiamato strategia del compromesso); l’amarezza di sentirsi stranieri, giuridicamente o sul piano dell’identità, nel paese che si sente proprio può essere compensata dalla costruzione di appartenenze molteplici e dalla percezione di essere responsabili per la propria famiglia; le difficoltà legate al contesto locale in cui si vive non vengono accettate passivamente: tanto l’ipotesi di emigrare quanto il desiderio di rimanere e contribuire a “migliorare” la propria terra, rappresentano due modi per non subire le difficoltà, ma per fronteggiarle. Guardare ai figli dell’immigrazione attraverso il prisma delle loro aspirazioni significa non limitarsi alla condizione presente, i cui dati - come il successo scolastico, l’occupazione o l’accesso alla cittadinanza- inducono a valutazioni abbastanza negative; ma cogliere le potenzialità di una generazione sociale che, anche attraverso i progetti e l’immaginario sul proprio futuro, porta avanti quotidianamente, e forse inconsapevolmente, una lotta alle pratiche neo-coloniali ancora in atto in Italia. Come sostiene Appadurai, la capacità di aspirare è distribuita in maniera diseguale tra i membri di una società. La deduzione più scontata è che si presenta in maniera maggiore nelle fasce sociali avvantaggiate. Non si intende smentire questa affermazione. Tuttavia le storie di “seconda generazione” di cui si è parlato in questa sede invitano a sviluppare il legame tra la capacità di aspirare e la posizione sociale anche in un’altra direzione. Talvolta sentire di poter migliorare la propria condizione è uno stimolo a impegnarsi per farlo. Nel caso dei figli e delle figlie dei migranti, a differenza dei poveri di Mumbai, non essere parte delle fasce sociali più alte non dipende necessariamente dal reddito. Attribuirei il loro posizionamento sociale più alle questioni che sono state presentate come ostacoli alla capacità di aspirare, quali lo status giuridico o l’immaginario sociale (anti)multiculturale. Molto si giocherà sullo spazio che la nostra società sceglierà di attribuire, o negare, ai migranti e ai loro figli. Ma ciò che si voleva mettere in luce nel corso di queste pagine è che qualcosa dipenderà anche dalla capacità di aspirare dei giovani di origine straniera, che non si mostrano come soggetti passivi travolti dagli ostacoli di cui si è parlato. Al contrario appaiono dotati di una certa agency, ovvero quella capacità di agire socio-culturalmente costruita che si colloca nella tensione tra la struttura socio-culturale e la capacità di contrastarla, pur essendone inevitabilmente condizionati. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 151 Simona Miceli DOI: 10.1400/228748 Se dunque è importante tener conto delle tendenze generali che attraversano una società, altrettanto interessante è ricorrere alle storie di vita e indagare le pratiche e le costruzioni di senso che ciascuno mette in atto nella vita quotidiana, perché in fondo è proprio lì che si stabiliscono gli equilibri tra i fattori macro-sociali e i percorsi biografici individuali. Riferimenti bibliografici Ambrosini M. (2004), Il futuro in mezzo a noi. Le seconde generazioni scaturite dall’immigrazione nella società italiana dei prossimi anni, in A. Ambrosini, S. Molina (a cura di), Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Torino: Edizioni Giovanni Agnelli: 1-53. Ambrosini M., Caneva E. (2009), Le seconde generazioni. Nodi critici e nuove forme di integrazione, in ‹‹Sociologia e politiche sociali››, 12: 25-46. Appadurai A. (2004), The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition, in V. Rao , M. Walton (eds), Culture and Public Action, Stanford: Stanford University Press. Bauman Z. (1999), La società dell’incertezza, Bologna: Il Mulino. Beccalli B. (2012), Questioni di rappresentanza delle aspirazioni, in O. De Leonardis, M. Deriu (a cura di), Il futuro nel quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare, Milano: Egea: 161-169. Beck U. (2000), La società del rischio.Verso una seconda modernità, Roma: Carocci. Bertani M., Di Nicola P. (2009, a cura di), Sfide transculturali e seconde generazioni, Milano: Franco Angeli. Bettin Lattes G. (2001), I giovani europei tra futuro e presente. La condizione giovanile e il tempo storico, in ‹‹Queste Istituzioni››, 123: 15-29. Caritas e Migrantes (2014), XXIII Rapporto immigrazione 2013.Tra crisi e diritti umani, Todi (PG): Tav editrice. Chambers I. (2003), Paesaggi migratori. Cultura e identità nell’epoca postcoloniale, Roma: Meltemi editore. Colombo E. (2007), Molto più che stranieri, molto più che italiani. Modi diversi di guardare ai destini dei figli di immigrati in un contesto crescente di globalizzazione, in ‹‹Mondi migranti››, 1: 63-85. Colombo E. (2012), Immaginario e differenza. Le aspirazioni multiculturali dopo la crisi del multiculturalismo, in O. De Leonardis, M. Deriu (a cura di), Il futuro nel quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare, Milano: Egea: 51-64. Colombo E., Leonini L., Rebughini P. (2009), Nuovi italiani. Forme di identificazione tra i figli di immigrati inseriti nella scuola superiore, in ‹‹Sociologia e politiche sociali››, 12: 59-78. Colucci M., Gallo S. (2014), L’arte di spostarsi. Rapporto 2014 sulle migrazioni interne in Italia, Roma: Donzelli editore. Dal Lago A. (2004), Non persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Milano: Feltrinelli. De Leonardis O., Deriu M. (2012, a cura di), Il futuro nel quotidiano. Saggi sociologici sulla capacità di aspirare, Milano: Egea. Del Boca A. (2005), Italiani, brava gente?, Vicenza: Neri Pozza Editore. Derobertis R. (2012), Southerns, Migrants, Colonized: a Postcolonial Perspective on Carlo Levi’s Cristo si è fermato a Eboli 152 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228748 Simona Miceli and Southern Italy Today, in C. Lombardi-diop, C. Romeo (eds), Postcolonial Italy. Challenging National Homogeneity, Palgrave Macmillan, New York:157-171. Granata A. (2011), Sono qui da una vita. Dialogo aperto con le seconde generazioni, Roma: Carocci. Hirshman A. (1970), Exit,Voice and Loyalty, Cambridge: Harvard University Press. Jedlowski P., Siebert R. (2011), Memoria coloniale e razzismo, in A. Mammone, N. Tranfaglia, G.A. Veltri (a cura di), Un paese normale? Saggi sull’Italia contemporanea, Milano: Dalai: 231-251. Jedlowski P. (2012), Il senso del futuro. I quadri sociali della capacità di aspirare, in O. De Leonardis, M. Deriu (a cura di), Il futuro nel quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare, Milano: Egea: 1-17. Jedlowski P. (2012b), In un passaggio d’epoca. Esercizi di teoria sociale, Napoli: Orthotes. Labanca N. (2002), Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna: Il Mulino. Lagomarsino F., Ravecca A. (2014), Il passo seguente. I giovani di origine straniera all’università, Milano: Franco Angeli. Leccardi C. (2012), I giovani di fronte al futuro: tra tempo storico e tempo biografico, in O. De Leonardis, M. Deriu (a cura di), Il futuro nel quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare, Milano: Egea: 31-50. Lombardi-diop C., Romeo C. (2012, eds), Postcolonial Italy. Challenging National Homogeneity, New York: Palgrave Macmillan. Mandich G. (2012), Il futuro quotidiano. Habitus, riflessività e capacità di aspirare, in O. De Leonardis, M. Deriu (a cura di), Il futuro nel quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare, Milano: Egea: 19-30. Mannheim K. (1924), Essays on the Sociology of Knowledge, London: Routledge & Kegan Paule, 1952. Mellino M. (2009), Cittadinanze postcoloniali. Appunti per una lettura postcoloniale delle migrazioni contemporanee, in ‹‹Studi culturali››, 2. Mellino M. (2012), Cittadinanze postcoloniali. Appartenenze, razza e razzismo in Europa e in Italia, Roma: Carocci. Palermo P. (2011), Dalle leggi razziali a quelle “razziste”? Proposte di comparazione fra alcune “declinazioni” della discriminazione, in ‹‹Mondi migranti››, 3: 215-228. Rampazi M. (2002, a cura di), L’incertezza quotidiana. Politica, lavoro e relazioni nella società del rischio, Milano: Guerini. Rampazi M. (2012), Una questione di rispetto. La costruzione del futuro nell’esperienza dei giovani, in O.De Leonardis, M. Deriu (a cura di), Il futuro nel quotidiano. Studi sociologici sulla capacità di aspirare, Milano: Egea: 83-99. Said E. (1978), Orientalism, New York: Pantheon Books. Schizzerotto A. (2002), Vite ineguali. Disuguaglianze e corsi di vita nell’Italia contemporanea, Bologna: Il Mulino. Schneider J. (1998), Italy’s “Southern Question”: Orientalism in One Country, Oxford and New York: Berg. Siebert R. (2003), Il razzismo. Il riconoscimento negato, Roma: Carocci. Spivak G. (1999), A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present, Cambridge: Harvard University Press. Tirabassi M., Del Prà A. (2014), La meglio Italia. Le mobilità italiane nel XXI secolo, Torino: Academia Univesrity Press. Triulzi A. (2005), Lo sguardo coloniale, in C. Pasquinelli (a cura di), Occidentalismi, Roma: Carocci. Triulzi A. (2008), Ritorni di memoria nell’Italia postcoloniale, in R.Bottoni (a cura di), L’impero fascista: Italia ed Etiopia, 1935-1941, Bologna: Il Mulino. Triulzi A. (2011), Memorie e voci erranti tra colonia e postcolonia, in U. Chelati Dirar, S. Palma, A. Triulzi, A. Volterra (a cura di), Colonia e postcolonia come spazi diasporici. Attraversamenti di memorie, identità e confini nel corno d’Africa, Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 153 Simona Miceli DOI: 10.1400/228748 Roma: Carocci. Unar (2013), Immigrazione Dossier Statistico 2013. Dalle discriminazioni ai diritti, Pomezia: Age. Verdicchio P. (1997), The Preclusion of Postcolonial Discourse in Southern Italy, in B. Allen, M. Russo (eds), Revisioning Italy: National Identity and Global Culture, Minneapolis and London: University of Minnesota Press: 191.212. Viesti G. (2005), Nuove migrazioni. Il “trasferimento” di forza lavoro giovane e qualificata dal Sud al Nord, in ‹‹Il Mulino››, 4: 678-688. Wihtol De Wenden C. (2004), Giovani di seconda generazione. Il caso francese, in A. Ambrosini, S. Molina (a cura di), Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Torino: Edizioni Giovanni Agnelli: 107-128. 154 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Contributions Anno IV, Numero 7/Giugno 2014 155 DOI: 10.1400/228749 Franco Rositi [Il populismo e l’eguaglianza immaginaria] 1. Definito come dirò, il populismo è nello stesso tempo un sintomo e un produttore dell’attuale crisi della democrazia nel nostro Occidente. La definizione che ho in mente è però molto più ristretta di tante altre in circolazione. In breve: antieuropeismo in genere, estrema destra, girotondi, la “rete” di Orlando, sindacati contrari all’abolizione dell’art. 18, antipolitica, anti-élitismo ecc., sono cose che con troppa leggerezza sono messe tutte insieme sotto la stessa etichetta di populismo, in specie nella letteratura in lingua inglese. Occorre invece, a mio giudizio, tenerle separate da un nucleo ideologico, sentimentale e morale che è caratterizzato dalla credenza che una partecipazione competente, e perfino democratica, al governo dello Stato sia a immediata disposizione del buon senso di chiunque (e pertanto del “popolo”), appunto senza mediazioni. Questo nucleo può anche, a volta a volta, contenere, in modo massiccio o marginale, alcune delle “cose” che ho elencato, ma vi aggiunge certo tono di frivola confidenza verso la propria positività e la propria forza, tale da rendere meno drammatica e meno guerriera la stessa indicazione dei nemici. D’altra parte, ciascuna di quelle “cose” può convivere, a volta a volta, con qualcosa della sindrome populista come io la penso. Sebbene io non sia uno specialista né del tema specifico né del sottosistema politico in genere, mi sembra che qualche guadagno di conoscenza possa venire da una definizione ristretta di populismo. Dovrò ovviamente precisarla; quanto detto finora è semplicemente allusivo e, spero, evocativo. Se vi insisto è per due motivi. Il primo consiste nel timore che l’etichetta venga indistintamente usata come denigratoria di qualsiasi prassi politica diversa dal modello di democrazia liberale, un po’ come sinonimo di una “politica di piazza”: come di cosa opposta all’ordine della rappresentanza elettorale o del diligente associazionismo civile su issues specifici. Il secondo motivo consiste nella convinzione che in realtà una definizione ristretta nel senso fin qui alluso copra un fenomeno ancor più pericoloso dei numerosi estremismi che attraversano le nostre democrazie: credo che il potenziale di mobilitazione contro gli estremismi eversivi o catastrofici sia nelle nostre società molto forte, mentre certa inclinazione al divertissement da parte dei media e nelle abitudini della vita quotidiana, nonché quelle retoriche dell’eguaglianza che sono presenti nella democrazia occidentale fin dalle sue origini, ci lascino indifesi nei confronti della verve spettacolare del populismo come da me inteso. Lo chiamerò talora, per escludere anche fenomeni più antichi, populismo contemporaneo. Posso ora avanzare una seconda premessa: io considero questo populismo contemporaneo come il sintomo di una malattia per la quale non ci sono cure di effetto immediato, una sorta di deperimento organico che chiederebbe, per essere superato, che un regime di vita socio-culturale più salubre si protraesse per un periodo molto lungo in modo metodicamente organizzato (scuola, occasioni e tempi di apprendimento per estese fasce di popolazione, mezzi di comunicazione di massa, rete), e che inoltre la scena politica fosse, ancora per un periodo molto lungo, attraversata da conflitti politici più seri di quelli attuali, ma anche meno parcellizzati e meno corpuscolari. Di fronte a una premessa di questo tipo, si può avere il sospetto che così si vogliano avanzare pretese tanto radicali quanto irrealistiche, e che sia più conveniente tornare alle urgenze quotidiane della politica, le quali, com’è noto, sono molto gravi in una fase del capitalismo senza sviluppo (o con sviluppo molto debole). In Italia, in particolare, sembra che le attese più ragionevoli siano per un governo che lasci per così dire nel loro brodo tutte le forme di populismo e che assuma come compito soltanto il rimedio alle diffuse deficienze organizzative, allo spreco e al protrarsi di fenomeni di criminalità organizzata e di corruzione nei quartieri alti della società. Ed è innegabile che queste ultime siano attese molto ragionevoli. Ma davvero si spera che una realistica laboriosità sulle tante circoscritte urgenze quotidiane possa essere sufficiente per attenuare il generale malessere dei nostri giorni? Si può riprendere quella via di sviluppo robusto Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 157 Franco Rositi DOI: 10.1400/228749 che farebbe dissipare tutti i fantasmi attuali della cattiva politica? E soprattutto: si può farlo tutti insieme (com’è stato nei “magnifici” vent’anni dell’ultimo dopoguerra), non un paese a scapito di altri, non alcune regioni e altre no? Il libro di Thomas Piketty è stato convincente, mi sembra di poter dire in breve, nel mostrare che un capitalismo a sviluppo debole o assente produce diseguaglianza sociale sempre maggiore e conseguente deterioramento del legame democratico, cosicché una redistribuzione della ricchezza a favore della crescita diventa urgente. E si ricordi che le economie dei paesi occidentali zoppicano almeno dagli anni ’70 del secolo scorso, quando già la sociologia critica (in particolare Claus Offe, allievo di Habermas, in Germania), e non solo le preoccupate diagnosi della Trilateral, ambigue dal punto di vista democratico, individuavano le ragioni di un appannamento del Welfare nell’avvitamento reciproco fra costi delle politiche sociali e crisi economica (i primi sempre più necessari davanti alla crisi, questa sempre meno contrastabile con interventi keynesiani non assistenziali, divenuti troppo costosi, e così via in corto-circuito). A partire dagli anni ’70 le due risposte principali a tale avvitamento sono state, nell’ordine, e secondo la ricostruzione fatta da Wolfgang Streek (2013), l’inflazione e l’indebitamento degli Stati (siamo ancora in questa seconda fase, e mi sembra si cerchi di uscirne tornando all’inflazione, Germania permettendo). Di fronte al perdurare nel mondo occidentale di un ciclo economico negativo (con eccezioni parziali: alcuni paesi e alcuni brevi sottocicli), sbiadisce la speranza di un ritorno spontaneo (automatico) alla grande continuativa crescita che fra 1945 e 1970 provocò anche un ridursi della diseguaglianza: sono sempre più numerosi gli osservatori che si rendono conto della necessità di interventi che siano più strutturali di quanto siano inflazione e indebitamento, in pratica la necessità di un controllo mondiale del gioco finanziario (si vedano in particolare i libri di Luciano Gallino) e di prelievi sulle “grandi ricchezze” anche mediante più rigorosi controlli fiscali (nonché reindirizzi della produzione e del consumo). Ma come ottenere governi capaci di tanto? Le pratiche vigenti per la formazione del consenso, e il generale clima culturale nel quale si forma il discorso pubblico-politico, non sembrano consentirlo. Il termine “populismo” viaggia oggi quasi con la stessa frequenza e con la stessa velocità del termine “crisi economica” nei commentari quotidiani della politica. Per citare il titolo di un buon testo (Albertazzi, McDonnel 2008), il populismo si aggira come il nuovo, ultimo spettro nelle società occidentali già affaticate dalla crisi economica. Mal definito, lo spettro diventa tanto più inafferrabile. 2. Mettiamo da parte qualsiasi riferimento al populismo russo del XIX secolo (con forte enfasi sulla tradizione religiosa del popolo oppure, nella variante della definizione di Lenin, con quella vena di forte anticapitalismo che è particolarmente adeguato alla mentalità di piccoli produttori); e così anche trascuriamo certi fenomeni tipici dell’America Latina, da Peron a Chavez (laddove “popolo” è, o comunque era, una stragrande maggioranza di poveri). Ci si riferisca soltanto ai nostri giorni, e alle società del cosiddetto mondo occidentale, non certo ancora complessivamente povere (nonostante gli incrementi dei loro indici di povertà). Se poi abbiamo in mente soprattutto il caso italiano, i lettori e chi scrive appartenendo a tale contesto, non credo possa derivarne un pregiudizio: i dati parcellizzati e modesti della ricerca sociale dicono molto meno di quanto sia disponibile alla quotidiana osservazione del fenomeno che noi tutti purtroppo possiamo fare de visu. Del resto qualcuno ha già rappresentato il nostro paese come il “paradiso” e il “più fertile terreno sperimentale” per gli studi su questo tema (Zanatta 2002). Da parte mia voglio ricordare che fra le prime tracce di attribuzione del fenomeno Lega-Bossi al populismo ci sono alcune intelligenti pagine di Roberto Biorcio nel libro sulla lega che Mannheimer curò nel 1991. In Italia inoltre abbiamo il precedente de L’Uomo Qualunque di Giannini, che però fu fenomeno abbastanza isolato ed ebbe vita breve (a essere larghi, fra 1944 e 1948). Pur così circoscritto negli ultimi vent’anni del mondo occidentale, il termine populismo, come abbiamo già detto, ha spesso nella letteratura una estensione eccessiva. Tale dispersione semantica è dipendente dal numero e dalla scarsa distintività degli attributi che gli sono normalmente associati. Si analizzi per esempio l’elenco di attributi presenti in letteratura secondo la ricostruzione che ne ha fatto Marco Tarchi (2008): a) La tendenza dei suoi leaders a invocare per se stessi una capacità straordinaria e immediata di interpretare i bisogni del popolo. b) L’insofferenza verso le regole formali della democrazia liberale che ostacolano la missione di promuovere 158 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228749 Franco Rositi il bene pubblico. c) Il frequente riferirsi al senso comune del popolo normale e alla tradizione condivisa dalla maggioranza della comunità d) Le accuse rivolte ai politici di professione e alle loro procedure di differimento, così come agli intellettuali e ai sindacati, imputati di voler dividere il popolo in classi. Non credo si possano individuare molte differenze formali fra questa rappresentazione del populismo e gli attributi con cui potremmo pensare a varie sindromi di estrema destra, fascismo compreso. Si tratta ovviamente di percorsi politici molto diversi, ma se si resta alla lettera di quell’elenco degli attributi non si possono cogliere cesure significative. Ed è frequente infatti che nella letteratura sui casi di populismo si mettano, fra questi casi, sia movimenti e partiti di estrema destra, con i loro lugubri stendardi della violenza, sia cose nostrane come la Lega, con i suoi comici cerimoniali di Medioevo e di ampolline (e con qualche violenza verbale, quale è anche il turpiloquio, e qualche “ammuina” di violenza comportamentale). Accade del resto che anche l’antieuropeismo venga comunemente arruolato nelle file populiste. Ovviamente, se adottassimo una qualsiasi definizione convenzionale potremmo trovarci d’accordo nell’osservare alcune somiglianze fra tutti i vari partiti o movimenti che “esprimono insofferenza verso le regole formali della democrazia liberale” e verso le burocrazie di Bruxelles: certo antieuropeismo, in particolare nel Nord Europa, è fra questi, e accomuna talora estrema destra e le parti più demagogiche del fronte conservatore, così come perfino alcuni estremismi di sinistra. Ma in questo modo non coglieremmo qualcosa di molto importante, quella paciosa e perfino festaiola convivenza con la prosa quotidiana della nostra società che è tipica in particolare del populismo italiano attuale (nonostante il saltuario dileggio delle istituzioni) e che forse nasconde il bradisismo più pericoloso per le nostre democrazie. Spero che quanto dirò via via renda più chiare queste affermazioni. Occorre dunque aggiungere alcuni attributi. Ma anche fare precisazioni su quelli comunemente adottati. Si pensi per esempio al problema del leaderismo, la nota sindrome della personalizzazione del comando politico. Non è cosa nuova - e del resto un leader visibile è un dispositivo generalmente utile per associare una moltitudine. Dovrebbe essere di piena evidenza che il darsi di un leader non è di per sé una malattia politica. Le differenze sorgono fra vari tipi di leader. Ancora nessuna differenza è però costatabile a riguardo all’appellarsi dei leader alla loro capacità di “costituire” e di “rappresentare” il popolo. Alcuni teorici del populismo hanno potuto allargare enormemente l’estensione del concetto di populismo proprio attribuendogli quel carattere tipicamente politico che consiste nella capacità di costituire il popolo e quindi di rappresentarlo. Si vedano in particolare Laclau (2005) e il reader a tesi di Panizza (2005), che contiene un altro saggio dello stesso Laclau. Potremmo dire che il tema viene così inserito in una cornice schmittiana: non manca neppure l’opposizione amico/nemico nella forma molto generica noi/loro, ma vi si aggiunge una maggiore attenzione all’opposizione dominanti/dominati. Ne deriva comunque che, se la missione della politica è semplicemente l’unificazione dei molti (Latour 2002), la forma suprema e positiva di politica diviene proprio lo stesso populismo così definito. Per la verità, qui tocchiamo un problema molto generale, e dolente, delle democrazie, l’ipostatizzazione non solo della idea di popolo (il «popolo introvabile» di Rosanvallon, ma, peggio, «un nome enfatico riferito a qualcosa che non c’è» secondo Sartori), ma anche l’idea di rappresentanza, con la sua ambiguità per molti versi conseguente: a risolvere, o ad attenuare la forza centripeta e totalizzante della sovranità popolare, devono essere messi immediatamente in campo (come fa anche la nostra Costituzione italiana all’art. 1) altri caratteri della democrazia, in particolare Stato di diritto, pluralismo, diritti delle minoranze, istituzioni intermedie non elettive fra Stato e cittadini, in una parola i “limiti” di quella sovranità. Ebbene, non è evidente che partiti e movimenti populisti siano sistematicamente contrari a questi correttivi. Certo essi manifestano talora strane idee sulla relazione fra consenso e legalità, ma strane enfasi sulla sovranità popolare si sono registrate anche fra rappresentanti di forze politiche più tradizionali, addirittura in difesa, per esempio, della invulnerabilità del mandato derivante da procedure sub-elettorali, quali le primarie, oppure in difesa della protezione di parlamentari dal potere giudiziario. D’altra parte, gli stessi correttivi al principio maggioritario sono di frequente messi in questione, da attori politici established, con la semplice e irriflessa giustapposizione all’idea di sovranità popolare (lasciata per così dire indisturbata) di un altro principio, quello della governabilità. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 159 Franco Rositi DOI: 10.1400/228749 Si fa talora ricorso, per precisare lo specifico dei movimenti e partiti populisti, ad una sorta di eccesso del leaderismo. Ma stranamente non possiamo concludere mettendo su tale eccesso l’etichetta “carisma” (Chiapponi, 2013 e 2014). Sebbene questa etichetta sia ormai inflazionata, essa continua a connotare qualcosa di religioso, una “straordinarietà” (è il termine weberiano) del capo carismatico la quale non esige affatto da parte dei seguaci i buoni sentimenti tipici della quotidianità, simpatia affezione vicinanza, ed esige invece devozione, qualcosa di più di quella “deferenza” verso autorità e istituzioni che la letteratura politologica ha talora attribuito alle buone democrazie (Kavanagh 1980). Questa devozione ha il suo contrappeso nei doveri che assume il capo carismatico, in particolare capacità di sacrificio, isolamento o distanza, e rigore fino alla neutralità affettiva. Ebbene, possiamo ora già cogliere qualcosa di molto distintivo nei movimenti e partiti populisti (lasciando da parte qualche caricatura del carisma, come le pose da guru di Casaleggio): i loro leader non solo non sono carismatici, ma addirittura sono il contrario, essi semmai eccedono in potere, non in una mistica dell’autorità. Hanno certo un seguito e una corte, ma pochi fedeli nel senso forte di questo termine. Sembra che la loro maggiore aspirazione consista nell’ottenere l’amore e la simpatia della gente (per avere potere o in aggiunta al potere). Si trascurino di nuovo i vari leader di destra e di estrema destra, e non si insista troppo sulla generica attitudine alla demagogia che, ridotta alle pratiche di invenzione del nemico e di propagazione di false promesse, è molto ubiqua nel tempo e nello spazio, e che certamente appartiene anche alla sindrome populista. Isoliamo invece quei leader che hanno per così dire ostentato la loro appartenenza al mondo della “gente comune”, con un eloquio linguisticamente approssimativo (per esempio George W. Bush, Antonio Di Pietro), oppure con gesti scanzonati e con superficiale edonismo (per esempio Silvio Berlusconi), oppure con il turpiloquio (per esempio Umberto Bossi e Beppe Grillo). Ridurre a questi pochi nomi un fenomeno che a una vasta schiera di osservatori appare molto esteso, e che addirittura da taluni è pensato come uno Zeitgeist, può sconcertare. Inoltre va precisato che, per ciascuno dei nomi fatti, la fiorente letteratura che li riguarda è piena di dubbi o reticenze nell’associarvi l’etichetta di populismo. Così ultimamente, per esempio, Biorcio e Natale (2013), Corbetta e Gualmini (2013), Diamante e Natale (2013) esprimono tutti riserve sulla opportunità di chiamare populista Grillo e il suo 5 Stelle, un po’ in vista di certe sue possibilità di trasformazione (del resto, non occorre mettere limiti alla Provvidenza), un po’ per certo favore alla giustezza di alcune sue polemiche, ma soprattutto, a mio parere, in ragione di una definizione incerta. Sembra talora che sarebbe conveniente ridurre il populismo ad una variabile fuzzy (che possiamo misurare solo per gradi di appartenenza), talaltra che miglior partito sarebbe di mettere tante lettere a pedice del termine quanti sono i suoi significati. Da parte mia, quel che sto cercando di fare è di limitarmi al populismo contemporaneo e non fascista né fascistoide, escludendo quanto non gli appartenga in modo forte e sicuro, includendo anche i casi di indifferenza all’asse destra-sinistra, trovando una proprietà significativa e le sue varie derivazioni. Mi riferirò d’ora in avanti esclusivamente all’Italia. Per quel che ne so, anche in altri paesi occidentali sono presenti componenti populiste del tipo di quelle italiane. Soprattutto lo stile di Bush jr. in America potrebbe reggere il confronto con le esibizioni nostrane. In fin dei conti è nata in quel paese quella politica-spettacolo (in verità come spettacolo della banale quotidianità) che, come preciserò in seguito, è una matrice della riduzione della politica all’inerzia del senso comune. Ma parlare di altri paesi richiederebbe dover organizzare molta informazione dispersa e non potersi avvalere di evidenze: un compito che eccede i limiti di questa nota. So bene che la realtà della Lega, di Forza Italia, dell’Italia dei valori, di M5S, e, per allargarci almeno un po’ rispetto all’Italia, di Bush jr. e Sarah Palin, è molto complessa e contiene molto altro al di là di un nucleo ideologico-culturale, nonché marcate interne differenziazioni. Cionondimeno esplorare questo nucleo può essere istruttivo altrettanto quanto conoscere la composizione sociale degli elettori e gli interessi “razionali” intervenienti. Si dovrebbe a mio parere partire dalla salda convinzione che un calcolo degli interessi (o un voto di scambio) è assente in un numero rilevante degli elettori e seguaci di quelle formazioni politiche. Approssimiamoci dunque, con quegli esempi in mente, al tipo ideologico (o culturale) puro di populismo contemporaneo. Possiamo a mio parere attribuirgli, insieme ad altri caratteri poco distinguenti, il carattere fortemente distinguente della ostentazione di una identità, o di una sostanziale uguaglianza, fra capi e seguaci: alcune doti di grande o di enorme ricchezza, di abilità e di forza fisica, restano appannaggio dei leader, ma non una superiore moralità né una superiore capacità di visione su ciò che è decisivo o ultimo. I leader non sono “migliori”, possono essere più imprenditivi, o più tenaci, o più eloquenti ecc., ma non sono più intelligenti nel senso di più 160 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228749 Franco Rositi capaci di “andare al cuore delle cose” (avrebbe detto Aristotele maggiore diànoia, non maggiore nous!). Si realizza così, forse per la prima volta nella storia, quel modello di «rappresentanza descrittiva» che fu proposto quasi mezzo secolo fa da Pitkin (1967), ma non nel senso di un gruppo di rappresentanti che ha la stessa composizione socio-culturale dei rappresentati (le stesse proporzioni di rilevanti caratteri socioeconomici, razziali, di genere ecc.), bensì nel senso di una immaginaria identità morale: come se i rappresentanti fossero lo specchio non deformante in cui i rappresentati possano vedere riflesso qualcosa che è per loro essenziale, senza sublimazioni e senza proiettare sull’altro impossibili desideri, vedere dunque riflessa la nostra normale mediocrità e le nostre ragioni. Sono per esempio convinto che l’ammirazione e la simpatia che ha avuto in Italia Silvio Berlusconi, anche da parte di tanta “povera gente” che non poteva certo esercitare un voto di scambio, non si deve a una proiezione su di lui del nostro comune sogno di ricchezza, ma all’idea che “nonostante la sua enorme ricchezza, egli è proprio come noi, niente di più”. È veramente troppo imputare a quote non marginali di popolazione la follia di desiderare le ricchezze di Berlusconi, e non la più ragionevole stima per una persona che non ha frainteso la propria fortuna come superiorità morale. 3. Siamo così giunti vicini al centro di quel carattere che molti osservatori hanno attribuito al “populismo”: l’antielitismo. Se non occorre superiorità morale per esercitare potere politico, è da condannare qualsiasi élite che sia, se si permette il gioco, elitaria. È questo un carattere che dovrebbe immediatamente escludere tanta parte dei partiti di estrema destra, i quali, in linea con la tradizione fascista, mantengono saldo il “principio del capo” come condottiero e creatore di fini (e se non ancora dispongono in concreto di un capo, lo attendono) e, più in generale, considerano come valore positivo una gerarchia moralmente costituita. Per essere conseguente, l’antielitismo non deve sciogliersi nella critica a queste élites (una critica che spesso è purtroppo facilmente condivisibile), ma deve mostrare diffidenza verso qualsiasi posizione superiore che non si risolva in pura funzione strumentale, in pura tecnica. Creatività e moralità sono del popolo, lo Stato sia uno Stato di funzionari, di amministratori. Era questa la posizione esplicita, e più volte insistita, di Guglielmo Giannini, fondatore e capo de L’Uomo Qualunque. Del resto, in linea con la fiducia nelle capacità intellettive del buon senso popolare, il controllo delle tecniche amministrative è pensato essere alla portata del comune cittadino. Certa ostilità verso i poveri intellettuali (difficilmente assimilabili ai “poteri forti”) è spiegabile solo entro una sindrome antielitaria di questo tipo. In particolare sono presi di mira gli intellettuali non tecnici (o non soltanto tecnici). Tanta antipatia popolare che, qualcuno ha detto, affligge la sinistra sarebbe dovuta proprio a quella fatua esibizione di superiorità morale (di nous!) che sarebbe tipica dei numerosi intellettuali-commentatori che la affollano. Gli scienziati, purché non al soldo dei potenti, sono altra cosa: essi non palesano, normalmente, un punto di vista superiore sulle questioni umane. È noto quanto durò poco, tanti anni fa, l’idillio fra Bossi e Miglio. Dovrebbe essere infine stupefacente constatare come tutte le formazioni politiche di cui stiamo discutendo siano assimilabili proprio per il bassissimo numero di intellettuali medio-alti al loro seguito, e perfino per un basso numero di giornalisti. L’anti-intellettualismo ha radici molto antiche, e non è circoscrivibile entro la sindrome contemporanea del populismo. Sarebbe interessante ricostruirne la storia - e per prima cosa constateremmo che spesso i più spietati propagatori di anti-intellettualismo sono appartenuti proprio al ceto degli intellettuali. Si può comunque, con una sommaria ricostruzione storica, suddividere l’anti-intellettualismo moderno in tre sottotipi, a seconda del motivo principale che lo anima: a) gli intellettuali sono accusati per le specifiche idee politiche che la loro maggioranza professa, in un determinato periodo e in una determinata società. In fin dei conti il quarto degli elementi elencati da Tarchi («voler dividere il popolo in classi») appartiene a questo sottotipo. Ugualmente gli appartiene, probabilmente, il maccartismo americano fra fine anni quaranta e primi cinquanta del secolo scorso, sebbene, come mostra la ricostruzione di Richard Hofstadter, nel vasto consenso popolare di cui godette la “caccia alle streghe” di Joseph McCarty erano presenti anche generiche antipatie per la supponenza delle “teste d’uovo”. Ma specifiche imputazioni politiche generalizzate sono state fatte anche da sinistra, da Paul Nizan fino al più attuale Serge Halimi (con l’approvazione di Pierre Bourdieu); b) gli intellettuali sono accusati della costruzione di mondi autoreferenziali, nei quali essi si rivestono di plumes et plumages, si assegnano il ruolo di maîtres à penser, di arbitri del gusto, di guide verso il futuro, di giudici morali — insomma, meno invisi per ciò che dicono che per Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 161 Franco Rositi DOI: 10.1400/228749 come lo dicono, per l’arroganza che mostrano, per la distanza che mettono dai reali, comuni, quotidiani problemi della “gente”; c) infine, accusati per un perfetto mix delle due precedenti imputazioni. Ebbene, l’anti-intellettualismo del populismo contemporaneo è a mio parere caratterizzato dai motivi b) e c). Per la verità, nel movimento-partito che è stato di Di Pietro era assente una specifica esplicita polemica contro gli intellettuali, ma il fraseggio e la mimica del leader erano almeno l’autorizzazione dell’atteggiamento presente nel tipo b). In Forza Italia è prevalso il terzo tipo, il mix di accusa di comunismo e di arroganza. Nella Lega di Bossi, lasciando da parte le recenti evoluzioni e alcune componenti più serie, è prevalso il secondo tipo. Nel Movimento 5 Stelle di Grillo assistiamo a un indubbio favore per quella parte della ricerca scientifica che promuove le preoccupazioni ecologiche, ma le pratiche comunicative, e lo stesso opinionismo in briciole della rete, sono una perentoria negazione di fatto delle funzioni della ricerca intellettuale. 4. Potrebbe sembrare, in definitiva, che nel populismo contemporaneo si depositino ideali egualitari. Ma a ben guardare non si tratta di una drammatica domanda di eguaglianza, come era nella tradizione illuminista e poi nella lunga storia del movimento operaio; si tratta invece della esibizione di una eguaglianza già attuale, comunque a portata di mano non appena ci si sia liberati da qualche casta parassitaria e dai “poteri forti”. Non occorrono “biblioteche popolari”, né scuole di formazione politica, né studiare, e neppure infine occorre rivoluzionare le strutture fondamentali della società. I leader rappresentano immediatamente moralità e sapere comuni, non ne sono, neppure in parte, produttori. Le ideologie sono un artificio intellettualistico che il buon senso della gente normale non può che disdegnare. Il professionismo politico non è necessario: sono sufficienti pochi mesi per apprendere tutto quello che in politica c’è da apprendere. È interessante annotare che tale ideologia della eguaglianza già attuale si è sviluppata, particolarmente in Italia, proprio negli anni in cui è cresciuta, anche in Italia, la diseguaglianza, e non solo quella fra i più alti centili di reddito-patrimonio (le “grandi ricchezze”) e tutto il resto. I movimenti-partiti populisti, almeno quelli italiani, non hanno alla base una rivolta contro la povertà crescente (il caso-limite è Forza Italia che ha a lungo negato la stessa crisi economica). Se oggi essi tutti assumono il cordoglio per la povertà, è solo perché questa è diventata in Italia ormai evidente, e non si può più tacerne. Alcuni studiosi hanno collegato la crescita dei movimenti-partiti populisti alle défaillances del sistema dei partiti. Il vuoto che si è creato nella capacità di rappresentanza dei partiti, nonché il vacillamento degli ancoraggi dei partiti al terreno delle associazioni, degli interessi organizzati e dei ceti di mediazione, avrebbero risvegliato una serie di energie latenti che si sono improvvisate come protagoniste del gioco politico. Questi homines novi, diversamente dai loro predecessori in momenti più normali, non si caratte-rizzano nel modo ipotizzato da Alessandro Pizzorno (1992), cioè non mostrano quella accentuata disposizione a comportamenti corruttivi la quale è facilitata dai più bassi costi morali che la devianza ha per quanti siano, come loro, liberi dal controllo di gruppi di appartenenza. Questi homines novi del populismo sono imprenditori di nuova politica e possono perfino sfidare regole del gioco, legalità, i “lacci e lacciuoli” dell’ordine costituito: una sfida pubblica, esplicita, argomentata, spregiudicata, non la devianza che semplicemente tende a restare nascosta. Essi possono farlo in ragione della propria forza e dell’altrui debolezza. È vero che qualcosa come lo sfruttamento del vuoto politico determinato dalla crisi dei partiti sia in parte all’origine delle fortune politiche di Berlusconi, ma questa è a mio parere una spiegazione insufficiente del fenomeno complessivo. Quella diagnosi non spiega la sorprendente convergenza delle forze nuove nella comune sindrome dell’egualitarismo immaginario, né spiega come una forza populista quale la Lega di Bossi abbia condeterminato la crisi dei partiti tradizionali, anzi che soltanto approfittarne. Quella diagnosi inoltre ha come corollario l’idea che, dopo un certo numero di anni di apprendistato politico, anche queste forze nuove si normalizzerebbero e perderebbero i tratti di pericoloso primitivismo con cui sono venute alla luce. È tale idea che ha convinto per qualche anno un serio progressista come Giorgio Bocca a mostrare favore verso le possibilità innovative della Lega, o ha convinto alcuni seri conservatori a appoggiare agli inizi Forza Italia o, più recentemente alcuni, esacerbati dalla diffusa illegalità italiana, ad essere simpatetici con M5S (sembra che sia vero che in politica la memoria sia molto corta, e che di conseguenza si apprende molto poco dal passato). La realtà è che già un quarto di secolo della nostra storia è stato segnato dalla centralità politica di vari partiti populisti, ciascuno con caratteri 162 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228749 Franco Rositi ideologici propri e con un proprio nucleo solido di elettori sociologicamente caratterizzato (anche se la massa di elettori di ciascuno di essi resta sociologicamente quasi amorfa), ma tutti convergenti nell’idea (non importa quanto intimamente condivisa dai loro leader) di non aver costituito il proprio popolo, ma di averlo trovato già miracolosamente costituito. È questa idea adulatoria che può spiegare almeno una parte del loro successo. Quando sembrava che il fenomeno dovesse attenuarsi, ecco che è sorta la buona stella di Grillo. Deve esserci, dietro questa convergenza sorprendente, qualcosa che la produce sistematicamente. Credo che si debba dare innanzitutto attenzione all’isomorfismo di alcuni fattori più generali - o, se si vuole, più genericamente caratterizzanti alcune mutazioni avvenute nel clima culturale. 5. Io penso innanzitutto alle mutazioni avvenute nella cultura di massa tradizionale (cinema, televisione, riviste). Fino alla metà degli anni ’80 del secolo scorso, questa cultura era caratterizzata, quando non da una seria critica della società contemporanea (più frequente di quanti molti credano), da un immaginario composto da personaggi di grande valore: estetico, intellettuale, morale. Essi non erano posti così in alto da impedire identificazioni da parte del pubblico, non erano dunque esclusivo oggetto di proiezioni, ma neppure rispecchiavano la comune vita quotidiana. Gli studi di Morin, di Alberoni e miei sul divismo rispecchiano abbastanza bene quella fase. Un mondo di eroi e di eroine, di caratteri forti, di mirabili amori, di tragedie sublimi presiedeva pressoché incontrastato l’immaginario di massa. Anche nelle versioni più vicine alla vita quotidiana, come nella commedia all’italiana, risaltavano bellezza e decoro di personaggi popolari. Questa cultura di massa continua ancora, ma accanto, soprattutto per certe mutazioni dello spettacolo televisivo, si è formato, a partire dalla metà degli anni ’80, un genere narrativo orientato a dar voce alla più comune e mediocre quotidianità. Si è allora verificato nell’Italia televisiva e anche, in parte, cinematografica, un po’ prima in altri paesi, ma non in modo così massiccio come in Italia, il notevole rafforzamento di una cultura che potrei chiamare casalinga e minimalista. Non si tratta soltanto di enfasi sulla vita privata, che è una caratteristica più tradizionale della cultura di massa, bensì dell’enfasi sulla positività di una vita privata mediocre. Quando negli anni ’60 Umberto Eco coglieva le ragioni del successo di Mike Buongiorno nel suo darsi come uomo comune, uomo qualunque, egli coglieva forse con troppo anticipo una sindrome che si sarebbe manifestata due decenni dopo con ben altra forza: potremmo dire che ancora nei suoi ultimi anni Mike Buongiorno, che pur ha concesso qualcosa all’immagine del nonno buono, è stato un modello di personaggio artificiale, un artefatto dello spettacolo, ed è stato un modello di formalità per molti versi rigorosa. Artificio, artefatto… sono parole che qui uso con significato positivo, in opposizione alla volgarità informale. Se continuiamo il confronto con il vecchio Mike, ben altra cosa, dobbiamo dire, è l’informalità dei talk show, la casualità delle mille conversazioni quotidiane propinate dalla TV, la sequenza della spontaneità delle interviste, la mediocrità dei personaggi privati che esibiscono in pubblico amori, abbandoni, ritrovamenti, pianti, figli ingrati – in corpi sgraziati e dunque del tutto “normali”, in linguaggi spontaneamente privati; ben altra cosa è inoltre quella mediocrità soddisfatta che sembra essere perfino un requisito di successo per molti presentatori, una condizione di accettabilità pubblica (ciarlieri e intrusivi, capaci di lasciarsi andare, esibizionisti di una generica modestia umana). Il primo fu Funari. Non necessariamente questa cultura casalinga e minimalista si è manifestata in forme triviali e sboccate, nel modo cosiddetto trash. La “cultura del Bagaglino”, da molti imputata come origine del successo di Berlusconi, oppure le sceneggiate di liti e baruffe in TV, oppure le interviste aggressive per strada, sono solo una minima parte di quella evoluzione culturale. La gran parte ne è perbenista, sentimentale. Richard Sennett ha ricordato come importante momento del palesarsi della decadenza dell’uomo pubblico le lacrime di Nixon in televisione. Si può avanzare, con Sennett, l’immagine dell’avvento di una democrazia psicomorfa, modellata di fatto e di diritto sui più comuni e più banali sentimenti. A me sembra che ci sia elevato isomorfismo fra questa corrente della cultura di massa e l’egualitarismo immaginario del populismo. Ipotizzo che l’arretramento di modelli di umanità in qualche senso “alta” abbia generato in porzioni non marginali di popolazione una più stabile accettazione del sé attuale, da una parte dilavando le diffuse aspirazioni a più luminosi modelli di vita, dall’altra producendo l’aspettativa a essere “riconosciuti” nella propria mediocre quotidianità, come cittadini di una società presente, non futura. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 163 Franco Rositi DOI: 10.1400/228749 Un secondo fenomeno che è emerso più tardi a livello di massa, alla fine del secolo scorso, e che può essere considerato più immediatamente isomorfo, è nella apologia delle virtù informative e conoscitive della rete, di Internet e dei suoi motori di ricerca. Carlo Formenti pubblicò nel 2000 un bel libro sugli «incantati dalla rete» dove si documentavano le teorie mistico-religiose che in America fiorivano (e continuano a fiorire) intorno al tema della Grande Rete. Più importante è la comune perdurante apologia della Rete, innanzitutto come dispensatrice di una cultura personalizzata e fai-da-te (quella riserva di mattoncini Lego con la quale chiunque (quisque de populo) sarebbe oggi in grado di costruirsi i propri giocattoli culturali, il proprio sapere e le proprie ferme convinzioni) e in secondo luogo come la piazza contemporanea in cui può formarsi la volontà popolare. Ma non è soltanto la coppia Grillo e Casaleggio a presidiare questa apologia della Rete. Potremmo ricordare qualche intellettuale che con ammodernata vena futurista, in una Italia pur tecnologicamente arretrata (come accadeva del resto anche negli anni del futurismo), ha esaltato la potenza destratificante della nuova cultura di massa digitale. Può essere tuttavia più significativo ricordare una intervista al “Corriere della sera” di Giulio Tremonti nel lontano 9 marzo 2000. Tremonti non è certo un populista di suo, ma disponibile com’è stato a partecipare a qualsiasi indizio di Zeitgeist, e appartenendo comunque a un partito populista, così dichiarava: «Il cyberspazio è il terreno di trionfo dell’individuo e di conseguenza è l’optimum per la destra libertaria. Internet è quanto di più antigiacobino possa esistere … La struttura della vecchia società sta alla nuova come un vecchio calcolatore sta a Internet. Quella era verticale, rigida, piramidale. La Rete è orizzontale, flessibile, anarchica, federale». L’immaginario sta producendo una società orizzontale, degerarchizzata. Il sentimento di eguaglianza che ne deriva è in realtà una risposta illusoria a un sentimento di centrifugazione dell’ordine sociale che rende evanescente l’esperienza di un centro ordinante, invisibili le gerarchie. In molti luoghi si moltiplicano perfino pratiche di comando automatico, laddove il comando non è più collegato ad atti di responsabilità discrezionale. Andrebbe per esempio osservato con attenzione il diffondersi di una cultura della valutazione mediante conteggio automatico dei meriti, tutt’altro che il giudizio complessivo di una autorità istituzio-nalmente competente. Si potrebbe dire che radicare le decisioni solo o principalmente su dati statistici rende tutti più eguali, se non sapessimo che in questo modo le decisioni diventano ancor più incontro-vertibili, non più responsabilmente soggettive. Ma qui dovrebbe porsi infine la questione sulle origini strutturali di questo egualitarismo immaginario. Una imponente riflessione si sta oggi accumulando sulla destrutturazione, pratica o materiale, di quella società verticale che è stato il presupposto della stessa democrazia moderna quando i suoi ideali non si sono iscritti nell’utopia libertaria. Alcuni brevi scritti di Ota De Leonardis (2008 e 2010) possono essere molto utili per entrare in questa riflessione, e per un primo ordinamento della letteratura relativa. De Leonardis propone in sintesi la metafora di Flatlandia, riferendosi al romanzo che Edwin Abbott scrisse nel 1884 e che raffigura una società a due sole dimensioni, popolata da figure geometriche piane. A questo tipo istituzionale di analisi si potrebbe aggiungere qualche considerazione sulle attuali tendenze dell’organizzazione del lavoro, decentramento e flessibilità o precariato. L’esperienza di una reale massa di eguali, quale la grande industria indubbiamente produceva, si stempera. La stratificazione sociale diventa così complessa che ognuno vede soltanto il vicino, un po’ più su o un po’ più giù, ma sostanzialmente eguale, e può più facilmente immaginare una generale eguaglianza. L’autorità diviene sfuggente, impalpabile, e dunque più facilmente può essere riposta in qualche ristretto circolo immaginario, in qualche piccola cerchia di cospiratori. L’eguaglianza immaginaria produce anche l’invenzione di un potere concentrato - e dunque la credenza di poterlo facilmente combattere. Queste considerazioni dovrebbero autorizzare l’ipotesi che nei paesi dove le grandi organizzazioni produttive occupano ancora uno spazio rilevante il sentimento dell’eguaglianza immaginaria dovrebbe essere meno diffuso, e quindi meno rilevanti i movimenti e i partiti populisti, oppure, più in generale, meno rilevante la sindrome populista nelle formazioni politiche. Ci sarebbe molto dunque da discutere. Ma intanto non si dovrebbe dimenticare che in genere non è vero che nella vita sociale i problemi si risolvono soltanto rimuovendone la cause. La complessità sociale ci impone spesso di curare direttamente i sintomi. 164 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228749 Franco Rositi Riferimenti bibliografici Albertazzi A., McDonnel D. (2008, eds), Twenty-First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy, New York: Palgrave MacMillan. Almond G. A., Verba S. (1980, eds), The Civic Culture Revisited, Boston and Toronto: Little, Brown and Company. Biancalana C. (2014), Il populismo nell’era di internet. Retorica e uso del web nel Movimento 5 Stelle, in «Il Mulino», 1: 53-62. Biorcio R., Natale P. (2013), Politica 5 stelle. Idee, storia e strategie del movimento di Grillo, Milano: Feltrinelli. Chiapponi F. (2013), Italy:Varieties of Populist Leadership, in S. Gherghina, S. Miscoin, S. Soare (2013, eds): 296-315. Chiapponi F. (2014), Un “populismo 2.0“? Note sul Movimento 5 Stelle, dattiloscritto, di prossima stampa. Corbetta P., Gualmini E. (2013, a cura di), Il partito di Grillo, Bologna: Il Mulino. De Leonardis O. (2008), Nuovi conflitti a Flatlandia, in G. Grossi (2008, a cura di), Conflitti contemporanei. Contrasti, scontri e confronti nelle società del III millennio, Torino: Utet. De Leonardis O. (2010), Sulle tracce di innovazioni istituzionali, in «RA. La rivista dell’AIS», 1: 1-13. Diamanti I., Natale P. (2013, a cura di), Grillo e il Movimento 5 Stelle. Analisi di un «fenomeno» politico, numero monografico di «Comunicazione Politica», XV, n. 1. Formenti C. (2000), Incantati dalla rete. Immaginari, utopie e conflitti nell’epoca della Rete, Milano: Cortina. Gherghina S., Miscoiu S., Soare S. (2013, eds), Contemporary Populism. A Controversial Concept and Its Diverse Forms, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. Kavanagh D. (1980), Political Culture in Great Bretain:The Decline of Civic Culture, in G. A. Almond, S. Verba S. (1980, eds). Laclau E. (2005), On Populist Reason, London: Verso. Latour B. (2002), Si l’on parlait un peu politique, in «Politix», 58: 143-165. Mannheimer R. (1991, a cura di), La lega lombarda, Milano: Feltrinelli. Mény Y., Surel Y. (2001), Populismo e democrazia, Bologna: Il Mulino. Panizza F. (2005, ed.), Populism and the Mirror of Democracy, London: Verso. Papa C. (2010, a cura di), Quaderno della Scuola per la buona politica (2007-2008), con una introduzione di L. Pennacchi, Roma: Ediesse. Pitkin H. F. (1967), The Concept of Representation, Berkeley: University of California. Pizzorno A. (1992), La corruzione nel sistema politico, introduzione a D. Della Porta (a cura di), Lo scambio occulto. Casi di corruzione politica in Italia, Bologna: Il Mulino, Rositi F. (2010), Sulla cultura di massa e sul consenso politico, in C. Papa (2010, a cura di). Streek W. (2013), Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, Milano: Feltrinelli. Tarchi M. (2003), L’Italia populista. Dal qualunquismo ai girotondi, Bologna: Il Mulino. Tarchi M. (2008), Italy: A Country of Many Populisms, in A. Albertazzi, D. McDonnel (2008, eds). Zanatta L. (2002), Il populismo. Sul Nucleo forte di una Ideologia debole, in «Polis», 2: 227-245. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 165 166 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar [Francia, Europa, Islam: un’intervista a Marc Lazar] a cura di Paolo Giovannini e Giulia Mascagni Parigi 27 ottobre 20141 La Francia, insieme all’Italia, vive da tempo una situazione di grave crisi. La curiosità che ci viene e che abbiamo posto anche ad altri intellettuali europei, è se veramente questa crisi sia una crisi economica, come di regola si dice. Dato che, come storico, hai sempre prestato molta attenzione alle radici dei processi sociali e politici, quali sono, a tuo parere, le ragioni di lungo periodo dell’attuale crisi? Questa crisi è fondamentalmente di natura economica, o ha invece una natura prevalentemente politica, o culturale? Attualmente, tutta l’Europa sta male. Nel caso francese credo ci siano tutti gli elementi evocati nella tua domanda: cioè crisi economica, crisi sociale, crisi politica e crisi culturale. Economica ovviamente perché, come in tanti paesi, c’è una disoccupazione fortissima ed una situazione anche di aumento della disuguaglianza, che colpisce molto un paese come la Francia che, sul piano appunto culturale, su un periodo molto lungo, diciamo, sicuramente dalla Rivoluzione Francese, aveva e ha sempre una passione per l’eguaglianza, per riprendere la famosa formula di Tocqueville, che sia l’eguaglianza giuridica o l’eguaglianza sociale. L’ineguaglianza colpisce i francesi anche perché le reti sociali sono meno forti rispetto ad altri paesi. Volendo fare, ad esempio, un confronto con il vostro paese, mi sembra che in Italia (almeno in una sua grande parte), pur in presenza di disoccupazione più alta e una situazione sociale molto tesa, la famiglia ha ancora un ruolo di ammortizzatore sociale, riscontrabile, per esempio, nel fatto che i figli rimangono molto a lungo a casa. Il che non è solo una bella cosa: ovviamente abbiamo ben presente tutti le conseguenze anche difficili per i giovani e il paese, però questo ammortizzatore sociale è meno forte in Francia, dove la famiglia ha conosciuto delle trasformazioni decisamente più radicali. Un altro esempio può essere fatto sull’individualismo: quello italiano sicuramente è una realtà; eppure in Italia la gente è molto meno solitaria che in Francia. Mi sembra che nel vostro Paese rimanga tuttora un elemento non solo di solidarietà primaria, come le famiglie, ma di sociabilità anche nelle città per esempio: se pure, sicuramente, si comincia a notare la scomparsa di alcune parti del tessuto sociale, rimane però tutta una rete, specialmente nei centri delle città italiane, che non sono stati totalmente distrutti, come in Francia. Mi ha sempre colpito quando vivevo a Firenze molti anni fa, o quando vivevo a Roma recentemente e ancora oggi andandoci molto spesso - il permanere di un tessuto sociale tenuto in vita dalla presenza ancora significativa di commercianti, artigiani, eccetera; tessuto sociale che è invece sparito in molte città francesi. E non è un caso, a mio parere, che ci sia molta più gente senza tetto in Francia: non solo immigrati, ma anche francesi cosi detti “autoctoni”. Quindi, crisi economica, crisi sociale e crisi politica: quest’ultima sicuramente è un elemento abbastanza nuovo, perché le istituzioni della Quinta Repubblica, che sembravano molto forti, oggi conoscono un processo di disaffezione da parte di tanti cittadini. Pertanto la forza dell’istituzione ed anche quella dello Stato non sono più esattamente come nel passato; da questo punto di vista, va ad intrecciarsi direttamente alla dimensione culturale il fatto che 1 L’intervista si è tenuta a Parigi il 27 ottobre 2014, ed è poi stata integrata a seguito dei gravissimi fatti avvenuti il 7 e l’8 gennaio 2015 - l’attacco terroristico alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi da parte di due jihadisti franco-algerini; e la sparatoria a Montrogue seguita dall’attacco ad un supermercato kosher nella zona di Porte de Vincennes a Parigi ad opera di un sedicente membro dello Stato Islamico. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 167 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 il modello repubblicano - un modello forte in termini di cultura politica, insediato da quasi due secoli - ormai non ha più la stessa capacità di mobilitazione rispetto al passato, anzi, a volte è contestato da diverse minoranze. Lo Stato non ha più la stessa capacità di intervento. Prendiamo un esempio emblematico. Storicamente è lo Stato che ha costruito il famoso ascensore sociale della scuola, questa cosa era mitica - e forse anche troppo mitizzata come dimostrato oggi da tanti storici - però esisteva malgrado tanti limiti una scuola repubblicana laica, che aveva maestri di grande qualità, i famosi Hussards noirs de la République, che portavano la laicità contro i preti, e che, quando vedevano un giovane in gamba di origine popolare, cercavano di aiutarlo per salire nella gerarchia sociale. Questo sistema, per diverse ragioni, non funziona più come una volta. A ciò si aggiunge che anche il ruolo che aveva la Francia in Europa e nel mondo non è più lo stesso. Il minimo che si può dire è che una parte della gente lo vive molto difficilmente. La globalizzazione e l’europeizzazione indeboliscono duramente il modello francese dello Stato-Nazione. Quindi, siamo un paese in grande difficoltà ma - e anticipo forse un po’la conclusione della nostra chiacchierata - che ha ancora tante ed enormi potenzialità. Capisco. Se tu dovessi dare un peso a questi diversi aspetti della crisi - economico, politico, culturale, sociale, eccetera - quale riterresti più importante rispetto agli altri? Credo che la crisi economica attuale, quella aperta nel 2007-2008, arriva in realtà a conclusione di un lungo periodo iniziato a metà anni Settanta. Secondo me è in quel momento, che in Francia come in tanti altri paesi, emergono un’altra società e un altro mondo. Oggi, cioè con la crisi del 2008, la dimensione economica gioca su diversi elementi che erano presenti sul lungo periodo, e specialmente pesa per la Francia la sempre più chiara consapevolezza di non essere più un paese al centro dell’Europa, al centro del mondo, come invece pensava di essere. Quindi la crisi economica è un elemento aggiuntivo ad un malessere più o meno diffuso e di cui i francesi hanno preso poco a poco coscienza. Ritornando alla domanda: questi quattro elementi, ossia quello economico, sociale, politico e culturale, mi sembrano molto intrecciati. Questi fenomeni sociali sono sicuramente intrecciati tra di loro. Ma insomma, è per tentare di dare un peso, come alcuni lo hanno dato in precedenza. Luciano Cavalli, per esempio, in una delle precedenti interviste2, pensava che la crisi fosse essenzialmente politica, anche se siamo in piena crisi economica… In Francia, da una parte, le istituzioni politiche della Quinta Repubblica rimangono molto forti. Per esempio l’attuale Presidente della Repubblica, François Hollande, è indebolito, è molto impopolare, però la sua legittimazione non è attaccata, perché è stato eletto per cinque anni. E dunque ha per esempio la facoltà, perché la Costituzione gli dà questa possibilità, di mandare soldati in Africa senza riunire il Parlamento. Ma, da un’altra parte, ormai c’è una sfiducia generale verso i partiti politici, la classe politica e le istituzioni. Nei sondaggi abbiamo quasi gli stessi dati dell’Italia sulla sfiducia verso i partiti e la classe politica. Anche se, per esempio, i francesi vanno comunque a votare per le elezioni presidenziali, perché piace molto lo scontro tra due persone al secondo turno che assomiglia quasi a un pugilato. Piace molto, però, nell’insieme delle elezioni, vediamo un astensionismo sempre più forte e la crescita del voto di protesta di tipo populista. Insomma, tutto questo è presente e, soprattutto, ci sono attualmente due elementi che contribuiscono al fatto che queste istituzioni, anche se rimangono forti, non godono più, a mio parere, del sostegno popolare. Per prima cosa, la Quinta Repubblica per funzionare bene ha bisogno di un Presidente forte, di un “carisma istituzionale”, anche se so che è un po’ un’eresia usare questa formula. Quando non c’è - ed è il caso di François Hollande che per diverse ragioni voleva essere un Presidente “normale” - il potere del Presidente della Repubblica si scioglie subito. L’altro elemento che perturba molto il sistema politico ed istituzionale è il sistema dei partiti: non solo dei partiti, che sono sempre stati molto deboli in Francia, ma del sistema dei partiti. Perché oggi il Partito Socialista è in piena crisi e così anche il partito di centro-destra U.M.P. (Union pour un Mouvement Populaire): quindi non abbiamo quel sistema bipartisan verso il quale pensavamo di andare all’inizio degli anni 2000, ma piuttosto un sistema nel quale è apparso un terzo grande partito, il Front National, con diversi altri piccoli partiti (centristi, sinistra della sinistra e verdi) indispensabili al PS e all’UMP per governare. Quindi il sistema non funziona più come una volta e bisogna 2 Cfr. La crisi italiana, in «Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali», anno III, n.5, 2013. 168 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar trovare una soluzione per ridare un sangue nuovo alle istituzioni della Quinta Repubblica; oppure, come dicono alcuni, cambiare di nuovo istituzioni e avere per una sesta volta un’altra Repubblica, tesi che io personalmente non condivido. Il problema è piuttosto grave perché si aggiunge al fatto che, come in tutte le altre realtà nazionali, il potere della politica sia molto più ridotto rispetto a prima a causa della globalizzazione e dell’europeizzazione. In un paese come la Francia, dove il volontarismo politico era molto potente e il ruolo dello Stato era centrale, questa crisi sicuramente è vissuta con più forza rispetto, per esempio, ad un paese come l’Italia in cui il potere politico repubblicano da questo punto di vista è sempre stato meno forte. Tutto questo fa sicuramente pensare che siamo in una situazione abbastanza preoccupante. Vedi delle ragioni di lungo periodo in questa situazione della Francia di oggi? Sì. Guardando al lungo periodo si individuano diverse tappe. Fino alla Prima Guerra Mondiale la Francia era uno dei grandi paesi europei, ma anche potenza mondiale: un paese che aveva un grande impero coloniale e una grande capacità di sviluppo, ovviamente in concorrenza con la Germania e l’Inghilterra, mentre gli Stati Uniti non giocavano ancora un grande ruolo, pur vivendo un periodo di forte crescita. Lo shock conseguente alla Prima Guerra Mondiale sicuramente è un primo momento di calo: anche se la Francia la vince, il sacrificio demografico è enorme. È un paese già un po’ indebolito. Poi, dopo la crisi politica ed economica degli anni Trenta, arrivò la seconda grande tappa, terribile: la sconfitta del 1940, molto traumatica: cioè, la Francia che crolla in alcune settimane di fronte alle truppe tedesche e naziste. Noi però abbiamo avuto la fortuna di avere un certo Charles de Gaulle: uno che, il 18 Giugno del 1940, da Londra, chiama i francesi a resistere e proclama di essere l’incarnazione della Francia. Grazie alla sua capacità politica, grazie alla riorganizzazione delle forze armate e grazie alla resistenza interna attuata da diverse componenti, la Francia si ritrova dalla parte dei paesi che vincono la guerra. Segue dunque un momento nel quale la Francia pensa di ritrovare un grande ruolo. La grandeur française, questa formula che in Italia usate molto a proposito della Francia, si lega all’esperienza di De Gaulle dal 1944 al 1946 (fino alle sue dimissioni). Una prova ne è data con la presenza della Francia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E un’altra di nuovo a partire dal 1958, quando lo stesso de Gaulle ritorna al potere dopo la breve esperienza della IV Repubblica (1946-1958) per formare la Quinta Repubblica. De Gaulle, attraverso la sua personalità e la sua azione, ritorna ad essere un protagonista importante in Europa e nel mondo. In Francia lo Stato gollista organizza una modernizzazione dell’economia e della società che, per la verità, era iniziato sotto la Quarta Repubblica, ma che è “messa in musica” da De Gaulle. Egli riesce a fare credere ai francesi che il loro è ancora un grande paese. Ciò in qualche modo ha “occultato” il fatto che la Francia non fosse più una grande potenza: perché le grandi potenze erano da una parte l’Unione Sovietica e dall’altra parte gli Stati Uniti. Durante tutto questo periodo però ci sono stati due altri eventi traumatici. La sconfitta di Ðiện Biên Phủ nel 1954, quindi la perdita dell’Indocina. E, soprattutto, l’indipendenza dell’Algeria nel 1962 dopo otto anni di guerra che hanno fatto tra i 350.000 e i 400.000 morti da parte degli algerini, quasi 25.000 morti militari francesi senza parlare dei civili uccisi e feriti. Il 1962 segna il momento in cui lo spazio francese si riduce, cioè non è più quel mondo imperiale, anche se la Francia ha ancora oggi diversi possedimenti per il mondo. E, per esempio, è in questo momento che nasce l’appellativo L’Hexagone per parlare della Francia, cioè il fatto che la Francia si riduce quasi alla sua parte metropolitana. Questo momento è già un momento nel quale i francesi iniziano a rendersi conto che non hanno più la stessa importanza di prima, anche se la costruzione europea nella quale la Francia gioca un ruolo decisivo contribuisce ad attenuare questa sensazione. Ma ci sono realtà che dimostrano la regressione dell’influenza francese. L’esempio che prendo sempre è quello della lingua francese. Il suo declino è stato impressionante, soprattutto negli ultimi anni, e nonostante la vitalità della francophonie che attrae ancora molta gente attraverso il mondo intero. Anche in Italia, per esempio, il francese è sempre meno parlato. Ne ho fatto l’esperienza personale negli ultimi trent’anni. Le nuove generazioni, spesso, come seconda lingua scelgono l’inglese. Anche in un paese molto francofilo come la Romania, stessa cosa. E ogni volta che ci sono conferenze internazionali in cui i francesi vogliono parlare in francese le sale sono vuote. Questo, per esempio, nel nostro piccolo mondo accademico è stato un trauma per tanti colleghi della mia generazione, quindi abbastanza anziani. Gli storici, ad esempio, erano convinti che tutti nel mondo parlassero e leggessero il francese perché c’era la famosa rivista Les Annales, fondata da Marc Bloch e Lucien Febvre, che era la rivista di riferimento: uno storico polacco, americano o italiano doveva imparare il francese per Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 169 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 leggere Les Annales e fare una carriera internazionale. Oggi non è più necessario salvo ovviamente per gli storici che studiano la Francia. Più generalmente, il sentimento di “declino” della Francia è vissuto drammaticamente, questo sicuramente più che l’Inghilterra, che è stata salvata proprio dalla lingua. La Francia, che era un paese per il quale la cultura giocava e gioca ancora un grande ruolo, si è resa conto che non era più al centro del mondo e questo ha provocato una forma di depressione collettiva, foriera di comportamenti diversi. Il dibattito è molto acceso tra quelli che sono nostalgici del passato - una corrente di pensiero condivisa da intellettuali, giornalisti, pubblicisti - che vorrebbero ritornare al passato glorioso, quelli che invece si inseriscono completamente nella globalizzazione a volte ignorando la tradizione francese, e infine quelli che sono tra i due e tentano di mescolare ciò che rimane della potenzialità specifica francese con l’apertura al mondo (una forma di french touch, se posso permettermi di usare una espressione inglese un po’ incongruente a proposito di questo argomento, all’interno del mondo globale). Quindi questa mi sembra la cosa che spiega nel lungo periodo come l’attuale crisi sia da noi vissuta, sicuramente in una maniera diversa rispetto a voi. L’Italia ha ovviamente un passato glorioso, ma dopo che il fascismo l’ha celebrato in una maniera parziale ed eccessiva, la Repubblica non ha saputo né voluto costruire un rapporto forte con il proprio passato. Invece, per un paese che da diversi decenni non si sente più al centro dell’Europa e del mondo, è un elemento che secondo me accentua il sentimento di crisi, e rende permanente la controversia tra quelli che pensano che siamo in declino totale (in francese li chiamiamo les déclinistes) e quelli che insistono sulla permanenza di un ruolo della Francia legato al passato ma anche alle sue potenzialità presenti. Andando un po’ più indietro, quindi guardando certi aspetti di composizione sociale della società francese, mi viene in mente il libro di Marx3, che tu conosci benissimo, sulle lotte sociali in Francia. Un’analisi innovativa della composizione sociale della società francese che risultò essere molto variegata: i contadini, gli operai, le città, le campagne, gli artigiani, eccetera. Ecco, questa variegata composizione sociale della metà dell’Ottocento, come si è riprodotta nello scorrere dei decenni e degli eventi? …Penso agli anni della Prima Guerra Mondiale... Ha avuto qualche influenza nel configurare la società francese e nel, come dire, produrre le ragioni della sua crisi nella trasformazione sociale? Per esempio con la scomparsa di certe categorie sociali e la comparsa di nuove. Con il mutamento di equilibri, innanzitutto equilibri di potere, tra una classe ed un’altra… Credo che ci siano stati molti studi dei sociologi francesi a proposito di questo. Tra i più belli, secondo me, sono da ricordare i lavori di Henri Mendras che ha dedicato molte delle sue ricerche alla scomparsa del mondo dei contadini e a tutti i grandi cambiamenti che hanno toccato la società francese4. Per rispondere alla tua domanda: innanzitutto qui come in Italia abbiamo perso tutto il mondo contadino. Sappiamo che la Francia è un paese più rurale che urbano fino al 1931, cioè l’urbanizzazione è abbastanza recente, e la componente rurale è fortissima in questo paese. La fine del mondo contadino è qualcosa che è legato ai trent’anni cosiddetti glorieuses5. Anche se ormai quest’idea dei trent’anni gloriosi e la loro periodizzazione sono molto criticati dagli storici, che giustamente dimostrano che non erano solo gloriosi, ma che c’erano disuguaglianze e contestazioni un po’- come dire - dimenticate o occultate, e che possono essere identificate altre scansioni temporali6. Nonostante l’evidente scomparsa del mondo contadino, in Francia come in Italia, tante famiglie hanno ancora un legame forte, e si vede con les maisons de campagne, cioè con le case che tanti mantengono in campagna, di solito con un giardino piccolo o meno piccolo di cui si occupano con grande attenzione. Ne sono emblema le forme di immaginario e di mitologia che in Francia rimandano ad un mondo contadino idealizzato, un po’ come quello che io chiamo la “sindrome Mulino Bianco” per l’Italia con queste pubblicità completamente... 3 Il riferimento è al testo Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850. 4 Henri Mendras, La Fin des paysans (1967) e La Seconde Révolution française (1988). 5 Les trente glorieuses: il riferimento è al trentennio tra il 1946 ed il 1975, in cui la Francia conosce un periodo di forte sviluppo economico e deriva dal titolo del libro (di grande successo) di Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses. Les révolutions invisibles de 1946 à 1975 (prima edizione 1979). 6 Cfr. per esempio, Céline Pessis, Sezin Torçu, Christophe Bonneul (a cura di), Une autre histoire des Trente glorieuses: modernisation, contestations et pollutions (2013); Jean-François Sirinelli, Les Vingt décisives 1965-1985. Le passé proche de notre avenir (2012) e Jean Vigreux, Croissance et contestations 1958-1981 (2014). 170 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar Fuori tempo. Immagini di realtà ormai estinte… Assolutamente! Ma piacciono molto, proprio perché tanti italiani hanno il legame con la terra. Anche in Italia, poi, un po’come in Francia ma ancora più pronunciata, avete l’alta propensione al risparmio: non mi fido tanto delle banche, e ancora meno della borsa perché so che domani potrebbe essere molto rischioso. Questa è una vecchia mentalità contadina, che però permane in modo estremamente forte. La Francia era un paese con molti contadini, che avevano una presenza di grande peso nella società e nella politica; ancora oggi - malgrado siano meno del 3% della popolazione attiva - conservano in buona parte questa rilevanza. In particolare sul piano politico: perché l’industria agroalimentare ricopre un enorme peso nell’economia nazionale, ma anche perché c’è questa mitologia. Il secondo elemento, comune a molti altri paesi, è la fine di una certa classe operaia a partire dagli anni Settanta. Già negli anni Sessanta si era ridotto il peso dei minatori; nel decennio successivo lo stesso accade per i metalmeccanici, per quelli che lavorano nella siderurgia, perbquelli che lavorano nei porti sul mare... I camalli… Sì! Queste erano le professioni della grande classe operaia, legate a una grande concentrazione di fabbriche, con comunità corporativiste ben organizzate attraverso il sindacato e molto spesso legate al Partito Comunista. Gli anni Settanta sono gli anni di una ampia ristrutturazione, di lotte e di grandissime sconfitte operaie. Un fatto che mi colpisce molto è che questo mondo operaio sparisce senza lasciare molte tracce a differenza, per esempio, di quello che è successo in Gran Bretagna, dove c’è tutta una filmografia che ne parla in maniera molto forte, come si vede con i film di Ken Loach. Questo perché in Inghilterra il mondo operaio era molto potente. Al contrario, secondo me, il mondo operaio francese era molto fragile in termini culturali malgrado il lavoro delle organizzazioni sindacale e politiche. Abbiamo pochissime indagini sociologiche sul destino di questo mondo operaio scomparso. Mi ricordo che un grande sociologo di orientamento marxista, Michel Verret7, che ha a lungo studiato la classe operaia, diceva che bisognava fare un piano di ricerca per raccogliere la testimonianza di questi operai che hanno perso tutto. Non l’abbiamo fatto, sfortunatamente. Ma attenzione: questa evoluzione del mondo operaio a mio parere non significa, come invece è stato scritto molto spesso, la fine della classe operaia. Perché abbiamo ancora molti operai, e tra questi tanti immigrati. Gli studi compiuti da numerosi sociologi evidenziano però che, pur esistendo sempre, non formano più la stessa classe operaia: non fanno più lo stesso tipo di lavoro, non sono più nelle stesse fabbriche, non si sentono di appartenere alla classe operaia, non sono più dotati di una “identità di classe” come i marxisti dicevano nel passato, anche se appunto esistono sempre. Inoltre, se si eccettua il Front National - ma torneremo sicuramente su questo - sono privi di rappresentanza politica. Altro aspetto molto importante è che in Francia, a differenza della Germania ed anche dell’Italia, la cultura manuale è poco considerata. In Italia avete un grande rispetto per l’artigiano, per chi fa il lavoro manuale, e anche se non è una situazione strutturata come in Germania, si può dire che ci sia una forma di mitologia dell’operaio e della sua capacità artigianale e tecnica. In Francia invece ciò è poco presente: la cultura predominante è quella del diploma educativo. Rispetto al mondo intellettuale il mondo manuale è poco e mal considerato. Insomma, la classe operaia classica è scomparsa, e sembra che a nessuno importi veramente. Ci sono pochissimi film, pochissima letteratura… Con rilevanti eccezioni. La scrittrice Annie Ernaux ha scritto bellissime cose sugli operai e il mondo popolare, e così François Bon. Però non mi sembra che abbiano avuto il successo di un Ken Loach. C’è poi la nota questione della classe moyenne, la middle class, ossia i ceti medi. Argomento molto complicato in quanto ricomprende tante componenti eterogenee, e con grandi differenze alle sue estremità tra una parte quasi in via di proletarizzazione, ed un’altra che avendo un alto livello di formazione e istruzione approfitta pienamente delle opportunità date dalla globalizzazione. I ceti medi, anche se di difficile definizione, sono indubbiamente centrali nella attuale configurazione sociale della Francia. Dunque questi, detti in poche parole, sono i principali elementi della società francese attuale. Bisogna però aggiungere tre cose, importanti perché hanno degli effetti sulla politica. In Francia, come in tutti gli altri paesi sviluppati, conosciamo un processo di individualizzazione molto forte, un processo complesso perché non impedisce la ricerca di forme di solidarietà. Poi c’è la paura del déclassment social (del 7 I titoli della trilogia di Michel Verret dedicata al mondo operaio sono: L’espace ouvrier (1979), Le Travail ouvrier (1982), La culture ouvrière (1988). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 171 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 perdere la propria situazione sociale) e della désaffiliation come diceva il sociologo francese Robert Castel8: il perdere il lavoro, divorziare, non avere più la casa, e cosi via, tutte le possibilità di perdita delle “affiliazioni” in un progressivo processo di rottura nella società. Queste paure sono quelle dei ceti popolari, e ma ormai anche di una parte dei ceti medi... E infine la terza cosa: l’immigrazione. Questione molto sensibile… La Francia è un paese di immigrazione, sin dall’Ottocento… Ti riferisci a processi migratori interni o anche a flussi migratori da altri paesi? Dunque, da una parte c’è stata e c’è una immigrazione interna: ossia tanti contadini che sono venuti nelle grandi città per trovare un lavoro e ciò spiega anche la fine del mondo contadino di cui abbiamo parlato. Una grande parte dei parigini per esempio sono originari della “provincia”. E dall’altra parte c’è stata e c’è un flusso dall’esterno: cioè, a partire dall’Ottocento abbiamo immigrazione belga, polacca, italiana, spagnola, ebrei dell’Est dell’Europa; quindi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di nuovo spagnola, portoghese, italiana e infine l’immigrazione maghrebina e dell’Africa nera. E più recentemente ancora da tutto il mondo. Si è detto che la Francia fosse “gli Stati Uniti dell’Europa” proprio perché abbiamo avuto questa centralità nei processi di immigrazione. La stima dei francesi di origine straniera è enorme: quasi un francese su quattro (22,5% per essere preciso), se si prendono in considerazione i quattro nonni, ha qualcuno della sua famiglia che non è francese. Ovviamente quello che è cambiato è il modello di integrazione, sicuramente. Il modello di integrazione repubblicano è noto: l’immigrato può fare nella sua vita privata le scelte che vuole - avere la sua religione, praticare la sua lingua, eccetera - però nello spazio pubblico deve accettare le regole della Repubblica e innanzitutto la laicità. Questo modello ha funzionato più o meno bene. Anche se adesso alcuni (esponenti del Front National ma anche pubblicisti, intellettuali non sempre legati organicamente a questo partito ma che hanno idee convergenti con le sue proposte) lo presentano come un modello perfetto, sappiamo che è stato molto più complesso: gli italiani per esempio, adesso presentati come un esempio di integrazione riuscita, non sono stati sempre ben accolti. Anzi, ci sono stati momenti di grandissima tensione. Basti ricordare il famoso incidente ad Aigues-Mortes nell’agosto 1893, in cui morirono otto italiani9. Però, più o meno, il modello repubblicano di integrazione per lungo tempo ha funzionato. Qualcosa si è rotto a partire dagli anni Settanta ed Ottanta con l’immirazione di origine maghrebina e dell’Africa nera. Per un misto di difficoltà, come per esempio la situazione economica e sociale degradata, una disoccupazione strutturale alta, la crisi della scuola che non ha più favorito l’integrazione, la concentrazione territoriale della popolazione straniera in alcune zone, il rigetto forte di alcuni immigrati che si sono sentiti e si sentono sempre mal accolti, discriminati e stigmatizzati (emblematico è il caso degli algerini, direttamente riconducibile alle vicende della guerra di Algeria), il comportamento di alcuni di essi è di rigetto della Francia, dei suoi valori, della laicità, cui a volte si accompagna anche un atteggiamento di ostilità nei confronti dei francesi. Tutto ciò ha portato alla situazione in cui siamo oggi, una situazione piuttosto difficile. Situazione difficile, suppongo, sopratutto dopo quello che è successo in questi giorni [il riferimento è agli eventi del 7 e 8 gennaio 2015]. Come vedi la società francese dopo questi drammatici eventi? Sono stati giorni di terribile tensione. Ma dal punto di visto della società francese ci sono almeno tre punti da sottolineare. C’è stata una reazione spontanea e immediata di una parte della società subito dopo l’uccisione dei componenti della redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo e di due poliziotti che facevano la guardia davanti alla sede del giornale, mercoledi 7 gennaio. Sulle piazze, per strada, sui luoghi di lavoro, nei media, su internet, c’èra tanta emozione, tante lacrime ma anche una enorme e chiara determinazione a difendere la libertà di espressione e dire, come era scritto sulla Place de la République a Parigi, «Not afraid». Ciò è legato agli argomenti di cui parliamo: si ritrovava la grande tradizione repubblicana francese, anche nell’attegiamento del Presidente della Repubblica (che in questa situazione di crisi estrema si è comportato benissimo) e dei partiti (malgrado la polemica che ad un certo punto è emersa riguardo all’esclusione del Front National tra i firmatari 8 La traduzione del termine in italiano rimane ad oggi difficile e poco efficace: il riferimento è al processo di dis-associazione, o disaffiliazione sociale. Cfr. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale: une chronique du salariat (1995). 9 Cfr. Gérard Noiriel, Le massacre des Italiens: Aigues-Mortes, 17 août 1893 (2005). 172 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar dell’appello alla grande marcia per la Repubblica di domenica 11 gennaio, alla quale hanno participato tanti leaders europei tra cui Matteo Renzi). Le manifestazioni di sabato 10 e di domenica 11 su tutto il territorio nazionale sono state enormi, le più importanti di tutta la storia francese. Sono state caratterizzate da una forma di fraternità, di invenzione individuale e collettiva e hanno mostrato come la cultura repubblicana fondata sui valori della libertà e della laicità rimanga ancora ben salda, almeno in una parte della società. Bsognerebbe avere a disposizione dati di tipo sociologico per meglio comprendere come queste manifestazioni siano state guardate e percepite in alcune zone della Francia. Perché, ed è il secondo punto che voglio sottolineare, ci sono stati atteggiamenti molto diversi da una parte minoritaria di francesi di origine immigrata: al momento del minuto di silenzio decretato dal Presidente della Repubblica giovedì 8 gennaio alle 12, sui social network, per la strada, nelle scuole, si sono fatte sentire forme di empatia e di aperta simpatia con i terroristi, e parole di odio contro il giornale Charlie per blasfemia nei confronti del Profeta, contro la polizia e contro gli ebrei (quattro di loro sono stati uccisi perché ebrei da uno dei terroristi). Si tratta di una parte minoritaria, ed è chiaramente stata condannata dagli esponenti dei musulmani: il problema è che gli stessi non rappresentano affatto l’intera comunità. Infine, ci sono stati alcuni attacchi contro moschee e luoghi simbolici dei musulmani organizzati e/o non condannati da parte di gruppi di ultra destra, per i quali islamisti radicali e Islam sono la stessa cosa (argomento che la stessa Le Pen non usa più). Gli atti terroristici hanno diversi obiettivi tra cui quelli di fare paura al popolo francese e provocare lacerazioni nella società e radicalizzazione dei comportamenti. Per il momento la Francia non è caduta nella trappola. Ma sicuramente questi giorni di gennaio dimostrano la necessità assoluta da una parte di avere una fortissima determinazione nella repressione degli islamici radicali e delle reti così come di combattere culturalmente e politicamente comportamenti di ostilità agli ebrei, alla Repubblica, alla laicità. Dall’altra parte, però, c’è anche da ripensare, nella scia della tradizione repubblicana, a ciò che è alla base e forma il sistema paese. Sopratutto perché si può ragionevolmente supporre che ci saranno altri attentati. Questo terrorismo viene tanto dall’estero quanto dall’interno e ci potranno essere o lupi solitari o persone appartenenti a reti molto ben organizzate che passerano all’azione. Dovremo vedere, insomma, se i politici sono all’altezza di questa coscienza civica, di cui una parte del popolo francese è portatore. Credo che questo sia quello che si può dire - in modo molto sintetico - della società francese oggi, per rispondere alla tua domanda. Grazie. Passiamo invece ad aspetti che Marx chiamerebbe di tipo sovrastrutturale, e cioè alla cultura politica, a cui già abbiamo fatto vari accenni. Focalizzando l’attenzione dell’analisi sulla cultura politica francese: quali sono le sue diversità rispetto alle culture politiche di altri paesi? Quali, eventualmente i demeriti che ritieni di maggior peso? Quale il suo rapporto con l’Europa? Innanzitutto la cultura politica francese era caratterizzata dalla presenza di uno Stato forte. Ed è una caratteristica che va ricercata nella storia, una storia di lunghissimo periodo. Tocqueville è stato tra i primi a spiegare per esempio che la rivoluzione francese era da una parte une grande rottura ma dall’altra ha continuato la centralizzazione amministrativa iniziata dall’Ancien Régime. L’idea che ci fosse uno Stato forte e cittadini senza corpi intermediari è un paradigma analitico oggi discusso dagli storici. Hanno fatto molti lavori sulla vita associativa, anche nel XIX ed all’inizio del XX secolo, per dimostrare che - contrariamente a quanto comunemente si pensa, ovvero che in Francia c’è lo Stato e ci sono i cittadini, e niente tra i due - la realtà è molto più complessa10. A mio parere, pur con le molte sfumature proposte delle ricerche più recenti, rimane ancora più evidente se letto in chiave comparata (e soprattutto con l’Italia) il fatto che lo Stato era forte e che la società civile malgrado i suoi tentativi era piuttosto debole o almeno molto determinata dal peso dello Stato. E ciò anche se dagli anni Sessanta e, soprattutto, Settanta ed Ottanta, c’è stato tutto un processo di decentralizzazione. La seconda idea, che ovviamente si lega allo Stato forte, è quella del volontarismo politico, cui spesso si accompagna la presenza di un uomo “provvidenziale”: insomma il misto tra giacobinismo e bonapartismo, sia di destra che di sinistra (perché com’è noto è la Francia che inventa il cleavage destra-sinistra a partire sempre della Rivoluzione francese anche se la traduzione politica concreta di questo cleavage prende tempo e se il suo contenuto cambia attraverso il tempo). Terzo elemento è quello della Repubblica: cioè, la République e la laicità. Essa si è imposta in diversi 10 Cfr. per esempio, Claire Andrieu, Gilles Le Béguec, Danièle Tartakowsky (a cura di), Associations et champ politique: la loi de 1901 à l’épreuve du siècle (2001). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 173 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 momenti della storia, ma soprattutto alla fine dell’Ottocento. Non è facile essere cattolico verso gli inizi del Novecento quando c’è la separazione tra Stato e Chiesa: il conflitto è abbastanza duro. La democrazia in Francia prende la forma della Repubblica. Eppure si sa che, per esempio, per tanti liberali americani ed inglesi, la Francia non è veramente un paese democratico, in quanto c’è un sistema repubblicano che non lascia molto spazio agli altri. Come direbbe Norbert Elias, questa configurazione, e cioè uno Stato forte, la Repubblica, la laicità, il volontarismo politico, ed anche la stessa idea che ciò non fosse una eccezione ma un modello universale, ha caratterizzato la Francia. Ma appunto oggi è messa in discussione. Lo Stato forte non è più lo stesso, in quanto le sue competenze sono modificate a causa dell’Europa, della globalizzazione ma anche delle richieste venute dal basso. Il volontarismo politico mostra i suoi limiti di nuovo e innanzitutto a causa della globalizzazione, del capitalismo finanziario e dell’Europa. La Repubblica e la laicità non hanno più lo stesso prestigio, sono attaccate a volte duramente da diverse componenti della società francese: una parte dei francesi di origine immigrata dice che questa Repubblica li ha trattati male e non li integra; una minoranza, molto visibile, non rispetta le regole repubblicane; ci sono anche molte critiche alla Repubblica per la sua azione nelle colonie. La Repubblica sembra avere perso il suo sex appeal, se così si può dire. La tua domanda sull’Europa è complicata, in quanto - secondo me - la Francia nel suo rapporto con l’Europa presenta tre paradossi. Il primo è che fin dall’inizio in Francia c’è stata una tensione permanente tra una tendenza sopranazionale federale, per esempio espressa da personalità del calibro di Jean Monnet e Robert Schuman, e la corrente dell’Europa delle Nazioni, con de Gaulle. Una tensione con cui spesso la Francia ha giocato anche per suo vantaggio, a volte insistendo sulla dimensione sopranazionale, a volte invece insistendo sulla dimensione Europa delle Nazioni. Il secondo paradosso, di grande rilevanza, è che la Francia è per un’Europa forte con istituzioni politiche deboli, perché così può salvare, o pensava di salvare, le sue stesse istituzioni nazionali, garantendo loro forza e autonomia. Nel pensare all’Europa di fatto la Francia riproponeva come unica possibilità il suo stesso modello, cioè lo Stato forte politicamente, economicamente, socialmente e culturalmente. Terzo e ultimo paradosso: la Francia ha sempre immaginato un’Europa a sei; e ha poi accettato i diversi allargamenti sempre però mirando alla centralità della coppia franco-tedesca, il famoso motore dell’Europa. Oggi questi tre elementi… Non ci sono più… Un’Europa sopranazionale? Nessuno o quasi nessuno oggi in Francia osa parlare e afferma pubblicamente di auspicare gli “Stati Uniti d’Europa”, come invece dice Matteo Renzi malgrado le critiche che fa all’Europa. Dire “Europa delle Nazioni” non significa quasi nulla perché le nazioni in Europa sono molto cambiate. Quindi questo primo elemento della politica europea francese tradizionale, caratterizzata dal paradosso che ho presentato, per il momento non funziona più. Il secondo elemento, cioè l’avere un’Europa forte ma con istituzioni deboli, non funziona neanche. Il terzo elemento, cioè un’Europa con il motore franco-tedesco, a me sembra, come dire, una necessità per l’Europa. Ma è comunque una visione oggi molto criticata: tanti Paesi dicono che questa è “vecchia storia”. I nuovi paesi venuti dall’Est non condividono il fatto che l’Europa possa essere sotto la cura di Parigi e di Berlino. Quindi, attualmente, la concezione della politica francese in Europa è, anche questa, in difficoltà. Bisogna ripensarla al più presto non solo per l’interesse della Francia ma anche dell’Europa stessa. Posso tornare un attimo indietro… Sì. Perché tu ad un certo punto hai parlato, giustamente per quello che ne so anche io, riguardo alla società francese, e alla società politica francese, e alle istituzioni francesi di un rapporto tra un centro forte ed una periferia, senza spazi intermedi, ecc. Allora mi veniva in mente, ovviamente, un grande sociologo francese, Émile Durkheim, che in realtà ha sempre insistito molto sui corpi intermedi. E sulla necessità di rafforzarli, proprio perché la società francese aveva corpi intermedi deboli. Un problema sollevato da tutta la sociologia europea di quel secolo, no? Cioè, il rafforzamento delle classi medie, il rafforzamento dei ceti intermedi, il rafforzamento delle istituzioni intermedie, che possono essere corporazioni, enti locali, come sono in Italia le Regioni, eccetera… Ecco, c’è davvero questo “vuoto” nel rapporto tra centro e, nemmeno periferia, ma cittadini? Assolutamente. Questa è un’ottima domanda. È vero che Émile Durkheim, con la sua idea chiave, cioè che 174 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar bisognerebbe avere dei corpi intermedi forti, ha avuto influenza sugli uomini politici … Eh, sì. È stato molto influente… Esattamente. La risposta a questa domanda però è difficile, in quanto ci sono due strutture che sono state sempre molto deboli in Francia, in qualità di corpi intermedi: i partiti politici ed i sindacati. A parte alcuni momenti, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, i sindacati sono molto deboli sul piano dell’adesione dei membri, ed il tasso di sindacalizzazione in Francia è sempre stato uno dei più bassi in tutta l’Europa. I partiti politici sono sempre stati molto deboli, fatte salve alcune eccezioni negli anni Trenta e, su una più lunga durata, il Parti Communiste Français (PCF), dagli anni Trenta all’inizio degli anni Ottanta. Ma attenzione: bisogna anche prendere in considerazione lo spazio intermedio. Penso al livello locale, alla dimensione municipale. Nella provincia è molto importante il lavoro del Sindaco e della sua squadra. La rete, i contatti, la sociabilità sviluppate a livello locale o regionale sono una realtà, e hanno ancora una certa importanza nell’intermediare tra cittadini e livello nazionale. L’altra realtà, molto presente in Francia ma che esiste anche in Italia, come confermato da diverse ricerche, è tutta questa ebollizione, questo grande sviluppo della vita associativa: associazioni di genitori, associazioni di alunni, associazioni sportive, associazioni culturali… Forma una rete incredibile… Ancora oggi… Sì, ancora oggi. E lo puoi vedere anche tu facilmente, aldilà degli studi che si possono leggere o si possono fare: quando, per esempio, sei invitato a fare una presentazione di un libro in una città di provincia è pieno zeppo, cioè la gente viene… A me non succede… [ride] [ride] L’ho visto anche in Italia.Vedi un sacco di persone, portate dalle associazioni più diverse, e che preferiscono venire ad ascoltare un vecchio professore piuttosto che guardare una trasmissione televisiva. C’è una grande ricerca di discussione, di scambi e questo è impressionante. Ma ci sono limiti. Abbiamo avuto un bellissimo studio sociologico su questo che ha ben messo in luce una importante questione di fondo11. Nelle indagini qualitative rivolte a questi membri delle associazioni, tutti spiegano la stessa cosa: sono membri di un’associazione, magari di genitori per la difesa della scuola pubblica minacciata, ma sostengono fermamente di non fare politica. E questo perché la sfiducia verso la politica è tale che si profila una forma di sostituzione. Ma, ovviamente, si potrebbe dire che fanno proprio politica, perché la vita associativa fa parte del capitale sociale, secondo la definizione tra tanti altri di Robert D. Putnam. Un altro elemento è il fatto che l’impegno, all’interno di queste associazioni, è molto individualizzato e non è più un impegno “totale” o “totalizzante”: io faccio parte di quest’associazione ma come individuo libero e se non sono d’accordo con il resto dell’associazione lo dico subito, anzi faccio mio mercato tra le associazioni e anche all’interno dell’associazione. Questo processo di individualizzazione nell’impegno mi porta a dire che non si possa più parlare di militantismo, espressione che ha origine latina di forte connotazione militare: questa parola secondo me non è assolutamente più idonea per definire le forme di impegno nella vita associativa. Ma questa vitalità associativa di cui parli è un po’in tutte le Regioni della Francia? Se è pur vero che, come al solito, ci sono Regioni che hanno più forza, si può però affermare che sia una cosa abbastanza diffusa su tutto il territorio. Certo. Indubbiamente abbiamo parlato molto della Francia, però fino ad ora non abbiamo parlato della sinistra francese… Vorrei sottolineare tre tratti tra i più salienti della cultura politica delle sinistre. Il primo è la grande difficoltà ad accettare il riformismo. Ed è un aspetto di lungo periodo: i francesi hanno un’idea del cambiamento assolutamente radicale; solo più di recente l’odio del riformismo sta inizia a ridimensionarsi. Questo non significa che non ci siano 11 Cfr. Sophie Duchesne, La Citoyenneté française (1997). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 175 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 stati diversi tentativi di avere un riformismo nell’Ottocento e nel Novecento, però l’idea che il vero cambiamento è il cambiamento radicale, è un’idea molto radicata ancora oggi, anche se in diminuzione. L’idea della rottura, della tabula rasa. François Furet, mi ricordo, in un seminario, diceva che quello che lo colpiva era il fatto che durante la Rivoluzione Francese i francesi hanno odiato il loro passato ed hanno voluto distruggere le chiese. E questo rende proprio bene l’idea della radicalizzazione, che l’unico cambiamento è quello forte, duro, totale, con un volontarismo politico importante. Un altro elemento della cultura della sinistra francese è il suo rapporto con la nazione repubblicana. La sinistra, almeno la maggioranza della sinistra, si riconosce nella nazione repubblicana e nel modello repubblicano universale. Una nazione aperta (anche se a volte nella storia la sinistra ha difeso posizioni della nazione più restrittive). Successivamente i socialisti alla fine del XIX secolo, e poi i comunisti si sono “convertiti” alla nazione repubblicana; anche se nel caso comunista erano legati all’Unione sovietica e quando bisognava scegliere tra la fedeltà all’URSS e la fedeltà alla Francia hanno sempre scelto la prima. L’Europa ha diviso la sinistra francese: una sua parte accetta l’Europa ed è europeista, e quindi accetta de facto una riduzione della sovranità della nazione; un’altra parte (sinistra di matrice comunista, estrema sinistra e anche una componente dei socialisti) è critica dell’Europa (a volte con argomenti convergenti a quelli dell’estrema destra) e difende la specificità nazionale, ma a differenza dell’estrema destra, ripeto, con un’idea di nazione aperta e non ripiegata su di sé. Il terzo tratto culturale della sinistra à la dimensione statalista della sinistra francese. Come per la nazione, se i socialisti e poi i comunisti all’inizio volevano distruggere lo Stato, si sono successivamente “convertiti” all’idea che lo Stato poteva essere lo strumento per trasformare la società. Certo all’interno della sinistra socialista ci sono stati a volte dibattiti forti su questa questione perché esiste una componente critica dello Stato e che crede di più alla potenzialità della società civile (una componente ben incarnata per esempio negli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo da Michel Rocard e della cosi detta “seconda sinistra” (la deuxième gauche). Diciamo però che tutto sommato la sinistra francese è abbastanza statalista ed è stata così quasi colonizzata dallo Stato. Aggiungerei una caratteristica sociologica. Abbiamo avuto in Francia un Partito Comunista molto settario (a parte alcuni momenti), stalinista e operaio - soprattutto ouvrieristico, che non è la stessa cosa di operaismo. Senza voler dire che tutti gli operai erano comunisti, anzi, per niente, c’era però questa componente sicuramente forte. A partire dagli anni Settanta, quando spariscono le grandi categorie di lavoratori come abbiamo visto, il Partito Comunista si ritrova in grave difficoltà. Il partito socialista invece, anche se aveva un po’di seguito nel mondo operaio è stato soprattutto un partito presente piuttosto nelle categorie del settore pubblico, come maestri e professori, e nei ceti medi (impiegati). E quando si guarda oggi la composizione dell’elettorato del partito socialista è gente di più di cinquant’anni, che vive in grandi città, che ha un alto livello di istruzione e che lavora nel settore pubblico. Non ha successo con la gente che lavora nel settore privato, con i giovani e tra i disoccupati. Una domanda di chiarimento. Prima è stata ricordata questa mitologia del mondo contadino, che ha rappresentato in passato anche una presenza reale e che comunque è sopravvissuta, in termini di immaginario, anche nelle generazioni attuali. Ecco, questo mondo, questa parte del mondo del lavoro, è stato in qualche modo presente nelle rappresentazioni politiche della sinistra francese oppure no? Mi viene in mente perché poi è da questo mondo che, per esempio, nei confronti dell’Europa, è emersa una critica forte, no? Manifestazioni per la difesa del prodotto agricolo francese, e simili. La sinistra era insediata in alcuni settori del mondo contadino. Era presente in tutto il territorio lungo il Massif Central o ancora nel Sud-Ovest della Francia, soprattutto tra i mezzadri, come in Italia, o tra i piccoli produttori piuttosto che tra gli operai del mondo agricolo. Sul piano della difesa di questo mondo contadino si è trattato, soprattutto, di una difesa di sindacati piuttosto legati alla destra o al Gollismo, che erano lobby potenti e meno legate alla sinistra. Il Partito Comunista aveva un piccolo sindacato contadino, che si chiamava MODEF (Mouvement de Défense des Exploitations Familiales). Il Partito Socialista aveva alcuni legami, però sotto la Quinta Repubblica, quando questo mondo più o meno sparisce, il principale sindacato è la Fédération Nationale des Syndicats d’Expoitants, che era vicino al Gollismo… Il Gollismo… E negozia direttamente con i Gollisti. Una formula giornalistica di successo diceva che i contadini bruciano le prefetture il sabato ma votano per il partito del governo la domenica. Volevo aggiungere, se me lo consenti, 176 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar una cosa che mi interessa molto. Nell’affrontare il tema della trasformazione della cultura politica francese ho cercato di porre in evidenza gli aspetti salienti, e vorrei brevemente di nuovo comparare la realtà francese con quella italiana. In Italia avete avuto vent’anni di Berlusconi: uno tsunami politico, uno sconvolgimento generale con partiti che scompaiono come la Democrazia Cristiana, il PSI, il PRI, il PLI, il PSDI o che cambiano come il Partito Comunista o il Movimento Sociale Italiano, nuovi partiti che emergono come la Lega Nord, poi Forza Italia o di recente il M5S. Tantissimi cambiamenti dunque. Però quando si guardano le mappe elettorali sono quasi le stesse del 1948… Forse anche prima. Prefasciste, diciamo… Assolutamente. In Italia, andando per sommi capi, la situazione è piuttosto statica: nel centro oggi c’è il Partito Democratico, ma prima si votava comunista e prima ancora socialista; il nord e il sud tendevano ad un voto bianco: Democrazia Cristiana, per esempio nella Prima Repubblica ed oggi Forza Italia, Lega Nord, eccetera. Se si guarda la mappa della Francia, invece, ci si trova davanti a due cambiamenti epocali: il Sud-Est della Francia, che era una zona di sinistra, nel lungo periodo è passato alla destra e all’estrema destra. E l’Ovest della Francia, che era bianco, democristiano, ormai è una zona socialista, almeno fino al 2014 perché forse le cose stanno cambiando di nuovo. Quindi ci sono stati cambiamenti fortissimi e importanti all’interno della cultura politica francese. Ma tu vuoi parlare dell’Europa? Sì, ma avrei ancora una curiosità… Prego. All’inizio di questa intervista hai parlato dell’avvento della disuguaglianza sociale in Francia, che è un aspetto che ci interessa moltissimo perché facciamo anche un po’di ricerche proprio su questi temi. Quando parli della disuguaglianza sociale ti riferisci soprattutto alla disuguaglianza di disponibilità economica o al fatto che si siano create delle fratture sociali anche su altri versanti della società francese? Ci sono disuguaglianze economiche e sociali, ovviamente, che sono sicuramente più forti. Ma ci sono anche disuguaglianze educative, cosa molto importante nel senso che ormai c’è un gap, una enorme differenza tra quei giovani che hanno la possibilità di crescere in una zona dove sono accessibili molte o comunque svariate chances educative, e quelli che ne sono esclusi. Anche la disomogeneità territoriale oggi è forte, e aumentano le divisioni. Alcune zone possono crescere abbastanza. Altre come il Nord ex-industriale verso Lille, Roubaix e Tourcoing o l’Est, la Lorena, sono molto meno avvantaggiate se messe a confronto con l’Alsazia o la Regione di Parigi. All’interno della stessa Regione di Parigi, si pone poi il problema, la frattura, tra Parigi città e periferie. Ci sono poi disuguaglianze tra uomini e donne, ovviamente; tra generazioni, cioè tra i più anziani ed i più giovani, e disuguaglianze tra francesi e immigrati. Quindi, ci sono diverse “fratture”. Ciò che mi colpisce molto, nel confronto con l’Italia, è il fatto che anche nel vostro paese le disuguaglianze sono molto forti eppure sembrano, come dire, dissimulate in una sorta di apparente egualitarismo, di sociabilità comune e di facilità di comunicazione. In Francia le ineguaglianze colpiscono un paese dove, l’ho già detto ma lo ripeto, la cultura dell’eguaglianza è quasi nel DNA francese … Nell’habitus sociale francese… Sì, nell’habitus sociale: poiché c’è stata la Rivoluzione Francese e c’è questa passione per l’uguaglianza. Per ritornare al discorso sul territorio, voi italiani pensate che la Francia sia un paese omogeneo. È falso. Ormai la sociologia e la geografia ci hanno dimostrato che, per esempio, abbiamo territori che sono completamente isolati e separati, le persone rimangono solo tra “simili”: si vede molto bene anche a Parigi e nella regione parigina. In alcune parti io non ci vado, per esempio, ma neanche la polizia, sono zone ormai dove nessuno entra… Si autogovernano, diciamo… Sì, ma significa traffici illeciti, criminalità organizzata, eccetera. E ciò ha conseguenze terribili per i giovani. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 177 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 E peggiori ancora per i giovani francesi di origine immigrata. Nel senso che, per esempio, uno che manda il suo curriculum vitae con un nome non facilmente identificabile come francese, dicendo che vive in queste periferie della regione parigina o di tale grande città di provincia, lo vede buttato subito nel cestino. Come colmare questa frattura che rischia di impedire a questi giovani di inserirsi nella società e di crescere dentro fino ad avere la possibilità di accedere a posti di dirigenti e di responsabilità? Ci sono diverse esperienze. Per esempio, in riferimento all’esempio appena fatto, l’idea del curriculum vitae anonimo, nel quale non si vede il nome, neanche la foto e neanche il luogo di residenza, per mettere alla luce le sole competenze. Oppure, ancora, nel mondo dell’insegnamento superiore quello che facciamo a Sciences Po12. Siamo un’Università preposta a selezionare le future élite dirigenziali di questo paese, e non solo, dato che abbiamo il 40% degli studenti stranieri. Già alcuni anni fa, abbiamo lanciato il dibattito in Francia e promosso convenzioni nelle zone cosiddette di éducation prioritaire - zone dove il Ministero dell’Educazione Nazionale cerca di mandare i professori, di investire più mezzi per avere una scuola più efficiente. Diamo anche a quei giovani, in condizioni materiali, sociali, culturali svantaggiate, la possibilità di essere candidati e selezionati nel nostro istituto. Abbiamo lanciato questo dibattito, che è stato duro, in quanto andava contro il sistema repubblicano fondato su criteri meritocratici universali. Noi siamo ispirati dal modello dell’affirmative action americana ma ripensato. Il concorso per entrare a Sciences Po è molto difficile. Abbiamo detto che alcuni di questi giovani non possono fare lo stesso tipo di prove scritte perché non hanno una preparazione culturale di base adeguata per fare la famosa dissertazione alla francese e non hanno nemmeno le giuste competenze in lingua straniera, mentre tutti gli iscritti devono parlare in inglese perché la metà dei corsi è in inglese, perché per ovvie ragioni sociali non hanno potuto imparare l’inglese. Abbiamo fatto degli accordi con questi licei che hanno preparato i loro studenti che vorrebbero entrare a Science Po. Questi studenti hanno un concorso specifico per loro, ossia non fanno le stesse prove e quelli che sono presi hanno un aiuto specifico. Ormai i risultati sono molto buoni, anche se è molto difficile per loro. Dopo di noi, altre grandi scuole hanno elaborato altri sistemi per allargare il loro reclutamento. Con questo non voglio fare pubblicità per la mia Università, ma solo tenere viva l’attenzione su due domande: come uscire da una società bloccata sulle sue ineguaglianze con una piccola minoranza che si riproduce all’interno del sistema educativo e poi all’interno della classe dirigente? E quindi come allargare la composizione della classe dirigente ad altre categorie? L’esperienza di Sciences Po è poca cosa, in quanto sono piccole minoranze. Sono però minoranze che crescono e quando fanno ritorno alle periferie la loro grinta e il loroesempio hanno un sicuro effetto: e i loro amici cominciano a pensare di potercela a loro volta fare. Non è la Rivoluzione, non è la soluzione di tutto. Però abbiamo cercato così di mettere al centro del dibattito il problema della disuguaglianza educativa e di aprire una riflessione sulla classe dirigente (la sua composizione, il suo atteggiamento, la sua competenza, la sua etica) in una società che rigetta sempre di più la classe dirigente. Io sono, alla LUISS, anche Presidente del Consiglio scientifico della School of Government, che ha appunto come funzione di formare classi dirigenti, e cerco di lanciare questo dibattito in Italia (senza ovviamente copiare Sciences Po anche se la Bocconi, lei sì, vi si è ispirata). Perché secondo me anche in Italia c’è il problema della classe dirigente e, specificamente, della sua composizione (senza parlare della sua formazione). Certo. Poi avete milioni di immigrati che rimarranno nel vostro Paese, soprattutto con il basso tasso di natalità degli italiani. Quindi, questi immigrati non saranno solo operai o giocatori di calcio, come Mario Balotelli. Forse in alcuni anni avrete una dirigenza… Che viene dal di fuori… Sì. Lo so che in Italia, ogni volta che se ne parla, la gente non concorda. Anche in Francia è stato difficile, ma forse meno in virtù della grande abitudine all’immigrazione. Oggi il modello di integrazione è molto complicato come abbiamo visto. Complicato anche dalla recente presenza del Front National. Anche il dibattito intellettuale è divenuto molto teso. Ci sono intellettuali, giornalisti, pubblicisti o scrittori molto “anti-immigrati” e che spiegano che la minaccia fondamentale è l’Islam e accusano le scienze sociali e storiche di dire stupidaggini. Criticano 12 Nome informale per indicare l’Institut d’études politiques (IEP) di Parigi. 178 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar duramente e non accettano di vedere che l’integrazione degli immigrati non sia stata cosa semplice nemmeno nel passato, che l’immigrazione attuale comunque sia diversa e non possa essere ridotta a quelli - minoritari ma fortemente attivisti - che odiano la Francia e i francesi, e che sia spesso oggetto di xenofobia e di razzismo. È vero che abbiamo avuto attentati, che i comportamenti di alcuni francesi di origine immigrata sono problematici, che l’antisemitismo cresce tra i francesi di origine araba e africana. Mai come quest’anno ci sono stati atti antisemiti e nel 2014, quasi 7000 ebrei sono partiti alla volta dell’Israele, ed è una cifra senza precedenti. Insomma un problema c’è, non voglio per niente negarlo. Dopodiché, secondo me, ci sono potenzialità e possibilità di integrazione, ma su un modello nuovo, perché il vecchio modello repubblicano, come il modello comunitario di integrazione negli altri paesi europei, sono ormai in crisi. Volevo tornare un attimo indietro su un altro punto: hai parlato di questa vocazione o di questa tendenza alla radicalità, a concepire il cambiamento come un cambiamento radicale, che è una cosa abbastanza interessante, in quanto l’Italia credo che sia abbastanza diversa da questo punto di vista. Ecco, ma come si spiega? Come dire, c’è poco da perdere? Forse perché i legami sociali e le radici sociali sono più deboli rispetto, per esempio, alla situazione italiana? Perché, parlando in generale, chi è a favore di cambiamenti radicali non ha forti legami sociali? Questo aspetto che hai sottolineato mi incuriosisce. Di nuovo credo che ci siano stati dei processi di forte radicalizzazione per ragioni ideologiche. Cioè l’idea che l’unico cambiamento è il cambiamento radicale sul modello della Rivoluzione Francese… Quindi più sul piano ideologico, diciamo… Il rigetto del riformismo inizia nel 1789, su questo c’è un bellissimo studio della storica Mona Ozouf13. Cioè, si delinea fin da subito un odio per le figure moderate. Questa è la dimensione ideologica. Sul piano sociologico, a mio parere, risulta rilevante che le organizzazioni sindacali fossero abbastanza deboli e quindi l’unica possibilità di farsi sentire fosse quella di usare metodi duri, a volte violenti, e radicalizzazioni retoriche… Le jacqueries… Sì, le jacqueries. È stato abbastanza presente in questa società l’uso della violenza verbale e, a volte, fisica. C’è un altro elemento sociologico, un punto comune con l’Italia, secondo me poco studiato ma importante. Il modello di struttura all’interno delle fabbriche era abbastanza autoritario e per molti anni non ha lasciato spazio alle organizzazioni sindacali. Di conseguenza c’erano scontri, scioperi, manifestazioni anche violente: in altre parole lo scontro di classe, di cui parlava Marx, era una realtà in Francia per molti anni. E allo stesso modo l’odio per il sindacalismo da parte del mondo imprenditoriale, la caccia ai sindacalisti è stata a lungo presente. Oggi però nella sinistra, la radicalità è soprattutto nella retorica. La cosa più emblematica è quello che ha fatto François Mitterrand negli anni Settanta: per arrivare al potere nel 1981, si radicalizzò molto a sinistra per prendere i voti dei comunisti, e cosi si è presentato come marxista, diceva del suo odio per i soldi e dichiarava di voler rompere con il capitalismo. Quando però arrivò al potere fece esattamente l’opposto. La radicalità a sinistra è prima di tutto una “postura”, spesso per guadagnare le battaglie interne alla sinistra. Ma le proposte oggi della sinistra a sinistra del PS o delle correnti di sinistra all’interno del PS, assomigliano molto alle pratiche della social-democrazia degli anni Sessanta e Settanta. Presentarsi all’interno del PS come riformista o, peggio, social-liberale scatena subito l’accusa di essere un traditore. Come negli anni Settanta, la sinistra del PS parlava a proposito di Rocard e dei suoi amici di “sinistra americana”. …Non c’è offesa peggiore … Peggiore non c’è. Se tu sei “sinistra americana”, significa veramente che sei un nemico non un avversario… Questo tipo di polemiche si usano anche oggi in Italia… Appunto. Però, secondo me, la potenza della sinistra - mi sembra più forte in Francia che in Italia. 13 Mona Ozouf, L’homme régénéré. Essais sur la Révolution française (1999). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 179 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 Passando all’Europa, qual è la tua opinione sulla classe politica francese, che conosci così bene e così da vicino? In particolare sarebbe interessante un tuo parere sul processo di formazione delle qualità tipiche della classe politica francese, che è un tratto molto distintivo della situazione della Francia. È un discorso questo che ci porta all’École nationale d’administration (ENA), a Sciences Po, eccetera, come centri di formazione della classe politica francese e delle sue élite interne. Una dinamica che in Italia, è molto meno presente. Il modello che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale si lega al fatto che gli studenti facevano, appunto, Sciences Po durante i tre anni e dopo, per una piccola minoranza, c’era l’École nationale d’administration, con due concorsi difficili: il primo per entrare a Sciences Po, il secondo per entrare all’École nationale d’administration che, appunto, offriva una formazione di qualità ed ha formato una grande parte della classe dirigente sotto due distinti aspetti: amministrativo da una parte, ma anche politico. Perché il fonctionnaire della Repubblica è parte della stessa classe politica: molti di questi fonctionnaires invece che rimanere alla testa di diverse amministrazioni, sceglievano infatti di fare politica. Questo era il cursus honorum della classe politica. Uno che aveva fatto l’École nationale d’administration entrava nel gabinetto di ministero di destra o di sinistra (piuttosto di destra fino alla seconda metà degli anni 70, dopo è cambiato). E dopo quest’esperienza, cercava di ottenere un collegio elettorale per farsi eleggere. Se era eletto, cercava di diventare direttamente ministro. Questo modello classico ha iniziato ad essere criticato a partire dagli anni Settanta e dagli anni Ottanta e lo è ancora oggi per diverse ragioni: perché era sempre la stessa categoria sociale a riprodursi (questa è stata l’accusa della scuola di Pierre Bourdieu), perché la formazione era di impronta molto “franco-francese”, decisamente poco aperta al mondo, poco legata alle scienze sociali e completamente fuori dal mondo dalla ricerca; poi perché chi si impiegava nel pubblico non aveva alcuna esperienza diretta del privato, cioè dell’impresa privata, infine perché questi giovani che uscivano dell’École nationale d’administration avevano il posto a vita senza nessun rischio. È anche stato criticato il fatto che molti facevano quello che chiamiamo pantouflage… I pantofolai? Esatto! Ad esempio: se a te funzionario del Consiglio di Stato propongono un posto nel mondo del privato: lo accetti, fai un sacco di soldi, e puoi essere anche il Dirigente di questa impresa. La metti in fallimento? Non c’è problema, ritorni al tuo posto. Di fronte a queste critiche le cose sono cambiate. Anche perché noi di Sciences Po abbiamo criticato questo modello. Abbiamo deciso di fare cinque anni di studi di cui un anno all’estero; obbligo - nato da necessità assoluta - di avere tre lingue per tutti gli studenti, ossia francese, inglese ed una terza lingua; apertura all’internazionalizzazione; più importanza alla ricerca. Il legame però tra noi e l’École nationale d’administration è e rimane forte. Se solo il 2% va all’École nationale d’administration, l’85% degli ammessi sono ex Sciences Po. Sciences P rimane dunque il canale principale di formazione. L’École nationale d’administration è cambiata: è più aperta alle lingue, più aperta al mondo. Ma non ancora, per esempio, si apre alla ricerca e questo è un grosso difetto della classe dirigente francese - come tra l’altro della classe dirigente italiana. Questo ci porta a riflettere sulle trasformazioni avvenute nello stesso percorso di formazione della classe politica. Su questo sono più prudente, in quanto ho solo un esempio sul Partito Socialista. Questo partito dal 1945 agli anni Settanta era un partito principalmente di maestri, di professori di licei. Invece negli anni Settanta, quando François Mitterrand prende la direzione del Partito Socialista, fa crescere una nuova generazione, come Lionel Jospin, Laurent Fabius e tanti altri che avevano fatto Sciences Po - o a volte un’altra grande scuola, l’École Normale Supérieure, l’École polytechnique e poi l’École nationale d’administration - e avevano scelto il Partito Socialista per convinzione o per opportunismo, in quanto avevano capito che il Partito Socialista poteva vincere. Questa classe dirigente aveva avuto esattamente la formazione di cui abbiamo parlato: buona, malgrado i suoi limiti. A partire dagli anni Novanta, abbiamo visto crescere un’altra generazione di giovani che hanno fatto un po’di studi, ma soprattutto politica: associazionismo, movimento giovanile studentesco, eccetera che spesso non hanno mai terminato i loro studi, non hanno fatto la tesi di laurea, eccetera e sono diventati dei dirigenti professionali del Partito Socialista14 14 Carole Bachelot, “Groupons-nous et demain”. Sociologie des dirigeants du Parti socialiste depuis 1993. Thèse de science politique. Sciences Po (2008). 180 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar Esatto. È un’altra classe dirigente, non è più la stessa del passato. Non significa che questi politici sono stupidi, anzi, ma non hanno le caratteristiche del passato. Bisognerebbe avere numerose e diverse ricerche e dati su questo: il modello École nationale d’administration almeno per il Partito Socialista, non è più l’unica scuola di formazione per la classe politica. … Anche noi in Italia conosciamo queste storie… Non oserei però dire che quelli che fanno la politica sono più i mediocri... Però puoi dirlo. Può essere un’ipotesi che suppone di essere verificata e studiata bene con criteri non facili da identificare. Ma mi sembra che qualcosa stia cambiando. A Sciences Po la cosa che cerchiamo di inculcare ai nostri studenti, che per la grandissima maggioranza avranno posti di responsabilità, è di non essere orgogliosi, di non avere questo spirito insopportabile di superiorità, di essere aperti al mondo, di insistere sull’importanza dell’etica pubblica, puntando sulla necessità di essere assolutamente esemplari nei comportamenti perché la moltiplicazione degli affari di corruzione indebolisce la classe politica e la classe dirigente in generale. Perché abbiamo la responsabilità di formare una parte di questa classe dirigente francese ma anche straniera che dovrà lavorare in società la cui tendenza è quella di criticare sempre più aspramente tutte le loro stesse classi dirigenti. Ma non rischia di essere una battaglia molto difficile, per non dire già persa? Quello che è venuto ad essere assolutamente dominante, lo dico con grande semplicità, è il valore del Dio denaro: chi più paga e chi più prende. E quando parlavi del privato e del pubblico… Sì, hai ragione. Cioè, almeno sull’esperienza che ho a Sciences Po, molti studenti dicono di voler guadagnare soldi. Scelgono alcuni master perché sanno perfettamente che, quando escono con questi master, avranno grande opportunità di lavoro e di guadagno. Vediamo l’utilitarismo degli studenti anche nel loro puntare su due precise discipline (siamo un’Università pluridisciplinare), l’economia e il diritto. Però c’è anche una minoranza che rigetta assolutamente questo modello; per la quale le priorità sono altre. Passando al tema dell’Europa, tanti sono gli interrogativi: se esiste una società europea; se l’Europa può essere un soggetto istituzionale nuovo; riguardo al divenire dei rapporti tra Europa e gli Stati Nazionali, se quanto radicalmente questi si modificano. Cose che si discutono anche in Italia in questo periodo… Qual è la tua opinione, attualmente, con riferimento principale alla società francese? La situazione è difficile. Non siamo più nell’ambito dello Stato nazionale, ma non siamo ancora in uno Stato europeo, quindi siamo in un periodo transitorio. Si delinea anche la fine di un certo modello europeo, ossia quello della pace, della prosperità, del pieno impiego e della protezione, le famose quattro P della concezione europea. La pace perché ormai il conflitto è ai confini e forse ci sarà la guerra contro il terrorismo sul territorio europeo. La prosperità perché anche se l’Europa rimane una zona ricca in confronto di altri continenti non è più la stessa prosperità di una volta. Il pieno impiego non c’è più e non ci sarà con buona probabilità per lungo tempo, società nelle quali la gente, soprattutto i giovani, non avranno lo stesso mestiere per tutta la vita. Si prospettano quindi periodi molto diversi, segnati da una grande mobilità, pieni di opportunità da una parte ma stressanti dall’altra parte. Infine, il welfare pur rimanendo ad un alto livello (basta fare la comparazione con gli Stati Uniti) non potrà più esser generoso come prima.Tutto questo - come è ovvio - alimenta la critica dell’Europa, critica che in Francia è molto forte. È molto forte perché è stato sempre una componente storica di una parte della cultura politica francese, sia di destra che di sinistra: da una parte, i comunisti come l’estrema sinistra hanno sparato a zero contro l’Europa e lo fanno sempre; e dall’altra parte i gollisti hanno sempre nutrito una grande sfiducia verso l’Europa ed Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 181 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 è la stessa cosa ovviamente per l’estrema destra. Questo potrebbe fornire nel futuro gli elementi di una eventuale ricomposizione politica francese, in quanto una parte del Partito Socialista così come una parte della destra si pongono in una posizione critica riguardo all’Europa, mentre altri appartenenti sia alla destra sia ai socialisti si ritrovano su posizioni altrettanto vicine ma per un’Europa forte. E oggi di rilievo è la critica della destra, con il Front National. Questo partito anche se non è - come si presenta - il primo partito francese, ha vinto le europee, è stato il primo partito alle elezioni europee e argomenti come l’anti europeismo, l’eurofobia e l’euroscetticismo sono sempre più diffusi. Il paradosso sta nel fatto che, dopo il Trattato di Lisbona, abbiamo assistito ad importanti trasformazioni democratiche dell’Europa: il Parlamento ha molto più potere e la Commissione Europea è stata formata in funzione anche del risultato delle europee; il Parlamento cerca di aumentare la sua attività e la sua capacità di intervento. E nello stesso tempo ci sono sempre meno europei che votano, come abbiamo visto alle ultime elezioni, soprattutto nei nuovi paesi. E quelli che votano scelgono i partiti populisti. C’è anche un problema economico, ossia come rilanciare l’Europa? Su questo devo dire che non ho competenza. Alcuni colleghi economisti mi dicono che bisogna ridurre assolutamente il deficit o il debito pubblico, questa è una priorità assoluta per loro. Invece il mio grande amico keynesiano Jean-Paul Fitoussi mi spiega che questa è una stupidaggine. Non ho un’opinione su questo, però vedo che c’è un dibattito. Soprattutto, come politologo quello che mi colpisce è l’incapacità di ragionare, sul lungo periodo, dei dirigenti europei. C’è stato questo terremoto delle ultime elezioni europee, c’è questa Commissione Juncker, che è il risultato di negoziazioni tra Partito dei Socialisti Europei e Partito Popolare Europeo, c’è una Commissione con diverse componenti, ma non si vede bene la capacità dei dirigenti di dare un messaggio agli europei e questa mi sembra una politica cieca. E dai risvolti gravissimi; con conseguenze che potrebbero essere devastanti, prossimamente, in diversi paesi, tra cui la Francia. La possibilità di una presidenza di Marine Le Pen nel 2017 non è assurda. Ma ritorniamo sul nostro ragionamento. I popolari sono stati incapaci di formare un gruppo al Parlamento Europeo. Dunque i nostri dirigenti pensano che sono deboli all’interno delle istituzioni e dunque, al loro avviso, nelle società. Ma non capiscono il malessere molto profondo in diversi paesi europei che spiega appunto i successi elettorali dei populisti. Ormai anche in Italia c’è un sentimento critico verso l’Europa, che arriva a risultati che non sarebbero mai stati pensabili quando ci siamo conosciuti a Firenze, quasi trent’anni fa, caro Paolo. All’epoca l’Italia era il paese più europeista di tutta l’Europa. Secondo me bisogna ripensare l’Unione Europea. Io sono piuttosto favorevole ad un’Europa a due velocità, con una parte dell’Europa con una più grande integrazione politica, economica, fiscale e sociale, anche se sarà difficile e, soprattutto, una capacità di ripensare la costruzione europea senza fermarsi alle vecchie P; ciò suppone di ripensare il modello europeo e di riproporre una narrativa europea. Se non lo si farà, se, per esempio, il Regno Unito esce dall’Europa dopo il suo referendum del 2016, potremmo avere un’ipotesi di disaggregazione completa dell’Europa con tentazioni di ripiegamento nazionale o regionale. Tuttavia bisogna essere cauti nelle nostre analisi. Quando si vedono i sondaggi, la maggioranza dei francesi vuole rimanere nella zona euro. Ma nello stesso tempo, l’idea di un ripiegamento sulla Francia mitica, la Golden Age della Francia di Marine Le Pen, è ormai condivisa da tanti intellettuali e pubblicisti che, continuamente, spiegano come era bella la Francia una volta, che questa è la Francia da ritrovare, preferibilmente senza troppi immigrati e senza l’Europa. Quindi, a mio avviso, siamo veramente in una situazione di grandissima emergenza e di pericolo. Confesso che, attualmente, sono pessimista su tante cose… Anche da questa prospettiva pessimista, potresti pensare che tra le soluzioni non garantite ma possibili, ci sia - dinamica che la società francese peraltro conosce bene - quella dell’emergere di una leadership? Una leadership capace di affascinare e riaggregare intorno al tema dell’Europa, e quindi in grado di costituire un motore di affermazione della stessa idea di Europa, prima ancora che della società europea. In altri termini, perché affidarsi solo a meccanismi istituzionali, elettorali, burocratici, anche economici …? Sono d’accordissimo, il problema è che non li vedo. Non vedo in Francia qualcuno che avrebbe questa capacità, non vedo il Presidente François Hollande, non vedo neanche, per il momento, il Primo Ministro attuale, non vedo il ritorno di Nicolas Sarkozy come un grande momento di speranza. Abbiamo (su questo bisognerebbe avere studi molto precisi) la sensazione di una forma di abbassamento della leadership politica in Europa. Non siamo colpiti dalla presenza della forza di alcuni leader. Forse è la ragione per la quale Matteo Renzi, attualmente in 182 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar Europa, suscita un tale interesse. Perché è giovane, perché ha questa capacità comunicativa fortissima, perché vuole riformare tante cose, perché si presenta come il salvatore non solo dell’Italia, ma dell’Europa. Dopodiché, bisogna vedere quello che ha veramente fatto e che farà prossimamente. Ma oltre il caso Renzi, siamo in una situazione un po’di vuoto della classe dirigente politica. In questa situazione, appunto pericolosa per l’Europa, non abbiamo figure di riferimento. Se si pensa alla nascita dell’Europa con Alcide De Gasperi, Robert Schuman e Konrad Adenauer; o ad altri momenti, come quando Jacques Delors è stato Presidente della Commissione. C’è stato un momento forte per l’Europa, di identificazione di una parte dell’opinione pubblica, Non vedo, diciamo, per il momento, la possibilità di una crescita di questa nuova leadership politica. Volendo continuare a ragionare, anche se forse un po’troppo astrattamente, non potrebbe essere uno spazio interessante per un’affermazione della sinistra europea? Perché in fondo l’idea di Europa, dopo i primi decenni, è venuta crescendo in questi ultimi dieci o quindici anni, che, forse, sono stati più di sinistra che di destra, con una direzione di sviluppo che è - chiamiamola come vogliamo - molto fondata sull’economia, sulla moneta, sull’efficienza, sulla razionalità. Un patrimonio di idee che si legano più semplicemente alla destra che alla sinistra. Non potrebbe essere, quindi, uno spazio ideale ma anche pratico che la sinistra non sa cogliere, non sa sfruttare? Come se la sinistra non riuscisse a dare o a ridare spazio e vita a nuove idee, a nuove prospettive di costruzione di un’Europa che, invece, si può ancora fondare sui valori della solidarietà, dell’uguaglianza, della giustizia sociale? È forse un’occasione che la sinistra sta perdendo, quando invece potrebbe avere tante ragioni per contrastare una destra europea che, apparentemente, come dicevi tu, è naturalmente critica anche verso quest’idea di Europa, ma forse è anche molto vicina… Non è che c’è uno spazio di azione, che oggi non viene sfruttato e che potrebbe essere sfruttato per creare un nuovo tipo ideale di Europa ed una nuova realtà europea? No, no, hai ragione, tutti se lo domandano. Nel 2009, i capi della sinistra socialista hanno fatto un grosso errore. Cioè la sinistra europea è partita alle elezioni europee assolutamente convinta che con la crisi economica subito la gente sarebbe ritornata a sinistra. Basta vedere le dichiarazioni dell’epoca. Ma il 2009 ha segnato un brutto risultato per il Partito dei Socialisti Europei. Nel 2014 i socialisti hanno fatto un manifesto e una campagna elettorale per dimostrare che era il momento della sinistra. Sono però due, a mio avviso, i principali problemi riscontrabili. Hanno puntato su una Europa più sociale, senza tenere conto che, appunto, una parte del loro elettorato si è ormai spostato su posizioni eurofobiche o euroscettiche o comunque critiche nei confronti dell’Europa. Ovvero - e questo è un problema sociologico - tutta la componente popolare, classicamente pilastro della sinistra, ormai è su una posizione critica ed ostile all’Europa, all’Europa di Bruxelles, all’Europa della burocrazia, all’Europa capitalista (e anche all’immigrazione). E per questa parte della popolazione i socialisti sono come i popolari, responsabili della grave situazione economica e sociale europea. E un elettorato molto difficile da recuperare per la sinistra: dunque questa è stata la prima resistenza. L’altro elemento è che forse la sinistra, ogni volta che parla dell’Europa, riprende diversi discorsi classici sul suo intervento sociale e manca un po’di riflessione. La sinistra ha una debolezza intellettuale e culturale e tutto il lavoro degli esperti e degli intellettuali vicini ai socialisti è preso poco in considerazione. Per ritornare un po’ sulla Francia, secondo i più recenti dibattiti in Francia si respirerebbe ormai un’atmosfera tipo anni Trenta: ci sono movimenti populisti, ci sarebbe una forma di ritorno di un nuovo fascismo, c’è sempre più razzismo, eurofobia, tentazioni di chiusura ecc. Non sono d’accordo. Bisogna pensare la situazione attuale certo con riferimenti alla storia ma con gli occhiali del presente. Non voglio negare che ci siano queste tensioni e la crescita di tutti questi movimenti populisti, di protesta, euroscettici, xenofobi e a volte razzisti è indiscutibile. Però d’altra parte credo che ci siano anche altri elementi: c’è una società che spinge per attuare una forma di conservatorismo sociale, che vuole difendere lo Stato sociale in Europa; c’è tutta un’altra società che cerca più democrazia, che vuole partecipare di più, che vuole inventare altri modelli, che funziona molto attraverso la rete sociale, internet, e che ha un’alta capacità di mobilizzazione. Il problema è che sono società diverse: la prima, quella del ripiegamento, è spesso di estrazione molto popolare; l’altra, che chiede più democrazia partecipativa, deliberativa, più trasparenza, che vuole essere più associata alla politica, è piuttosto la fascia di popolazione con un certo livello di istruzione… È sempre stato così. Storicamente ci sono stati momenti nei quale il mondo operaio ha potuto avere altre esperienze, altre attese ed Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 183 Marc Lazar DOI: 10.1400/228750 altre aspettative. Quello che cerco di spiegare è che non c’è una sola tendenza nelle nostre società europee, ci sono diverse dinamiche contradittorie e la responsabilità della sinistra da questo punto di vista - e con questo riprendo uno spunto di riflessione emerso in più passaggi di questa lunga intervista - è la battaglia culturale. Sicuramente c’è una battaglia culturale da riprendere. Io non vedo il trionfo della destra in Europa. Non sono d’accordo con l’idea, sviluppata da Raffaele Simone, che ha avuto più successo in Francia che in Italia. Nel suo libro, che è stato quasi un best seller in Francia, si sostiene che la società del futuro sarà di destra, in quanto le società sono invecchiate, hanno paura, e la destra è capace di fare un discorso liberalista ma anche di edonismo sociale, mentre la sinistra è triste15… Lo dice lui… Io non la penso così. E innanzitutto penso che il discorso sia molto più complicato. Penso che le culture politiche della sinistra e della destra sono in grande difficoltà, perché non è vero che c’è solo uno spostamento verso la destra, in quanto una parte della destra ha recuperato molte cose della sinistra, come sul piano economico, sociale, dei diritti civili. Per esempio: la destra ha rinunciato (con l’eccezione dell’Inghilterra) a tagliare completamente lo Stato sociale, perché una buona parte del loro elettorato li sanzionerebbe subito. Sul piano dei diritti civili, la destra non osa ritornare indietro sulle riforme fatte dalla sinistra. Credo che anche se in Francia ritornerà al potere la destra, e nonostante le manifestazioni contro e le dichiarazioni di Sarkozy, il diritto di matrimonio per le coppie di uno stesso sesso, non dovrebbe essere toccato. Quindi, diciamo, c’è una parte della sinistra che, almeno sul piano economico, va verso il centro, verso il social liberalismo. E c’è una parte della destra che ha recuperato una parte delle “libertà dei costumi” della sinistra e che non osa troppo attaccare il welfare. Ricapitolando: la sinistra e la destra hanno grossi problemi ideologici e di cultura come partiti di governo. Invece quello che cresce, appunto, sono i movimenti di protesta, gli estremismi, i populismi. Da questo punto di vista, Marine Le Pen è molto interessante come caso, perché è una che, ovviamente, riprende il suo solito vecchio argomento contro gli immigrati, contro Bruxelles, contro la classe politica, contro il Partito Socialista e l’UMP (usando la formula dell’UMPS), contro tutte le élite, eccetera. Però con alcuni cambiamenti e “aggiornamenti” importantissimi. Primo: si presenta come il grande difensore della Repubblica, mentre la fazione dell’estrema destra era ostile alla Repubblica. Secondo: si presenta come il grande difensore della laicità contro la minaccia islamica, come il difensore della Repubblica laica. Come mai, si chiede, una può avere il velo mentre la tradizione repubblicana è di evitare tutti i segni religiosi pubblici? Terzo: difende le donne, dicendo: “Io sono una donna moderna, divorziata, eccetera e gli islamici vorrebbero ritornare sulle nostre grandi conquiste”. Quarto: difende lo Stato sociale (non è liberista come suo padre), ma un Stato sociale riservato ai francesi. Con questo ha fatto breccia e riscosso consenso nel mondo operaio e popolare. Però, se ci fai caso, affronta anche il problema dello stato sociale, che è un problema importantissimo. Ci si muove su un piano che è un piano di valori, no? Il problema, secondo me, è un po’questo. Cioè che in Europa siamo da tempo in una fase che i sociologi chiamano un po’ frettolosamente postmoderna: ma che cosa significa? Significa di più che muoversi sull’avere o non avere il famoso piatto di lenticchie. Probabilmente bisogna muovere i gruppi, i ceti, le classi, le società intere intorno a un universo di valori - possiamo definire così ciò di cui parlavi - e sapersi muovere su questo terreno stabilirà chi vince o chi perde. In questo senso, ti posso fare un’ultima domanda: oggi una delle critiche che si fa all’Europa, come sai benissimo, è che sia un’Europa tedesca, l’Europa della finanza, l’Europa dei mercati, l’Europa, diciamo, repressiva, soprattutto sul piano economico. Ma la Francia, proprio per la sua tradizione, che tu hai ricordato tante volte in questa intervista, non potrebbe arrivare a costituire, ad affermare un’anima diversa per l’Europa, e diventare - forse per certi aspetti anche insieme all’Italia - una protagonista? Si può arrivare ad ipotizzare una costruzione dell’Europa non in salsa tedesca, ma in salsa francese, no? Più fondata su valori e ideali che non su efficienza, economia… Bisognerebbe avere una leadership politica capace di avere valori di riferimento… La Francia li ha avuti. 15 Raffaele Simone, Le Monstre doux. L’Occcident vire-t-il à droite? (2010). 184 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228750 Marc Lazar Sì li ha avuti. Ma oggi un po’meno. Il solo modello francese esteso a tutta l’Europa è impossibile. I paesi sono diversi. L’idea francese che la Francia è il principale paese dell’Europa, insieme alla Germania, è un po’superata. L’Europa, per ragioni storiche, ha bisogno di una alleanza tra Germania e Francia forte ma non esclusiva, e questo è già difficile da accettare per una parte della classe politica francese. Come ho scritto recentemente16, la Francia vuole un matrimonio con la Germania e a volte, quando c’è un problema con la Germania, pensa alla vecchia amante, che si chiama Italia… Quindi va a vedere l’amante, che ha solo la funzione di rinnovare il matrimonio con la Germania. Questo atteggiamento classico è oramai superato. La Francia potrebbe puntare ad un nuovo diverso ruolo. E a questo io - da questo punto di vista sono e mi sento molto francese - credo. Noi francesi abbiamo certi valori di libertà, di eguaglianza, della fraternità, di diritti umani, eccetera che sono costituitivi dell’identità europea. Credo molto al fatto che la Francia possa sempre portare avanti questi valori, a condizione di non avere un atteggiamento di arroganza verso gli altri paesi e di non essere convinti che tutti i paesi debbano fare come i francesi. Questo può essere il contributo francese all’Europa. Penso inoltre che la Francia non sia avviata alla regressione generalizzata. Certo indubbiamente ci sono molti elementi spia del declino francese: come, per prendere solo un esempio, il degrado della competitività delle nostre imprese. E lo dobbiamo accettare. Eppure ci sono anche molti cambiamenti forti in Francia. Sono stupito, per esempio, dalla capacità linguistica ormai acuisita dai francesi: prima era impossibile vedere gente che parlavano un’altra lingua, ma ormai tanti giovani hanno capito che, se non parlano almeno l’inglese, non ce la faranno. È presente e riconosciuta la necessità di aprirsi e anche di prendere lezioni da ciò che viene dall’estero. Una parte della società ha molto più presente un ruolo della Francia oggi ridimensionato. Però si può pensare sempre che la Francia abbia un ruolo. Abbiamo enormi potenzialità, malgrado tutto: un’amministrazione efficiente, una forte posizione geografica in Europa, la rete di infrastrutture pubbliche, una manodopera molto qualificata e che ha un’alta produttività, intellettuali di prestigio, grandi università, una cultura sempre innovativa ecc.. Sul fatto che la Francia possa avere un ruolo, come dici tu, per una ricostruzione di valori europei, sono assolutamente d’accordo. Bene… Lo spero almeno! 16 Il riferimento è all’articolo L’amante di Francia, pubblicato sul quotidiano «La Repubblica» in data 24 ottobre 2014 (http://ricerca. repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/10/24/lamante-di-francia41.html). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 185 186 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Book Reviews Anno IV, Numero 7/Giugno 2014 187 188 Anno IV, Numero 7/Giugno 2014 DOI: 10.1400/228751 Book Review [Mafie del nord. Strategie criminali e contesti locali] Rocco Sciarrone (ed.), Book series of the Fondazione Res, Rome: Donzelli, 2014 ISBN: 978-88-6843-060-3 The Social Reproduction of the Mafias: Mechanisms and Processes This book lends itself to various interpretations, all of considerable interest. The most logical and immediate one satisfies the need to learn about a social process that till now has been little and badly investigated, or almost always within narrow territorial and temporal limits: namely the breeding grounds within Italy, rates of expansion, modes and routes of those criminal phenomena (Mafia, ‘Ndrangheta, Camorra, and their variants) that until a few decades ago existed and thrived almost exclusively in their territories of origin, the regions of southern Italy. Whoever is interested in this type of literature - I would suppose the vast majority of those who take this book in hand - will find in the seven chapters from III to IX a careful, intelligent reconstruction of the Mafia’s principal processes of social reproduction (Mafia being a term I use here as elsewhere as a shortcut to refer to the various criminal organizations under examination): from the case of lower Latium to those of Lombardy, Piedmont, Western Liguria, Reggio Emilia, Prato and Veneto. Beyond the wealth of narratives, I was struck and stimulated by the way Sciarrone and his researchers orient themselves in the cognitive process, and by the results this work strategy has achieved. So I will focus especially on this, though here and there turning my attention - for the sake of exemplication and support of specific arguments - to this or that case study. The methodological and theoretical approach, which Sciarrone summarizes on p. XIV and then develops in the first chapter, aims entirely at “discovering” and understanding the processes of the mafias’ social reproduction. The research query is clear, and it is posited entirely within a classic formulation of the sociological tradition: to understand change, understand why society changes. The research is therefore not about criminal sociology, as it may strictly be defined, but is the result of applying the best sociological tools and, I would say, those of the social sciences, to investigating a definite social process and the mechanisms that nourish it: the reproduction, in some territories of central and northern Italy, of mafia organizations typically and historically rooted in the southern regions. The specification I have made regarding disciplinary collocation may appear superfluous, if not useless, but I hope that the few points I examine will clarify the reasons for it. The ideal-typical approach. Sciarrone (his collaborators will pardon me this repeated synecdoche, but it is expressively easier to incorporate them in the editor’s name) uses often this classic Weberian tool. In my opinion, its application provides him with the most valuable interpretive key of his whole research. The reasons are varied. Sciarrone, who is interested in reconstructing the mechanisms of reproduction of the mafias in their new enclaves, quickly realized that the study of those processes, investigated so to speak in their nascent state, supply it with this ideal-typical tool, usable not only to study that process, but more generally to reconstruct and evaluate the ways in which the mafias - the new ones as well as the more traditional ones - establish themselves1. It is in this ideal-typical frame that Sciarrone and his collaborators gradually collocate the results of their various case studies. I will cite some of the more interesting ones, arranging them by analysis context. Space. Seeing in what territories the mafias expand, at what rate, in what ways and by what paths, is the best method for understanding the mechanisms and processes of social reproduction.The case studies obviously provide a variety of indications, but all are highly dependent on the features of the local host societies: type of production structure, law enforcement effectiveness, activatable social networks, ethnically homogeneous settlements, and so 1 See especially par.4 of the first chapter. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 189 Book Review DOI: 10.1400/228751 on. The diversification of these features favors one or another type of mafia expansion: simple infiltration in some areas (see the case of Tuscany) and entrenchment in others (in the case of Emilia Romagna); how these different modes and action strategies for “insertion” in local societies are seen to prevail: through imitation, according to a very common logic in the processes of social mobility (the theory of reference groups comes immediately to mind), or through hybridization, if the cultural environment and social distances allow connubium and commercium between aliens and natives. Physical space and social space, in their inextricable intertwining, stand in the way as obstacles or, vice versa, facilitate very differentiated means and strategies of action. While, for example, the geographical proximity between Calabria, Campania and Latium offers an easy explanation for the greater presence in Latium of the ‘Ndrangheta and the Camorra, in the long run - to which Sciarrone and his staff constantly pay close attention, so rare in today’s atemporal sociology - in reality there has been a succession of historical phases (the dominion of the large estates, the land reclamation of the 1930’s, the post-war construction boom, etc.) which so uniquely changed the face of the Latium region, each area thereby exerting a force of attraction towards different “populations” and criminal groups. While not a decisive factor, the smaller geographical distance can be a help, but nothing more, in establishing long-lasting relationships, exchanges, material and non-material support between target and source areas. The nature and constitution of these ties present various points of interest, which the research takes into account. Here I recall one in particular: that the acquisition of knowledge and skills in the latest expansion areas can become a factor of “criminal” modernization of the more traditional areas of origin. This process, very common and much studied in standard migration phenomena2, by no accident finds a correspondence in those investigated in this book: demonstrating, in my opinion, how the strategies and models of action are to some extent independent of the ordinary or criminal nature of groups “on the move” and of their lawful or unlawful ends. Time. As I have already mentioned, Sciarrone explicitly adopts a process-type perspective, which moves indistinctly - as Elias teaches - among the levels of individuals and families, clans and groups, organizations and local societies. Perhaps the case study where the process approach is applied most successfully is the one on the Canavese area (Chap. V), where the expansion of the criminal element (in this case the ‘Ndrangheta) takes on different forms within a relationship shifting between economics and politics (p.179). At the individual-family level (to use a category of Schumpeter’s)3 the weightier processes are identifiable in the unfolding of migratory chains (with consequent selection of “personnel” on the basis of family and clan affiliations) and/or in the changing conditions of the local target societies, evaluated more or less favorably for the development of criminal careers. Their typological representation takes into account another mechanism of Mafia enclaves in non-traditional areas: adaptation. According to a Parsons-type biological and social principle, the criminal will pursue his career positively to the extent that he is able to adapt to the host environment - since, as Sciarrone notes, the time required for changes in the context conditions are inevitably longer than those sufficient for the agents to “fit in”, for better or worse, with the rules of the target environment (pp.214-15). At the local society level, Reggio Emilia, where the Calabrese ‘Ndrangheta has prospered, is a good example of the usefulness of employing process-type reconstructions of events. The crisis of the large estates, which had stricken the Crotona area in the post-war period, though at first it had given rise to proto-mafia phenomena fueled by layoffs of the Barons’4 security personnel, subsequently became a “pioneer” activity5: which in the case 2 See the study on Reggio Emilia and - for the description of some international cases - The New Argonauts: Regional Advantage in a Global Economy, by Anna Lee Saxenian (2007), «Journal of Economic Geography», 7 (1). 3 I refer to J.A. Schumpeter’s essay (1927), Die sozialen Klassen im ethnisch-homogenen Milieu, in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», LVII, 1-67 (translated into English as Social Classes in an Ethnically Homogenous Environment, in Imperialism and Social Classes, New York, A.M. Kelly, 1951). 4 It is a widely known process in sociology (from Schumpeter to Mosca, to cite its major proponents), according to which, when a social group can no longer exercise its function, is in definitive decline or utilizes its former know-how - in this case, the specialized use of violence - to “create” a new function for itself. 5 See p.265 and all of par. 2 Il ponte migratorio, on the case of Reggio Emilia (chap. IV). 190 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228751 Book Review of Emilia Romagna opened the way, as often happens in processes of mobility, to larger and “purer” groups of criminal elements. In this initial phase of expansion there prevailed what might be called a process of primitive accumulation, financed by kidnappings, drug dealing, extortion, etc., followed by a gradual stabilization, with reinvestments of “dirty” capital, bribery, consolidation of favor-bartering with members of the political and economic establishment, to the setting up of a social network capable of managing the power acquired with little risk and practically no need to resort to acts of criminal violence6. Culture, values and localized social networks. There is a courageous research question to which Sciarrone’s group attempts, in large part successfully, to give an answer: whether or not, in addition to the important material conditions that favor the expansion of the mafia system, other more intangible conditions also play an important role. The answer is unequivocal: the mafias expand successfully wherever local values, ideologies and cultures are, as it were, ready to receive them, since there are already present in their own cultural system elements (and practices) syntonic with elements (and practices ) of the mafia culture. There are two cases, the Venetian one and the Tuscan one, which in different ways lend themselves well to an exemplification. For the sake of brevity, I will consider this aspect along with another that deserves attention on its own, namely the relationship between economic crisis and penetration of the Mafia. I do so because the crisis condition - and in particular that of the long, serious crisis we are still going through - sheds a sharper light on the mechanisms we are dealing with.Which are essentially two, differing from each other, but which in a crisis situation can produce the same results. First: the informality which in the districts in question often accompanies economic and commercial transactions (the legendary handshake that seals a deal) leaves the way open for opportunistic behavior that in times of crisis (but perhaps not only) have a greater attraction, to the point of verging upon unlawful conduct or at any rate where the boundary between what is lawful and unlawful becomes blurred7. Second, on a cultural level, if we consider that the mafias’ choices of territories to penetrate often take into account - consciously or not - the value standards and lifestyles of the population, what happens is that the unlawful conduct meets no effective “moral” resistance because it fortuitously plays on shared values8: which, if in normal situations these in part take multiple forms, under the pressure of the crisis they converge into a single form. Violence and tradition. The strength of the mafias, their capacity to manage their affairs, their need to obtain obedience from their followers as from those they harass or corrupt, is based on two factors: violence and tradition. Both absolve the function of keeping the mafia associations together; both, although in a different way, contribute to maintaining order in the target area. It is interesting to note how Sciarrone makes clear reference, in writing about violence, to Weber’s famous statement on the (legitimate) use the State can make of it when other means are unable to obtain obedience against possible resistance. What emerges from the case studies9 is that, while the criminal organizations equip themselves for a specialized use of violence, its exercise is actually a last resort, to be employed only when all other attempts have failed to achieve satisfactory results. What we see therefore is the belief that the use of violence by the mafia is in the last analysis considered “legitimate” when the Mafia societystate is at risk of disintegrating or disappearing: as demonstrated by the fact that up to that limit the preference is to threaten violence rather than exercise it10. 6 The dissolution of the large estates triggered a not dissimilar process, except obviously for the different plane of illegality on which it was enacted, to the events well narrated by Brusco, Capecchi and others related to the crisis of the Officine Reggiane and the consequent spread of worker and technical know-how over the surrounding area, which led quickly to the development of an efficient, thriving system of small metalworking industries. 7 See especially the case of Prato pp.304-305. 8 It is a kind of reasoning dear to Parsons as interpreter of social change: an operation of cultural change is successful to the extent that it refers to an already present value, of which it offers a different formulation. 9 Again, see especially the case of Prato, p. 325. 10 See for example the case of the Veneto region (pp.346-347), and the Tuscan case of Prato (p.324). It is no accident that newspapers speak of a State within the State, of State-Mafia negotiations, of occupation of the State, etc. Not without reason, I think, as in all the cases studied the constant attempt of mafia groups to infiltrate and condition the political and institutional sectors has demonstrated, to Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 191 Book Review DOI: 10.1400/228751 Even rituals and traditions fill in to perform important tasks. The research makes two interesting observations. The first is that in the new Mafia enclaves ritual and tradition are more preponderant than in their areas of origin, almost reinforcing an identity that is felt as isolated, estranged and threatened, and therefore tightening internal discipline through a mystical reinforcement of collective identity.The second is that use is made of symbols, rituals and instrumental exhibitions - all of which Sciarrone defines as an “imaginary dimension” - in order to present mafiosity in the best light possible for achieving criminal accreditation, either by competing mafia groups or by the local society . Sciarrone’s research offers many other stimulating points, but the reader will have understood where, in my opinion, the value of this book lies: in Author’s ability to make the best use of the theoretical and conceptual tools which sociology and the social sciences make available for responding to research questions. This ability shows through in all of his analyses, and especially in the interpretations of their results: an ability of which Sciarrone does not always reveal the disciplinary ascendancies, even if of certain derivation, since they have obviously become organic parts of his way of thinking and working. Sometimes, it is true, he relies on usages that are widespread in the sociological mainstream, for example when he resorts to the category of social capital (which in my opinion will never be criticized enough, especially for its tendentious and misleading name) in support of his interpretation of the Mafia processes of expansion. But these are venial sins. There remains the matter of a research that delves deeply into the social mechanisms of mafia reproduction, following paths whose roots strike deep even in the far off history of the lands of origin. A book to read for the many things it says about the mafias of the north, but also a paradigmatic text - unfortunately rare in the Italian and international production of these years - of how good sociological research can be done. I immediately correct myself: how research and social science can be done. (Paolo Giovannini) wit to become a State within the State. 192 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228751 Book Review [Un racconto del lavoro salariato] di Guido Baglioni, Bologna: Il Mulino, 2014 ISBN: 9788815251879 Alla ricerca dell’operaio perduto All’interno del dibattito sociologico sul tema del lavoro c’è qualcosa di nuovo, anzi, di antico: si torna, anche grazie al volume di Guido Baglioni Un racconto del lavoro salariato, a parlare di fabbriche e di operai. I lavoratori salariati, anche quelli manuali dell’industria, continuano a rappresentare una componente significativa dell’occupazione, soprattutto in alcuni territori dove sono ancora presenti importanti siti produttivi. Eppure, è soltanto con riferimento a vicende di dismissione o di ristrutturazione aziendale, a disastri ambientali e incidenti sul lavoro, che la questione operaia torna a far parlare di sé. E’, questa che Accornero chiama una “visibilità negativa” (Accornero 2009), uno degli elementi che contribuiscono a rafforzare l’idea che quello del lavoro operaio sia un universo ormai marginale e residuale all’interno della società contemporanea. Su quanti siano - e su chi siano - gli operai oggi, su come vivono e lavorano, su quanto, e per cosa, continuino a distinguersi da altre componenti sociali, sappiamo in realtà ben poco. Nella sostanziale disattenzione del dibattito scientifico, che ha da tempo spostato il baricentro dei propri interessi su altre priorità - flessibilità, immigrazione, povertà, disoccupazione, giovani, donne, ceto medio, etc. - tale curiosità resta inappagata; peggio, lascia spazio all’affermarsi di rappresentazioni univoche e semplificate - la fine del lavoro, la scomparsa della classe, la solitudine delle “tute blu” - spesso veicolate e rafforzate da una produzione letteraria, cinematografica, giornalistica che negli ultimissimi anni è stata, al contrario, assai abbondante. Se alcune importanti ricerche hanno permesso, in anni a noi vicini, di aprire uno spiraglio di conoscenza sulle condizioni di lavoro degli operai metalmeccanici (Carrieri, Damiano, Ugolini 2005) resta tuttavia difficile ricondurre alle condizioni materiali del lavoro gli interrogativi intorno a quale sia oggi l’identità operaia e cosa abbia sostituito l’idea di classe. Quell’invito lanciato da Beaud e Pialoux alla fine degli anni ’90 di un retour à la condition ouvrière (Beaud, Pialoux 1999) è stato in Italia, come del resto anche in Francia, sostanzialmente inascoltato. Nel suo volume, Baglioni, si inserisce in questo vulnus riuscendo in modo assai convincente a mostrare, attraverso un godibile intreccio di letteratura specialistica - e non - di dati e riflessioni che molto devono alla sua militanza sindacale cislina, il ruolo che il lavoro salariato ha avuto nelle dinamiche economiche e sociali che hanno contraddistinto il Paese tra gli anni ’50 fino ai nostri giorni. Il libro ripercorrere un cammino a ritroso lungo questo ampio arco temporale, un cammino che diventa agevole e snello grazie all’ancoramento che propone intorno a tre diverse fasi. La prima è quella dello sviluppo, che inizia nell’immediato dopoguerra e che prosegue per circa un trentennio, caratterizzata da profondi cambiamenti nella struttura produttiva e occupazionale, e da un forte mutamento economico e sociale del Paese. E’ il periodo nel quale si affermano forti esperienze sindacali all’interno di un modello di relazioni industriali improntato a quell’azione rivendicativa grazie alla quale si giungerà a conseguire diritti fondamentali in campo lavorativo e sociale. Quella che va dagli anni ’80 fino al 2008 è la seconda fase, contraddistinta dal diffuso benessere ma anche dal primo manifestarsi di una fragilità, al contempo economica e Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 193 Book Review DOI: 10.1400/228751 politica, che si sostanzia nell’affermarsi della centralità del problema occupazionale. E’ nel corso di questo periodo che l’azione sindacale perde vigore e capacità propositiva per assumere un carattere prettamente difensivo. La crisi che si inaugura nel 2008 apre una terza fase, nella quale, a una diminuzione dei posti stabili e a una crescente diffusione delle occupazioni atipiche e spesso precarie, si associa una progressiva erosione non solo del benessere ma anche dei diritti sociali e civili conquistati nei decenni precedenti. Nel volume, alla trama del tempo si intreccia l’ordito dei nuclei tematici che consentono all’Autore di comporre il suo affresco a tutto tondo sull’Italia del lavoro salariato. Non sembra, Baglioni, andare tanto alla ricerca delle ragioni che hanno caratterizzato il passaggio di epoca; non entra nelle aporie del modello di accumulazione capitalistica con l’obiettivo precipuo di spiegarle: il suo scopo non è convincere, ma informare, consegnando una testimonianza, viva e critica, di ciò che è ed è stato il lavoro salariato. Il lettore si trova così immerso in una lettura a più voci nella quale tutti gli attori coinvolti entrano, di volta in volta, in scena. Se le ragioni alla base del mutamento non fanno l’oggetto centrale del libro, sono tuttavia accennate grazie a rimandi veloci (ma mai impliciti) ad autori classici e contemporanei, senza che questo corpus importante di citazioni - spesso in nota - arrivi a frenare la scorrevolezza del testo. In altre parole, l’Autore riesce, nell’uso che fa dei riferimenti, a imboccare quel passaggio stretto che si apre tra la volontà di non appesantire la lettura ai non addetti ai lavori - cui il volume, pure, è destinato - e la necessità di offrire agganci e stimoli di approfondimento a chi si avvicina al saggio partendo da un interesse scientifico. Nei primi tre capitoli del testo vengono proposti i principali modelli socio-economici e politico-istituzionali comunista, socialista, socialdemocratico, cattolico, ma anche quello delle scienze sociali - che hanno contribuito in diverso modo, e partendo da presupposti assai differenti, a definire e interpretare il rapporto tra lavoro e società. In quest’analisi l’Autore dedica ampio spazio alla dottrina sociale della Chiesa, sottolineando il ruolo di primo piano giocato non solo nel contribuire a inquadrare e comprendere la questione del lavoro, ma anche nell’aver contribuito al configurarsi di quella “socialdemocrazia imperfetta” in cui l’economia sociale si lega ad un retroterra culturale che pur non amando il mercato, o almeno non amandolo spontaneamente, lo accetta come un’istituzione non eludibile e necessaria in virtù della crescente concorrenza internazionale. Nei capitoli IV e V, che costituiscono il secondo blocco tematico, avviene l’incontro con gli attori protagonisti del rapporto di lavoro salariato: sindacato e imprenditori. Riguardo al primo, Baglioni, dopo averne tratteggiato l’evoluzione in termini generali, torna a riaffermare, acuendone la portata, la tesi da lui già sostenuta in altri volumi (Baglioni 2008), quella di un accerchiamento e di una riduzione quantitativa e qualitativa del sindacato. La crisi, nella lettura che ne propone in questo nuovo volume l’Autore, ha certo peggiorato una situazione già difficile, aggravando il disorientamento dell’azione sindacale, che tuttavia preesisteva da anni. La strada da imboccare - come esorta Baglioni, “senza nostalgia del passato” - per promuovere un rinnovamento sembra a tratti passare più attraverso un mutamento della retorica con la quale ci si definisce - “smettere la tesi di essere solo una grande corporazione anti-innovativa” - o i rapporti che legano alla politica - “più sobri” - che non nell’adozione di strategie organizzative e di lotta o, ancora, nel modo di intendere la relazione tra lavoro e capitale. E’ proprio alla controparte del lavoro organizzato, imprenditori e manager, al modo in cui questi hanno guardato al salariato, che Guido Baglioni dedica un’ampia riflessione. In particolare, l’Autore evidenzia un passaggio importante: se fino a pochi anni fa nella stragrande maggioranza dei casi i datori di lavoro avrebbero preferito non trovarsi ad avere a che fare con il sindacato - vissuto come una complicazione, un costo, un ostacolo alle decisioni - con la crisi si assisterebbe, secondo Baglioni, alla ricerca di nuove forme di collaborazione. Attenuato come frequenza e come intensità, il conflitto riguarderebbe ormai, secondo Baglioni, sempre meno il contrasto tra impresa e dipendenti mentre i problemi competitivi e gli effetti della crisi avrebbero favorito l’instaurarsi di pratiche collaborative e partecipative, per contenere la riduzione dei posti di lavoro, per migliorare la produttività, per abbassare l’assenteismo, o, ancora per negoziare l’attivazione di provvedimenti e previdenziali e assistenziali all’interno dell’impresa. A questo modo di guardare ai lavoratori corrisponde un mutamento nel modo in cui questi guardano alla loro controparte. Se in passato la legittimazione era scarsa e le critiche abbondanti, nella crisi “i padroni” appaiono molto più accettati: vengono tendenzialmente assimilati agli altri gruppi sociali, per i costi che anche loro sopportano, passando sotto silenzio le corresponsabilità nella riduzione degli investimenti, dell’inefficienza, 194 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228751 Book Review della mancanza di innovazione del nostro sistema produttivo e amministrativo. E’ questo un elemento che, nelle pagine finali del volume [205] Baglioni collega al tema della perdita d’identità del lavoro salariato. Questa, “le sue ragioni”, “la sua intensità”, dipende, infatti, in larga parte dal confronto, dalla distinzione, dalla contrapposizione, dalle trattative con gli altri: fra tutti i “padroni”. Ma oggi, come ci ricorda ancora l’Autore, quando anche questi non sono “estranei e lontani” ma conosciuti, vicini, e assomigliano alla controparte tradizionale e non sono quasi mai considerati il “nemico”. L’ultimo nodo tematico (capitoli VI, VII e VIII) si concentra sul tema del lavoro – su cosa sia stato, su cosa sia e su cosa potrebbe essere - sul suo contenuto e sul suo significato: vengono esplorati i caratteri del lavoro manuale, la “percezione degli operai”, la trasformazione del loro stile di vita, le attività e gli interessi oltre il lavoro. Si tratta della parte più classicamente sociologica del volume, quella che, riconnettendosi a una tradizione lontana (e persa) di riflessione sul mondo operaio, dentro e fuori dalla fabbrica ci consente, almeno in parte, di coprire quel vuoto conoscitivo che è andato cumulandosi negli ultimi decenni e di cui si diceva in apertura. Con l’affermarsi della tesi dell’affluent worker (Goldthorpe 1973) si è andata, infatti, perdendo la specificità del lavoro operaio mentre, contestualmente, sul piano interpretativo si è affermata l’idea che il cambiamento del lavoro prescinda sempre più dai mutamenti di carattere organizzativo e vada ricondotto ad una dimensione squisitamente sociale. Ciò che avviene all’interno dell’organizzazione può, eventualmente, influire nella misura in cui si modificano le “regole regolative” del lavoro, mentre le “regole costitutive” dell’esperienza operaia e la loro metamorfosi nel tempo sarebbero influenzate prevalentemente da cambiamenti sociali, dai valori e dagli atteggiamenti verso il lavoro, dalla differente natura e ricchezza del capitale umano e del capitale sociale, dagli orientamenti della legislazione sul lavoro e dalle politiche pubbliche (Negrelli 2009). L’attenzione alla dimensione sociale del cambiamento è certo fondamentale, e già Goldthorpe e la sua équipe nella loro ricerca si ponevano lo scopo di conoscere gli operai non solo nella loro veste di lavoratori dell’industria, ma anche come mariti, padri, vicini e amici; individui, cioè, con determinate storie e finalità (Romagnoli 1973). Le modalità con cui gli operai definiscono il lavoro non dipenderebbero né dal clima aziendale né dalle condizioni tecniche né, tantomeno, dal tipo di regolazione che viene proposta del sistema di accumulazione capitalistico, quanto piuttosto da una variabile indipendente rispetto alla situazione lavorativa, che ha a che fare con il sistema di ruoli e i progetti sociali degli attori. In merito a questo aspetto, il valore del libro di Baglioni, risiede, ci sembra, più che nel modo in cui si inserisce all’interno del dibattito circa la preminenza dei fattori organizzativi o di quelli sociali, nel dar conto dei mutamenti che caratterizzano il profilo di questa componente occupazionale; nella sua capacità di proporre una narrazione articolata e a tutto tondo del lavoro salariato, nella sua dimensione di produttore, di consumatore e di cittadino. A questo proposito l’Autore ben sa che la logica dei comportamenti sociali, come il consumo, va al di là dei criteri propri della razionalità economica: se dietro alle cifre spese ci sono i prodotti, dietro i prodotti c’è il valore sociale che viene loro accordato e l’uso che ne viene fatto. In questa prospettiva, che da Engels a Halbwachs, ha interessato tanta della sociologia classica, le classi sociali non si distinguerebbero soltanto per i propri mezzi ma per i propri bisogni. Va infine osservato come la realtà che ci consegnano le fonti statistiche nel loro insieme, confermi e aggravi il quadro a tinte fosche che emerge dal volume. Una lettura che integri i dati Istat dell’Indagine Forze di lavoro con quelli dell’indagine campionaria sui bilanci delle famiglie italiane di Banca d’Italia consente, ad esempio, di mettere in evidenza come il deterioramento della condizione operaia riguardi non solo la dimensione lavorativa (peggioramento delle condizioni di lavoro, precarizzazione dei contratti) ma anche quella economica e, più in generale, gli stili di consumo e di vita. Se l’operaio italiano, nonostante sia più istruito che in passato, non ha smesso la tuta blu per vestire il camice bianco del tecnico - così come si preconizzava alla fine degli anni ’80 - non è nemmeno diventato l’affluent worker che, grazie agli elevati stipendi, insegue stili di vita e di consumo tipici del ceto medio impiegatizio. Tutto il contrario. Tanto per fornire un dato, secondo l’indagine di Banca d’Italia, famiglie con capofamiglia operaio, che corrispondono a circa un quarto del totale, detengono il 7,5 per cento del complesso delle attività finanziarie e il 22,1 per cento delle passività. Pertanto al 2012 l’ammontare della loro ricchezza finanziaria netta risulta negativo ed equivalente, in valore assoluto, al -8,3 per cento del totale della ricchezza finanziaria netta, contro il -2,8 per cento del 2010. La stessa fonte consente di mettere in evidenza come, non Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 195 Book Review DOI: 10.1400/228751 solo rispetto agli anni ’80 le fratture all’interno della struttura sociale si sino aggravate ma anche come, all’interno dello stesso lavoro dipendente, sia andata crescendo nel corso del tempo la distanza, in termini di benessere economico, tra gli operai e le altre componenti dell’occupazione. Questo della stratificazione interna al mondo del lavoro salariato e del mondo in cui essa si definisce nelle tre fasi temporali individuate, è un aspetto forse poco enfatizzato dall’Autore che, pure rivolge, nelle pagine finali, uno sguardo attento alla figura del lavoratore povero. Globalmente, si trae la conclusione che, in un periodo storico caratterizzato da una profonda crisi del sistema di produzione fordista e da un crescente innalzamento dei tassi di disoccupazione sino andate affermandosi nuove linee di frattura nella struttura sociale che non hanno sostituito quelle tradizionali ma, semmai, si sono sovrapposte ad esse. In questo modo, ad esempio, le categorizzazioni che riposano sull’opposizione tra inclusi ed esclusi sembrano aver progressivamente marginalizzato una visione di classe offuscando la questione operaia fino a farla scomparire. Il libro di Baglioni torna, con originalità, su questo tema proponendo una narrazione del lavoro operaio che si presta, ci pare, a far da cornice a una rinnovata stagione di riflessione e ricerca intorno a questo tema. (Annalisa Tonarelli) Riferimenti bibliografici Accornero A. (2009), Il lavoro che cambia dopo la classe, in «Quaderni di Rassegna Sindacale», 1: 7-26. Accornero A. (2011), Quando c‘era la classe operaia, Bologna: Il Mulino. Baglioni G. (2008), L’accerchiamento. Perché si riduce la tutela sindacale tradizionale, Bologna: Il Mulino. Beaud S., Pialoux M. (1999), Retour sur la condition ouvrière. Enquete aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard, Paris: Fayard. Carrieri M., Damiano C., Ugolini B. (2005, a cura di), Il lavoro che cambia. La più vasta ricerca sui lavoratori italiani, Roma: Ediesse. Goldthorpe J.H, Lockwood D., Bechofer F., Platt J. (1968, eds), The AffluentWorker: Industrial Attitudes and Behaviour, Cambridge: Cambridge University Press; trad. it, G.Romagnoli (a cura di), Classe operaia e società opulenta, Milano: Angeli, 1973. Halbwachs M. (1912), La classe ouvrière et le niveau de vie, Paris : Felix Alcan. Magatti M., De Benedittis M. (2006), I nuovi ceti popolari. Chi ha preso il posto della classe operaia?, Milano: Feltrinelli. Negrelli S. (1991), La società dentro l‘impresa, Milano: Angeli. 196 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Reviews and profiles Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 197 198 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228752 Rebecca Gumbrell-McCormick, Richard Hyman, Trade Unions inWestern Europe. Hard Times, Hard Choices Oxford: Oxford University Press, 2013, ISBN: 9780199644414 For decades, and even more since the onset of the economic crisis, trade unions have been under pressure, have been on the defensive. They have lost power resources, first of all with the decline of membership density, that in some countries has fallen drastically and almost continuously. Also to be considered the weakening of collective bargaining, the decline of unions influence on governments and also of their public reputation. These tendencies have been driven by different factors, from the intensification of cross-national competition, to the fragmentation of production processes and labour, to the dominance of neoliberal ideas, that have made labour market deregulation, decentralization of collective bargaining and austerity measures the priorities. Even so, even in the current «hard times» (and stimulated by these), trade unions have often developed new thinking, readjusting or significantly modifying their approaches and practices, sometimes embracing «alternatives to their time-honoured traditions». Innovations to the representative action and effective responses to the old and new challenges are then possible. And unions remain relevant socio-economic actors (and also an important subject for scientific studies); still providing collective voice to employees, constituting a form of countervailing power to the dominance of capital and a «sword of justice» (Flanders 1970), defending the most vulnerable and disadvantaged. This is the recurrent optimistic key message of the book of Gumbrell-McCormick and Hyman. The authors examine the challenges facing trade unions and their responses in ten countries, grouped according to the four commonly identified varieties of capitalism in Western Europe. Such an overview is based on the findings of an articulated and in-depth four-years research, carried out through interviews with key unions representatives, academic experts, informed observers and through a meticulous analysis of documents and secondary literature. Challenges are similar in all the countries, but may have different implications, depending on the institutional context. And the same is for trade unions responses, even though – as authors point out – not always in a neat way; in this respect, differences are also affected by unions power resources, identities, understandings of their mission. Engaging with the debate on revitalization, authors describe trade unions initiatives on five fundamental themes: recruitment, representation and mobilisation, including organising experiences; restructurings, i.e. mergers and organisational redesigns; collective bargaining; relations with government and political parties, alliances and collaborations with other organisations and renewing of the «moral» power resources, i.e. defining a social vision and communicating it; international level actions and approaches to internationalism. The analysis emphasizes the best practices, but gives also details on failed experiences and on progressive adjustments of the different ‘instruments’, considering the dilemmas unions had/have to face, the context of conditions that enhanced or hindered the specific responses. In this way, the book provides a very interesting reading for researchers, trade unionists and policymakers. Authors insist on the importance of the «complementary power resources», not necessarily new but not sufficiently appreciated in the past by trade unionists. They are first of all the discursive and communicative ones. In a sort of «battle of ideas», unions have to convince their mission is a better and more democratic society. Besides, they have to contrast the «decline of the public discourse on work» and on quality of work (Crouch 2012). The other complementary power resources, as already said, are logistical and collaborative, i.e. alliances and cooperative relationships with other groups, movements, organisations. Anyway, at the end of the book, Gumbrell-McCormick and Hyman, returning on all the themes, remind that there are no simple and unique solutions for trade unions; extensions/adjustments of their representative action, Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 199 DOI: 10.1400/228752 innovative responses, alternative practices are important, but unions have to adopt a more strategic approach, a long-term planning, a wider coordination, selecting priorities and making, if necessary, «hard choices». Closely linked, trade unions have to make a more systematic effort to incorporate the multiple aspirations and interests of the today’s increasingly fragmented workforce, by ensuring fist of all internal democratic processes. (Marcello Pedaci) References Crouch C. (2012), Il declino delle relazioni industriali nell’odierno capitalismo, in «Stato e mercato», 94: 55-75. Flanders A. (1970), Management and Unions, London: Faber. 200 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228752 Andrea Muehlebach, The Moral Neoliberal. Welfare and Citizenship in Italy, Chicago: The University of Chicago Press, 2012, ISBN: 9780226545400 The Moral Neoliberal explores the erosion of the twentieth-century ethos of re-distributional reciprocity and the rise of another in its wake.Western Society has institutionalised a concept of social citizenship by the development of national systems of welfare state. As Western economies grew through Fordist organization of industrial production, more and more complex, articulate mechanisms of wealth redistribution were put in place. Social citizenship was seen as an organically conceived system of obligations among societal collectivities, wherein the state emerged as but one of several constituencies. Rooted features of gift, such as freedom, obligation and reciprocity had been compounded in bureaucratic structures of state administrations. From understanding welfare state as an expression of gift, it descends a working principle of solidarity revolving around some long-term system of re-distributional reciprocity. However, the spirit of gift does not disappear under neoliberal conditions, but it starts to be performed differently compared with the past. Among European Countries, only in Italy there has been launched a national law on volunteering activities. Third sector organizations engaged in social welfare provision rose in number and in coverage of a more and more conspicuous share of elderly people in need for assistance. Voluntary organizations – either affiliated to Catholic Church or to the Left parties’ politics – perform their social functions through a moral authoritarianism which characterizes a new ethical kind of citizenship. One can think that catholic non-profit organizations and parishes would be the obvious ethnographical location for a research on this kind of ethical attitude. On the contrary, Muehlebach chose to delve in deep an organization that grew out of Left trade unionism background: The AUSER or Voluntary Association for the self management of Services and Solidarity, founded in 1992 by Spi-CGIL, in Sesto San Giovanni AUSER local branch. It is worth to mention that Sesto San Giovanni is a working-class town located in the urban peripheral ‘red belt’ where the Left dominate politics for most of the postwar period; throughout the 1980s this whole area suffered a massive de-industrialization. Muehlebach unfolds a new Lombardian landscape of welfare in the making. Rightwing political parties in Lombardy (namely Popolo della Libertà and Lega Nord) have had a role in formulating a distinct model of welfare governance, by blending in a particular type of neoliberalism together with element of Catholic social doctrine. Roberto Formigoni, Governor of Lombardy since 1995 (and long-time member of Comunione e Liberazione, a Catholic social movement), attempted to generate a cultural and anthropological shift in citizens’ conception of man and society. That amounted to a huge privatization wave of public services, particularly social welfare care services, which had drawn on the growth of voluntary and non-profit organizations in the region. More generally, Italian state withdrawal from welfare provision has occurred very swiftly compared to Western Europe, also because the state has always been rather alien to its citizens. Voluntarism is undergoing a growth almost everywhere in western world. Italy is the first country to treat such activities with a distinct body of law. More than this, no other country in Europe relies as extensively on volunteer labour as Italy. In Muehlebach’s opinion, these and other features describe a socio-political-economic context that is attuned to and which seems to anticipate neoliberalization. As for the analytical object, Muehlebach is interested in studying caring individuals that perform a free work of care, a relational work. It is not a productive work in the sense of accumulation of economic capital, in as much it accumulates valued relations among compassionate individuals. That kind of neoliberalization which Muehlebach calls Moral Neoliberal, has influenced the appearance of those volunteers performing a sometimes crucial work of care in the social arena. Italian State and other collective actors within it have shown a will for exploitation of this valuable relational work, and also to see volunteers as to be animated by affect rather than intellect, by feel and act upon these feelings rather than rational deliberation. Muehlebach stresses the dimension of action for others instead of the care for the self. That is, she wants to show Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 201 DOI: 10.1400/228752 Italian way to neoliberalism to be supportive of a compassionate and empathetic self as the centre of subjects’ social universe. Hence the research main focus revolves around the process of moralization inherent to postindustrial forms of citizenship. That begs the question as to why unwaged work can become desirable to people in everyday life. Moral neoliberal has the capacity to appear not as a charity but as a form of emancipation, that is why ethical citizenship has become so persuasive. Through the vehicle of morality subjects get involved into processes and activities they might not be in agreement with, documenting a shift in social conventions of moral responsibility shared across the political spectrum. Leftist volunteers are however aware of the shifting institutional structures of which state’s mobilization of their unwaged labour is part. Sure enough, historic political cultures like Socialism and Catholicism of Italy, provide subjects with useful instruments to elaborate ethical citizenship in their own terms. There is an opulence of virtue in that people have to exhibit the capacity to remain valued member of society. For that matter, public recognition is crucial, as voluntarism grants citizens to appear in public as more than private and dependent figures. But the general acknowledging accorded to certain forms of non-remunerated work, goes hand in hand with the neglecting, or worse, denigration of others (i.e. women performing household work have never been awarded of such a public recognition as volunteers’)1. Ethical citizenship is a racial and cultural thing too: It is best practiced by those who are culturally predisposed to reconstitute broken social ties. Ethics is thus located in practice and action, or rather in histories, social life and meanings. Generally speaking Muehlebach traces the ways in which welfarist and post-welfarist forms of collective good are complexly interwoven. This kind of neoliberalism differs significantly from the one depicted in Dardot and Laval (2013) New Way of the World in that neoliberalism is not thought as a dynamic of global market forces dissolving any previous form of social relation other than governed by utilitarianism and rational calculation. On the contrary to the market neoliberal, the moral neoliberal is a form of ethical living which presents itself as a negation of market ideology and yet, it is integral to neoliberalism more broadly conceived. To give a theoretically grounded explanation Muehlebach takes Adam Smith’s work as the clearest examples of the intimate connection between market and morals, economics and ethics. The suggested compatibility of The Wealth of Nations and The Theory of Moral Sentiments as for the coherence between economies of self-interest (or what Smith’s called self-love) and economies of fellow feelings, stands for that market transactions are evacuated of benevolent feelings but they are not emancipated from passions. Smith’s equation interest-passion is often misrecognized by scholars who have interpreted the concept of interest in all too rationalist and instrumentalist terms. However, The Theory of Moral Sentiments appears not in contrast to TheWealth of Nations but as another variation on a general theme: A universe of human (economic, political and moral) action animated by affective disposition and actions. In Chapter two the Author sets out to define this ethical citizenship in the context of the ethnographic study. The outset of the chapter is titled: “A crisis of loneliness”. Here, some chronicles of current events at a time when the Author was arranging her fieldwork are given. The reader is kept abreast of many relevant facts about the city of Milan in 2003 when she arrived in Milan. The account starts with some characterization of the local government, its political affiliation, and the links to national politics. At the time of observation, the city of Milan and its people were experiencing a tough situation, for economic hardships due to the loss of work and insufficient income. Labour market inefficiencies produced a latent economic crisis (later on, the sudden economic crisis globally burst in 2007-2008 elicited, if possible, even worse effects) that was sublimated in an existential crisis. Loneliness was identified as the first among new needs by social politics, what the Author takes as instance of resignification of a “welfarist” category, including relational rather than material poverty.Then ethical citizenship is addressed after a social citizenship based reconstruction of welfarist twentieth-century Italy. By the 1970s Italy’s public expenditure in pensions and health care system, the latter based on universalistic principles, reached its peak. Nonetheless social services had never seen a dominant state in mediation of social solidarity, a huge labour of care that has since its inception been performed by the family (households) and the church. The presence of the state in the social services has ever been tenuous at best. In this realm social citizenship is being rivalled by a form of citizenship that is taking shape under neoliberal conditions: Ethical citizenship. Ethical 202 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228752 citizenship institutionalises moral and affective, rather than social and political ties, primarily duties rather than rights; private obligations rather than social rights and a shift from socially granted provision to discretionary bestowed generosity. This conceptual setting represents the fertile ground where Muehlebach’s research takes inception. Standing at the centre of this unremunerated labour regime of care, a subject derives great pleasure from unwaged work, in very post-modern terms. Work has become the central locus of psychic and emotional investment or, as cited by Muehlebach, puts it, “as a good in itself: a means towards self-realization rather than as an opportunity for selftranscendence”. Particularly interesting is both the persuasiveness of ethical citizenship and its ‘integralism’. As to the former is a social form that destabilizes social citizenship as a mode of collective living for it generates new modes of belonging and participation. For native Italians is a means to acquire some sort of belonging by producing and thereby partaking in the collective good. As to the latter, ethical citizenship has a real fundamentalist character, being that is it hardly traceable onto either leftist or rightist commitment. Moreover ethical citizenship is based on a new set of exclusions whereby immigrant caretakers labour in the shadows of the domestic sphere of private Italian homes. “You cannot simply start volunteering just like that!” (original emphasis). Thus begins Chapter Three. Title itself - Consecrations: From Welfare State to Welfare Community - is typifying about role models and expectations loaded on volunteers in social welfare services of care in Lombardy. At the course on volunteering provided by Ciessevi (Centro servizi per il volontariato per la provincia di Milano) a class of aged women, mainly between fifty and seventy, was kept conscious about the need for proper training, motivations and goals concerning volunteering. Volunteering is institutionalised by an oath (signing a registration sheet) which has deep symbolic importance as a practice and pedagogical moment in which a highly moralized, indeed sacralized, social contract come into being (Muehlebach 2012). Here the author introduces the reader to the innermost features of volunteering and the moral neoliberal, as the amalgamation between legal and theological at the basis of a moral order of a privatizing service economy. The making of a moral neoliberal welfare community, where the production of ethical citizens relies on the sacralization of the social realm and the figure of freely labouring citizen at its centre, has the capacity to encompass – better than the state and the market – social particularism and a fractured citizenry. Here there is in other words a welfare utopia put into effect, as a combined output both of a history of a welfare-state building ever infused of a catholic repertoire, and of a more recently replacement of liberal welfarism and state-mediated social citizenship, by a sacralized society leaded by third sector. So we have had a withdrawal of the state from public services provision in the realm of care, followed by a sacred social where the figure of volunteer is epitomized with heroic traits of altruism in a kingdom of gift, that is the third sector. Muehlebach refers to an off-modern project of welfare-state building in Italy to signify that modernity, rather than being evacuated of the sacred, in fact deployed it as a necessary moment of any institutional practice with aspirations to public efficacy (Muehlebach 2012). In a retracing of Italian nation state building, wherein the state appropriates of the church’s right to administer charity, the Author states that the new nation attempted to replace the ecclesiastic system of charity with modern social assistance. The goal was to have the nation state as a community of welfare, promoting secular and rational government as necessary condition of modernity. In this section, an extremely interesting reconstruction of Italian nation state building is given, where the steps and stages of welfare state are retraced from national unification in 1861, up to the second postwar period and to the present days. All this reconstruction hinges on an account of the relationship between sacred and secular, state and church, from the first compulsory national insurances for the old age, and against injury risk on the job, to postwar layout of national welfare state. Then the last twenty years have seen a fundamental switch of the tendency to expand welfare state that characterized Italian political landscape from World War II. In Lombardy has been enforced a public-private welfare economy, as elsewhere in central and northern Italy. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 203 DOI: 10.1400/228752 However this privatization must not be seen as a brute shift away from public provisioning toward the private market. In conclusion, the Author is interested in the ways in which practices and institutions associated with the public, get transformed into appearing as private. In other words this revolves around the question of how the existing public-private mix, on which the state had always relied, has being re-signified and re-codified in a particular location (Lombardy) and historical moment (the present days). The last section of the book (Part Three) debates on the actual production of compassion. The Author answers the question as to how does love become a form of labour explicitly distinguished from other activities. Italian State, in Muehlebach reasoning has created a legal framework that provides for the delivery of a standardized account of the volunteer, her motivations and goals. Moreover it has been put in place a sort of normative management system, aptly directed to make of both individual volunteers and volunteering work itself, a normative moral subject targeted in policy texts and law inscriptions. So a form of private virtue has been equated with the larger public good. If asked what different have volunteers to offer in respect to professional nursing and doctoral staff to the unfortunate, the old-aged, the poor and dropped out people, there is just one unanimous answer: Love! This ability to get involved in specific acts of other recognition however is not at all spontaneous. The spirit of gifting is achieved through a legal regime and dedicated institutions aimed at providing symbolic and material infrastructures. Citizens are marshalled in such a way that volunteering might be resembling some sort of industry. An industry of a particular kind is true, but nonetheless a gathering of pedagogical methodologies handed out to classes of aspirant volunteers every year. Techniques of moralization rely on Christian hermeneutics of listening and witnessing. What is more, these notions have to be put in practice translating affect into pragmatic action. So Muehlebach aims to delve deeper in a detailed anthropological description of these classes of volunteers that produce a citizenship lived with the heart with the outcome of a “humanitarianized” public sphere that makes individual compassion and private empathy primary public virtues. Muehlebach then gives a very suggestive account of the production of dispassion rooted in the entire system of monetary distribution of social welfare provisions in Milan. Public social welfare and local government, has proven here incapable of any kind of actual help and support for problems, no matter they are big or small, experienced by the huge variety of needy people. It is precisely amid dispassionate places and drop-outs that, on the contrary, Muehlebach’s volunteers have proven great patience and heroic spirit of gifting. Age has become a concrete principle of identification and mobilization, performing a role in reification of social distinction. Chapter Five is about the topic of active elderly and events and practices associated with an Age Full of Virtue. It is not surprising how, given the extension of our life span, could have changed the role of senior people cohorts in demographic structure for age of western societies, and Italian demographics in particular. It is a striking point made by Muehlebach, when she reminds a TV programme numbered among broadcast shows on Italian public television (RAI) in 2003. It was a reality show called Super Seniors, which brought together an even number of men and women between the ages of sixty and seventy-seven in a location on the hills surrounding Rome. The programme did not attain success in ratings, which is not the point in question, however. Point in question was actually to represent elderly as protagonists and not as passive onlookers. It rendered apparent a Gemeinschaft of morally productive action coupled against the lost sense of community in capitalist modernity. More than this they emerged as key redemptive actors in a world experiencing post-modern social dysfunctions, such as anomie and atomization, vanity and selfishness and so on. The latter example instantiates a more general phenomenon of activation of elderly citizens. The Sixth Chapter, inasmuch dealt with elderly participation into the burgeoning moral economy set out to be potentially valuable to Italian society, accounts for delayed outcomes occurring somewhere after the inception of utopian practices, that is the above mentioned moral neoliberal spirit of gifting and care for others. There is a kind of paradox in the way neoliberalism present itself, or as a social force sometimes interpreted as an occasion to rescue old-establishment norms and values. Leftist pensioners volunteering for AUSER, for instance, try to reinvigorate an actively oppositional, militant culture which they learn during their working life in 204 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228752 postwar period. Ethical citizenship seems have little relevance with freedom, as it binds together stranger people to each other through sense of duty and compassion. Nonetheless morality could be also represented as decidedly liberating, if seen from the perspective of Left traditional solidarity programme. Again, working-class solidarity expressed in leftist terms hinges on the crucial distinction between work and commitment. Even though a personal commitment is also to be found in the waged labour market, those who practice volunteering activities, experience a strictly moral call of duty. Smith’s suggested compatibility of TheWealth of Nations and of The Theory of Moral Sentiments as for the coherence between economies of self-interest (or what Smith’s called self-love) and economies of fellow feelings, seems to be also present in this growing economy of unwaged labour. In particular, relational work of leftist volunteers appears to be deeply rooted in their personal and collective histories of political activist. Their past is drawn on to elaborate their current commitments, in an active recuperation of past practices and meaning, that allowed them to feel like protagonists in the Lombardian welfare utopia (Muehlebach 2012: 180). Lastly, Chapter Seven questions the fact that the general acknowledging accorded to certain forms of nonremunerated work, goes hand in hand with the neglecting, or worse, denigration of others. It is the Private Face of Privatization of care. The author explores the perception of Italians on the immigrants work of care in private homes, suggesting that there is a tension between the feeling of “have the enemy into the house” as for immigrant effort in looking after the old, and what immigrants themselves think of natives, depicted as egotistical, hypocritical and spoiled. Muehlebach is interested in everyday discursive processes through which volunteers distinguish their free relational work, from immigrants’ material (waged) work, denying the latter a social recognition and capacity of these women to produce social relations whatsoever. The moral neoliberal order emerges this way, as a highly segregated one, in a narrative of materiality versus relationality which includes the distinction between remunerated work of immigrants and un-remunerated work of volunteers. The key of this distinction revolves around the emotional expenditure of volunteers that others (including immigrants) would not be prepared to bear. Strikingly Muehlebach argues, on the immigrant caretaker phenomenon, that one moment she found these women to be positioned as blatant signs of the nation’s crumbling family values. The next they were completely erased as public figures and rendered invisible through acts of forgetting (Muehlebach 2012: 209). Volunteering in today’s Lombardy instantiates an ethical citizenship which institutionalises a private moral duty of care, a moral authoritarianism.The former welfare state built on social citizenship, granting social rights by public provisioning of a range of services, seems to leave space to an age full of virtue, where catholic social doctrine and leftist class solidarity again merge together. Nonetheless this age is also one of renewed forms of social exclusion and non-recognition, as for the immigrant caretakers, which is the private face of privatization of care. As I tried to argue in this review, Muehlebach’s The Moral Neoliberal, clearly shows, by an acute ethnographical analysis, some of the innermost features of social welfare provision in Lombardy, where many historic characteristics of Italian social security system have sublimated self interest and fellow feelings at the individual level, and in a particular institutional public-private mix open to a variety of social actors and constituencies. (Alberto Nucciotti) References Dardot P., Laval C. (2013), La nuova ragione del Mondo, Roma: Derive Approdi. Muhelbach A. (2012), The Moral Neoliberal:Welfare and Citizenship in Italy, Chicago:The University of Chicago Press. Muhelbach A. (2009), Complexio Oppositorum: Notes on the Left in Neoliberal Italy, in «Public Culture», Vol. 21(3): 495-515. Muhelbach A. (2011), On Affective Labor in Post-Fordist Italy, in «Cultural Anthropology», Vol. 26 (1): 59-82. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 205 206 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 DOI: 10.1400/228753 [Recommendations] Micol Bronzini, Nuove forme dell’abitare. L’housing sociale in Italia, Roma: Carocci, 2014, pp. 272, ISBN: 9788843073467. The text of Bronzini - with a final contribution of Francesco Minora dedicated to the comparison of the collective actions of institutions in France, Italy and United Kingdom - want to address the issue of housing difficulties in our country, starting from its historical, economic and social roots. During the seven chapters of the book, the focus is on the emergence of the problem in the current times of exacerbated estate speculation and economic crisis, and analyzes the current shift of attention from “policies for house” to “policies for living”, up to investigate innovative solutions of social housing, that - with the specificities of the Italian model - are recently developing in several areas of the country. Bruno Grancelli, Imprese, mercati e regime amministrativo. Le architetture del capitale in Russia, Milano: Franco Angeli, 2014, pp. 144, ISBN: 9788891706812 Based on the author’s own research and evaluation, and on a review of co-evolutionary literature, the study addresses the co-evolution of institutional and organizational change in Russia. Because the reconstruction of the markets in Russia seems to be a very political and institutional process - and shortly social - the analysis focuses just on systemic transformation, especially in the aspect of big capital’s architecture produced by the intertwining of relationships between political and economic elites. These relationships are analyzed in order to highlight the formation of entrepreneurship, and local development of small-size enterprise. Concluding, the book focuses on changes in state-business relations, but also with the aim of seizing the implications, yet little explored, for the forms of entrepreneurship, the spread of local environments and development. Donatella della Porta, Alice Mattoni (editors), Spreading Protest. Social Movements in Times of Crisis, Colchester (UK): ECPR Press, 2014, 324 pp., ISBN:9781910259207. Donatella Della Porta and Alice Mattoni edit this volume of great relevance on the origins and especially on the diffusion mechanisms of protest movements against austerity that spread around the world in the period from 2008 to the present. The numerous contributions hosted in the book reconstruct a convincing comparative picture of the populist protests which reacted to the dramatic economic crisis of 2008. This volume is not a simple collection of essays on the different national realities, but it offers to the scientific discussion a rich material for a renewal theory on how collective movements arise and establish themselves in an age of globalization. Aline Sierp, History, Memory, and Trans-European Identity: Unifying Divisions, London/New York: Routledge, 2014, 204 pp., ISBN: 9781138786936 This volume is the first important book of a young researcher at the University of Maastricht, published on a central theme for the symbolic construction of Europe: the possibility of a transnational memory. Starting from the historical cases of Germany and Italy, Aline Sierp investigates the possibility of a European memory culture, as founding a common identity which can overcome national historic divisions. The author’s position is between a positive evaluation of the processes of creation, preservation and transmission of European values, and the ascertainment of the persistent difficulties to developing a common historical memory: however, indispensable premise to proceed on the road to European unity. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 207 DOI: 10.1400/228753 Georg Simmel, Il mediatore, edited by Annalisa Tonarelli, Roma: Armando editore, 2014, pp.79 ISBN: 978-886677-812-7. The reflection proposed by Simmel on the figure of the “mediatore” (mediator) addresses two different levels. The first concerns the contribution that the extract from the book Sociology, published in this volume, it may have for the understanding of sociology formal, and the contribution that it offers to the study of social dynamics. The second aspect is part of a perspective both more pragmatic and more topical. At a time when, even as a result of recent normative measures, the mediator takes on increasing importance in the extra-judicial settlement of the conflict, the need to equip these new figures with an adequate training emerges clearly: in the mediation the technique must be accompanied and completed with theoretical and epistemological assumption. Simmel’s reflection, as usual, offers a contribution easily accessible, yet extremely effective: the formal analysis of the dynamics of relationships is so universal to result a key tool for the activities of the mediator as well as of those social worker who has to manage conflicting dynamics. 208 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 [Authors] Carlo Baccetti teaches Politics, Policies, Governance and Local Politics at the University of Florence. He has taught at the University of Catania, at the University of Barcelona (Autònoma) and at the ICPS in Barcelona. He has written articles and books about political parties, political culture, local and regional politics and elections. Recent books: I postdemocristiani (2007); Il popolo in Comune. Politica e amministrazione a Empoli dal 1946 al 1980 (2011); Uno contro tutti. La sfida del Movimento 5 Stelle (2013); Der aufhaltsame Abstieg der Partei Italia dei Valori (2008-2013) (2014). He is editor in chief of the semiannual review Quaderni dell’Osservatorio elettorale. Laura Bazzicalupo is full Professor of Political Philosophy at the University of Salerno. She has worked on the cross between aesthetics and politics ; most recently she has been involved in biopolitics , governmentality, and neoliberal transformations of democracy. She collaborates with the magazine «Filosofia politica». Her most recent monographs are Il governo delle vite (2006); Superbia (2008), Biopolitica, una mappa concettuale (2010); Eroi della libertà (2011); Politica. Rappresentazioni e tecniche di governo (2013); Dispositivi e soggettivazioni (2014). Lorenzo Bernini is a researcher in political philosophy at the University of Verona, and a science supervisor at the PoliTeSse research center - Politiche e teorie della sessualità (Politics and theories of sexuality). He is a member of scientific commitee of «AG About Gender» and is on the editorial staff of «Filosofia politica». His interests range from modern political philosophy to theories of radical democracy, from feminism to gender studies and queer theories. His publications include: Le pecore e il pastore: Critica, politica, etica nel pensiero di Michel Foucault (2008); Apocalissi queer: Elementi di teoria antisociale (2013). Paola Bordandini is associate professor of Political Science at the Department of Political Science, University of Bologna, where she teaches Methodology of political science and Methodology of social science. She has written Cultura politica e piccola impresa nell’Italia plurale (2006); Delegati di partito. Sdi e Nuovo Psi (2011), with A. Di Virgilio; La spada diVendola. Una risorsa o un problema per il centrosinistra? (2012). Her publications also include journal articles and essay on political parties, trust and social capital. Lorenzo Bruni currently attends a PhD program in Policy theory and research at the Department of Political Science of the University of Perugia. His PhD thesis concerns theoretical and empirical research on shame as a social emotion. He is a member of RILES-Ricerche sul Legame Sociale and collaborates with the Centro Studi Storico-Filosofici di Marsciano. His most recent publications are: the article Riconoscimento e capitalismo.Tra conflitto di classe e ideologia dell’autorealizzazione, in “Quaderni di Teoria Sociale” n. 14/2014; and the book chapters:- Il disagio giovanile come sofferenza sociale, in A. Santambrogio, Giovani a Perugia.Vissuti urbani e forme del tempo (2014, ed.); - Intersoggettività, identità, conflitto. Una teoria normativa della società, in I. Pozzoni, Schegge di filosofia moderna XII (2014, ed.). Mario Caciagli is professor emeritus at the University of Florence. He was full professor of Comparative Politics at the Faculty of Political Sciences from 1987 until 2010. Prior to that he was a professor in the Faculty of Political Sciences of the University of Catania (1973-1984) and in the Faculty of Political Sciences of the University of Padua (1971-73 and 1984-1987). He has been a visiting professor in Barcelona and Santiago de Compostela, and also in Heidelberg, Bonn, Innsbruck and IEP of Paris. Since 1981 he has been the Director of the Quaderni dell’Osservatorio elettorale, a semiannual review on electoral studies. Roberto Cartocci is full Professor of Political Science at the Università di Bologna since1999, and currently teaches Methodology of political science and Theory of political development. His main research interests can be summarized as: political culture, social capital, quality of Democracy, electoral trends, methods for social science, political development, comparative politics. His publications include: Le Mappe del Tesoro (2007); Geografia dell’Italia Cattolica (2011). Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 209 Dimitri D’Andrea teaches Political Philosophy at the University of Florence. He has written on the Modernity Theory and on the transformation of categories of modern politics, such as sovereignty, the nation-State, globalization, conflict, political identity, and environmental risks. Among his recent publications: L’incubo degli ultimi uomini. Etica e politica in Max Weber (2005); Global Warming and European Political Identity, in F. Cerutti, S. Lucarelli, The Search for a European Identity.Values, policies and legitimacy of the European Union (2008, eds.); with R. Badii,Shoah, modernità e male politico (2014, eds). Antonio Floridia is public officer of the Regione Toscana, and supervisor of the Electoral Observatory as well as of the “Policies for participation” Sector. Among his recent publications, the volume La democrazia deliberativa: teorie, processi e sistemi (2012). Paolo Giovannini, former Dean of the Faculty of Political Science “Cesare Alfieri” at the University of Florence, and former professor of Sociology. Visiting professor at Warwick, Barcelona, and other European universities. Associated with several research centres, he has founded a Research Laboratory on Social Changes (CAMBIO): currently, he is Editor-in-chief of the online journal of the same name. Daniel Innerarity is professor of Political Philosophy and “Ikerbasque” researcher at the University of Basque Country. He is also the Director of the Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.org), a former Robert Schuman Visiting Professor in the European University Institute of Florence, Fellow of the Alexander von Humboldt Foundation at the University of Munich and visiting professor at the University of Paris 1-Sorbonne. His recent publications (in English) include: Rethinking the Future of Politics (2010); The future and its Enemies (2012); with Javier Solana, Humanity at Risk.The Need for Global Governance (2012, eds); The Democracy of Knowledge (2013); AWorld of Everybody and None (2014). Marc Lazar, Dean of the Graduate School of Paris Institut d’études politiques from 2000 to 2007, he is currently professor of Political History and Sociology, Director of the Center of History and President of the Advisory Council in the same Institute. Director of the GREPIC (Group of Pluridisciplinary Studies on Contemporary Italy) at the CERI (Centre d’études et de recherches Internationales, CNRS-Sciences po), he is also President of the School of Government at Luiss University “Guido Carli” in Rome. His research interests include: the Left in Europe; comparative politics in France and Italy; relations between history and political science. Columnist for the Italian newspaper La Repubblica. Vanesa Lio has a degree in Communication Sciences (Universidad de Buenos Aires) and a Masters degree in Public and Political Comumunication (Università di Pisa). She is a fellow of the Argentine Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) and researcher at the Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IDIHCS, Universidad Nacional de La Plata). She is currently attending a PhD in Social Sciences at the Universidad de Buenos Aires. Simona Miceli has a Masters Degree in Political Sciences from the University of Calabria. She graduated with a thesis on the aspirations and identity of second-generation immigrants. She will soon begin a PhD program in “International Studies” at the University “L’Orientale” of Naples. In November, she took part in a workshop at the International Metropolis Conference on Migration, Energy for the Planet, Feeding Cultures, where she presented a paper entitled Second-Generation Immigrants’ Capacity to Aspire: Incentives and Obstacles. Angela Perulli is Associate Professor of Sociology at the Università degli Studi di Firenze, where she teaches Sociology and the Sociology of everyday life. Director of the Laboratory Cambio and member of the Figurational Research Network, her main research topics are: social processes, time patterns, social inequalities, process sociology, social theory. Co-editor of Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali, she collaborates with several scientific journals, such as «Stato e Mercato», «Cuadernos de Relaciones Laborales» and Human Figurations. In 2013 she received a N.Elias Stipendium from the Deutsches Literaturarchive (Marbach a.N.). 210 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 Franco Rositi Former professor of Urban sociology, Methodology of social sciences, and Sociology at the Universities of Milan, Bari, Turin and Pavia. Founder and editor of the Methodology of human sciences series, directed by Alberto Marradi. Retired in November 2010, he was appointed Professor Emeritus of Sociology, University of Pavia. Until recently, he coordinated a research project of national interest (PRIN) on “The Quality of Public Argumentation” involving various departments of the Universities of Pavia, Milan, and Bologna. Among his most recent publications: Sulle virtù pubbliche. Cultura comune, ceti dirigenti, democrazia (2001); La ragione politica (2013); I valori e le regole. I termini della teoria sociologica (2014). Annalisa Tonarelli, PhD, is assistant professor of Sociology of Labor and Industrial Relations at the School of Political Sciences “Cesare Alfieri”, Università degli Studi di Firenze. She coordinates the Laboratory of Labor Sciences Laboris, at PIN Polo Universitario Città di Prato, and she is also a member of CAMBIO, the research unit on social changes of the Department of Political and Social Sciences (DSPS), and member of LUAM, Laboratory on conflict mediation and resolution, Department of Law. She teaches Social problems (post-graduate course). Her main research interests concern: the labor market; employment and new forms of labor and professions; work, family and gender; working class conditions and industrial decline; poverty and social inclusion. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 211 212 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 [Call for papers] Number 9 / June 2015 The monographic section of the June 2015 issue will focus on the following question: which spaces of recognition are opening up for new families? This issue, devoted to family change, will reflect on the political and social circumstances – unprecedented in our country – that seem to be converging, in different fields, toward a resolution of difficulties that till now have proven insurmountable: spaces are opening up for proposals to regulate and/or sustain new ways of managing and experiencing family relationships; or, at least, after having long been suppressed in our country, the topic has finally entered the arena of public debate. We especially have in mind reform proposals and bills dealing with judicial regulations that have long been politically or technically “untouchable”, such as rapid divorce, the passage from foster care to adoption, recognition of domestic partnerships and equal filiation status, as well as proposed policies (traditionally absent from our welfare system) for supporting single-parent or multicultural families, and public advances on alimony settlements. Just as it becomes interesting to look into the social and legal practices resulting from the introduction of shared child custody, or even the possibility – which now seems to be opening up – of normalizing divorce even in the religious sector. The call is open to Italian and foreign scholars who have done research on these or similar relevant issues. In particular, we encourage contributions that focus on the specific ambiguities inherent in our question: whether these transformations should be interpreted in a context of matured social consciousness, as a result of the diffusion of variant family forms in the social fabric, of changes in the political system, or as a merely cultural consequence of globalization/Europeanization. Priority will be given to theoretical and research contributions that have a gender slant, that make comparisons with the experiences in other countries, and that are sensitive to current polarizations of inequality. The editors are also interested in evaluating contributions to the Journal’s non-thematic area, which includes the Sections Eliasian Themes, Essays and Researches, and Contributions. They also invite profiles, reviews and recommendations of books, essays and scientific events. The invitation to participate in the selection is intended for researchers from all fields of the social sciences, with no preference for particular theoretical or methodologicalapproaches. The texts - unpublished and not submitted simultaneously for evaluation by other journals - must be sent by April 10th, 2015 to the editors, in docx, doc, or rtf format, according to the Indications for authors published on our website, at: [email protected] The editors determine the publishability of contributions on the basis of the opinions of anonymous referees, in accordance with the double-blind peer review formula. Exception is made only for articles in the Contributions section. The editors will inform authors of the outcome of the referee decisions, and hence acceptance or not of the article within a month after its submission. The texts sent must be between 30,000 and 50,000 characters (spaces and bibliographical references included). There must also be attached: a) a brief biographical note (approximately 600 characters, spaces included) with information about the university/institution of membership, research topics pursued, projects in progress, and major publications; b) a short abstract in English, in which the gist of the article is indicated in a clear and concise manner; c) some keywords (3 to 6, at the close of the English abstract) in order to recap with extreme brevity the subjects treated. Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014 213 [Call for papers] Numero 9 / Giugno 2015 La parte monografica di Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali in uscita a giugno 2015 sarà incentrata sul seguente interrogativo: se e quale spazio di riconoscimento si stia aprendo per le nuove famiglie. Il numero dedicato al mutamento delle famiglie vuole riflettere sulle circostanze politiche e sociali - inedite nel nostro paese - che sembrano convergere verso la possibilità, in campi diversi, di superare difficoltà fino ad ora insormontabili: si aprono spazi per proposte tese a regolamentare e/o sorreggere modi nuovi di fare e vivere relazioni di famiglia; o, almeno, dopo essere stato a lungo tacitato nel nostro paese il tema entra nel discorso pubblico. Pensiamo in particolare a proposte di riforma e disegni di legge su regolazioni giuridiche a lungo politicamente o tecnicamente “intoccabili”, sul divorzio breve, sulla possibilità di passare dall’affidamento all’adozione, sul riconoscimento delle famiglie di fatto, sulla parificazione definitiva della filiazione; e ancora alle proposte di policies (da sempre assenti nel nostro sistema di welfare) di supporto alle famiglie monogenitore o alle famiglie multiculturali, di anticipazione pubblica dell’assegno divorziale. Così come diventa interessante interrogarsi anche sulle pratiche sociali e legali conseguenti all’introduzione dell’affidamento condiviso, o persino sulla possibilità - che sembra oggi aprirsi - di normalizzare, anche in senso religioso, i divorziati. La call è aperta a studiosi italiani e stranieri che abbiano svolto ricerche su questi temi o su temi simili pertinenti. In particolare si sollecitano contributi che tematizzino la specifica ambiguità contenuta nel nostro interrogativo: se si debba interpretare la trasformazione come una maturazione della coscienza societaria, come un effetto della diffusione di variant family forms nel tessuto sociale, o della trasformazione del sistema politico, o come ricaduta meramente culturale del processo di globalizzazione/europeizzazione. Verranno privilegiati i contributi teorici e di ricerca capaci di valorizzare un’ottica di genere, di proporre comparazioni con l’esperienza di altri paesi e sensibili ai processi di polarizzazione delle disuguaglianze in atto. La Redazione è altresì interessata a valutare contributi per la parte non tematica della Rivista. Rimane inoltre gradito l’invio di schede, recensioni e segnalazioni di libri, saggi ed eventi scientifici. L’invito a partecipare alla selezione è rivolto a ricercatori di ogni ambito delle scienze sociali, senza alcuna preferenza per particolari approcci metodologici o teorici. I testi - inediti e non sottoposti contemporaneamente alla valutazione di altre riviste - devono essere inviati entro e non oltre il 10 aprile 2015 alla redazione, in file formato docx, doc, o rtf, seguendo le Indicazioni per gli autori pubblicate sul sito, all’indirizzo: [email protected] La decisione sulla pubblicabilità dei contributi spetta alla Redazione sulla base dei pareri di referenti anonimi, secondo la formula del double-blind peer review. Sono esclusi da tale procedura solo gli articoli destinati alla sezione Interventi. La Redazione si impegna a comunicare agli autori l’esito del referaggio e l’eventuale accettazione dell’articolo entro un mese dalla sua presentazione. I testi inviati devono essere compresi tra le 30.000 e le 50.000 battute (spazi e riferimenti bibliografici inclusi). E devono essere corredati di: a) breve nota biografica in inglese (600 battute circa, spazi compresi) completa di indicazioni riguardanti università/ente di appartenenza, temi di ricerca seguiti, progetti in corso, principali pubblicazioni; b) abstract in inglese dove si indicheranno in modo chiaro e sintetico i punti salienti dell’articolo; c) alcune parole chiave (da 3 a 6, in chiusura dell’abstract) per richiamare, in estrema sintesi, gli argomenti trattati; d) per i contributi in italiano, titolo dell’articolo anche in lingua inglese. 214 Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014
Scarica