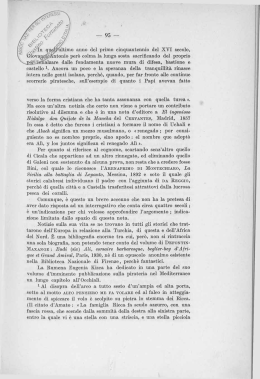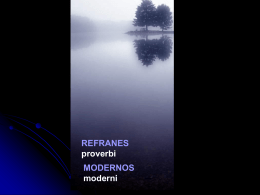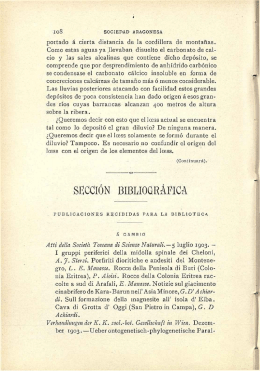Quaderno del Dipartimento di Letterature Comparate , Direttore Otello Lottini Comitato scientifico Fausta Antonucci, Isa Dardano Basso, Alessandra Contenti, Marino Freschi, Giulia Lanciani, Filomena Liberatori, Giuli Liebman Parrinello, Letizia Norci Cagiano, Valeria Pompejano, Marinella Rocca Longo, Giuliano Soria, Carla Maria Solivetti, Paola Splendore, Krassimir Stantchev Coordinamento editoriale Maria Carella, Maria Cristina Desiderio, Rosa Di Paolo, Agnese Nobiloni Toschi, Maddalena Pennacchia Segreteria organizzativa Daniela Tosoni Copia omaggio non destinata alla vendita Il “Quaderno” ha cadenza annuale. Le richieste di scambi vanno dirette al Dipartimento di Letterature Comparate, Via Valco di San Paolo, - Roma. Rivista in corso di registrazione presso il tribunale di Roma. Il Dipartimento di Letterature Comparate si dichiara pronto a regolare le eventuali spettanze per le immagini di cui non è stato possibile accertare i crediti. Il testo è disponibile sul sito Internet di Carocci editore nella sezione “PressonLine”. a edizione, dicembre © copyright by Dipartimento di Letterature Comparate, Università degli Studi Roma Tre Editore: Carocci (Roma) ISBN ---- Finito di stampare nel dicembre dalla Litografia Varo (Pisa). Impaginazione ed editing: Le Varianti, Roma. Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. della legge aprile , n. ). Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno o didattico. Indice Presentazione di Otello Lottini Anglistica «Darting Fire and Speaking Thunder». L’arma da fuoco nella riflessione settecentesca, di Simona Corso Mamfurio e Oloferne, di Masolino D’Amico Il discorso indiretto libero nel testo narrativo. Caratteristiche e traduzione, di Paola Faini Seduzioni epistolari nell’età dei Lumi. L’equivoco e provocante carteggio amoroso di Giustiniana Wynne, scrittrice anglo-veneziana (-), di Nancy Isenberg Note sulla relazione intermediale tra letteratura e cinema, di Maddalena Pennacchia «Between mimicry and mockery»: straniamento e autoparodia nella letteratura della migrazione, di Paola Splendore Sperimentazioni linguistiche e traduzione: la prosa acustica di Evadne Price in Not So Quiet…, di Barbara Antonucci Due scialli dall’India: echi d’oltremare in Jane Austen, di Maria Paola Guarducci Recensioni Francesistica Per una rappresentazione del sabba tra parola e immagine. Il Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons di Pierre de Lancre, di Isa Dardano Basso La nostalgia della parola arcaica, di Rosa Di Paolo Borgognoni in Italia (-), di Letizia Norci Cagiano Léopold Sédar Senghor o cent’anni di negritudine, di Valeria Pompejano La tentazione, il volo e la visione: tre tempi de L’image d’un mage ou Le spirituel di André Mage de Fiefmelin, di Luigi Magno Blaue Augen, blonde Bestie (und keine Zigeuner im grünen Wagen), ovvero l’ironica solitudine di Tonio Kröger, un saltimbanco sul filo della fin de siècle. Uno studio comparato, di Francesca Milaneschi L’esotismo al servizio dell’art pour l’art: Hérodias di Flaubert, di Federica Sforazzini INDICE Germanistica Rileggendo Una teoria del turismo di Hans Magnus Enzensberger, di Giuli Liebman Parrinello Bad : «Una parola importante per la cultura germanica», di Agnese Nobiloni Toschi Il Gruppo : scrittori tedeschi dal al , di Marta Bignami Ispanistica Modelli femminili nel romanzo spagnolo dell’Ottocento: Pepita Jiménez vs Tristana, di Fausta Antonucci “Rosa naturale” e “rosa di carta”: il popolarismo poetico nel dibattito spagnolo otto-novecentesco, di Maria Cristina Assumma Lingua e dialetto in Felipe Trigo, di Filomena Liberatori Il paesaggio come ricerca nel viaggio italiano di Calo Carratalà, di Otello Lottini Il ritmo nella lingua: Son de negros en Cuba di Federico García Lorca, di Pina Rosa Piras Agli albori dell’ispanismo italiano: il ruolo dei “Quaderni Ibero-Americani”, di Giuliano Soria …Y pusieron esposas a las flores di Fernando Arrabal. Piani della rappresentazione e livelli di senso, di Simone Trecca Scrittura e oralità nella letteratura spagnola contemporanea: El Jarama di Rafael Sánchez Ferlosio, di Laura Mariottini Lusitanistica Contributo alla ricostruzione genetica di un corpus letterario, di Giulia Lanciani Delfini e gattopardi, di Giorgio de Marchis Usi linguistici della comunità giudeo-portoghese di Amsterdam, di Letizia Grandi Slavistica Terme?… Sauna?… No: russkaja banja, di Maria Carella Tradurre significati nascosti, di Julija Nikolaeva Strategie citazionali postmoderne: i Sinie nosy e la tradizione dello jurodstvo, di Laura Piccolo INDICE Contributi Modelli e proposte per diventare un lettore interculturale, di Carmine Chiellino Concorrenti o colleghi? Osservazioni sulle traduzioni italiane della letteratura russa, di Anna Jampol’skaja Attività scientifica del Dipartimento Convegni PRESENTAZIONE di Otello Lottini Questo numero del “Quaderno del Dipartimento di Letterature Comparate” (che mantiene, per l’essenziale, la struttura di quello precedente) è articolato attorno alle tradizionali aree di studio del Dipartimento (e cioè, anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica, lusitanistica, scandinavistica e slavistica) di cui accoglie una parte rilevante della produzione scientifica del . Da quest’anno, aggiungiamo un’altra Sezione, intitolata Contributi, in cui ospitiamo studiosi esterni al Dipartimento, invitati a collaborare, in modo da arricchire i contenuti della rivista, con ricerche, studi, idee, provenienti da altri contesti scientifici, nazionali e internazionali. In questo numero, abbiamo invitato Carmine Chiellino, dell’Università di Augsburg, in Germania, e Anna Jampol’skaja, dell’Università di Mosca. Sottolineo con piacere, inoltre, la presenza di giovani ricercatori e anche di giovani dottori e dottorandi (che si stanno formando nel nostro “Dottorato di culture e letterature comparate”) come segnale di apertura verso nuovi colleghi e nuovi studiosi. Con queste innovazioni, il numero dei contributi e il numero delle pagine sono notevolmente aumentati, per cui la rivista ha acquisito ormai lo spessore di un denso e ampio volume. L’interesse suscitato dal “Quaderno”, naturalmente, è un sintomo della sua forza attrattiva, ma anche della vitalità e della crescita del lavoro scientifico del Dipartimento e i suoi effetti pongono l’esigenza, forse, di trovare, per l’immediato futuro, una diversa periodicità. Questi tre aspetti – apertura ai giovani, apertura alla ricerca scientifica internazionale e aumento dei contributi dei colleghi del Dipartimento – ci rendono particolarmente soddisfatti della rivista e del suo ruolo come punto di riferimento dell’attività scientifica e culturale dei docenti del Dipartimento, fondata su un’ampia varietà di indagini, di ricerche e di temi, sempre più ricchi e importanti, che offriamo all’attenzione della comunità dei lettori. In questo senso, intendiamo contribuire a promuovere il dialogo con altri studiosi, oltre che tra di noi, in un confronto approfondito di pensiero e di analisi, partendo dalla peculiarità delle diverse aree scientifiche in cui si articola il nostro Dipartimento. *** Come si può vedere dai contributi presenti in questo numero, la rivista offre una visione di assieme, articolata e complessa, delle espressioni artistico-letterarie e delle OTELLO LOTTINI problematiche culturali e linguistiche dell’Europa, come anche delle loro interrelazioni postcoloniali, basate su storici e complessi contatti fra testi e contesti diversi. Ma l’obiettivo del “Quaderno” è anche quello di inserire queste riflessioni (pur fondate su rigorose specificità e settorialità, proprie del circuito accademico) in un più ampio orizzonte di elaborazione culturale europea. Perciò, intende offrire, soprattutto ai giovani studiosi e ricercatori e ai lettori in genere (oltre che alla comunità scientifica nazionale e internazionale), strumenti adeguati per poter analizzare, nel migliore dei modi, le trasformazioni diacroniche e sincroniche, culturali, linguistiche, letterarie e artistiche del mondo europeo, nella complessità delle sue manifestazioni comunicative e creative. Decifrare queste trasformazioni significa integrarle su un terreno culturale comune, attraverso l’interpretazione dei linguaggi specialistici e del dialogo delle lingue, delle letterature e delle arti di riferimento. Per quanto tecniche, insomma, sono convinto che queste ricerche aprano un percorso privilegiato per accedere a un’articolata e approfondita comprensione delle società europee e occidentali. *** Questo “Quaderno”, dunque, si propone come luogo di ricerca, di riflessione e di elaborazione culturale del Dipartimento, aperto, come abbiamo visto, anche ai contributi di personalità esterne, di diversi orientamenti teorico-metodologici, intellettuali e scientifici. Col nostro lavoro, intendiamo dare un apporto non solo all’arricchimento della ricerca scientifica e al rinnovamento dell’università, ma anche, più in generale, al perfezionamento della convivenza collettiva e allo sviluppo dell’Italia. È opinione diffusa che oggi il nostro paese viva in una condizione di debolezza – soprattutto sul piano scientifico, culturale e formativo – che potrebbe portarlo ad avvitarsi pericolosamente su se stesso, col rischio di pervenire a una vera e propria decadenza (di cui, peraltro, si avvertono già i primi segnali). È necessaria, perciò, un’azione di ricostruzione e di rinnovamento, a partire dalla vita universitaria, che si deve fondare su nuovi progetti e nuove idee, per individuare lungimiranti obiettivi e inedite direzioni. Tutti dobbiamo operare per mettere in grado il nostro paese di affrontare le sfide della competizione scientifica e culturale internazionale e di reggere l’urto di un’accelerata e tumultuosa globalizzazione. Credo che le personalità vive e aperte del nostro Dipartimento, del nostro Ateneo e, direi, di tutta l’università italiana siano sempre più consapevoli che le pratiche di adattamento congiunturale, proprie della vita universitaria degli ultimi decenni, devono lasciare il passo a un impegno di ricerca più rigoroso e profondo, con lo sguardo fisso all’orizzonte e ai modelli scientifici e culturali del XXI secolo, più che a quelli del secolo appena passato, su cui la maggior parte dei docenti si è formata. Credo che sia necessario stimolare e promuovere un lavoro collettivo per identificare, nella nuova situazione che si sta creando, l’interesse strategico dell’università, la sua nuova mission, sempre più fondata sul merito e sulla qualità, in un contesto di pratiche di valutazione esterna e di autovalutazione, quali espressioni di una nuova visione dell’impegno universitario. Si tratta, cioè, di sviluppare diverse progettualità che possano rendere il nostro Dipartimento e il nostro Ateneo punti di riferimento scientifici di eccellenza, in Italia e in Europa. PRESENTAZIONE Segnalo, in particolare, a titolo esemplificativo, alcuni imperativi del nostro lavoro intellettuale: – Dobbiamo approfondire le coordinate di una nuova identità culturale europea – fondata sul comune retaggio umanistico e cristiano, oltre che sulla dimensione razionalistico-scientifica, propria dell’età moderna – ma coniugate nel rispetto delle realtà nazionali e delle variazioni regionali. – Dobbiamo rielaborare le condizioni culturali di un approccio diverso all’Altro, che ormai è tra noi e non è più, come in passato, un lontano e distante fenomeno esotico, attrezzando il paese, e in special modo i giovani, a una nuova e inedita convivenza sociale e a un approccio critico verso le differenze culturali, fondato sulla nozione di reciprocità; ma dobbiamo proporci anche di sviluppare le risorse umane e incrementare quelle economico-finanziarie, per attrezzarci meglio in vista della competizione scientifica e culturale fra i paesi europei e, più in generale, occidentali. – Dobbiamo lavorare tra i mass media, sempre più al centro della vita culturale moderna, come mai è accaduto nella storia dell’umanità, rivitalizzando i mezzi culturali tradizionali (insegnamento, libro, arte, teatro ecc.). In questo senso, dobbiamo trovare e affinare un nuovo equilibrio del sapere tra dimensione affettivo-emozionale e dimensione razionale-intellettuale, tra acquisizioni collettive e acquisizioni personali, tra attivismo percettivo (creativo e produttivo) e riflessione (meditazione e contemplazione). – Dobbiamo affrontare anche il problema della soggettività individuale, perché ogni fase di cambiamento altera le consuetudini e i valori stabiliti, che erano nicchie rassicuranti entro le quali gli individui si adattavano a vivere. Essa pone al nostro orizzonte delicati problemi di identità psicologica, di disagi profondi, di frustrazioni e, sovente, di vere e proprie insofferenze che lievitano, spesso oscuramente, all’interno della vita accademica e in quella più generale del paese. *** L’evoluzione della società europea e occidentale, a partire dal Rinascimento e fino a questi ultimi decenni, è arrivata a un punto tale per cui, come osserva Ortega y Gasset, non può esistere senza libro, cioè senza scienza e senza tecnica (sul piano materiale) e senza un repertorio di idee (sul piano culturale e morale). Le speranze riposte nel libro sono state in gran parte realizzate: esso ha prodotto le scienze della natura e le scienze storiche, le scienze tecniche e quelle politiche. Tutta la società moderna è la conseguenza ultima della fiducia nel libro: è il trionfo della scrittura laica sul libro rivelato da Dio e sul libro delle leggi dell’autocrazia. La ribellione dei popoli è avvenuta nel nome del libro, della ragione, della cultura. Il libro, che ha segnato la fase trionfante dell’età moderna, ora ne segna la fine o, perlomeno, la mette in crisi. Ogni strumento creato dall’uomo per rendere più facile la vita, quando si trasforma in nuova difficoltà, gli si rivolta contro: da qui il libro – problema di oggi. Ma se all’inizio della modernità si trattava di “cercare” i libri e il problema principale era la produzione, oggi, il problema è inverso, in quanto si tratta di promuovere la lettura, cioè di “cercare” i lettori. L’enorme abbondanza di libri entro cui viviamo, infatti, si è trasformata in una selva tropicale che ci accerchia e rischia di soffocarci. Perciò, essi vengono percepiti sempre di più come difficoltà, nel senso che sono diventati un problema a causa della loro stessa sovrabbondanza (oggi siamo in presenza di una sorta di autodistruzione OTELLO LOTTINI del libro, per eccesso di produzione e di accumulazione). L’uomo, insomma, non può essere troppo ricco: se deve scegliere tra un numero eccessivo di possibilità rischia di fallire, in quanto perde il senso del necessario. Da qui nascono le crisi storiche. Nei nostri giorni bisogna negoziare con l’abbondanza per eliminare ciò che non ci interessa, esercitando la nostra responsabilità individuale, ed elaborare gli automatismi necessari per vivere questa nuova fase storica. Ma l’avvenire dei libri, in quanto depositari della conoscenza e della memoria, sarà ancora sicuro e decisivo per molto tempo, anche se esiste il problema della loro conservazione (a causa della loro fragilità) a cui, però, si può far fronte con la possibilità di registrarli su microfilm o elettronicamente. *** Malgrado tutto, il libro continua a essere importante, anche se non è più solo, ormai da tempo, nella repubblica della letteratura e del sapere, ma è in compagnia delle immagini. Anzi, c’è sempre maggiore sinergia tra immagine e scrittura, per cui la carta stampata non è destinata ad essere sconfitta dalle immagini. Fino a poco tempo fa, la scrittura sembrava aver perso la guerra contro gli audiovisivi. Ma, poiché la lettura è una necessità biologica della specie umana, nessuno schermo e nessuna tecnologia arriveranno a sopprimere il bisogno della lettura tradizionale. L’aumentata crescita del consumo di immagini (televisione, pubblicità, cinema, ecc.) provoca nuove curiosità verso la scrittura (a eccezione della fascia dei soggetti a rischio, di cui satura l’ulteriore esigenza di informazione) per un bisogno di ripetizione, come forma di rassicurazione, e per la necessità di approfondire e di riflettere. Oggi, la scrittura torna in primo piano, grazie al computer, che sconvolge ogni relazione con l’immagine (in quanto sullo schermo del computer ci sono soprattutto parole). Il computer è civiltà dell’alfabeto e l’alfabetizzazione attraverso il computer promuove e non ostacola quella via libro, mentre la velocità condiziona il nostro modo di assorbire le informazioni. Bisogna respingere l’atteggiamento manicheo di certi studiosi o intellettuali per i quali la scrittura rappresenterebbe il bene e l’immagine il male. L’una, la cultura; l’altra, il vuoto. Ciò che è importante, invece, è il modo in cui questa nuova sinergia si iscrive nel corredo della specie umana dell’uomo di oggi, dopo una millenaria esperienza “mediatica”. Si sa che in un primo tempo l’umanità ha consacrato le tracce della sua esperienza mediante la tradizione orale. Poi è apparsa la scrittura (di cui la stampa rappresenta l’accelerazione rivoluzionaria) con la quale si è passati dalla linearità temporale del discorso parlato a una linearità spaziale, che permette di andare a recuperare l’informazione precedente con dinamica sequenziale. Nel XX secolo, la civiltà ripropone la situazione anteriore a quella della stampa, in cui l’immagine e l’oralità si mescolano e si completano (come era accaduto, per esempio, a partire dalle Piramidi egiziane fino alle chiese gotiche o barocche). Attualmente, il computer, restituendoci una civiltà alfabetica, ma anche sequenziale, ci consente di lavorare con dati e informazioni che collegano il concettuale dell’immagine con l’intuitivo della scrittura. Tutto il problema consiste nel riuscire a filtrare bene questa grande quantità di informazioni e di farlo nel momento giusto, perché non abbiamo più il tempo della riflessione di cui si disponeva in passato. PRESENTAZIONE Nella nostra società, perciò, bisogna essere capaci di vivere in modo stimolante la pluralità dei linguaggi in cui siamo immersi, perché c’è diversità, interferenza e simultaneità comunicativa e creativa. Questa pluralità introduce una frattura radicale nella storia, in senso hegeliano: oggi, non è più possibile pensare al linguaggio (o alla letteratura o all’arte) come a una serie di graduali trasformazioni e aggiustamenti che riprendono ciò che c’era in precedenza, poiché siamo immersi in una dinamica di continua innovazione culturale. Ciò che caratterizza la nostra civiltà – in cui si mescolano letteratura, cinema, televisione, stampa, teatro, ecc. – è il plurilinguismo metodico, ideativo e produttivo, reciprocamente interconnesso. È questa la nuova frontiera problematica della società e della storia. *** Anche il quadro culturale generale si muove nella direzione della ricerca e dell’apertura verso nuove realtà, in modo più empiricamente immediato che in passato. Essa implica una chiave di lettura dinamica e pragmatica, che fa entrare in crisi le costruzioni a priori e le considerazioni e le individuazioni astratte dei referenti sociali e delle delimitazioni di genere. Ciò sembra accadere perché, caduta la frontalità visiva come punto di vista unico o dominante, l’uomo di oggi vive in un mondo in cui la caratteristica principale non è più la linea, ma la curva: circolarità di linguaggi, di saperi, di immagini, di informazioni. In questo contesto, cadono le rigide dicotomie spaziali e temporali, i dualismi speculativi, platonici e cartesiani e la linearità progressiva, a vantaggio di una diffusa flessibilità, fondata su dinamiche policentriche e su una nuova articolazione sociale dei linguaggi, come dei loro contesti d’uso e di valore. Le contrapposizioni di un tempo non si danno più con la stessa nettezza, ma aumentano le tendenze verso la molteplicità, sorgono nuovi problemi e nuovi soggetti sociali, cadono vecchie certezze, si sviluppano società differenziate e anche la letteratura trova dimora in altri siti e in altri linguaggi, sempre più diversamente ricca nella disseminazione del senso e nell’articolazione polimorfica. ANGLISTICA Simona Corso Masolino D’Amico Paola Faini Nancy Isenberg John McCourt Maddalena Pennacchia Paola Splendore Barbara Antonucci Maria Paola Guarducci «DARTING FIRE AND SPEAKING THUNDER». L’ARMA DA FUOCO NELLA RIFLESSIONE SETTECENTESCA* di Simona Corso I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Albert Einstein, Lettera a Harry S. Truman, La polvere da sparo, ci dicono gli storici della tecnica, fa la sua comparsa nella Cina del ; non si sa tuttavia se i cinesi la usassero in guerra. In Europa viene introdotta già alla fine del XIII secolo, ma solo all’inizio di quello successivo si scopre che, mettendo in un tubo di ferro un proiettile e un po’ di polvere, si produce una detonazione capace di impartire al proiettile moto e direzione. Nel XV secolo la tecnologia della polvere applicata ai cannoni fa progressi e le guerre cominciano a essere decise dalle bordate dei cannoni. Azionare un cannone richiede però, ancora, un coraggio straordinario: su due cannoni azionati, uno salta in aria. Perché la polvere da sparo fosse impiegata in un’arma da impugnare fu dunque necessario superare un’elevata soglia di diffidenza e paura. Alla metà del Quattrocento, tuttavia, compaiono le prime armi da fuoco e intorno al sembrano ormai entrate nell’uso. In questi anni, con l’invenzione del moschetto, capace di perforare le armature, l’arma da fuoco entra stabilmente negli eserciti, rivoluzionando quella che John Keegan ha chiamato l’arte occidentale di fare la guerra (cfr. Hall, , vol. III, t. , pp. -; Keegan, , pp. ss.). La letteratura registra col consueto ritardo questa novità tecnologica destinata a cambiare la faccia del mondo. Benché cenni alle armi da fuoco non manchino nei testi cinque o seicenteschi (il caso più celebre è forse quello dell’Orlando Furioso, dove Orlando, inorridito dall’archibugio del re Cimosco, glielo sottrae per seppellirlo in fondo al mare, sperando così di privare per sempre gli uomini della polvere da sparo), è la letteratura settecentesca a consacrare l’arma da fuoco come uno dei simboli pregnanti dell’Occidente. In quest’epoca l’arma da fuoco fa parte ormai del corredo abituale di un soldato europeo (o di un viaggiatore in cerca d’avventure), eppure nei testi letterari può essere ancora descritta come un oggetto magico-diabolico, in grado di suscitare sgomento o ammirazione, soprattutto se guardata da occhi stranieri: gli occhi di Friday o degli indigeni africani (Robinson Crusoe, ; The * Queste pagine traggono spunto da una relazione presentata al X Convegno internazionale della British Comparative Literature Association “Invention: Literature and Science” (Leeds, - luglio ). Per una prima trattazione di questi temi rinvio all’ultimo capitolo del mio Automi, termometri, fucili. L’immaginario della macchina nel romanzo inglese e francese del Settecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma . SIMONA CORSO Further Adventures of Robinson Crusoe, ), del re di Brobdingnag (Gulliver’s Travels, ), di Rhedi (Lettres Persanes, ) o di Candide, che, pur essendo vestfaliano, è “candido” al pari di un “selvaggio” (Candide, ). In questi cinque testi l’arma da fuoco esibisce chiaramente la sua origine geografica: prodotto della tecnologia occidentale, finisce col diventare un simbolo pregnante di quella civiltà, al punto che la sua comparsa sulla scena è in grado di evocare in un lampo l’Europa, e per lo più il suo dominio su altre civiltà, così come la minaccia della sua soppressione equivale a ipotizzare la fine del predominio occidentale, se non della civiltà occidentale tout court. In questi testi, destinati a divenire canonici, la riflessione sull’arma da fuoco diviene dunque una riflessione (a opera di quattro celebri commentatori europei) sui valori e i disvalori della contemporanea civiltà occidentale: perizia tecnologica, predominio della sfera politica, arroganza culturale, ma anche prime serie contestazioni della guerra. Nella prefazione a Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies l’antropologo-biologo Jared Diamond () racconta che la sua ventennale ricerca sulle differenze storico-biologico-culturali tra le diverse popolazioni della terra trasse origine da una conversazione tenuta nel su una spiaggia della Nuova Guinea con un giovane leader politico del luogo, di nome Yali. Mentre passeggiavano sulla spiaggia, Yali chiese al ricercatore americano (allora in Nuova Guinea per uno studio di ornitologia) come mai nel giro di duecento anni un gruppo sparuto di europei bianchi fosse riuscito a conquistare una terra che per parecchie migliaia di anni era appartenuta alle popolazioni locali. Poiché Diamond imbarazzato rimaneva in silenzio, Yali suggerì che la fulminea conquista dei bianchi fosse dovuta ai loro beni materiali, che gli abitanti del luogo chiamavano sinteticamente “cargo”: asce di acciaio, fiammiferi, medicine, vestiti, bibite, ombrelli… In quegli anni, aggiunge Diamond, molti coloni bianchi disprezzavano i “primitivi” guineani senza mezzi termini: il più stupido dei bianchi godeva di uno standard di vita assai più alto di un politico locale importante e intelligente come Yali. Eppure, sia Diamond che Yali sapevano bene che, in media, i locali erano abili e capaci almeno quanto i colonizzatori. Cosa su cui Yali probabilmente aveva rimuginato a lungo, quando formulò la domanda che avrebbe spinto Diamond ad abbandonare l’ornitologia per dedicarsi all’antropologia: «Come mai voi bianchi avete tutto questo cargo e lo portate qui in Nuova Guinea, mentre noi neri ne abbiamo così poco?». Benché non conoscesse la risposta, Yali aveva senz’altro azzeccato la domanda. Senza “cargo”, sia pure fatto a pezzi dal naufragio, la storia di Robinson (e probabilmente la nostra) sarebbe stata molto diversa. Se Robinson Crusoe è il primo uomo a calpestare la natura incontaminata dell’isola su cui ha fatto naufragio, tuttavia, grazie al relitto della nave, il naufrago inglese è un Adamo un po’ particolare, fornito di pipa, martello e cannocchiale, oltre che di quel corredo fondamentale che Christopher Hill (, p. ) chiamava «mental furniture». Ma è l’arma da fuoco, annoverata «tra le cose che più mi stavano a cuore», a fare di lui un Adamo dall’inequivocabile origine geografica: Robinson non è tanto il primo uomo, quanto il primo uomo occidentale ad abitare un’isola rimasta fuori dalla “civiltà”. Il primo colpo di fucile sparato da Robinson sull’isola ha tutta l’aria di un evento mitico, quasi un incontro originario tra wilderness e civilisation: «I shot a great Bird which I saw sitting upon a Tree on the Side of a great Wood, I believe it was the first Gun that had been fir’d there since the creation of the World» (Defoe, , p. ). « DARTING FIRE AND SPEAKING THUNDER » Già prima del naufragio l’arma da fuoco è un attributo fondamentale di questo intraprendente mercante di York. E non solo perché in più occasioni il fucile lo salva da una morte certa, ma anche perché gli rivela il potere simbolico oltre che reale della tecnologia. La terribile novità della detonazione, e lo stupore che lo scoppio della polvere desta tra i «selvaggi», è un motivo che ricorre spesso nel romanzo. Già in una delle prime avventure, la fuga da Salé in compagnia di Xury, Robinson sperimenta il potere emotivo oltre che materiale dell’arma da fuoco. Quando Robinson spara sui leopardi che li inseguono, i selvaggi, che di fronte alle belve erano rimasti impassibili, cominciano a tremare: «It is impossible to express the Astonishment of these poor Creatures at the Noise and Fire of my Gun; some of them were even ready to dye for Fear» (ivi, p. ). Non senza malizia Robinson descrive in termini simili le urla delle bestie «upon the Noise or Report of the Gun, a Thing I have some reason to believe those Creatures had never heard before» (ivi, p. ). La stessa malizia, forse, spinge Defoe a far sì che i primi bersagli del fucile di Robinson siano delle belve feroci. Giacché le prime tre volte che Robinson impugna il fucile lo fa per difendersi da animali in procinto di divorarlo, il lettore sarà incline a credere che tutte le volte in cui Robinson tornerà a impugnare il fucile lo farà per legittima difesa. Al principio del romanzo, del resto, l’equazione tra bestie e selvaggi è più che una maliziosa allusione. Con la brutale schiettezza che lo caratterizza, Robinson la asserisce senza pudore: «We could ne’er once go on shore but we should be devour’d by savage Beasts, or more merciless Savages of human kind» (ivi, p. ). (In realtà, quando Robinson e Xury approderanno sulla costa africana, gli indigeni si riveleranno inaspettatamente gentili; questo tuttavia non impedirà a Robinson di conservare intatti i pregiudizi sui selvaggi, nei confronti dei quali sull’isola svilupperà una vera e propria psicosi.) Il fucile, dunque, già nelle avventure che precedono il naufragio, sembra un attributo fondamentale di questo avventuriero determinato a rimanere vivo. Non ci sorprende, pertanto, che, scoperto il relitto della nave, il pensiero del naufrago corra ad armi e munizioni. Nel mondo adamitico di Robinson Crusoe non ci sono né tavoli né sedie, ma ci sono armi e polvere da sparo in abbondanza. Negli anni a venire Robinson si chiederà più volte che cosa sarebbe stata la sua vita senza fucile né munizioni: «I should have liv’d, if I had not perish’d, like a mere Savage» (ivi, p. ). L’arma da fuoco, con cui Robinson uccide o stordisce uomini e bestie, appare come il grande retaggio della civiltà occidentale, l’unica macchina che il naufrago trae intatta dalla nave e senza la quale, seppure fosse rimasto in vita, «sarebbe vissuto come un puro selvaggio». Nell’ordine del giorno che Robinson si impone per non inselvatichire, il giro col fucile è il momento cruciale della giornata, più importante della preghiera, del lavoro, del sonno. Il fucile, che in Marocco gli ha salvato la vita da leoni e leopardi, ora gli fornisce il cibo per conservarla. Non avendo semi da coltivare, Robinson diventa cacciatore. Del cacciatore Robinson acquisisce non solo l’abilità nel tiro, ma anche la psicologia, ossia la freddezza nel piombare addosso alla preda senza alcun riguardo per la vita della vittima. Le condizioni estreme di vita trasformano questo agiato borghese inglese in un tiratore spietato che racconta (e infligge) la morte in stile matter of fact. Il registro non cambia quando la preda cambia natura. Poiché, come Robinson torna spesso a ripetere, i «selvaggi di genere umano» potrebbero essere «più spietati» delle «bestie selvagge», lo scontro coi selvaggi si presenta come una prosecuzione dei lunghi anni di battute di caccia. Durante i dieci anni che separano SIMONA CORSO la scoperta dell’orma sulla sabbia dall’effettivo sbarco dei selvaggi Robinson intraprende una corsa agli armamenti senza precedenti. Progetta stragi, trasforma il capanno in un fortino, inventa armi sempre più sofisticate (persino una mitragliatrice ante litteram, fatta di sette fucili legati insieme a cui dare fuoco in un colpo solo). Non trascura neanche il profilo ideologico: dapprima si presenta come una lepre braccata e dunque obbligata a difendersi da «creature più pericolose del diavolo, cioè i selvaggi della terra ferma» («some Creatures more dangerous than the Devil, viz […] the Savages of the main land», ivi, p. ); poi, quando la storia della legittima difesa non convince più (perché mai un’orma sulla sabbia dovrebbe rappresentare una dichiarazione di guerra?), dà alla guerra un fondamento morale. Consapevole che Dio lo ha fatto nascere nella parte “buona” del mondo («in a Part of the World, where I was distinguish’d from such dreadful Creatures as these», ivi, p. ), Robinson si sente investito del compito mostruoso di rimediare alle sviste della Provvidenza: sradicherà il cannibalismo annientando il popolo che lo pratica. È la fase più acuta della crisi: la distanza tra Robinson – armato, razionale e assistito da Dio – e i selvaggi – nudi, brutali e abbandonati dal cielo – non potrebbe essere maggiore. Un problema pratico però si impone. Uccidere uno, due, venti selvaggi non servirebbe a niente se anche uno riuscisse a fuggire e avvisare la sua gente; è possibile allora uccidere tutti i selvaggi? La polvere da sparo ha prodotto un sogno, quello della invincibilità, che è anche un incubo, l’incubo clausewitziano della guerra totale («to kill another, and so another, even ad infinitum», ivi, p. ). Tra ripensamenti e crisi di coscienza, Robinson resta tuttavia saldo nel suo militarismo. La cattura di Friday gli consente di uscire dal feroce dilemma (distruggere tutti i selvaggi o farsi distruggere da loro), ma non lo distoglie dai propositi di strage. L’alternativa alla distruzione totale è la colonizzazione, ma anche la colonizzazione si fa a colpi di fucile. Anzi, è proprio Friday, il buon selvaggio che consente l’inizio della colonizzazione, a consacrare l’arma da fuoco e trasformare in dio colui che la impugna. La reazione di Friday davanti al fucile è nota. Atterrito da quell’oggetto «che contiene un’inesauribile riserva di morte e distruzione» (ivi, p. ), Friday si inginocchia, supplica il fucile di risparmiarlo, gli parla. «If I would have let him, he would have worshipp’d me and my Gun» annota Robinson con una certa soddisfazione (ibid.). Comincia così la “civilizzazione” di Friday. Robinson gli insegna a parlare l’inglese, ad aborrire la carne umana, a coprirsi d’abiti, a pregare Dio. Quindi lo inizia al «secondo mistero dell’Occidente» (ivi, p. ): la polvere da sparo. Dopo avere ottenuto da Friday la promessa che si impegnerà a divenire l’eroe civilizzatore (ossia l’assassino) della sua gente, Robinson gli mette in mano il fucile. «Do exactly as you see me do» (ivi, p. ) gli dice, puntando il fucile contro gli indigeni appena sbarcati. Uno dei selvaggi sopravvissuti descriverà la battaglia come un incantesimo: «Men were kill’d by Thunder and Lightning, not by the Hand of Man […]; for it was impossible […] that a Man could dart Fire and speak Thunder, and kill at a Distance» (ivi, p. ). Ecco svelato il segreto micidiale del warfare occidentale: la morte sterilizzata, a distanza, l’assassinio emotivamente non connotato. Alla fine dello scontro non solo i selvaggi, ma Robinson stesso sembra non sapere dire «da chi venisse tutto questo» (ivi, p. ). Conta i corpi dei caduti e lui stesso con stupore annota: ventuno vittime fra i selvaggi, zero fra i nostri. I successivi scontri sull’isola tra europei e indigeni, narrati in The Further Adventures, riproducono lo schema di questo primo scontro. La grande battaglia che pone fine alle ostilità, in cui ventidue europei sbaragliano le orde di indigeni « DARTING FIRE AND SPEAKING THUNDER » uccidendone centottanta, è da un lato l’amplificazione della prima battaglia combattuta da Robinson e Friday, dall’altro la riproduzione in scala delle campagne di conquista che portoghesi, spagnoli, inglesi e olandesi avevano condotto nelle Americhe, quando poche centinaia di uomini ne avevano sopraffatto migliaia. Il processo indolore di pacificazione che segue alle ostilità è una chiosa di Defoe, la soluzione ideale oltre che narrativa al conflitto permanente. I riti di pace promossi dal governatore spagnolo riecheggiano a distanza di anni l’amicizia tra Robinson e Friday. Dopo il sangue e il fuoco, il drammatico scontro tra Europa e mondo caraibico si stempera in tenere storie di amicizia. Robinson Crusoe e The Further Adventures diventerebbero così romances sul colonialismo, romanzi capaci di trasformare in storie a lieto fine il tragico rapporto tra europei e indigeni. Fin qui la storia di Robinson sembra raccontarci una storia arcinota: le società tecnologicamente più avanzate sono destinate a dominare le altre; col noto corollario che la superiorità tecnologica è spesso anche superiorità culturale. Ma la storia non finisce qui. Il massacro del Madagascar di cui di lì a poco Robinson sarà testimone getta un’ombra sinistra sull’epopea di questo colonizzatore britannico sempre pronto a impugnare il fucile. Lasciata l’isola, Robinson torna in Brasile e da qui salpa per il Capo di Buona Speranza. La nave approda sulle spiagge del Madagascar. I marinai inglesi vengono accolti pacificamente e trattati con grande civiltà. Sulla spiaggia si celebrano riti di pace e si fanno scambi commerciali. Tuttavia, qualche ora dopo «quei macellai dei nostri inglesi» infrangono i patti di pace e mettono a ferro e fuoco il villaggio. Tra le esplosioni delle granate le capanne saltano in aria, le donne vengono massacrate, i bambini trucidati. Robinson assiste inebetito al massacro, atterrito dalla «rabbia addirittura selvaggia», «dal furore quasi inumano» dei marinai inglesi («such instances of rage, altogether barbarous […], a fury something beyond what was human», Defoe, , cap. X). Per il resto del viaggio non fa altro che imprecare contro i compagni, finché questi, stanchi delle sue prediche, lo abbandonano nella rada del Bengala. Qui, nuovamente «solo nella parte più remota del mondo» (ivi, cap. XI), Robinson riflette sulla sua vita passata. Il ricordo del Madagascar continua a tormentarlo e adesso ha quasi paura di impugnare un’arma contro i selvaggi, sia pure allo scopo di difendersi. All’improvviso Robinson capisce che la miscela di arroganza e polvere da sparo può essere micidiale. Se all’inizio delle sue avventure riteneva che sarebbe stato peggio finire nelle mani dei selvaggi che nelle fauci dei leoni, ora pensa che «sarebbe stato molto meglio cadere nelle mani dei selvaggi», che finire nelle grinfie dei capitani inglesi e olandesi, maestri di «torture barbare e inumane» («it were much better to have fallen into the hands of the savages […], than those who would perhaps glut their rage upon me by inhuman tortures and barbarities», ivi, cap. XIII). «Perché quei capitani inglesi e olandesi sono un branco di gente impulsiva, superba e insolente, che non sa cosa sia la giustizia né sa comportarsi come dettano le leggi di Dio e della natura; ma [ha] la boria del comando e non comprend[e] la natura del proprio potere». «Perché i selvaggi, per dargli quello che gli spetta, non mangiano un uomo finché non sia morto […] ma questi altri avevano molte arti che superavano la crudeltà della morte». Sperduto nell’Oceano Indiano, in preda al disorientamento spaziale e ideologico, l’eroe dell’ethos occidentale per la prima volta prende le distanze dalle «arti» degli europei, «questi altri». La condanna delle «arti che superano la crudeltà della morte» non significa una tardiva condanna delle armi da fuoco o della tecnologia né un’opzione finale per la pace, quanto piuttosto un brivido di orrore di fronte a ciò che le armi possono “fare” SIMONA CORSO anche al di là delle intenzioni di chi le usa. Il massacro folle e gratuito del Madagascar provoca in Robinson una crisi di coscienza: dopo aver ucciso per trent’anni uomini e bestie con freddezza, ora Robinson comincia a provare orrore a impugnare un’arma. Come pochi personaggi letterari sanno fare al pari di lui, Robinson ripensa al passato e lo vede sotto una luce diversa. È proprio vero che il fucile preserva il colonizzatore europeo «quello di un tempo»? Non lo trasforma forse in un megalomane esaltato che finisce col perdere il bene più prezioso, la consapevolezza dei propri limiti? Cosa succede quando un uomo armato fino ai denti e con scorte di polvere praticamente inesauribili si scontra con un mondo in cui non si è mai udito un colpo di fucile? Forse l’uomo che sull’isola progettava di uccidere tutti i selvaggi non era poi così diverso dai marinai inglesi che radono al suolo il villaggio del Madagascar. La storia di Robinson narra una duplice tragedia: che cosa accade quando una civiltà tecnologicamente superiore decide di sopprimerne una tecnologicamente inferiore; e che cosa accade quando una civiltà viene svuotata di tutto tranne che delle sue invenzioni tecnologiche. Gli inglesi del Madagascar che massacrano i gentili africani con cui qualche ora prima hanno stretto patti esprimono questa tragica dissociazione tra civiltà e tecnologia. E insegnano a Robinson che, oltre al potere simbolico e al potere materiale, le armi hanno un altro diabolico potere: quello di trasformare gli uomini in esseri «dalla rabbia selvaggia», «dal furore quasi inumano». Il re di Brobdingnag, che Gulliver incontra nel secondo dei suoi viaggi, non ha dubbi. Le armi da fuoco («those terrible engines») devono essere il prodotto di «qualche genio del male, nemico del genere umano» («some evil genius, enemy to mankind», Swift, , pp. -). Quando Gulliver, in una delle sue gaffe proverbiali, gliele offre in dono, il re le rifiuta orripilato. Benché poche cose lo delizino tanto quanto «le nuove scoperte nell’arte e nella natura» («the new discoveries in art or nature»), il re si dice disposto a perdere metà del suo regno piuttosto che a introdurvi questa strana invenzione di cui Gulliver gli ha appena fornito un dettagliato ragguaglio. La distinzione tra tecnologia «buona» e tecnologia «demonica» non è un motivo nuovo in Swift. Lo ritroveremo nel terzo libro, dove la stupidità umana sarà immortalata in una gloriosa rassegna di tecnologia inutile. Il re gigante, protettore delle arti e delle scienze, promuove la scienza che incrementa la vita, ma condanna quella che, producendo macchine distruttive («the destructive machines»), semina morte. Come nell’isola di Robinson basta un colpo di fucile a evocare l’Europa, così ora il rifiuto opposto dal re al dono di Gulliver cancella di incanto «three and four hundred years» di civiltà occidentale. Ipotizzare un mondo senza armi da fuoco è ipotizzare uno scenario di civiltà alternativo a quello dell’Europa contemporanea: un mondo in cui il re rifiuta di farsi arbitro assoluto della vita e della libertà del suo popolo, prediligendo una ricetta di governo piuttosto «limitata»: «He confined the knowledge of governing within very narrow bounds; to common sense and reason, to justice and lenity, to the speedy determination of civil and criminal causes; with some other obvious topics which are not worth considering» (ivi, p. ). La condanna dell’Europa, che serpeggia per tutto il libro, diviene spietata nell’ultima parte. È vero, la critica si è estesa ormai a tutto il genere umano e tuttavia, poiché (come sa bene Gulliver) la propria cultura è la prigione percettiva da cui si osserva il mondo, è l’uomo europeo quello descritto e denigrato nell’ultimo libro. Quando Gulliver, nel disperato tentativo di riscattare sé e la sua gente dall’umiliante « DARTING FIRE AND SPEAKING THUNDER » accostamento con gli Yahoo, narra all’amico cavallo dei progressi a cui è giunta in Europa la tecnologia balistica, fornendo un rabelaisiano elenco di armi e modi d’usarle – cannoni, colubrine, moschetti, carabine, pistole, palle, polvere, baionette, battaglie, assedi, ritirate, attacchi, mine, contromine, bombardamenti e scontri navali –, il cavallo inorridito gli prega di tacere. Poi aggiunge: «What you have told me upon the subject of war, does indeed discover most admirably the effects of that reason you pretend to» (ivi, p. ). E conclude che il corrompersi della ragione sia cosa assai peggiore della condizione di bruti («when a creature pretending to reason could be capable of such enormities, he dreaded lest the corruption of that faculty might be worse than brutality itself», ivi, p. ). Ritorna amplificato il dubbio di Robinson, se la malvagità degli europei, affinata in arti crudeli, non superi l’amorale violenza dei “bruti”. Ma compare anche un motivo che sarà ripreso da Rousseau e dibattuto per tutto il secolo: quello della forza corruttrice della ragione, che si oppone al motivo augusteo della forza civilizzatrice della ragione. (Si direbbe che in Swift convivano entrambi i motivi: nei cavalli virtuosi rivive il mito primitivistico di una Natura non contaminata dai veleni della Ragione, e tuttavia la loro società razionale, decorosa, algida e disumana incarna alcuni degli ideali più alti della Civiltà della Ragione, purché, ovviamente, il lettore non prenda troppo sul serio neanche i cavalli, capaci di pungere, come tutti gli altri, col pungiglione dell’ottusità e della ferocia.) Come il cavallo apprende inorridito, tra gli effetti «straordinari» della ragione che gli europei pretendono di possedere ci sono non solo le armi da fuoco, ma anche l’avventura coloniale, inconcepibile senza di esse, definita in un celebre passo «pirateria legalizzata», opera di «esecrabili ciurme di macellai» («execrable crews of butchers»), in cui orrendi delitti vengono commessi in tutta libertà («free license given to all acts of inhumanity and lust, the earth reeking with the blood of its inhabitants», ivi, p. ). Tuttavia, come Gulliver sa bene, chi ieri è stato nano oggi può ritrovarsi gigante. Alla fine dell’ultimo libro (ivi, cap. IX) apprendiamo che i mostruosi Yahoo che popolano la terra dei cavalli potrebbero discendere da due Yahoo venuti dal mare. Altri indizi sparsi qua e là insinuano il dubbio che i due Yahoo venuti dal mare fossero inglesi, i quali, trovandosi ad abitare tra creature più virtuose di loro, cominciarono a essere disprezzati e sprofondarono a poco a poco nella condizione di bruti. Le miserevoli condizioni dei loro discendenti, costretti a far da servitori ai cavalli, potrebbero dunque rappresentare la punizione ideale per il massacro coloniale. Sembra quasi la storia di Robinson alla rovescia. Neanche Gulliver, con la sua aria urbana e cerimoniosa, riesce a far cambiare idea al cavallo sulla “civile” Europa. Sotto il gilet di seta, anche lui è uno Yahoo, e persino più esecrabile degli Yahoo, perché se gli Yahoo sono bruti e amorali, lui e i suoi connazionali sono esseri immorali, che usano il loro «minuzzolo di ragione» per costruire macchine che seminano morte. In un saggio di qualche anno fa, Claude Rawson ammoniva a non tirare la giacchetta di Swift né da un lato né dall’altro: a non farne né lo xenofobo-misantropomisogino di alcune letture critiche «indignate» («the indignant diatribes of self-righteous postcolonial censors»), né il benevolo difensore di giuste cause (democrazia, denunzia della schiavitù, anticolonialismo) «refashioned» dalle anime belle dell’era dei Ph. D. Swift non è né l’una né l’altra cosa; o piuttosto è l’una e l’altra cosa insieme (Rawson, , p. ). Mi pare tuttavia che insieme al veleno, che Rawson ammonisce a non diluire (e che di fatto secoli di letture “liberali” non sono riuscite a dilui- SIMONA CORSO re), i Travels continuino a distillare alcuni succhi salutari: la condanna della guerra, espressa spesso sotto forma di condanna dell’arma da fuoco; il monito a non scambiare il proprio punto di vista con la misura delle cose; oltre al grande insegnamento, tipico della satira, che le situazioni sono sempre reversibili, anche quelle di sopraffazione: chi ieri ha ridotto a bestie uomini di altre terre, domani potrebbe fare da bestia da tiro ai cavalli. Nelle Lettres Persanes di Montesquieu riaffiora il dibattito sul valore ambiguo della tecnologia, portatrice ora di progresso ora di decadenza. Alcuni persiani attraversano l’Europa e ne passano al setaccio costumi e istituzioni. Usbek, uno di loro, rinuncia progressivamente all’iranocentrismo e diviene un estimatore dell’Europa, almeno quella politica. Ma Rhedi, suo corrispondente, gli ricorda che l’Occidente non è solo libertà e gaiezza, ma anche violenza, massacri, guerre. Prima di Rousseau, Rhedi parla degli effetti negativi del sapere tecnologico occidentale e insinua che il progresso delle scienze e delle arti abbia finito col provocare la decadenza dell’Occidente. «Depuis l’invention de la poudre», dice, «il n’y a plus de places imprenables; c’est-à-dire, Usbek, qu’il n’y a plus d’asile sur la terre contre l’injustice et la violence» (Montesquieu, , p. ). L’Europa di cui parla Rhedi non è la terra della libertà e della legge descritta da Usbek, ma la patria di un’ambigua tecnologia che moltiplica le guerre e favorisce i massacri di intere popolazioni. Il suo Oriente, di contro, non è il regno del dispotismo e della paura più volte descritto da Usbek, ma un mondo sognante, arcaico e semplice. La provocazione di Rhedi suscita la reazione di Usbek che in una lettera appassionata difende l’Occidente anche nel suo simbolo più oscuro, le bombe. La polvere da sparo, argomenta Usbek, rende le guerre non più sanguinose, ma più brevi. Come ogni cosa, anche le armi vanno considerate all’interno del sistema politico di cui fanno parte: l’arma da fuoco in sé non è né bene né male; è l’uso che se ne fa a essere buono o cattivo, e l’uso dipende dalla volontà politica che muove l’arma. È meno temibile un sovrano illuminato dotato di armi da fuoco, che un sovrano dispotico con una frusta in mano. L’argomento di Usbek ricorda la distinzione che Hannah Arendt (, pp. -) traccia tra violenza e potere, col noto corollario della superiorità del potere sulla violenza. I più crudeli mezzi di coercizione, scrive Arendt, sarebbero inefficaci senza un sistema di potere che li sostiene. Persino il totalitarismo, il cui principale strumento di dominio è la tortura, ha bisogno di una base di potere: la polizia segreta e la rete di informatori. In modo analogo, ciò che consentì ai proprietari di schiavi di dominare sugli schiavi, di gran lunga più numerosi di loro, non furono i mezzi di coercizione, quanto piuttosto il sistema di potere, cioè, in primo luogo, la ferrea solidarietà tra proprietari. È il potere – sembra dire Usbek – a calibrare la violenza e non la violenza a guidare il potere. In Europa il limite alla tecnologia balistica è, ancora una volta, il diritto. La paura di Rhedi, che la tecnologia generi «quelque manière de destruction plus cruelle que celle qui est en usage» (Montesquieu, , p. ), Usbek la ritiene infondata: «Si une si fatale invention venait à se découvrir, elle serait bientôt prohibée par le droit des gens; et le consentment unanime des nations ensevelirait cette découverte» (ibid.). Con più di due secoli d’anticipo Usbek e Rhedi fissano i termini del dibattito nucleare. Un’arma altamente distruttiva, dice Usbek, che distruggerebbe anche chi « DARTING FIRE AND SPEAKING THUNDER » la usa, smette di essere un’arma e diviene un deterrente. Poiché l’istinto di conservarsi è più forte di quello di distruggere, una simile invenzione sarebbe “seppellita” dal consenso unanime delle nazioni. A patto, però – obietta Rhedi –, di essere tra le nazioni a cui è consentito di esprimere il consenso. Se il disarmo nucleare di questi ultimi decenni sembra dare ragione a Usbek, l’orrore di Hiroshima e Nagasaki dimostra che la paura di Rhedi non era affatto infondata. Alcuni anni fa lo storico John Keegan esprimeva l’ipotesi (e la speranza) che dopo cinquemila anni di guerre documentate potessero essere in atto cambiamenti culturali e materiali che inibirebbero la tendenza dell’uomo a impugnare le armi. Il cambiamento materiale salta agli occhi: è l’emergenza delle armi termonucleari e del loro sistema di lancio con missili balistici intercontinentali. Tuttavia, aggiungeva lo storico con un certo sconforto, i cinquanta milioni di individui morti in guerra dopo il agosto sono stati uccisi non da armi nucleari ma da «armi a poco prezzo» (Keegan, , p. ). L’aereo che sfonda il grattacielo dimostra che la «destruction cruelle» paventata da Rhedi può venire da qualsiasi oggetto e che, come obiettava Usbek, ancora più temibile della tecnologia è la volontà umana di distruggere. Il cartesiano Usbek riteneva che le armi altamente distruttive sarebbero state seppellite prima ancora d’essere usate e che i fucili («le armi a poco prezzo» nelle parole di Keegan) non avrebbero ucciso più di quanto non avrebbero fatto le armi bianche, perché in ultima analisi a uccidere non è tanto l’arma quanto la mano che la muove. La storia, o la follia umana, ha provato false entrambe le ipotesi. La tecnologia della polvere da sparo ha moltiplicato le guerre e dilatato la morte. Neppure i più tenaci avversari dell’idea che la tecnologia determini le forme sociali dei popoli potrebbero negare che lancia, mazza e arco limitano i danni che gli esseri umani possono infliggere gli uni agli altri, soprattutto perché limitano la distanza dalla quale possono essere inflitti. Inoltre, come Swift aveva intuito, l’arma da fuoco ha modificato per sempre la psicologia del soldato. In Francia a Swift sembra far eco Voltaire: se Montesquieu ritiene che tutte le armi si equivalgano giacché sono semplici strumenti della volontà che le muove, Voltaire, si direbbe, vede più lontano. Candide è uno dei primi soldati spaesati e inebetiti che nei secoli seguenti popoleranno la letteratura europea. Attraverso la sua allucinata partecipazione alla guerra, scopriamo che, a differenza di quanto riteneva Usbek, non sempre è l’uomo a manovrare la pistola, ma spesso è la pistola a manovrare l’uomo. Ci sono strumenti che finiscono col dominare colui che dovrebbe semplicemente “usarli”. Scriverà Hannah Arendt nel : I progressi compiuti dalla scienza non hanno nulla a che vedere con l’“io voglio”; essi seguono le proprie leggi inesorabili, che ci costringono a fare tutto ciò che siamo in grado di fare, senza considerare le conseguenze. Che l’“io voglio e io posso” debbano disunirsi? Aveva forse ragione Valéry quando affermò cinquant’anni fa: «Si può dire che tutto ciò che sappiamo, vale a dire tutto ciò che siamo in grado di fare, ha finito per volgersi contro ciò che noi siamo?» (Arendt, , pp. -). Come Voltaire intuisce prima di Valéry, l’arma da fuoco spossessa il soldato del coraggio ferino, ma ancora remotamente umano, richiesto al guerriero armato di lancia e ne fa l’azionatore semicosciente del proprio moschetto. Arruolato senza ren- SIMONA CORSO dersene conto, Candide si ritrova nel bel mezzo di una sanguinosa battaglia. Col tipico gusto per l’elenco in crescendo, Voltaire descrive il campo come si presenta agli occhi di Candide: uomini ustionati, vecchi crivellati, donne sgozzate coi bambini appesi alle mammelle sanguinanti; pezzi di cervello, braccia, gambe. Non sappiamo perché un esercito faccia guerra all’altro. Le cause lontane sono assenti, forse inesistenti. Sul campo di battaglia resta il solo fatto della guerra in tutta la sua insensatezza: piombo, fuoco e corpi fatti a pezzi. Delle cause della guerra resta solo una buffa perifrasi tratta dalla metafisica: la baionetta è «la raison suffisante» della morte di qualche migliaio di uomini, la moschetteria della scomparsa di altri diecimila, l’artiglieria della distruzione di seimila uomini per parte. Come in un sogno meccanico Candide vede sfilare migliaia di armi che sparano e uccidono: gli uomini sembrano spariti e Candide si ricorda che ci sono loro dietro questa danza infernale solo quando fuggendo inciampa sui cadaveri. La guerra diventa un balletto di armi impazzite, un’azione così folle che agli occhi di Candide sembra destituita dei suoi agenti (Voltaire, , pp. -). Sentiamo l’eco di Gulliver, che all’Europa dilaniata dalle guerre preferisce un regno di stalle, o di Rhedi, preoccupato che il celebrato progresso delle scienze non sia altro che il progresso della morte. Certo, la guerra non si fa solo in Occidente, ma le guerre meccaniche, dove migliaia di baionette uccidono milioni di uomini, sembrano alla metà del Settecento l’oscena gloria dell’Europa. Dalla storia della vecchia con una sola natica Candide apprende che in Marocco si combatte con furore pari, se non superiore, a quello con cui si combatte in Europa (ivi, cap. XI); ma il lettore apprende anche, con un brivido d’orrore, che a rifornire il Marocco di armi è una potenza cristiana (ivi, cap. XII). Benché nel Candide la denuncia investa tutti (prussiani, francesi, portoghesi, turchi, marocchini, brasiliani), sembra tuttavia che il grande imputato sia l’Europa, per almeno due ragioni: per la ragione banale che l’Europa offre già abbastanza motivi per indignarsi, senza che sia necessario cercarli altrove; e per la ragione meno banale che, poiché in alcune parti d’Europa è possibile parlare contro la violenza e l’intolleranza senza correre il rischio di venire uccisi, è più delittuoso tacere. Come ha scritto Starobinski (, p. ), Candide è sia un’antologia delle atrocità del tempo che il primo esempio di un atteggiamento diventato oggi tipico in Occidente: la tendenza a informarsi su tutte le piaghe dell’umanità e a soffrirne. Nei pressi della città di Surinam, Candide incontra uno schiavo nero senza una gamba e senza un braccio. Gliene chiede il motivo e l’uomo risponde: «Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on ne coupe la jambe: je me suis trouvé dans le deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe» (Voltaire, , p. ). Il signor Vanderderdur che ha tagliato la gamba al povero nero è europeo; ma è europeo anche Candide, che indignato lo racconta al mondo. Nell’Europa fatta a pezzi dalla baionette esiste una voce in grado di sovrastare il sibilo dei proiettili: l’opinione pubblica, ultimo salvagente della moralità, come insegnava Locke, in un mondo di gente immorale. A questa Europa dell’opinione pubblica si rivolge Voltaire, quando racconta qual è il prezzo dello zucchero che addolcisce la cioccolata del mattino o quando descrive l’orrore di una campagna di guerra. Gli eventi degli ultimi anni rivelano purtroppo che la cultura della guerra è viva e vegeta. Dipenderà da noi ridurre lo spazio di quella cultura ed estendere quello dell’opinione pubblica. « DARTING FIRE AND SPEAKING THUNDER » Note . La traduzione in italiano dei brani riportati, salvo diversa indicazione, è mia. . «Savages» Robinson definisce, senza troppe cerimonie, tutte le popolazioni indigene che incontra durante i suoi viaggi, dal Marocco ai Caraibi al Madagascar. . Sugli effetti morali della distanza cfr. Ginzburg (, pp. -). . Per The Further Adventures of Robinson Crusoe (il seguito, meno noto, del fortunatissimo romanzo) ho consultato il testo online riprodotto su The Project Gutenberg-Online Book Catalog, tratto dall’edizione Seeley, Sevice & Co del a cura di David Price. Le citazioni in inglese sono tratte da questa edizione, che riporta l’articolazione in capitoli. Poiché, trattandosi di un testo online, è impossibile fornire il numero di pagina, per le citazioni da questo testo mi limiterò a fornire il numero del capitolo. L’unica edizione cartacea che sono riuscita a reperire (Wildeside Press, Doylestown, Pennsylvania, senza data), priva del tutto di apparato critico, sembra riprodurre il testo di Price. La versione italiana di Antonio Meo e Giuseppe Sertoli (Defoe, ) si rifà invece alla Shakespeare Head Edition dei Novels and Selected Writings of Daniel Defoe, Blackwell, Oxford . I due testi differiscono in alcuni punti, come si dirà più avanti. . Così li definisce Hulme (, pp. ss.). . Quest’ultima citazione è tratta dalla versione italiana (Defoe, , pp. -). Evidentemente il testo di riferimento (Shakespeare Head Edition, Blackwell ) differisce dall’edizione di Price del , in cui tale passo non compare. . Anche questo passo, citato dall’edizione italiana (Defoe, , p. ), non si trova (perché censurato?) nell’edizione del . . In Oroonoko () di Aphra Behn troviamo già una brillante esemplificazione di tutto ciò: nelle piantagioni del Surinam, scrive Behn, i proprietari di schiavi non usano fucili, dal momento che in quelle terre, a causa del clima, il ferro si arrugginisce in fretta; per soggiogare i Negroes si servono piuttosto di una rete di alleanze. Usano, tuttavia, le armi come simboli di potere, o di intimidazione, e di tanto in tanto esibiscono i fucili arrugginiti per pura scena: «They had rusty useless guns for show» (Behn, , p. ). Bibliografia (), Sulla violenza, trad. it., Mondadori, Milano (ed. or. ). (), Oroonoko or The Royal Slave. A True Story (ed. or. ), in Id., Oroonoko, The Rover and Other Works, edited by J. Todd, Penguin Books, Harmondsworth. CORSO S. (), Automi, termometri, fucili. L’immaginario della macchina nel romanzo inglese e francese del Settecento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma. DEFOE D. (), The Further Adventures of Robinson Crusoe, edited by D. Price, Seeley, Sevice & Co. ( a ed. ) (reperibile online nel catalogo di The Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org). ID. (), Robinson Crusoe, edited by M. Shinagel, W. W. Norton & Co., New York and London (a ed. ). ID. (), “Le avventure di Robinson Crusoe”, seguite da “Le ulteriori avventure” e “Serie riflessioni”, traduzione di G. Sertoli, Einaudi, Torino. DIAMOND J. (), Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies, W. W. Norton & Co., New York and London. GINZBURG C. (), Uccidere un mandarino cinese. Le implicazioni morali della distanza, in Id., Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza, Feltrinelli, Milano. HALL A. R. (), Tecnologia militare, in Ch. Singer et al., Storia della tecnologia, trad. it., Bollati Boringhieri, Torino, vol. III, t. . HILL C. (), Robinson Crusoe, in “History Workshop”, , pp. -. HULME P. (), Colonial Encounters. Europe and the Native Caribbean -, Routledge, London and New York. ARENDT H. BEHN A. SIMONA CORSO (), La grande storia della guerra. Dalla preistoria ai nostri giorni, trad. it., Mondadori, Milano. MONTESQUIEU CH. (), Lettres Persanes, édité par P. Vernière, Garnier, Paris (a ed. ). RAWSON C. (), God, Gulliver, and Genocide. Barbarism and the European Imagination, -, Oxford University Press, Oxford. STAROBINSKI J. (), Il rimedio nel male. Critica e legittimazione dell’artificio nell’età dei lumi, trad. it., Einaudi, Torino. SWIFT J. (), Gulliver’s Travels, in “Gulliver’s Travels” and other Writings by Jonathan Swift, edited by M. Kosh Starkman, Bantam Books, New York (a ed. ). VOLTAIRE (), Candide ou l’optimisme, in Id., Candide et autres contes, édité par F. Deloffre, J. Van den Heuvel, Gallimard, Paris (a ed. ). KEEGAN J. MAMFURIO E OLOFERNE di Masolino D’Amico Nel suo classico studio su Pene d’amor perdute, Frances A. Yates () propose una soluzione per almeno alcuni dei misteri di questa commedia, così limpida in superficie ma anche così piena di allusioni oggi difficilmente decifrabili, in quanto dirette a un pubblico di iniziati. La trama – quasi l’unica in tutta la produzione di Shakespeare alla quale non sono stati trovati degli antecedenti in qualche lavoro di altri – si riassume in poche righe. Un giovane re di Navarra convince tre fedeli cortigiani suoi coetanei a ritirarsi con lui per un periodo di meditazione che durerà tre anni, durante il quale ciascuno si impegna a non frequentare esponenti dell’altro sesso. Subito dopo però piomba nel buen retiro del quartetto una regina di Francia, in importante visita diplomatica. Il re è costretto ad accoglierla, e i suoi compagni a fare lo stesso con le tre dame che la accompagnano: inutile dire che i voti sono presto dimenticati e che ciascuno dei quattro non solo si innamora di una diversa sopraggiunta, ma le fa la corte, sia pure cercando di agire all’insaputa degli altri. Ci sono piccoli equivoci e contrattempi, e una trama secondaria in cui dei personaggi pieni di prosopopea – uno spagnolo spaccone, un curato di campagna, un maestro di scuola, un gendarme – offrono con le loro goffe affettazioni di cultura una versione grottesca della raffinatezza accademica dei cortigiani, mentre dei villici amoreggiano con una concretezza ignota ai loro superiori. Ridotta così all’osso, la vicenda è semplicissima e in grado di arrivare anche dove non ci aspetteremmo; di recente, per esempio, l’avventurosa regista anglofrancese Corinne Jaber ha raccontato di essere riuscita ad allestirla nientemeno che a Kabul, con attori afghani tutti rigorosamente maschi e completamente digiuni di Shakespeare. Dopo avere scartato molti altri lavori del Bardo che si erano sentiti proporre, quegli interpreti musulmani, del tutto estranei alle tradizioni e alle convenzioni teatrali dell’Occidente, avevano trovato qui parecchi motivi con cui identificarsi: separazione dei sessi, aspirazione dei maschi alla purezza, corteggiamento romantico a forza di poesie… D’altro canto, si diceva, il lavoro pullula di interrogativi insoluti, a partire dalla sua stessa data di composizione, certamente anteriore al ma, si direbbe, non così antica come si congetturò in passato, quando qualcuno la assegnava addirittura al , ossia a uno Shakespeare esordiente o quasi. Oggi si tende a collocarla piuttosto intorno al , avvicinandola dunque a pièces come Sogno di una notte di mezza estate e Romeo e Giulietta, rispetto alle quali Pene d’amor perdute dovette godere di minore successo, anche se spettatori raffinati avrebbero continuato a coltivarla: fu rappresentata davanti alla Regina nel o nel , e nel il conte di Southampton, antico protettore di Shakespeare nonché, forse, dedicatario dei Sonetti, la scelse per intrattenere Giacomo I invitato a casa sua dopo che il sovrano lo aveva fatto liberare dal confino nella Torre dove Elisabetta lo aveva fatto rinchiu- MASOLINO D ’ AMICO dere per la parte avuta nella ribellione del conte di Essex. E proprio Essex e Southampton figurano nella complessa e affascinante spiegazione proposta dalla Yates. Nel suo saggio ormai lontano nel tempo, la grande esperta di occultismo rinascimentale muove da un passo controverso del testo, in cui sembrerebbe alludersi a una cosiddetta School of Night (scuola della notte), per costruire una tesi secondo cui attraverso le pretese accademiche del Re di Navarra la commedia vorrebbe canzonare una precisa cerchia esoterica di intellettuali fiorita intorno all’ex favorito della Regina Sir Walter Ralegh. Di questa cerchia o scuola segreta – “scuola di ateismo”, come si mormorò – facevano parte tra gli altri il poeta e drammaturgo George Chapman, talvolta indicato come il poeta-rivale dello Shakespeare dei Sonetti e autore di un poema intitolato Shadow of Night; il letterato Gabriel Harvey; l’erudito e traduttore John Florio. Sir Walter Ralegh cadde in disgrazia nel e finì nella Torre, reo di avere sposato una dama della Regina senza chiedere l’augusta approvazione, e circa due anni dopo il gruppo di dotti che egli aveva animato fu messo sotto inchiesta. Tra le affettazioni di questa School of Night, un po’ ispirata alle accademiche neoplatoniche fiorite in Italia, c’era quella di privilegiare la sapienza sulla galanteria. L’affermazione che le donne vanno subordinate allo studio campeggia, per esempio, in un saggio scoperto dalla Yates e scritto dal conte di Northumberland. Costui, che è nominato da Chapman nella dedica di Shadow of Night, era amico di Ralegh e marito dal – attenzione – di Dorothy Devereux. Dorothy era sorella sia del conte di Essex sia di Penelope, alias Lady Rich, celebrata a suo tempo come Stella nei sonetti di Sir Philip Sidney: la quale Stella o Penelope, così come sua sorella era stata umiliata (si fa per dire) dal poco cavalleresco Northumberland, suo consorte dal , aveva dovuto subire un’analoga censura da parte di un postulante del suo principale corteggiatore, leggi un certo Giordano Bruno, erudito italiano dai trascorsi religiosi. Questi aveva dedicato vari anni prima, nel -, a Sir Philip (il quale, si ricordi, sarebbe morto giovane, in battaglia, nel ) alcuni libri nella propria lingua tra cui uno intitolato De gli eroici furori, nel quale si condanna l’amore romantico e in particolare la prassi di comporre sonetti, in favore del perseguimento di una forma di cultura più alta. È vero che nella conclusione questo Giordano Bruno aveva tentato di fare un po’ di marcia indietro, affermando che le donne inglesi fanno eccezione in quanto creature celesti e persino “stelle”. Ma qualche anno dopo la partenza del Bruno dall’Inghilterra, il suo amico e quasi compatriota (inglese di padre italiano) John Florio aveva rinnovato l’attacco contro le donne nei dialoghi usciti come Second Fruits (). Pene d’amor perdute sarebbe dunque la risposta, ovviamente giocosa e in chiave, contro questi peccati di lesa sovranità delle dame, promossa dal clan Essex-Southampton-eredi di Sir Philip Sidney. Fondata com’è in gran parte su congetture, la teoria della Yates non è accettata, oggi, dalla maggior parte degli eruditi, né è questa la sede per discuterla. Fu nella sua formulazione, tuttavia, che emerse per la prima volta nella vasta opera della studiosa, e proprio in un rapporto sia pure alla lontana con Shakespeare, quella figura di Giordano Bruno al quale ella avrebbe in seguito dedicato ricerche molto approfondite e originali, neanch’esse sempre approdanti a tesi che gli altri esperti abbiano accolto senza riserve. Ovviamente anche altri, prima e dopo la Yates, si sono sforzati a loro volta di spiegare gli enigmi di Pene d’amor perdute. Tra questi c’è chi pur non avendo una teoria generale per l’interpretazione di tutta la commedia cerca spesso di decifrare almeno alcune allusioni. In particolare, molti hanno avanzato l’ipotesi che i caratteri più ridicoli, vale a dire il quartetto di buffi individui che MAMFURIO E OLOFERNE agiscono nella trama secondaria, fossero caricature di persone esistenti davvero. Di Don Armado, il magniloquente spaccamontagne spagnolesco, qualcuno ha persino argomentato che avrebbe dovuto far pensare allo stesso Sir Walter Ralegh, solo perché costui aveva un forte accento dell’Ovest dell’Inghilterra, e a quanto pare pronunciava, non diversamente da Don Armado, la parola sirrah (appellativo con cui ci si rivolge a un inferiore) come se fosse scritta chirrah. Altri candidati a simili indagini sono stati il maestro di scuola Oloferne, il curato Nataniele e il gendarme Dull (Intronato, nella versione di Nemi D’Agostino). Qui vorrei occuparmi del maestro Oloferne, che nella commedia arriva tardi, solo al quart’atto, ma la cui presenza è incisiva. Il suo imponente nome biblico Shakespeare lo derivò con ogni probabilità dal Gargantua di Rabelais (), dove l’insegnante di latino del protagonista, definito «grand docteur sophiste», si chiama Maistre Thubal Holoferne (e Tubal si chiamerà un altro personaggio shakespeariano, l’ebreo amico di Shylock nel Mercante di Venezia). Nel William Warburton, curatore di un’edizione di Shakespeare peraltro non troppo autorevole, dichiarò senza esitazione (e senza prove) che Oloferne era certamente una caricatura di John Florio. Tra le altre candidature emerse in seguito e sostenute da altri ci furono quella del poeta Chapman; del matematico Thomas Harriot (altro adepto della “scuola di ateismo” di Ralegh, poetastro a tempo perso, ed ex maestro di scuola); di un innominato maestro di scuola di Shakespeare stesso. Per nessuna esistono prove convincenti, a parte il fatto che tutti i candidati furono dei letterati e degli eruditi, presumibilmente propensi a citare i classici, più o meno a proposito, e a sciacquarsi la bocca con vocaboli rari. Queste ipotesi più o meno fantasiose si scontrano però con le parole di saggezza che si trovano in quella che è rimasta a tutt’oggi la migliore analisi dei personaggi comici di Pene d’amor perdute, vale a dire uno studio pubblicato nel lontano , autore tale Oscar James Campbell. A proposito del nostro Oloferne, costui scrive (traduco): Queste teorie […] oltre a essere impossibili da dimostrare, ignorano l’esistenza di una delle più diffuse e popolari convenzioni del palcoscenico italiano del tempo – quella del pedante. Il modello di questo personaggio era una figura internazionale, prodotto della cultura del Rinascimento. Con l’avvento della nuova scienza i metodi intellettuali degli scolastici o dei filosofi della scuola medioevale diventarono naturalmente oggetto di ridicolo. Questo tipo di studioso finì per apparire come un’assurda combinazione del logico intransigente e del retore formale. Nel teatro fu fatto argomentare secondo tutte le forme del sillogismo – concedendo il maggiore e negando il minore. […] Più tardi le esagerazioni dello stesso umanista diventarono oggetto di satira – la sua saggezza sicura e superiore, che tuttavia lo rendeva inerme davanti a qualsiasi situazione difficile, e la sua lingua variopinta, mezzo italiana e mezzo latina. Costui ha una inclinazione speciale per sfoggiare la propria erudizione negli scambi con persone di classe inferiore, tra le quali suscita equivoci che lo riempiono di furore. Di solito si innamora, e in questa condizione le sue insaziabili citazioni di massime latine e di antecedenti classici lo rendono particolarmente ridicolo. Viene sempre ingannato e fuorviato, ma cerca di trarre consolazione dal suo sapere. Pensa ai grandi uomini del passato che sono stati perseguitati dalla sventura e spera che questo pensiero gli porti l’equanimità. Ogni tanto si fa di lui un filosofo a parole e un ipocrita licenzioso nei fatti. Come tale viene scoperto e scacciato (Campbell, , pp. -). Secondo il Campbell, dunque, Don Armado e gli altri, e segnatamente come si è visto Oloferne, lungi dall’essere stati ispirati da personaggi esistiti, sono in realtà tipi fissi o MASOLINO D ’ AMICO maschere che vengono dalla Commedia dell’Arte italiana. Don Armado è la riproposta rinascimentale del Miles Gloriosus plautino, dotato ora di tratti iberici data la familiarità del Bel Paese con milizie di quella provenienza: elemento indispensabile nel repertorio di parecchie compagnie e particolarmente evidente in quella dei Gelosi, il cui capocomico G. B. Andreini, che lo interpretava, gli diede il nome di Capitan Spavento di Valle Inferno. Poco meno frequente fu la maschera del pedante, ovvero pedagogo, ciarlatano, spesso definito “il Dottore” e di solito battezzato Graziano. L’attore dei Gelosi specializzato in questo tipo fisso – latino maccheronico, etimologie assurde, citazioni sciocche, pronunce grottesche di parole, passione per i sinonimi – si chiamava Ludovico Bianchi. Così definisce il Pedante, o Dottore, Luigi Rasi nel suo fondamentale studio I comici italiani. Biografie, bibliografia, iconografia: Il Dottore è sempre il solito ignorantone, saccentone, che sputa sentenze, con mescolanza inevitabile di latino maccheronico, di citazioni spropositate, di etimologie bislacche… Segno evidente che il tipo vero del Graziano ebbe al cospetto del pubblico per base unica la saccenteria ignorante, la etimologia insulsa, la storpiatura grottesca di vocaboli, la buffoneria delle citazioni latine (Rasi, , vol. I, p. ). Sono tratti indubbiamente applicabili all’Oloferne di Shakespeare, ma a questo punto ci si domanderà dove e quando il Bardo abbia avuto contatti con i comici italiani. Questi come è noto visitavano spesso la Francia – Andreini, con i Gelosi, fu a Parigi nel , , , e - – ma le loro spedizioni in Inghilterra, seppure certamente avvennero, sono meno documentate. L’unico elemento riconducibile alla troupe dei Gelosi che risulta abbia visitato Londra, per esempio, è Donato Martinelli, fratello di Tristano che era l’Arlecchino di Andreini, e questo avvenne negli anni . Tuttavia è del , ossia in epoca shakespeariana, un attacco del libellista Thomas Nashe, autore di Pierce Pennilesse, contro i players beyond the sea (attori d’oltremare), i quali sarebbero «una sorta di comici strabuzzatori di occhi e sboccati, che fanno recitare le parti femminili a delle puttane – e non si tirano indietro davanti a nessuna battuta immodesta o azione poco casta che possa suscitare il riso». Li vide, Shakespeare? Probabilmente, sì; in ogni caso, sapeva certo di loro. Usa ben tre volte il termine Pantalone per definire un vecchio risecchito, in Come vi piace (II, vii, ), in Otello (I, ii, ) e nella Bisbetica domata (III, i, ), dove sono presenti anche vari pedanti, veri e finti. Inoltre potrebbe avere letto Gl’Ingannati (), dove c’è un Piero buffo tutore di Fabrizio; la pièce fu tradotta in latino come Laelia e allestita dagli studenti del Queen’s College di Cambridge nel e poi nel , e la si è indicata come una fonte della Dodicesima notte. Infine, un Pedante corteggia una servetta in un latino incomprensibile, nella commedia pre-shakespeariana anonima The Two Italian Gentlemen. Non risulta che faccia parte delle fonti sicure cui Shakespeare può avere attinto o, meglio, che gli abbiano consegnato una maschera riconoscibile come quella di Oloferne in Pene d’amor perdute, Il Candelaio di Giordano Bruno, che è forse il più famoso e illustre testo italiano cinquecentesco (letterario, perché non risulta sia stato rappresentato) in cui campeggi un Pedante ridicolo. Ma leggendo Il Candelaio accanto a Pene d’amor perdute, la tentazione di pensare che il Bardo lo abbia avuto per le mani è quasi irresistibile. Per scrupolo, prima di compiere questa operazione ci porremo due domande. Le prima è: poteva avere accesso Shakespeare a una copia del lavoro? E la risposta è sì, poteva. Il Candelaio era stato MAMFURIO E OLOFERNE scritto e pubblicato a Parigi nel , e se anche il volume non fosse arrivato in Inghilterra per conto suo, può ben darsi che l’autore ne portasse seco una o più copie quando si trasferì a Londra nel per un lungo soggiorno, come ospite dell’ambasciatore francese. Bruno lasciò definitivamente le Isole Britanniche l’anno dopo, ben prima di quando presumibilmente Shakespeare arrivò a Londra, ma quando questo avvenne o poco dopo, nei primi anni , è quasi certo che il giovanotto di Stratford ebbe contatti con personaggi che a Bruno erano stati vicini, come il surricordato John Florio, della cui traduzione di Montaigne come ben si sa si abbeverò assai (e che forse è citato in Pene d’amor perdute in un detto italiano pronunciato da Oloferne e presente in Second Fruits: «Venetia, Venetia, Chi non ti vede, non ti pretia»). Seconda domanda: era in grado Shakespeare di leggere l’italiano di Giordano Bruno? Anche qui la risposta è affermativa. Nel senso che pur non essendo mai stato dimostrato che Shakespeare sapesse davvero l’italiano (così come non sapeva davvero né il latino né il greco, almeno secondo Ben Jonson), qualsiasi uomo colto del suo tempo un po’ di italiano lo masticava, o almeno aveva chi lo masticava per lui. Come fece, in seguito, Shakespeare a leggere la novella di Giovambattista Giraldi Cinthio dalla quale ricavò Otello? E non è significativo che proprio a Londra, durante il suo soggiorno, Giordano Bruno abbia pubblicato e in gran parte dedicate a Sir Philip Sidney ben sei opere in italiano, come dire quasi la totalità della sua produzione in questa lingua? Non sapremo mai se il Mamfurio di Giordano Bruno abbia direttamente ispirato l’Oloferne di Shakespeare, ma è indubbio che i due “siano” lo stesso personaggio, ovvero la stessa maschera, e che dunque risalgano a quel comune archetipo che gli studiosi succitati hanno descritto. Mettiamoli per un momento l’uno accanto all’altro. Entrambi sono ossessionati dalla lingua. Ecco alcune etimologie di Mamfurio: Ma chi è questa che con quel calato in brachiis [cesto sulle braccia] me si fa obvia? È una muliercula, quod est per ethimologiam sexo molle, mobile, fragile e incostante, al contrario di Ercole. O bella etimologia! È di mio proprio Marte or ora deprompta [emessa] (Il Candelaio, I, v). GIO. BERNARDO: …Vorrei saper da voi che vuol dir: pedante. MAMFURIO: Lucentissime voglio dirvelo, insegnarvelo, declamarvelo, esporvelo, propalarvelo, palam farvelo, insinuarvelo, et – particula coniunctiva in ultima dictione apposita – enuclearvelo; sicut, ut, velut, veluti, quemadmodum nucem ovidianam meis coram discipulis, – quo melius nucleum eius edere possint, – enucleavi. Pedante vuol dire quasi pede ante: utpote quia ave lo incesso prosequitivo, col quale fa andare avanti gli erudiendi puberi; vel per strictiorem arctioremque aethymologiam: P e, perfectos, – D a n, dans, – T e, thesauros. – Or che dite de l’ambedue? (Il Candelaio, III, vii). E questo è Oloferne: HOLOFERNES: The deer was, as you know, sanguis, in blood; ripe as the pomewater, who now hangeth like a jewel in the ear of coelo, the sky, the welkin, the heaven; and anon falleth like a crab on the face of terra, the soil, the land, the earth. NATHANIEL: Master Holophernes, the epithets are sweetly varied, like a scholar at the least: but, sir, I assure ye, it was a buck of the first head. HOLOFERNES: Sir Nathaniel, haud credo. DULL: ’Twas not a haud credo, ’twas a pricket (Love’s Labour Lost, IV, ii) . MASOLINO D ’ AMICO Sia Mamfurio sia Oloferne adoperano termini latini che spiazzano i loro interlocutori, il che costa caro a Mamfurio, il quale, derubato, si ostina a chiedere aiuto in un latino con parole che nessuno capisce, ovvero che i mariuoli da cui è circondato fingono di non capire. In Pene d’amor perdute il Pedante non ha molto da fare, è una figura di contorno, sia pure gustosa, e il ludibrio al quale viene esposto quando i cortigiani ridono della pantomima che ha offerto coi suoi compagni è bonario, tanto che probabilmente lui non se ne rende nemmeno conto. Mamfurio nel Candelaio occupa invece un buon terzo della vicenda, anche se si mantiene totalmente passivo, limitandosi a sproloquiare con molto sussiego, senza registrare gli sberleffi della canaglia; alla fine però il suo creatore, come volendo colpire attraverso lui tutta una genia che disprezza, lo fa punire crudelmente, permettendo che i farabutti lo spoglino prima del suo denaro, poi dei suoi abiti e, infine, lo bastonino sulle terga e sulle mani. Oltre ad avere tante caratteristiche in comune, in un paio di occasioni Mamfurio e Oloferne agiscono nello stesso modo. Entrambi si occupano di epistole amorose: Mamfurio ne ha scritta una a beneficio del Candelaio infoiato, mentre Oloferne esamina con perizia quella in versi inviata da Berowne a Katharine, ma recapitata per errore alla contadinella Jaquenetta. Inoltre, sia Mamfurio sia Oloferne si esibiscono in una composizione poetica di dubbio valore e di stile antiquato, il primo in una imitazione di Ovidio in metro zoppicante e rime abbastanza astruse, il secondo in versi allitterativi, passati di moda da mezzo secolo. Nessuno dei due ha tuttavia il minimo dubbio sulla propria eccellenza. MAMFURIO: Che vi par di questi versi? Che ne comprendete con di vostro ingegno il metro? OTTAVIANO: Certo, per esser cosa d’uno della profession vostra, non sono senza bella considerazione. MAMFURIO: Sine conditione et absolute denno esser giudicati di profonda perscrutazion degni questi frutti raccolti dalle meglior piante che mai producesse l’eliconio monte, irrigate ancor dal parnassio fonte, temprate dal biondo Apolline, e dalle sacrate Muse coltivato. E che ti par di questo bel discorso? Non vi admirate adesso come pria già? (Il Candelaio, II, i). HOLOFERNES: This is a gift that I have, simple, simple; a foolish extravagant spirit, full of forms, figures, shapes, objects, ideas, apprehensions, motions, revolutions: these are begot in the ventricle of memory, nourished in the womb of pia mater, and delivered upon the mellowing of occasion. But the gift is good in those in whom it is acute, and I am thankful for it (Love’s Labour Lost, IV, ii). Sia Mamfurio sia Oloferne, infine, sono dominati – a questo si è già accennato – da una insana passione per la lingua: si beano, ripetiamolo ancora una volta, di citazioni, elenchi di sinonimi, false etimologie, parole rare, commenti sulla pronuncia corretta e via dicendo. Queste sono le caratteristiche della maschera del Dottore o Pedante. Ma sia in Mamfurio sia in Oloferne il tratto non è solo pretesto di lazzi: è funzionale all’essenza della commedia. Pene d’amor perdute è infatti una commedia “sulla” lingua, una commedia che espone una sua riflessione sulla lingua. Ci sono quattro gruppi di parlanti, il re e i suoi cortigiani, che si esprimono in maniera artificiale, con eleganti ricercatezze; il quartetto dei buffi, capitanato da Don Armado e da Oloferne, che cercando di eccellere in questo stesso campo commette esagerazioni e spropositi; i contadini, che comunicano con rozza MAMFURIO E OLOFERNE efficacia, ma con scarsa finezza; e la regina con le sue dame, che propugnano un modo di esprimersi sincero e cristallino – che si fanno beffe dei tentativi dei loro corteggiatori, e che da ultimo, quando vincono, li condannano a tornare alla schiettezza. Si è discusso se Shakespeare dilungandosi scherzosamente sulle esercitazioni poetiche dei cortigiani (ma alcune delle poesie che compose a loro nome sono così valide, che finirono in antologie dell’epoca) volesse prendere di mira uno stile preciso come il cosiddetto eufuismo del drammaturgo e scrittore John Lyly. Ma sembra più plausibile che lodando la mancanza di artifici volesse solo reagire genericamente contro gli eccessi della retorica barocca, della quale peraltro egli stesso era e sempre più sarebbe diventato un esponente eccelso. Non c’è da meravigliarsi: in ogni epoca gli scrittori hanno teorizzato la semplicità naturale anche quando praticavano il contrario. Nelle due poesie intitolate Jordan, George Herbert (-), forse il più grande, con John Donne, dei poeti barocchi inglesi, esalta proprio quella genuinità che egli non praticava («I pastori sono persone oneste, lasciateli cantare,» dice, «gli indovinelli li faccia pure chi vuole»). Perché questi ideali linguistici vengano applicati sul serio bisogna aspettare la fondazione della Royal Society (), ovvero, per quanto riguarda il nostro marinismo, della romana Accademia dell’Arcadia (). Ma non spingiamoci troppo in là. Tutto questo è solo per dire che in Pene d’amor perdute, dove ogni parlante ha una funzione precisa in quanto esponente di uno stile, Oloferne ha il compito di incarnare gli eccessi e le assurdità ai quali la lingua può essere spinta se maneggiata con esagerata pignoleria e con falsa erudizione. E Il Candelaio? Ebbene, anche Il Candelaio è in non piccola parte una commedia “sulla” lingua. In primo luogo, perché dà inizio al gruppo delle opere, tutte scritte nel giro di pochissimi anni, in cui Giordano Bruno abbandonò il latino per il volgare, allo scopo di rivolgersi a un pubblico se non più ampio (ripetiamolo, i suoi lavori in italiano furono tutti pubblicati e diffusi all’estero), certo più dinamico, più aperto, meno paludato. E in secondo luogo, perché l’italiano di Giordano Bruno è tutt’altro che una lingua accademica. Quando scrive in italiano, Giordano Bruno adopera una lingua vivacissima, liberissima, estrosissima, personalissima, a un tempo dotta e popolaresca; una lingua talvolta oscura, ma piena di invenzioni, lampi, dissonanze; una lingua che sembra volersi beffare dei dotti e della buona educazione. In un contesto dove tutti i personaggi si esprimono con una vivacità e un’energia irresistibile, il pedante Mamfurio ha la funzione del reazionario, dell’oscurantista che cerca di impedire lo sviluppo e il progresso con il suo stupido, miope culto della presunta autorità di scrittori vissuti quindici secoli prima e di una lingua ormai morta e imbalsamata (anche il latino di Giordano Bruno, vale la pena di ricordare, è spregiudicatamente libero e anticlassicista). Sopra ho detto che evidentemente il suo creatore odia questo presuntuoso, intollerante, ottuso, ostinato difensore del passato remoto. Lo odia con tutte le forze, e noi non ce ne meravigliamo. I Mamfuri di questo mondo erano, per un uomo come Giordano Bruno, nemici mortali. E lo dimostrarono. Note . Così propose Bradbrook (). D’altro canto J. A. K. Thompson avanza l’ipotesi che esclamando «chirrah!» Don Armado tenti in realtà un saluto alla greca, «chaire», che si trova tra le formule suggerite da Erasmo in Familiaria Colloquia. MASOLINO D ’ AMICO . Tutte citazioni dal Candelaio di Giordano Bruno sono tratte dall’edizione a cura di I. Guerrini Angrisani, Rizzoli, Milano . . «Il cervo l’era, come saprete, d’ottimo sangue, sanguis, maturo come il pomo di paradiso, che ora pende come un gioiello dall’orecchia del coelum, cielo, firmamento, volta celeste, e tutt’a un tratto ti casca come mela sarvatica sovra la faccia di terra, suolo, terreno, globo terracqueo. DON NATALINO: Davvero, mastro Oloferne, gli epiteti sono squisitamente variati, farina del sacco d’uno studioso per dire il meno; ma signor mio, io v’assicuro che si trattava d’un cerotto con le prime corna sul capo. OLOFERNE: Haud credo, don Natalino. INTRONATO: Gnornò che non era un alto redo, ma un cerbiatto d’anni dua» (traduzione di N. D’Agostino). Tutte le citazioni da Love Labour’s Lost sono tratte dall’edizione bilingue Pene d’amor perdute, a cura di N. D’Agostino, Rizzoli, Milano . . «Questo mio è un dono di natura che ho, semplice semplice; è un folle spirito stravangante, pieno di forme, figure, profili, oggetti, idee, apprensioni, mozioni e revoluzioni. Codesti son generati nel ventricolo della memoria, nutriti nel grembo della pia mater, e sbrodolati al maturarsi dei tempi. Ma il dono funziona solo in quei che han l’ingegno affusolato, e io ne dico mercé» (traduzione di N. D’Agostino). Bibliografia BRADBROOK M. C. (), The School of Night, Cambridge University Press, Cambridge. CAMPBELL O. J. (), Love’s Labour’s Lost Restudied, University of Michigan Studies Shakespeare, Milton and Donne, New York. RASI L. (), I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia, Fratelli Bocca, Firenze. YATES F. A. (), A Study of Love’s Labour’s Lost, Cambridge University Press, Cambridge. in IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO NEL TESTO NARRATIVO. CARATTERISTICHE E TRADUZIONE di Paola Faini Dal discorso diretto e indiretto al discorso indiretto libero Lo stile indiretto libero trova nel discorso letterario, e in particolare nel romanzo, un’applicazione privilegiata. La sua presenza in un testo narrativo rivela la volontà autoriale di proiettare l’atto di narrazione verso prospettive nuove: a partire dal XIX secolo, esso contribuisce a una maggiore interiorizzazione della rappresentazione romanzesca, delineando i processi mentali e le emozioni di un personaggio. Questa tipologia di discorso (che per brevità definiremo, secondo l’uso comune, DIL; nella terminologia anglosassone FIS, Free Indirect Speech) si presenta come una forma di citazione caratterizzata da una sorta di ambiguità: in esso, infatti, si intersecano e si compenetrano aspetti del discorso diretto e di quello indiretto, libertà espressiva e complessità. A differenza del discorso diretto, caratterizzato dal doppio livello della frase citante e della frase citata, il DIL appare libero, così come è sciolto dalla subordinazione alla frase citante tipica del discorso indiretto, nel quale si determina la perdita di autonomia dei connettivi. A rendere agevole l’individuazione del discorso diretto, come nell’esempio [], contribuisce in larga misura la presenza di indicatori grafici (ad esempio, le virgolette) e dei due “centri” discorsivi cui si è appena fatto cenno, ovvero il contesto citante e l’enunciato citato: [] «This is not a smoking carriage,» Mrs Norman protested (Woolf, , p. ). Ancora discorso diretto, ma di livello alquanto più elaborato, ritroviamo nell’esempio []: [] This is life, they should have said, as Fanny said it now (ivi, p. ). Qui l’assenza di indicatori grafici a contrassegnare la “presa di parola” potrebbe ingannevolmente suggerire che si tratti di DIL, ma la presenza di un contesto citante (they should have said), di un deittico, this, che rimanda alla formulazione in presa diretta di un io interno al contesto citato, e infine del tempo presente (This is life) porta a escluderlo, a favore del discorso diretto. Il discorso diretto, «citazione per eccellenza» (Beccaria, , p. ), appare la scelta ottimale ove si intenda creare un’apparenza di oggettività: esso, infatti, con- PAOLA FAINI sente l’attribuzione dell’informazione a chi in prima istanza l’ha formulata, giacché riproduce “letteralmente” la parola altrui, e crea un effetto di realistica immediatezza mediante l’eventuale uso di forme ellittiche, esclamazioni, interiezioni e simili. Diversa è la natura del discorso indiretto, caratterizzato da un unico sistema enunciativo, che va in direzione di una parafrasi della parola altrui, anche fedele, ma pur sempre parafrasi. Va ricordato, infatti, che il discorso indiretto non è la riproduzione di una comunicazione verbale, bensì una sua interpretazione da parte di un narratore. [] Miss Thomas, one of the typists, said to her friend that if the cabinet was going to sit much longer she should miss her boy outside the Gaiety (Woolf, , p. ). L’esempio rivela il venir meno dell’indipendenza sintattica, con la conseguente subordinazione del contesto citato al contesto citante. Il centro deittico, ovvero la collocazione dell’io parlante, si sposta sul contesto citante (il discorso indiretto non prevede un io), e l’eventuale effetto emotivo è azzerato, poiché il discorso indiretto è necessariamente incompatibile con tutti quegli elementi indicativi di una presa diretta tipica del parlato: interiezioni, esclamazioni, forme ellittiche scompaiono nel discorso indiretto. In sostanza, se Miss Thomas avesse avuto la parola in questo contesto, avrebbe assai probabilmente espresso il suo disappunto, quanto meno con l’introduzione di una carica emotiva segnalata dal punto esclamativo. Seppure in modo diverso, nelle due tipologie di discorso appena esaminate, il contesto citato è in rapporto con il contesto citante. Al contrario, nel DIL nessun verbo “regge” grammaticalmente le parole citate, non vi è collegamento né subordinazione, non vi è alcuna modalità introduttiva specifica, né slivellamento netto tra discorso citante e citato. A segnalare la presenza del DIL è, piuttosto, una discordanza enunciativa, il cui scopo sembra essere proprio l’attenuazione dello slivellamento: [] She knew herself to be of the first utility to the child; and what was it to her if Frederick Wentworth were only half a mile distant, making himself agreeable to others! (Austen, , p. ). In questo esempio la seconda parte del periodo appare palesemente sciolta dal collegamento con una qualsivoglia frase introduttiva citante: manca un verbo di dire, mentre si avverte quella discordanza improvvisa di cui si diceva, discordanza che determina un mutamento rispetto alla frase precedente, e produce uno stile che non può dirsi né diretto (dato l’uso della terza persona) né chiaramente indiretto, data la presenza dell’esclamazione che apporta un’enfasi tipica del parlato, e dunque incompatibile con il discorso indiretto nel quale tali marche soggettive non sono utilizzabili. A ulteriore conferma, si ha l’uso della terza persona e del passato, caratteristico del DIL proprio per il suo frequente ricorrere nel discorso narrativo, caratterizzato per lo più dalla presenza della terza persona e del passato. IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO NEL TESTO NARRATIVO Il DIL nel discorso narrativo Prossimo al mimetismo dello stile diretto, il DIL introduce l’evocazione di parole, pensieri, sensazioni e sentimenti del personaggio. In esso avvertiamo ciò che può essere definito come l’impronta del locutore e che consente a giusto titolo di qualificare come “espressiva” una forma narrativa caratterizzata dall’intersezione della struttura linguistica con l’uso linguistico. In questa situazione, l’intenzione comunicativa contempla la possibilità di influire sui modi della formulazione, e dunque sulla ricezione del messaggio da parte del destinatario, la cui sensibilità di decodificazione è stimolata al massimo livello. Quanto detto connota il DIL come strumento particolarmente adatto al discorso narrativo, giacché esso consente di realizzare una forma di polifonia basata sulla simultaneità: non una voce, quella del narratore o quella del personaggio, bensì due, quella del narratore e quella del personaggio. Voci che si giustappongono e si sovrappongono, al punto che il DIL non può dirsi totalmente a carico né dell’uno né dell’altro, né complessivamente, né a livello di frammento. È attraverso il DIL che il narratore, pur conservando il controllo materiale e finale dell’atto narrativo, consente l’entrata pur se indiretta del personaggio, il cui punto di vista irrompe nella narrazione, mutando la certezza d’individuazione di quell’io che produce il messaggio, e determinando una sorta di fusione delle due voci e, con essa, appunto, la polifonia. L’inevitabile conseguenza è che il DIL riverbera i suoi effetti sulla ricezione del messaggio, inducendo una percezione diversa rispetto a quella del discorso diretto (in cui il personaggio comunica direttamente, e si ha la forza massima dell’ io che produce il messaggio) e del discorso indiretto (in cui la forza dell’io produttore del messaggio raggiunge il suo livello minimo). A differenza degli altri due tipi di discorso, il DIL appare come una via intermedia, nella quale una sorta di velatura attenua il confine tra le due voci: il gioco della polifonia entra in atto, consentendo il duplice contatto sia con il filtro del narratore sia con la voce – che talvolta si fa pensiero – del personaggio. Appare dunque evidente che il ricorso al DIL, lungi dall’essere scelta casuale, è indicativo di un’esigenza precisa di adesione alla realtà e, nel contempo, di ricerca di un’elaborazione estetica. Il linguaggio viene restituito nel rispetto della sua “reale” formulazione, mediante una sorta di compromesso tra due voci, che si fondono in modo indubbiamente efficace: la voce del narratore gestisce l’atto di citazione, mentre la voce del personaggio può inserire effetti tipici del parlato, sia a livello di interiezioni, sia a livello di lessico e strutture, con il conseguente riscontro di costrutti e forme tipicamente colloquiali. Da ciò scaturisce una sorta di “alterità”, che distingue ulteriormente questo tipo di discorso da quello puramente indiretto, e che può talora rivelare una variazione di registro anche subitanea. L’inserimento di quelli che abbiamo indicato come “effetti tipici del parlato” appare consolidare la presenza di un atteggiamento soggettivo del locutore che – includendo se stesso – definisce nella sua completezza il processo di formulazione e, di conseguenza, di comprensione del messaggio, e fa sì che il destinatario (nel nostro caso, il lettore) possa orientare la ricezione dell’informazione. Si realizza così la stessa messa in atto della soggettività che caratterizza il ruolo dell’osservatore/locutore nella percezione/formulazione delle situazioni: nel costruire una scena, anche solo mentale, l’osservatore/locutore vi include se stesso, la visione che ne offre è egocen- PAOLA FAINI trica e tale punto di vista si trasferisce nell’informazione mediata dal segnale linguistico. Quella che si coglie è la sua visione, la sua costruzione e percezione, nonostante sia possibile avvertire – mediato dall’uso della terza persona – il riaffiorare della voce narrante. In presenza di questo fenomeno di forte soggettività, il destinatario del messaggio viene sollecitato a entrare in contatto con questa particolare visione, senza dover sottostare alla mediazione palese di un narratore che offre la sua rappresentazione del discorso. Il DIL in traduzione Se questa è la condizione che il DIL pone nel testo di partenza (testo originale), a essa dovrà necessariamente adeguarsi l’atteggiamento del traduttore letterario. Lo stile indiretto libero, infatti, più degli altri stili, rischia di essere corrotto in traduzione, con conseguenti modifiche di prospettiva che possono determinarne la risoluzione in uno stile puramente narrativo. Il rispetto che l’atto di traduzione assicura alla volontà autoriale dovrà dunque realizzarsi anche attraverso il mantenimento della soggettività e della polifonia che caratterizzano il testo fonte. Un rispetto da esercitare nei limiti consentiti dalla lingua di arrivo, e da modulare sulle diversità culturali che regolano l’uso e la consuetudine del linguaggio emotivo: a fronte di una cultura inglese che sembra prediligere l’understatement, la minimizzazione, la cultura italiana, non raramente, tende verso ciò che altri definirebbero non necessario, superfluo giacché il suo carattere “emotivo” la porta a cercare l’abbellimento, la conservazione, l’uso di artifici stilistici, ad esempio il facile concedersi, a fini espressivi, all’iterazione, all’accumulazione. Anche di questo dato è opportuno che il traduttore tenga giusto conto, controllando e dosando i propri interventi e agendo, nei limiti del possibile, secondo un criterio “conservativo” dell’efficacia dell’originale. La valutazione del modo, o dei modi, di traduzione del DIL può aiutare a comprendere in quale misura l’atteggiamento traduttivo definisca l’atto di comunicazione semantica nella sua completezza e nel modo più vicino alle intenzioni dell’autore. Gli esempi che seguono (i primi due tratti da Mrs Dalloway di Virginia Woolf, ) hanno la funzione di dimostrare come, nel complesso equilibrio del testo letterario, variazioni apparentemente minime determinino in realtà spostamenti anche rilevanti della focalizzazione. [] Clarissa was really shocked. This a Christian – this woman! This woman had taken her daughter from her! She in touch with invisible presences! Heavy, ugly, commonplace, without kindness or grace, she know the meaning of life! (Woolf, , p. ). La presenza del DIL in questo breve passo è indubbia: a rivelarlo sono l’uso della terza persona e del passato, le marche espressive e le forme ellittiche, la carica emotiva diretta della formulazione. Vediamo in che modo questo stile di discorso viene gestito in traduzione. IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO NEL TESTO NARRATIVO [.] Clarissa ne era realmente sgomentata. Costei osa dirsi cristiana! Questa donna! Questa donna che mi ha tolto la figlia! E sarebbe in contatto, costei, con potenze celesti? Goffa com’è, brutta, ordinaria, senza un briciolo di grazia e gentilezza – costei pretende di conoscere il significato della vita! (Woolf, , p. ). La tendenza al completamento e all’iterazione, in una parola alla ridondanza di cui si diceva a proposito dell’italiano, appare evidente in questo esempio di traduzione. Nella frase ellittica dell’originale, «She a Christian – this woman!» la sospensione, la frattura introdotta dal trattino viene a restituire graficamente un istante di afasia nell’indignata reazione della protagonista, dando al discorso un suo concitato carattere emotivo. Carattere che solo in parte sopravvive nel momento in cui la frase, da ellittica che era, viene realizzata nella sua completezza sintattica in [.], «Costei osa dirsi cristiana!». Questa variazione nella struttura, oltre ad affievolire l’efficace verosimiglianza prodotta dalla frammentarietà del pensiero, determina inevitabilmente il venir meno dell’effetto di sospensione che era dato dall’indicatore grafico e dalla scansione in due frasi indipendenti. Frasi che, nella traduzione, sono riportate in discorso diretto libero, determinando l’uscita di campo della voce del narratore. A essere mantenuto ed esaltato è il solo aspetto dell’immediatezza della presa diretta: anche l’indicazione spazio-temporale comunicata dal dimostrativo questa, che traduce l’originale this, pone l’enunciato a carico della sola Clarissa, il cui pensiero prende forma in presenza di Miss Kilman (this woman). Il vero problema traduttivo, tuttavia, si presenta con la frase successiva, «This woman had taken her daughter from her». Se la polifonia era pienamente realizzata nel testo fonte, per la contemporanea presenza di this (indicatore a carico del personaggio) e della terza persona (indicatore a carico del narratore), nel testo di arrivo la scelta traduttiva, benché renda efficacemente la comunicazione semantica in discorso diretto libero, in realtà, con la rinuncia al DIL, modifica il punto di vista e annulla la polifonia, cosicché l’unica voce percepibile appartiene al personaggio/locutore. Il completamento di quelle che nel testo di partenza erano strutture ellittiche caratterizza il resto del brano in [.], con il conseguente definitivo annullamento dell’effetto polifonico. Diverso appare l’atteggiamento del traduttore nel secondo esempio: [.] Clarissa ne fu davvero sconcertata. Quella donna – una cristiana? Quella donna le aveva sottratto la figlia! E si diceva in contatto con presenze invisibili! Goffa, brutta, volgare, senza grazia né gentilezza, pretendeva di conoscere il significato della vita! (Woolf, , p. ). Lo stile traduttivo appare qui più controllato, più aderente all’essenzialità del discorso originale e, soprattutto, più attento alla conservazione dell’effetto di polifonia. La struttura ellittica del discorso viene mantenuta, ed è risolto con sensibilità il problema posto dall’espressione «She a Christian – this woman!». La frase, che nella sua frammentaria brevità rivelava lo scetticismo dubbioso di Clarissa rispetto a «this woman/quella donna», viene ora ribaltata per consentire di dar voce a quel dubbio mediante una forma interrogativa, il cui indicatore emotivo sottolinea la preservazione del DIL. PAOLA FAINI A determinare lo spostamento della focalizzazione in direzione del narratore è, invece, la scelta del traduttore di rendere il dimostrativo this (come già detto indicatore della voce del personaggio/locutore, Clarissa) con quella. Una modifica che produce un effetto di allontanamento, non disgiunto tuttavia da una ben individuabile carica emotiva, che riporta alla pulsione negativa di Clarissa e può dunque motivare questa scelta. Dallo stesso romanzo è tratto il prossimo esempio: [] But to go deeper, beneath what people said (and these judgements, how superficial, how fragmentary they are!) in her own mind now, what did it mean to her, this thing called life? Oh, it was very queer. There was So-and-so in South Kensington; someone up in Bayswater; and somebody else, say, in Mayfair. And she felt quite continuously a sense of their existence; and she felt what a waste; and she felt what a pity; and she felt if only they could be brought together; so she did it. And it was an offering; to combine; to create; but to whom? (Woolf, , p. ). Qui il discorso si carica di sfumature più complesse, intrecciando stili diversi, muovendosi di continuo tra l’effetto di presa diretta prodotto dall’immediatezza del presente («and these judgements, how superficial, how fragmentary they are!» e ancora, «but to whom?»), e l’effetto di polifonia prodotto dal DIL («what did it mean to her, this thing called life?») con il suo gioco di contrasti tra il passato e la circostanziata presenza dell’indicatore this. A questo si aggiunga l’accostamento di voci (tanto efficace che il narratore sembra compenetrarsi nel personaggio, facendone definitivamente suoi i pensieri) alla cui realizzazione contribuisce l’assenza di qualsivoglia indicatore grafico a fissare il confine tra i due discorsi: «and she felt what a pity; and she felt if only they could be brought together». I due punti di vista si fondono senza soluzione di continuità; presente, passato, vicino, lontano, frammentazione, tutto contribuisce a comporre una sensazione di fluidità, di scorrimento, di sfioramento di una mente che ora affiora ora torna a immergersi nella voce narrante. I due esempi di traduzione appaiono profondamente diversi nei loro effetti. [.] Ma per scendere più a fondo, al di sotto di quello che dice la gente (e quanto son superficiali, questi giudizi, quanto son frammentari!) fra sé e sé adesso si chiede: che cosa significa, per me, questa cosa chiamata vita? Oh, è una cosa molto strana. Qui abbiamo Tizio o Tizia, a South Kensington; là, in Bayswater, abbiamo Caio o Caia; eppoi qualcun altro, mettiamo, a Mayfair. Ebbene, lei avverte di continuo la sensazione della loro esistenza; e si dice: ma che spreco! E pensa: che peccato! Se solo si potesse metterle assieme, queste persone! Allora lei si adopra in tal senso. Per combinare; per creare. Si tratta di un’offerta – ma a chi? (Woolf, , p. ). I tratti caratteristici del traduttore, lo stesso di [.] si confermano in questo secondo brano. L’effetto di presa diretta è correttamente mantenuto, in parte anche nell’ordine frastico di «e quanto son superficiali, questi giudizi, quanto son frammentari!». Poi, improvvisamente, tutto cambia, con l’inserimento di un verbo citante che non compariva nel testo originale, e che determina un movimento del discorso da indiretto libero a diretto. Ciò che era implicito diventa esplicito, al punto che la polifo- IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO NEL TESTO NARRATIVO nia scompare e Clarissa, il personaggio, dà voce in prima persona a un pensiero che, in verità, si agitava nella sua mente, ma senza realizzarsi in una formulazione compiuta. Questa scelta di offrire al lettore una chiave privilegiata per entrare nei pensieri di Clarissa deve scendere a patti con l’irrompere della voce narrante, che si impone da subito con il suo «Ebbene» e con il suo verbo citante, «si dice»: «Ebbene, lei avverte di continuo la sensazione della loro esistenza, e si dice: […]». Una presenza che filtra anche le battute successive, caratterizzate dal doppio livello citante e citato, e che al tempo stesso non rinuncia a imporre la presenza forte del personaggio, con un recupero della presa diretta tramite la trasformazione del tempo verbale che, da tempo passato nel testo fonte, qui diventa presente, e presente rimane fino alla conclusione del periodo. Una modifica radicale, dunque, che stravolge quel lieve, delicato andirivieni di voci, quel gioco di sfumature che contribuivano a comporre, tassello dopo tassello, il senso ondivago di «this thing called life». Il secondo traduttore, lo stesso di [.], presenta uno stile diverso. [.] Ma per andare più a fondo, al di là di quello che dice la gente (e come sono superficiali, frammentari, quei giudizi!), nella mente sua, che significava per lei, questa cosa che chiamava la vita? Oh, era davvero strano. C’era il Tal dei tali a South Kensington, o il Tal altro ancora, ad esempio, a Mayfair. Lei aveva costantemente il senso della loro esistenza, e pensava che spreco, e provava pietà, e sentiva se soltanto li si potesse mettere tutti insieme, e lo faceva. Ed era un’offerta: mettere insieme, creare. Ma per chi? (Woolf, , pp. -). Gioco polifonico, stile ellittico, mancanza degli indicatori grafici e dei verbi citanti che erano stati invece introdotti in [.]: tutto contribuisce a rendere questa traduzione assai più vicina allo spirito dell’originale, consentendo lo spostamento rapidissimo della focalizzazione dall’una all’altra voce, e poggiando, solo di un tono in più rispetto al testo fonte, sul tasto del narratore, mediante lo slittamento da «these judgements» a «quei giudizi». Esattamente la stessa modalità di presa di distanza tra le due voci che era stata applicata nel precedente esempio dello stesso traduttore. La tecnica raffinata che Virginia Woolf mette in atto nei suoi romanzi, e di cui si è dato qui solo un circoscritto esempio, trova un’anticipazione nell’opera narrativa di Jane Austen, ritenuta una sorta di pioniera nell’uso consapevole del DIL a livello narrativo. Riprendiamo l’esempio citato in apertura, il frammento tratto da Persuasion (postumo, ), di Jane Austen. [] She knew herself to be of the first utility to the child; and what was it to her if Frederick Wentworth were only half a mile distant, making himself agreeable to others! (Austen, , p. ). Il tratto più caratteristico va riferito all’enfasi prodotta dalla frase esclamativa, che ben comunica l’impulsività emotiva del parlato. È soprattutto questo l’aspetto da preservare in traduzione, ed è ciò che accade nell’esempio che segue: PAOLA FAINI [.] Sapeva di essere utile, essenziale, al bambino; e cosa le importava se Frederick Wentworth si trovava solo a mezzo miglio di distanza e si rendeva simpatico ad altri! L’aspetto enfatico appare invece alterato dalle modifiche introdotte nel secondo esempio di traduzione: [.] Sapeva di essere di grande utilità al bambino e che cosa poteva, quindi, importarle se Frederick Wentworth era ad appena mezzo miglio di distanza e si stava rendendo simpatico ad altri? Una domanda retorica, ovviamente, e che tuttavia ha l’effetto di modificare l’atteggiamento emotivo del locutore originario, che non si poneva in forma interrogativa rispetto alla possibilità di un incontro con Frederick Wentworth, ma sembrava allontanarla da sé, quasi con indifferenza. È dunque con sfumature diverse che si definisce qui il pensiero della protagonista, Anne. E ancora: con l’introduzione del modale e dell’avverbio (quindi), il rapporto tra le due frasi si fa più forte, e più percepibile diventa il filtro della voce narrante. Concludiamo con un ultimo esempio, dallo stesso romanzo. [] Charles agreed; but declared his resolution of not going away. He would be as little encumbrance as possible to Captain and Mrs Harville; but as to leaving his sister in such a state, he neither ought, nor would. So far it was decided; and Henrietta at first declared the same. She, however, was soon persuaded to think differently. The usefulness of her staying! – She, who had not been able to remain in Louisa’s room, or to look at her, without sufferings which made her worse than helpless! She was forced to acknowledge that she could do no good; yet was still unwilling to be away, till touched by the thought of her father and mother, she gave it up; she consented, she was anxious to be at home (Austen, , p. ). In questo passo l’apertura al DIL si realizza con cautela, attraverso una sorta di anticipazione verbale offerta dal verbo dichiarativo declared. Verbo che pur non avendo alcun rapporto sintattico con le frasi immediatamente successive, nondimeno sembra fungere da preavviso della presa quasi diretta che aspetta il lettore. La frase che segue, infatti, presenta la vera e propria “dichiarazione” di Charles, essenziale, emotivamente distanziata, ma chiaramente attribuibile al personaggio: «He would be as little encumbrance as possible to Captain and Mrs Harville; but as to leaving his sister in such a state, he neither ought, nor would». Anche il comportamento di Henrietta viene anticipato da un verbo, persuade: pur se non esplicitamente verbo di dire, esso comunque implica un atto linguistico, la cui elaborazione traspare tutta nel DIL che segue, collocato in una dimensione emotiva dalla presenza di elementi espressivi come le esclamazioni: «The usefulness of her staying! – She, who had not been able to remain in Louisa’s room, or to look at her, without sufferings which made her worse than helpless!». Questa volta, tuttavia, l’attribuzione della voce è meno certa: Henrietta deve essere persuasa, e a convincerla sono parole pronunciate da un locutore non chiara- IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO NEL TESTO NARRATIVO mente identificabile. Ma questo poco importa: quel che conta è che l’intento comunicativo si realizzi in una forma, quella del DIL, che consente di avere un contatto con l’evento, con la situazione. Una forma in cui il narratore fa un passo indietro, rinuncia all’atto diegetico per lasciare spazio a una mimesi che meglio renda la concitata emotività del momento; un narratore che subito dopo riprende le fila del suo racconto per concluderlo rapidamente. In un contesto di rapida riproduzione di scambi verbali filtrati dal narratore, i due interventi in discorso indiretto libero risaltano per la loro forza individuale e soggettiva, per la loro immediatezza di comunicazione. Vediamo ora come due diverse traduzioni affrontano il testo, premettendo che il periodo viene riportato nella sua completezza per consentire la migliore comprensione del contesto, anche se l’attenzione si concentrerà su alcuni aspetti circoscritti. [.] Charles era d’accordo, ma dichiarò la sua risoluzione di non lasciare Lyme. Avrebbe dato il minor disturbo possibile al capitano Harville e a sua moglie; ma quanto ad abbandonare sua sorella in tali condizioni, non doveva e non voleva farlo. E questo era deciso; anche Henrietta, dapprima, espresse gli stessi propositi, ma venne presto convinta a cambiare idea. Figurarsi di quale utilità sarebbe stata restando lì! Lei, che non era riuscita a rimanere nella camera di Louisa, o a guardarla senza essere colta da sofferenze che la lasciavano del tutto priva di forze! Dovette riconoscere di non poter essere di alcun aiuto, e tuttavia era ancora riluttante ad andarsene. Questo finché, commossa al pensiero del padre e della madre, cessò di insistere; acconsentì, e fu tutta presa dall’ansia di ritrovarsi a casa (Austen, , pp. -). [.] Charles assentì ma si dichiarò risoluto a non allontanarsi. Avrebbe dato il minor disturbo possibile al capitano e a Mrs Harville ma non doveva né voleva lasciare sua sorella in un simile stato. Questo fu ritenuto giusto e anche Henrietta avrebbe voluto restare ma la convinsero a cambiare idea. Che utilità avrebbe avuto la sua presenza? Non era neppure riuscita a rimanere in camera con Louisa e non poteva guardarla senza provare sofferenze tali da impedirle di essere minimamente di aiuto. Fu costretta ad ammetterlo, eppure non riusciva ad accettare l’idea di dover andare. Soltanto al pensiero del padre e della madre si lasciò convincere, anzi divenne ansiosa di tornare a casa (Austen, , pp. ). Concentriamo l’attenzione esclusivamente sugli aspetti già evidenziati nell’analisi del testo di partenza. In [.] la dichiarazione di Charles appare resa nel rispetto della comunicazione originale, e altrettanto si può dire per il discorso che persuade Henrietta dell’inutilità di rimanere ad assistere la sorella Louisa. Le marche emotive sono conservate, l’effetto mimetico della frase originale è assicurato. Per quanto libera e indiretta possa essere la formulazione, ancora avvertiamo l’eco dei discorsi. Il ritmo, cadenzato, riflessivo, del testo originale e di [.] assume un tempo diverso in [.]: qui tutto scivola via rapidamente, quasi senza dare il tempo di avvertire il passaggio di voce, già di per sé marcato solo labilmente in questo passo. Piccoli dettagli, ma non irrilevanti ai fini dell’effetto globale, “smontano” la limpida precisione del testo di partenza. «The usefulness of her staying!»: il tono di sorridente ironia, che ancora si coglieva nella frase esclamativa in [.], va perduto in [.], nell’incisiva definitività di una domanda che non attende risposta. E scompare PAOLA FAINI anche il pronome, She, che apriva la frase successiva e che correttamente viene conservato in [.], «Lei», a riprendere, indirettamente, un’immaginaria frase rivolta ad Henrietta, «Proprio tu, che non sei riuscita a rimanere nella camera di Louisa…». Soppresso il pronome, dettaglio solo apparentemente minimo, tutto cambia, la frase perde la vivezza della presa diretta, e con essa scompare anche l’opportunità di mantenere la marca emotiva, l’esclamazione. A rimanere è solo un atto diegetico, un resoconto riassuntivo di ciò che poteva esser stato detto. Il DIL è scomparso, e con esso è scomparsa la polifonia. In conclusione, appare evidente che gli interventi traduttivi che abbiamo preso in considerazione apportano variazioni minime, di cui il lettore del testo di arrivo, privo di possibilità di raffronto, non ha cognizione alcuna. Ciò assicura, in ogni caso, la piena fruibilità e godibilità del testo. Tuttavia, per quanto singolarmente minime possano essere queste variazioni, quando esse appaiono ripetute, insistite, e tendono a creare uno stile traduttivo alternativo allo stile autoriale, ne risulta un duplice effetto: a livello globale si determina un’alterazione stilistica di portata non indifferente; a “microlivello” si rischia di modificare l’impronta caratteriale del personaggio, facendone qualcosa di diverso rispetto a quello che era. Sul significato di queste apparenti irrilevanze è dunque opportuno riflettere, giacché a essere coinvolto e responsabilizzato – nei confronti dell’autore e del lettore – è proprio l’atteggiamento del traduttore e la sua volontà di risultare fedele, nei limiti del possibile, all’equilibrio delicato dell’universo narrativo al cui interno egli si muove. Note . Si parla di discorso in quanto atto di enunciazione proprio in relazione all’analisi letteraria di un testo. L’enunciazione definisce, infatti, il soggetto dell’enunciato, la relazione tra locutore e interlocutore, e infine il modo in cui il soggetto si pone nei confronti dell’enunciato. . Le lingue verbali sono definite “codici a citazione” in quanto «consentono di formare enunciati che possono diventare oggetto di altri enunciati» (Beccaria, , p. ). . Il discorso indiretto libero, come si vedrà, è autonomo. Esso non richiede necessariamente una frase citante (in realtà si può riscontrare un introduttore verbale o nominale, purché siano presenti altre marche del DIL) e consente l’uso di deittici che apparirebbero non corretti nel discorso indiretto. Tempo, luogo e dimostrativi, infatti, nel DIL si regolano sul «centro deittico dell’enunciazione citata» (Mortara Garavelli, , p. ). . Si ricorda qui la distinzione tra enunciato ed enunciazione. L’enunciato è esclusivamente verbale; l’enunciazione implica elementi non verbali (mittente, destinatario, contesto). Le forme del discorso diretto o indiretto appartengono al piano dell’enunciazione, che è pertanto detto anche piano del discorso. Cfr. supra, nota . . Gli indicatori grafici, oltre a poter essere variabili (le virgolette possono essere sostituite, ad esempio, dal trattino), non sono indispensabili per definire la tipologia del discorso. È dunque possibile che siano assenti. . Il rapporto tra struttura linguistica e uso linguistico è riferibile alla distinzione saussuriana tra langue e parole. . Si accenna qui brevemente alla differenza tra DIL e discorso diretto libero (DDL), indicati anche come monologo interiore narrato (proprio per la presenza della polifonia narratore/personaggio) e monologo interiore citato, ovvero una sorta di «soliloquio in forma diretta senza introduttori sintattici e grafici» (Beccaria, , p. ). Quest’ultimo è caratterizzato dall’uso della prima persona, dunque quanto mai vicino all’effetto del parlato. A corollario delle distinzioni indicate tra i vari tipi di discorso, va detto che da più parti è stato giustamente notato come la narrativa moderna, con il suo uso disinvolto della sintassi e conseguentemente dei punti di vista, stia erodendo i confini tra i diversi tipi di discorso riportato. IL DISCORSO INDIRETTO LIBERO NEL TESTO NARRATIVO . La cosidetta realtà della formulazione è un dato acquisito sulla base del patto narrativo che si stabilisce nell’accettazione della finzione letteraria. . Rilevando questo legame con il parlato, Norman Page definisce il DIL come una combinazione di «detachment and economy with dramatic vividness and stylistic variety» (Page, , p. ). . Sarà opportuno ricordare che, nel discorso letterario, ogni elemento, sia fonologico sia morfosintattico, «interagisce col piano del contenuto» e contribuisce a determinare il senso globale del testo (cfr. Marchese, , p. ). . Ulteriori considerazioni sul passo originale sono rimandate al discorso di confronto tra testo di partenza e testo di arrivo. . Va sottolineato che questa forma indica familiarità, interesse, ed è spesso usata nello stile informale. That può invece creare un effetto di rifiuto emotivo nei confronti dell’oggetto a cui viene applicato. In questo caso, comunque, l’indicatore spaziale designa il contesto, nonché il rapporto locutore-interlocutore. Per la definizione stessa di deissi, «il soggetto riferisce il suo enunciato al momento dell’enunciazione, ai partecipanti alla comunicazione e al luogo in cui l’enunciato è stato prodotto» (Dubois, , p. ). Appare dunque chiaro che la modifica eventuale di questo indicatore non è priva di conseguenze. . Il risultato è l’introduzione della prima persona, e la percezione netta è che a parlare o pensare sia l’io di Clarissa. . Quella, esattamente come that, comunica l’effetto di rifiuto emotivo (cfr. supra, nota ). . A livello compositivo, questo effetto si può ricollegare a quella «doccia d’immagini»che Mario Praz definiva come tipica della tecnica di scrittura di Virginia Woolf. Una «doccia d’immagini» che egli assimilava alla «doccia di sensazioni sotto cui ci mette la vita» (Praz, , p. ). . Sia nell’edizione Mondadori dei Romanzi, sia nell’edizione Feltrinelli, una piccola porzione di testo («someone up in Bayswater») è mancante, probabilmente a causa di un refuso tipografico. . Cfr. il già citato Page (). . Il brano viene presentato nella sua completezza, per dar modo di cogliere i passaggi dall’uno all’altro tipo di discorso. Bibliografia AUSTEN J. (), Persuasione, traduzione di R. C. Cerrone, TEA, Torino. EAD. (), Persuasione, traduzione di L. Pozzi, Garzanti, Milano. EAD. (), Persuasion, Oxford University Press, Oxford. BECCARIA G. L. (a cura di) (), Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica , Einaudi, Torino. DUBOIS J. (), Dizionario di linguistica, Zanichelli, Bologna. MARCHESE A. (), Dizionario di retorica e di stilistica, Mondadori, Milano. MORTARA GARAVELLI B. (), Strutture testuali e retoriche, in A. A. Sobrero (a cura di), Introduzione all’italiano contemporaneo. Le strutture, Laterza, Roma-Bari. PAGE N. (), The Language of Jane Austen, Barnes&Noble, London. PRAZ M. (), Storia della letteratura inglese, Sansoni, Firenze. WOOLF V. (), Jacob’s Room, Penguin Books, Harmondsworth. EAD. (), Mrs Dalloway, Oxford University Press, Oxford. EAD. (), Mrs Dalloway, traduzione di P. F. Paolini, Newton & Compton, Roma. EAD. (), Romanzi, traduzione di N. Fusini, Mondadori, Milano. SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ETÀ DEI LUMI. L’EQUIVOCO E PROVOCANTE CARTEGGIO AMOROSO DI GIUSTINIANA WYNNE, SCRITTRICE ANGLO-VENEZIANA (-) di Nancy Isenberg Reputazioni Negli anni della sua giovinezza, Giustiniana Wynne fece girare la testa e sussultare i cuori di alcuni fra i più ricchi e potenti uomini d’Europa. Se era la sua bellezza ad adescarli, a incantarli erano le sue parole. Intelligente, vispa, lettrice appassionata e di gusti inconsueti per una donna di allora, seduceva i suoi ascoltatori con giudizi inaspettati e commenti provocatori, offerti con tale grazia da suscitare invidia. Non più fanciulla, quando divenne scrittrice, con eguale potere di seduzione catturò i suoi lettori. Durante la vita e per molti decenni dopo, Giustiniana Wynne e le sue opere furono ammirate e ricordate in Italia e all’estero, ma la notorietà internazionale non le garantì fama duratura, forse perché la Wynne sfuggiva a qualunque facile classificazione. Per metà inglese e per metà veneziana, scrisse soprattutto in francese, e per giunta il pubblico la conosceva con il nome austriaco del marito. Non potendo rivendicare piena cittadinanza nella storia letteraria nazionale di un singolo paese, quando la memoria dei viventi svanì, il suo nome divenne sempre meno noto… fino al , quando grazie a una scandalosa scoperta fu riportato alla ribalta. In quell’anno, uno studioso austriaco identificò Giustiniana Wynne come la misteriosa Mlle XCV, protagonista di uno degli episodi più intriganti ed erotici di Historie de ma vie, le memorie di Giacomo Casanova. Quel raconteur libertino per eccellenza, sostenendo di averla desiderata sin da quando era una fanciulla, narra di come la incontrò qualche anno più tardi a Parigi e di come lei gli si rivolse al fine di interrompere una gravidanza indesiderata. Casanova descrive pure un incontro segreto con una levatrice (che tuttavia non ebbe l’esito voluto), confessando poi che lo stato della ragazza non gli impedì di trovarla irresistibile. E così – secondo il racconto di lui – la sedusse con un inganno fatto di promesse, pozioni ed erotismi. Il risultato desiderato, ovviamente, non fu raggiunto e quindi – sempre secondo la versione di Casanova – egli l’aiutò a nascondersi in un convento fino alla nascita del bambino. Nel frattempo, uno dei nemici del seduttore impenitente denunciò alla polizia l’atto ignominioso e illegale al tempo; venne così avviato un processo ai suoi danni. Grazie a vari indizi biografici su Mlle XCV sparsi tra le memorie di Casanova, il codice di quest’ultimo venne decifrato e il vero nome di Mlle XCV finalmente svelato. Circa un decennio dopo quel riconoscimento (a metà degli anni Venti), cominciarono a venire alla luce a Venezia e nei dintorni delle lettere d’amore, scritte da Giustiniana, e queste caddero giusto tra le mani di alcuni ammiratori di Casanova. NANCY ISENBERG Lo spasimante della ragazza – e il presunto padre del figlio che portava in grembo – era Andrea Memmo, giovane erede di una delle più antiche e importanti famiglie di Venezia. Lo stato sociale di lui era troppo elevato rispetto a quello di Giustiniana perché si potesse combinare un’unione ufficiale. Ne conseguirono una forte opposizione familiare da entrambe le parti e una segretezza obbligata nella relazione: ingredienti questi che conferirono a Giustiniana e alle sue lettere una vivissima e quasi sfacciata audacia e passione. Un’audacia e una passione che avrebbero solleticato la fantasia dei casanovisti per anni a venire. Una bella donna con un passato lussurioso, coinvolta in una specie di ménage à trois (perché Memmo e Casanova erano amici di vecchia data): ecco l’identità stuzzicante che le attribuirono implicitamente negli studi pubblicati in seguito. Fuorviati da quest’immagine, i casanovisti tralasciarono ogni altra sua caratteristica. Per tutto il Novecento, quindi, Giustiniana Wynne rimase imprigionata nel ruolo di allettante e peccaminoso oggetto del desiderio. Nell’autunno del , un discendente diretto di Memmo ha pubblicato un libro sulla storia d’amore della Wynne con il suo antenato, basato non solo su quelle lettere ma anche su nuovi documenti: un centinaio di lettere scritte in segreto da Memmo alla giovane Giustiniana, scoperte in un palazzo di famiglia a Venezia. In A Venetian Affair, Andrea di Robilant inquadra con la dignità che merita la figura di Giustiniana nel suo ruolo di amante e lasciandoci con il desiderio di conoscere altro di lei e della vita che era riuscita poi a costruire per sé. Nell’impossibilità di sposare l’amore della sua vita, Giustiniana, fra i suoi tanti pretendenti altolocati, optò per l’anziano conte austriaco, Philip Joseph Orsini Rosenberg, ambasciatore imperiale a Venezia. Un matrimonio di convenienza, di certo. Eppure una scelta che sapeva di libertà e di indipendenza, entro i limiti imposti a una donna di allora. Per cinque anni sua moglie, e poi sua vedova, godette del prestigio conferitole dal nome e dal titolo aristocratico del marito e divenne una delle animatrici più stimate dei salotti illuminati veneziani. La sua carriera di scrittrice professionista, iniziata solo al compimento dei quarantacinque anni, durò meno di un decennio, interrotta da una malattia che le tolse la vita. In quel breve periodo pubblicò otto volumi, conquistandosi sulla scena internazionale la fama di brillante e originale osservatrice. Mise a frutto il suo talento nei diversi generi letterari, scrivendo saggi, memorie e novelle veneziane e orientali . Pubblicò anche un poema occasionale e una cronaca di Venezia in festa. Secondando i dettami del proprio carattere e della moda letteraria del tempo, si liberò degli schemi consolidati, sfidando i critici a trovare una definizione calzante per i suoi lavori. Il suo “romanzo antropologico” – ambientato tra i popoli slavi – li disorientò completamente, costringendoli a confrontarsi con un genere ancora da inventare. Ancor più arduo classificare la sua “guida filosofica” a una villa, e in particolare al suo parco abbellito di reperti archeologici; parco nel quale avvenivano gli incontri di un gruppo di intellettuali progressisti dell’epoca. La comparsa sull’“European Magazine” di Londra valse alle sue novelle un’ampia diffusione. Le riedizioni, le traduzioni e gli adattamenti teatrali delle sue opere, che continuarono ad apparire fino alla metà dell’Ottocento, sono una testimonianza tangibile del successo che le arrise. Così come la sua fama è confermata dall’encomio di un ammiratore anonimo pubblicato nel : le sue opere, egli afferma entusiasta, «hanno fatto conoscere a tutta Europa il sommo ingegno di questa Dama» e le sue qualità «desterebbono invidia ne’ migliori Letterati del Secolo» . Quindici anni SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI dopo la sua scomparsa tanta ammirazione era ancora viva, come ci testimonia Melchiorre Cesarotti quando ebbe a scrivere a un suo amico che il merito della Wynne «non cede alle più celebri d’Inghilterra e di Francia». Così fu conosciuta in vita e venne ricordata a lungo da un vasto pubblico di ammiratori e ammiratrici dopo la sua morte. Anche se la sua carriera letteraria iniziò ufficialmente molto più tardi, è nelle lettere che scrisse appena ventenne ad Andrea Memmo che Giustiniana trovò la propria voce di scrittrice. Scrivendo per lo più in italiano, ma anche in francese e inglese, in queste lettere crea una narrazione del desiderio e dell’autodeterminazione che oggi possiamo leggere come una provocatoria esaltazione dell’individualità emancipata cantata con voce femminile. Seduzioni epistolari Una mattina, ai primi di ottobre dell’anno , la giovane Giustiniana salì sul burchiello che l’avrebbe condotta, costeggiando le sponde del Brenta, da Venezia a Padova. Di lì avrebbe viaggiato in carrozza prima verso Ovest e poi, traversando le Alpi, a Nord, in direzione di Parigi e, più tardi, di Londra. La severissima madre, con un gesto inaspettatamente generoso, aveva concesso a Memmo di accompagnarla durante questa prima tappa del viaggio che li stava per separare. La famiglia Wynne stava lasciando Venezia per andare a stabilirsi nella patria del padre, scomparso sette anni prima: Venezia era la città dove Giustiniana era nata e cresciuta, nella quale aveva conosciuto Andrea Memmo e lo aveva amato per cinque anni. Partire era sembrata l’unica risposta agli scandali e ai pettegolezzi sorti attorno alla storia d’amore tra Giustiniana e Memmo. Memmo, alcuni mesi prima della partenza, vincendo le obiezioni di entrambe le famiglie, tentò un’audace sfida alle convenzioni sociali e politiche della Serenissima: provò a ottenere dallo Stato l’assenso al matrimonio. Il tentativo fallì e il mondo di sogni e speranze dei due giovani innamorati crollò loro addosso. Giustiniana era figlia di un baronetto inglese e di una bellissima veneziana con ascendenze greche. Sir Richard Wynne, rimasto vedovo nel suo paese e giunto a Venezia nel , si era subito innamorato di Anna Gazzini. Giustiniana, nata nel , fu il primo frutto di quell’amore. Il suo arrivo precedette di due anni il matrimonio dei genitori. Da quell’unione nacquero altri cinque figli ma a breve la famiglia Wynne avrebbe subito la perdita della più piccina nel , seguita dalla scomparsa del capofamiglia nel . Nello stesso anno in cui morì suo padre, Giustiniana conobbe Andrea Memmo. Lei aveva quattordici anni, lui ne aveva ventidue. Due anni dopo i due giovani si sarebbero innamorati. Memmo (come lei gli si rivolgeva sempre, mai chiamandolo “Andrea”) discendeva da un’antichissima e stimatissima famiglia veneziana che, sin dalla fondazione della Repubblica, ebbe a rivestire un ruolo da protagonista nella vita politica della Serenissima. Come era stato per i suoi avi, per Andrea si prevedevano non solo alti incarichi di Stato, ma anche un matrimonio che ben si accordasse a tali ambizioni. “Sposarsi bene” era un vero e proprio obbligo per i figli delle casate iscritte all’Albo d’oro, quindi chiamati a governare. Di otto anni più grande di Giustiniana, mentre muoveva i primi passi nelle sfere della politica, Memmo aveva ancora molto tempo libero a disposizione. Girellava assieme ad altri simili a lui per rango e inclinazione: NANCY ISENBERG pronti di spirito, avventurosi, e vogliosi di novità. Frequentava il circolo degli inglesi a Venezia: compagnia colta, cosmopolita, in grado di esercitare un forte potere d’attrazione, polo di idee innovatrici provenienti dal Nord, in una città ormai priva di estro inventivo e slancio ideale e ben consapevole di esserlo. Fu a casa di uno di loro, il console, mecenate e mercante d’arte Joseph Smith, che conobbe Giustiniana. Andrea era un giovane di spirito dai modi spregiudicati e libertini: il desiderio di una vita intensa e appassionata lo rendeva irresistibile agli occhi di Giustiniana, giovane spigliata e curiosa quanto lui. La madre di Giustiniana non tardò a preoccuparsi, ben consapevole della necessità di preservare l’integrità della figlia, assicurandole così il matrimonio più vantaggioso possibile. Benché Memmo fosse innamorato quanto la fanciulla, la sua presenza nella vita di Giustiniana minacciava di compromettere la riuscita degli irriducibili obiettivi della signora Wynne. Memmo aveva comunque provato a smentire la signora Wynne, rivolgendosi agli “avogadori di comun”. Quella commissione, che tra le tante mansioni aveva il compito di approvare i matrimoni dei patrizi, riuscì a scovare, infrangendo le speranze di Memmo, verità nascoste sul passato della signora Wynne. La famiglia di lei, anni addietro, aveva intentanto un processo contro un “greco di cui non si conosce il nome” che l’aveva “deflorata” da giovanetta, lasciandola incinta. Come usava a quei tempi, il neonato fu poi abbandonato presso un orfanatrofio. Così la reputazione di Giustiniana fu doppiamento intaccata, perché per la piccola, pettegola Venezia aristocratica, lei era non solo l’“erede” della macchia materna ma anche lo “scarto” di un fidanzamento fallito proprio a causa di quella macchia: la vicenda della signora Wynne, infatti, determinò l’insuccesso del folle tentativo di Memmo volto alla conquista del nulla osta al matrimonio. Dunque, la Signora Wynne, accampando la doppia necessità di dover fornire la migliore educazione possibile ai suoi ragazzi e di doversi occupare dell’eredità del marito, raccolse la sua figliolanza al completo e partì alla volta dell’Inghilterra. La complessità del dramma si palesa appieno, poco alla volta, nelle lettere che Giustiniana scrive a Memmo dopo la separazione. Il tormento prende forma nelle parole: strumento per rievocare i momenti sublimi e quelli più dolorosi della loro quinquennale, proibita e turbolenta relazione; mezzo per renderlo partecipe delle insostenibili sofferenze patite sotto il giogo soffocante della madre. Il potere delle lettere Con la partenza da Venezia, la scrittura diventa per Giustiniana l’unico strumento per tenere in vita la relazione con Memmo. Impara a valersi della forma epistolare con maestria, al fine di suscitare e tener desti nel suo caro lettore interesse, coinvolgimento ed eccitazione. Giustiniana è combattuta tra ragione e desiderio e il contrasto diviene palese quando scrive. La voce della ragione le suggerisce di non indugiare e di frapporre una distanza emotiva dall’amato. Considerata la totale assenza di speranza per il loro amore, sarebbe stata una scelta saggia. Ma un’altra voce, più vicina al cuore, la persuade a non lasciarlo andare. Giustiniana scrive la prima lettera immediatamente dopo la partenza. Descrivendo il tormento della passione e del distacco, crea una “lettera di lamento” nella migliore tradizione ovidiana («Che dolore è il mio! Che disperazione! Ah, che t’amo pur troppo e non lascio di dirtelo anche ne’ primi momenti del mio distacco» SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI Vicenza, ottobre ). È anche la lettera in cui gli dice «[…] sarai mon cher frère», stabilendo con ciò un gioco di ruolo da fratelli. Propone questa finzione di amore fraterno come un legame più plausibile: una versione disinnescata dell’intimità carica di erotismo che fino a quel momento li aveva legati. Ma è veramente la voce della ragione che la spinge a rivolgersi a lui in questi termini? Giustiniana ebbe a vivere un periodo straordinario: il copione che regolava il delicato e complesso mondo delle relazioni sociali stava subendo cambiamenti radicali. In tutta Europa, in quei tempi prerivoluzionari, nuovi concetti di amicizia intima e di philadelphia (amore fraterno) cominciavano a scandire le interazioni sociali, sia nella sfera pubblica che in quella privata. All’interno della struttura famigliare, il rapporto tra fratello e sorella si era caricato di ambiguità erotica, in conseguenza della nuova capacità emotiva e affettiva su cui si fondava. Il legame tra fratello e sorella era basato spesso sulla conoscenza che l’uno aveva della vita privata e delle esperienze intime dell’altra e viceversa. Non era inusuale confidare a un fratello, o a una sorella, le proprie frustrazioni e disfatte sentimentali. Fratelli e sorelle potevano trovarsi a mimare gli atteggiamenti degli amanti e nei loro scambi epistolari imitavano il discorso amoroso. Mentre si esercitavano con il linguaggio del desiderio, lo esorcizzavano, poiché il legame fraterno dava loro licenza di sfidare dei tabù. «Mon cher frère» è una maschera che Giustiniana usa per mantenere viva la fiamma della passione nonostante la separazione fisica, ed è anche una strategia molto appropriata per le missive dirette a Venezia, la città delle maschere e dei giochi di ruolo libertini. Nel chiamare Memmo «mon cher frère», Giustiniana percorre, senza valicarla, la linea di confine tra l’affetto accettabile e quello inaccettabile, suscitando ansia e tensione che giocano a suo vantaggio . La posa fraterna di Giustiniana le permette di confidare a Memmo le esperienze e i sentimenti più intimi, consentendole così di mantenere alto il coinvolgimento emotivo del “fratello” nella propria vita. Ed esibendo la propria fragilità emotiva e vulnerabilità fisica, Giustiniana compie impliciti atti di seduzione. Nel periodo parigino viene corteggiata, tra gli altri, da due principi russi e un moschettiere francese. La ragazza scrive della loro rivalità, delle scene di gelosia – che porteranno, a un certo punto, a una sfida a duello – e anche delle loro rozze esplosioni di desiderio carnale: La sera nel lasciar l’appartamento della padrona, il moscovito che mi dava mano in un picciolo andito si prese ad abbracciarmi strettamente. La forza, le preghiere, le seduzioni, tutto impiegò per prendersi meco qualche libertà. Mi toccò il petto e voleva avanzarsi ma tanto io mi difesi malgrado la sua insistenza e la tentazione che potea cagionarmi un uomo ch’io vedea fuor di sé affatto, tremante e amabile, che alla fine gli scappai dalle mani, avendogli prima stracciato un manicotto e graffiate tutte le mani (Parigi, dicembre ). Più avanti nella stessa lettera, la sua camera da letto in un albergo di Parigi diviene lo scenario di ancora un’altra narrazione erotica. L’attenzione al dettaglio, con l’inserimento di dialoghi, aumenta la tensione conferendo al racconto una dimensione quasi teatrale: Non so qual’ora si fosse della notte […] quando, svegliata da un romore, mi trovai tutta scoperta, essendomi state tirate a basso le coltrici […] «Chi è là?», dissi e sentii rispondere, «Point de bruit, Mademoiselle; écoutez un seul mot de la fenêtre [Non NANCY ISENBERG fate rumore, Mademoiselle. Ascoltate una sola parola dalla finestra]». Conobbi con mia sorpresa la voce du mousquetaire [del moschettiere]. «Et comment, Monsieur [Ma come, Monsieur]», gli risposi, «que prétendez vous à l’heure qu’il est? Partez d’abord [cosa volete a quest’ora? AndateVene subito]». «Vous dire [Volevo dirVi]», soggiunse, «que je vous adore et que je prétends vous le prouver [che Vi adoro e che voglio dimostrarVelo]». «Vous êtes un fou, Monsieur [Voi siete matto, Monsieur]», risposi, «et je crois que la cervelle vous tourne. Ainsi quittez vite ma fenêtre, ne m’hasardez pas davantage ou je vais vous regarder comme le dernier des hommes [e credo che abbiate perso la testa, quindi lasciate subito la mia finestra e non mi infastidite più o Vi guarderò come l’ultimo uomo della terra]». Questi seguitava a tentar di persuadermi che m’accostassi ed io tacea quando d’improvviso s’accorse naturalmente che la porta avea la chiave al di fuori, ch’era stata dimenticata, e senza far altre parole, entrato dentro pian piano, si gittò sul letto in un momento. Figurati il mio spavento. «Scélérat, que prétendez vous de cette violence? Je vous déteste. Partez [Scellerato, che volete ottenere con questa violenza? Vi detesto. Andate via]». Ma egli senza badarmi, gittata la sua veste da camera, era entrato nel letto e cominciava a voler prendersi la libertà che poteva. Io non sentii che la rabbia e ’l disprezzo cagionatomi da un’azione sì indegna. Mi difesi con tutta la forza e grazie alle mie ugne e alla mia mantiglia che mi copriva tutta e che per ventura io avea meco, lo ridussi che dovette contentarsi di prender il partito di sedurmi colle buone. Pianse. Pregò. Indegno! Figurati, la violenza m’è odiosa. Io l’odiava, ma che fare? E come liberarmi? S’io gridava, mia madre, donna impetuosa, avrebbe fatto un romor senza fine. Sarei stata la favola dell’albergo o di colui che avrebbe raccontata a suo modo l’avventura se io taceva. Da un altro canto, il dibattermi ch’io facea, l’altercar delle voci potea farmi sentire e che sarebbe mai stato se mia madre fosse venuta e avesse trovato meco un uomo a quel modo? Considera s’io lo detestava allora. Un poco dunque dibattendomi, un poco pregando, un poco ingiuriandolo, al fine, considerata da colui l’impossibilità di riuscire (vile!), mi pregò di tacer l’affare e uscì della stanza. Respirai, corsi alla porta, mi chiusi ben dentro e mi copersi nel mio letto, ma non chiusi più occhio. Il pericolo corso e la rovina mia che da un sol momento poteva esser prodotta mi tenne sempre svegliata. Non sapea qual partito prendere e mi risolsi di non far parola (Parigi, dicembre ). Il vivido racconto di Giustiniana ci trasmette un’idea molto chiara della vulnerabilità fisica e sociale di una giovane donna nel mondo del grand tour settecentesco. L’effetto che il racconto ebbe su Memmo, possiamo immaginare, fu ben diverso. Nella sua narrazione dell’evento, i dettagli su cui Giustiniana indugia – la coperta tirata via, la mantella che l’avvolgeva, persino la presenza dell’aggressore nel letto – dovevano evocare il suo corpo e i ricordi dell’amore fisico che lei e Memmo avevano conosciuto insieme. Complici di questa indiretta seduzione epistolare, la carta e l’inchiostro che ne fissano i dettagli servono a risvegliare i sensi di Memmo, a ravvivare la sua passione che affiora in superficie sotto forma di rabbia, gelosia, o una sensazione di frustrante impotenza. Anche noi veniamo sedotti, voyeuristicamente, mentre leggiamo nelle lettere di Giustiniana racconti come quello del moschettiere. Ma allo stesso tempo, ci mettono di fronte alla dura realtà di quanto caro potesse costare a una donna ciò che voleva un uomo. Ci troviamo a seguire Giustiniana nella sfida quotidiana di giovane donna del tempo che tenta di partecipare al gioco del corteggiamento secondo le proprie regole, non quelle di un uomo. SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI Narrazioni epistolari e parole taciute Giustiniana scrive con urgenza, rubando spazi e tempi in cui comporre le lettere. Il lettore percepisce la loro emotiva spontaneità. Eppure, quando vengono lette come un discorso continuo, queste lettere hanno una fortissima affinità con il romanzo epistolare. Incidenti di percorso dettati dal destino, disavventure, imprevisti romantici da cui Giustiniana può emergere trionfante o umiliata, ma che sempre suscitano pettegolezzi su di lei, servono a concatenare una serie di episodi sensazionali, melodrammatici e picareschi – persino un intreccio matrimoniale e una fuga coperta da un travestimento – conducendo la narrazione da una lettera all’altra. Nel periodo della fuga di Giustiniana da Parigi (quella raccontata da Casanova, per nascondersi in convento), la narrazione si fa polifonica: per un periodo di due mesi e mezzo non vi sono lettere sue. L’intreccio, la suspense, le prime spiegazioni sulla sua scomparsa, vengono avanzati e sorretti tramite delle lettere scritte a Memmo da un certo uomo d’affari francese, “F—”, dal poeta patrizio veneziano Tommaso Farsetti, residente a Parigi, e da Niccolò Erizzo, ambasciatore veneziano alla corte francese. Erizzo scrive a Memmo: Voi m’avete onorato di scrivermi due lettere nelle quali mi chiedete con gran premura cosa sia della Vostra bella Wynne che da molti giorni non Vi scrive, e della quale cominciate a intendere a parlar equivocamente con Vostra sorpresa, e perciò vorreste da me esatta relazione di quanto è seguito […]. Credo […] che sia affatto superfluo il dirVi più poiché penso, s’è vero quanto mi fu detto, che Voi sareste più in situazione d’informar me che io Voi. Tra l’altre cose si vuol credere che ella sia o corsa a Venezia o dove Voi l’avrete consigliata (Parigi, maggio ). Questa lettera, dal tono duro e accusatorio, lascia disorientato il lettore, incalzando la narrazione, fino a che, dopo due lettere di “F—” e una di Farsetti, si arriva a una lettera molto lunga di Giustiniana (diciannove pagine di manoscritto) che completa il dénouement di questo episodio carico di mistero e di tensione. Le lettere, che devono essere scritte e recapitate in segreto, che vengono intercettate e cadono in mano al “nemico”, svolgono appieno il ruolo di coprotagoniste in questa narrazione epistolare, proprio come Memmo, cui è affidato il ruolo di confidente, svolge un’altra delle funzioni che ci aspettiamo di trovare nei romanzi epistolari settecenteschi. Ma quando leggiamo le lettere di Giustiniana a Memmo siamo anche ben consci di quanto siano reali, di quanto ci dicano della vita di una giovane donna privilegiata e istruita alla metà del XVIII secolo – e di quanto non ci dicano. Perché, mentre le leggiamo, dobbiamo anche tentare di percepire le parole taciute di Giustiniana. Nel comparve sul mercato antiquario di Parigi una lettera manoscritta settecentesca senza mittente e senza destinatario, che dal contenuto tuttavia si desume sia stata indirizzata a Casanova. La calligrafia della missiva sembra proprio quella di Giustiniana. Le parole sono quelle di una donna disperata che chiede aiuto in una situazione estrema: «Metto nelle vostre mani la mia vita, la mia riputazione, il mio essere […] vi scongiuro a interessarvi per un’infelice che non ha nel caso suo d’altra risorsa che la morte se non si ritrova rimedio al suo stato». La lettera getta una nuova luce sull’annosa questione della divergenza tra la versione drammatica di Giustiniana riguardo a quest’episodio della sua vita e quella picaresca, erotica raccontata dal grande affabulatore libertino nelle sue memorie. NANCY ISENBERG Sappiamo dalle lettere di Giustiniana che, durante il suo soggiorno a Parigi, la ragazza era in procinto di sposarsi con uno degli uomini più ricchi di Francia, Alexandre La Riche de la Pouplinière. Minacciata a morte dagli avidi parenti di quest’ultimo, eredi designati del suo patrimonio, Giustiniana fuggì di nascosto in un convento e per salvaguardare la propria incolumità e per sfuggire alle pressioni materne al matrimonio con un uomo tanto più anziano di lei. Come si è già detto, secondo Casanova, Giustiniana aveva un’altra ragione per sottrarsi agli occhi del mondo: una gravidanza. La domanda ineluttabile che sospinge gli aficionados di Casanova in una direzione e gli estimatori di Giustiniana in quella opposta recita: quanto è attendibile il racconto di Casanova sugli altri dettagli? I lettori che hanno familiarità con le memorie di Casanova ben sanno che, oltre ai tanti fatti confermati da ricerche storiche, ci sono anche tantissimi ricordi confusi: nel racconto che ci interessa, ad esempio, si contano almeno una trentina di inesattezze riguardanti date, luoghi, nomi, successioni di avvenimenti e addirittura viene citata la presenza di una persona che invece era già morta all’epoca degli avvenimenti narrati. I dettagli erotici dei racconti casanoviani sono, ovviamente, di più difficile verifica rispetto ai dati anagrafici o alle cronologie degli eventi. E da un vero libertino, per definizione un affabulatore di narrazioni fantastiche, perché attendersi qualcosa d’altro? Difatti, un paragone veramente obiettivo tra le memorie di Casanova e le lettere di Giustiniana rivela semplicemente che non si può determinare, esclusivamente sulla base delle loro parole, se l’uno sia più attendibile dell’altra. E dunque, le suggestive incertezze e i dubbi stuzzicanti che emergono dalle differenze tra i due testi potevano essere considerati, fino a poco tempo fa, un arricchimento tendente ad aumentare il fascino delle lettere e della loro autrice. Ma l’apparizione della lettera di Parigi ha cambiato tutto. Il documento ha un effetto piuttosto sconcertante, poiché ci induce a riflettere: quanto era diversa la realtà di Giustiniana rispetto a quella che descrive nelle lettere a Memmo? Lontana dal suo unico vero amico, prigioniera di un rapporto di amara ostilità con la madre, Giustiniana era pronta a infliggere al suo corpo qualsiasi forma di abuso («non temo i dolori»), anche a rischio della vita, nel tentativo disperato di cancellare la sua sfortunata condizione. Priva di alternative, si vide costretta a rivolgersi a Casanova. Colui che ella definisce «insoffribile» in una lettera a Memmo diventa nella lettera a Casanova stesso il suo «angelo tutelare». Perché nelle sue lettere a Memmo non trapela nulla di tutto questo? Ovviamente non poteva scrivere di tali questioni, non con il pericolo costante che le lettere cadessero tra le mani di qualche “nemico”. «Devo dirti molte cose» scriveva Giustiniana, «ma tremo, se anche questa va smarrita o se cade in mano altrui» (Parigi, febbraio ). La sua reputazione correva il rischio troppo alto di venire irrimediabilmente compromessa. Ma non era solo la sua reputazione a rischio: mentre era nascosta in convento, fu coinvolta nel processo contro Casanova, sospettata di essere lei la ragazza che il libertino aveva condotto dall’ostetrica e per quel che lei sapeva, l’aborto, o anche il solo tentativo d’aborto, veniva punito con la morte. Aveva scritto a Memmo dal convento di Conflans, «Credo che la levatrice sarà impiccata a momenti» (Conflans, giugno ). La lettera messa all’asta a Parigi dimostra quanto non solo quella lettera ma l’intera corrispondenza di Giustiniana a Memmo sia un raro e potentissimo brano della storia del desiderio e della sessualità femminili, di ciò che doveva essere taciuto e di ciò che si poteva rivelare. SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI L’esistenza della lettera recentemente scoperta indubbiamente accredita la versione di Casanova riguardo alla fuga di Giustiniana da Parigi. D’altro canto, non abbiamo modo di giudicare l’attendibilità di quei passi del suo racconto che dispiegano i dettagli degli incontri nell’attico e delle pozioni magiche. Tuttavia, a questo proposito, conviene prendere atto che il mondo illuminato e anticonformista di Giustiniana e di Casanova è assimilabile, per molti aspetti, agli anni Sessanta e Settanta del Novecento, in Europa e negli Stati Uniti, quando la libertà sessuale era emblema di una grande crisi culturale, pur esprimendo desiderio autentico di libertà individuale. Dubito che Giustiniana fosse così ingenua da credere alle pozioni magiche di Casanova: se gli si concesse (e, ci si può domandare: abbiamo davvero bisogno o diritto di saperlo?), l’avrà fatto, con tutta probabilità, in quello spirito di sperimentazione. Una cronaca del mondo materiale e sociale L’interesse per le lettere di Giustiniana non è certo limitato all’episodio parigino e all’intreccio della sua storia con quella di Casanova. Mentre Giustiniana viaggia e si adatta a nuove situazioni, si rivela anche molto in sintonia con il mondo materiale e sociale in cui vive, e applica la propria intelligenza al compito di catturare e rappresentare quel mondo per Memmo. Le lettere di Giustiniana offrono un resoconto gradevolissimo, e straordinariamente originale, del suo grand tour. Da Vicenza a Verona, da Milano a Torino, da Parigi a Bruxelles a Londra, la giovane donna condivide con Memmo le proprie impressioni della vita delle città mentre visita palazzi reali, passeggia nei loro giardini, partecipa a serate di gala all’opera, osserva il re a cena a Versailles. Giustiniana ha l’occhio penetrante e una penna talvolta spietata quando si tratta di moda, gusto e presenza estetica. A Milano i vestiti delle donne sono ben più aggraziati dei loro volti. A Torino, l’opposto. Quanto agli uomini, sono sciocchi a Milano, maldestri nel corteggiamento a Torino, ma magnifici a Parigi, con i loro panciotti ricamati in oro, le scarpe dai tacchi rossi, i toupet arricciati. Giustiniana ammira il modo di recitare della leggendaria Clairon, ma la delude il famoso castrato Tenducci (Londra, novembre ). Ovunque vada, comunica le sue descrizioni di vita a Memmo associandole a una loro esperienza condivisa, un amico o una conoscenza in comune nel loro ambiente, un luogo dove usavano incontrarsi. Il mondo sociale di Giustiniana, prima a Venezia e poi in viaggio, si snoda attorno a una rete di anticonformisti e liberi pensatori, schietti riformatori politici e sociali. Voltaire, che lei nomina in diverse occasioni, era uno dei loro luminari. Alcuni erano massoni: negli anni delle lettere di Giustiniana, una rete sotterranea di affiliati alla massoneria stava propagandosi attraverso l’Europa, dando origine a una potente minaccia sovversiva contro la Chiesa e lo Stato. Il grand tour era per alcuni una missione massonica segreta; per altri, il circuito massonico si identificava appieno con l’itinerario del tour. I frammassoni avevano il dovere di aiutarsi l’un l’altro e di offrire ospitalità. Il padre di Giustiniana era stato vicino alla massoneria, così come lo era Memmo. In tal modo (se la mia interpretazione dei dati è corretta), la giovane percorreva l’Europa sotto la tacita protezione di due generazioni di confratelli, ottenendo ad esempio il permesso, altrimenti impossibile, di risiedere a Parigi mentre francesi e inglesi erano in guerra. Così sembra che la massoneria fosse sem- NANCY ISENBERG pre discretamente presente ai margini del mondo privato di Giustiniana, determinando talvolta piccole svolte e insinuandosi, senza clamore, nel suo vissuto. Il desiderio di indipendenza Per quanto determinata emotivamente e intellettualmente, come donna Giustiniana era ben consapevole di quanto fossero limitati la sua indipendenza e il suo potere nel mondo sociale e materiale. Come donna non aveva denaro proprio, né alcuna altra proprietà di cui potesse disporre liberamente. Eppure, era capace quanto un uomo di desiderare potere economico. Con un tale potere – immaginava – avrebbe ingaggiato un pittore per farsi fare un ritratto per Memmo («ma questi pittori di vaglia ne chiedon tanto che non posso per ora farti questo piacere», Parigi, dicembre ), oppure avrebbe diviso le sue ricchezze con lui («Vedi qual raggio di fortuna mi si presenta, fortuna che, lasciandomi libera, potrei, com’è l’unico mio pensiero, divider teco?» Parigi, s.g., febbraio ), potendo «dar dipendenza dove ora dipendo» (Bergamo, ottobre ). Giustiniana sognava di esercitare influenza politica tramite un’amicizia con qualche uomo potente che avrebbe ascoltato i suoi consigli. «Non diffidar», scrive a Memmo, «ch’io non sia ancora per far eleggere a mia istanza […] un viceré o un governatore in America» (Bruxelles, settembre ). Il matrimonio per Giustiniana significava «perdere quella libertà che pregerò sempre sopra ogni ricchezza, perché può lasciar e la quiete dell’animo e la scelta di quasi tutte le cose» (lettera senza data, febbraio ). Erano questi i suoi pensieri durante il soggiorno a Parigi nell’inverno del . Sei mesi più tardi, a Londra, era ancora dello stesso avviso, come appare evidente quando esclama: «Un mari est une vilaine chose! [Un marito è una brutta cosa!]» ( ottobre ). È Memmo, invece, che vuole vederla “sistemata” in una relazione stabile. Giustiniana ribatte che non è interessata al matrimonio, che non aspira a diventare la moglie di un duca o di un “milord” come lui vorrebbe: «Sai tu ch’io credo già, come al solito, di non maritarmi mai? E ch’io penso di far della mia dote un vitalizio per migliorar la mia condizione? […] intanto ho scritto a Parigi per aver informazioni sufficienti perché colà gl’interessi vanno assai più alto» (Londra, novembre ). Ma rifiutare il matrimonio non è una decisione facile da prendere. Le pressioni sociali e familiari sono enormi. La “giusta” sistemazione le darebbe la sicurezza economica che le manca. Nonostante tutti prevedano per lei un marito a Londra, Giustiniana scrive: «Penso solo a scegliere un luogo per mia dimora che sia e di mio genio e di libertà» (Londra, giugno ). Nel mondo di Giustiniana e nella sua scrittura, rango, stato e condizione sono fondamentali coordinate di identità, che segnalano la posizione di ognuno sulla scala sociale. Alcuni suoi amici e conoscenti erano nati nei ranghi più alti, altri avevano migliorato il proprio stato nella vita tramite il matrimonio o l’affermazione intellettuale. Giustiniana misurava la loro condizione, e la propria, in base al reddito annuale, il valore in proprietà, e i mutamenti di fortuna, in meglio o in peggio: J’ai pourtant fait connoissance avec une aimable personne. C’est une jeune fille de bonne maison a ans, assez mignonne et très vive. Étant héritière de deux cent mille livres sterlins elle vient d’en être privée par son père qui sembloit l’adorer et qui ne SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI possedoit que cette unique enfant. Les personnes aux quelles il a laissé son bien ne lui furent jamais connues. Elle est a la chancellerie et l’on espère qu’elle fera casser au parlement ce testament barbare [Ciò nonostante, ho conosciuto una persona amabile. È una giovane di buona famiglia di diciott’anni, piuttosto carina e molto vivace. L’erede di duecento mila sterline, ne è stata privata da suo padre il quale pare l’adorasse e che aveva questa unica figlia. Non ha mai conosciuto le persone a cui egli ha lasciato questo tesoro. Si è rivolta alla cancelleria e si spera che riuscirà a fare invalidare dal parlamento questo testamento barbaro] (Londra, novembre ). Uno dei suoi racconti pettegoli sulle fortune e sfortune altrui ci riporta in vita una figura familiare, resa immortale da una celebre filastrocca inglese: Si parla qui assai d’una bellezza un po’ comune. Questa è la Kitty Fisher di dieci nove in vent’anni. Questa ragazza vive colla maggior splendidezza possibile, spende dodici mila lire l’anno ed è la prima del suo rango che abbia livree e le dia sino a’ portatori della sua sedia. Dappertutto se ne veggono stampe. È piccola e non mi par bella. Gl’inglesi però la credono ed è lo stesso. È famosa la disputa che questa ragazza ebbe con Milady Coventry. Son sempre messe al paragone l’una dell’altra, e la Coventry non isdegna di aver una somma gelosia di questa sua rivale. Incontratesi un giorno al parco a cavallo, milady chiese alla Kitty chi fosse il sarto che avea fatto il suo abito e dall’altra le fu risposto ch’essendo quell’abito un regalo di Milord Coventry, poteva ella chiederlo a lui. Milady la chiamò impertinente e l’altra le disse che l’aver trovato un pazzo di milord che l’aveva sposata mettea tra loro la sola differenza che le dovea far sopportar questa ingiuria, ma che anch’ella volea sposare un altro milord unicamente per renderle la pariglia e torle il passo (Londra, novembre ). Scrivere della vita di altre donne portava Giustiniana a riflettere sulla propria condizione: «Ah, io era nata in verità per uno stato più comodo. Intanto non so ben adattarmi al mio» (Londra, febbraio ). Nutrire un tale desiderio non era insensato allora: nel mondo di Giustiniana, i sogni che prevedevano una scalata sociale potevano in effetti avverarsi. Questa realtà si trovava colta e rappresentata nei tanti romanzi che riempivano le bancarelle di libri del tempo e che tenevano in vita quegli stessi sogni. I protagonisti erano giovani uomini e donne che iniziavano il loro viaggio verso l’età adulta, animati dal desiderio di mutare stato sociale, in un modo o nell’altro. Moll Flanders, Pamela, Joseph Andrews, Tom Jones provenivano da un ambiente diverso, ma la posizione sociale di Evelina, protagonista del romanzo omonimo di Fanny Burney, era simile a quella di Giustiniana, e come lei, la giovane donna dovette affrontare questioni di legittimità legate alla propria nascita e situazione sociale. Le lettere di Giustiniana possono essere lette in perfetta armonia con il genere settecentesco del romanzo di formazione. Le lettere di Giustiniana, che coprono un periodo di due anni, terminano quando lei e la sua famiglia, delusi dalla vita in Inghilterra, colti da nostalgia di Venezia, fanno ritorno in Italia nell’autunno del . La famiglia si stabilisce temporaneamente a Padova, mentre la signora Wynne predispone un’adeguata abitazione a Venezia. Mentre Giustiniana attende l’imminente incontro con Memmo, riflette sulla propria situazione, pienamente consapevole del fatto che lei e Memmo non potranno ricominciare da dove la loro relazione si era interrotta. Nel frattempo Memmo, costretto da pressioni sociali, ha iniziato una relazione con un’amante ufficiale, e tutta Venezia, dalle spie degli Inquisitori ai pettegoli locali, è pronta a NANCY ISENBERG osservare ogni loro mossa. La giovane gli dice: «Noi non dobbiam crederci e poveri noi davvero se ascoltassimo ancora i nostri cuori. Io non so che mi dica il mio per voi ma certo che s’egli si facesse sentire, non guadagnerebbe nulla perch’io ho giurato di esser sorda» (Padova, novembre ). Così, mentre dignità e orgoglio faticosamente tentano di dominare il desiderio, la corrispondenza di Giustiniana si interrompe. Revisioni e adattamenti Anche se le lettere di Giustiniana furono scritte originariamente per gli occhi di Memmo soltanto, a un certo momento, nell’ultima decade del XVIII secolo, circa quarant’anni dopo la fine della loro relazione e probabilmente dopo la morte di entrambi, le lettere che lei gli scrisse furono ricopiate con cura in tre serie di volumi da almeno tre diverse mani anonime. A noi sono giunte queste copie manoscritte, non le lettere originali. Sono queste le lettere che iniziarono ad apparire intorno al a Venezia, e nei dintorni della città, e che richiamarono l’attenzione degli specialisti di Casanova, rilanciando l’interesse per Giustiniana nel XX secolo. E i manoscritti manifestano chiaramente l’intenzione che dev’esserci stata di offrire, a un certo punto, le lettere al pubblico. Ci sono validi motivi per credere che la stessa Giustiniana stesse lavorando su un’edizione delle lettere scritte a Memmo quando morì. Quasi tutte le altre sue opere possono essere lette, sotto una certa luce, come preludio a un tale progetto, perché in tutte vi è l’eco della storia d’amore che li vide protagonisti. Il primo volume che pubblicò era stato scritto in forma di lettera, indirizzata a «mon cher frère», anche se, in questo caso, si riferiva al fratello reale, Richard; nella raccolta dei suoi saggi si trovano memorie su cui indugia nel ricordo del suo primo grande amore; scrisse un’allegoria sulla costanza in amore in onore del matrimonio della figlia maggiore di Memmo, a lui dedicandola esplicitamente; l’ultima opera a stampa racconta una storia d’amore giovanile troncata dall’inimicizia altrui e dalla diversità. Questo racconto, ambientato tra i popoli primitivi morlacchi rivela anche un interesse condiviso con Memmo, il quale all’epoca stava scrivendo delle relazioni rivolte ai senatori della Serenissima su interventi umanitari a favore proprio di quei popoli. Dopo la pubblicazione di Les Morlaques, nel , a mio avviso Giustiniana si appresta a curare un’edizione delle sue lettere a Memmo. Quali potrebbero essere stati i criteri per la revisione di quella corrispondenza, tesoro di potenti ricordi, di appassionati sogni e delusioni giovanili? È naturale per uno scrittore “migliorare” i propri ricordi per ottenere l’effetto narrativo desiderato e per far risplendere nel racconto un’incarnazione migliore del proprio sé. È normale che agiscano forze psicologiche potenti, che siano consciamente riconosciute o no da chi scrive. Giustiniana, nel curare un’edizione delle sue lettere a Memmo negli anni della sua maturità, potrebbe avere anche assecondato un moto narrativo liberatorio per affrontare dei ricordi estremamente penosi e pieni di rimpianto. Riflettere sugli impulsi che possono entrare in gioco in queste circostanze ci porta a immaginare simili meccanismi in opera al momento dell’originaria stesura. Nell’atto della scrittura, a parte l’autocensura già menzionata risultante da pressioni più sociali che psicologiche, quanto della costruzione del sé di Giustiniana ha alterato il modo in cui le lettere originali riflettevano (o non riflettevano) le sue reali SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI esperienze di vita? Un commento di lei stessa, scritto trent’anni più tardi, solleva più di un dubbio a questo riguardo. In una rivisitazione degli anni della giovinezza, Giustiniana ricorda come «the contradiction and the opposition [le contraddizioni e le opposizioni]» dell’amore per Memmo l’avevano portata a un tale stato di passione che aveva «no other nourishment than variety of reading, no other relief than writing without end [nessun altro nutrimento che la varietà della lettura, nessun altro sollievo che lo scrivere senza fine]». Confessò che le sue letture erano analoghe allo stato della sua mente, e che si riconosceva «in all the lovesick and unfortunate heroines who occurred in [her] books [in tutte le eroine infelicemente innamorate che comparivano nei suoi libri]». E dunque, quanto delle eroine di romanzi come Pamela () e Clarissa (-) di Samuel Richardson, o Lettres de Mistress Fanni Butlerd à Milord Charles Alfred () di Marie Jeanne Riccoboni, influenzò la proiezione del sé nelle lettere? Ed è forse incauto aggiungere a questa lista The Female Quixote () di Charlotte Lennox, la cui eroina, come Giustiniana, tendeva a rendere indistinte la propria identità e la propria esperienza da quelle delle eroine dei suoi testi? Sulla base di questa “confessione” di Giustiniana, sembra legittimo porre la questione di altre possibili influenze letterarie, forse più attinenti alla decisione di pubblicare le lettere che a una loro revisione negli ultimi anni della decade del . Le lettere, così come le conosciamo oggi, possono essere lette, per certi versi, come una mediazione tra due romanzi epistolari “bestseller” del tempo: Julie o la nouvelle Héloïse () di Jean-Jacques Rousseau e Les Liasons Dangereuses () di Choderlos de Laclos. Il primo, la storia di un amore impossibile, in cui la differenza di classe gioca un ruolo importante, fu uno dei romanzi più popolari del suo tempo. Nei primi anni della decade del , Les Liasons Dangereuses, storia di intrighi, macchinazioni e inganni mossi da passioni diaboliche, divenne celebre all’istante in tutta Europa, con scandalo di molti. Entrambi i romanzi, in modi differenti, anche opposti, invitano il lettore a una riflessione sui meccanismi che all’epoca regolavano il mondo del desiderio, sui limiti estremi cui ci si può spingere per colpa di passioni frustrate, sulle restrizioni e i freni imposti alla passione dalle norme e dalla morale della società. Giustiniana, forse, come dicevo, vide la propria storia nelle lettere come una via di mezzo tra queste due narrazioni. E proprio questa presa di coscienza, dato il vasto successo dei due romanzi, la incoraggiò forse a mettersi al lavoro, per preparare un’edizione delle lettere. È un’ipotesi e niente di più, generata dall’irresistibile desiderio di penetrare i misteri che circondano i manoscritti, e non è l’unica. Giustiniana non può avere ignorato l’intenzione di Casanova di scrivere le sue memorie: egli l’aveva dichiarata nell’ Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu’on appelle les Plombs che uscì nel . E quindi potrebbe avere deciso di non lasciare a Casanova l’ultima parola e aver voluto dare al mondo la propria versione. Non credo affatto che Giustiniana affabulasse quanto Casanova. Tuttavia, al di là di ogni contesa sulla veridicità delle loro narrazioni parallele, così come apprezziamo i racconti di lui riconoscendovi proiezioni tipiche del desiderio maschile, possiamo godere di quelli di lei come altrettante esplorazioni del cuore femminile. E Memmo? Le ipotesi su un suo ruolo nella faccenda si rivelano molto più intricate delle due precedenti. All’avvicinarsi dell’ultimo decennio del Settecento, quando Giustiniana stava presumibilmente preparando le lettere per la pubblicazione, NANCY ISENBERG Memmo aveva raggiunto l’apice della sua carriera politica: vedovo teneramente dedito all’educazione delle due adorate figlie, Lucietta e Paolina, era da poco rientrato a Venezia da Roma, dove per diversi anni aveva ricoperto l’incarico di ambasciatore presso la Santa Sede. Le strade di Memmo e Giustiniana si erano apparentemente divise per sempre dopo il ritorno della giovane a Venezia e il matrimonio di lei con il conte Rosenberg Orsini, avvenuto poco dopo, anche se sussistono prove del fatto che in realtà continuarono a incrociarsi in pubblico: avevano amici in comune (ed esiste almeno un incontro documentato presso la villa del senatore Querini); avevano interessi intellettuali affini (quali, ad esempio, i morlacchi di cui già si è parlato); entrambi si erano ingegnati per offrire un riconoscimento a stampa della loro amicizia memorabile (Giustiniana nelle sue memorie, Memmo in un’opera sulla pianificazione urbana). Negli anni della sua ambasceria romana, Memmo rifletteva sul caro carteggio della sua giovinezza, con un occhio all’interesse che avrebbe potuto avere per il grande pubblico. Lo sappiamo da una lettera che scrisse nel a un amico toscano al quale confidò che conservava «almen trenta tomi» della sua corrispondenza con Giustiniana. E nella stessa lettera, considerando la mancanza tra i libri scritti nello «stil familiare italiano de’ buoni esemplari» riteneva «non essere inutili» le lettere di Giustiniana. Superato lo stupore per la consistenza di quel carteggio – ben trenta tomi! – e la frustrazione per il suo quasi totale smarrimento, viene forte il sospetto (ricordando il ruolo di promotore di Memmo, per esempio, nel progetto per conquistare La Pouplinière) che egli fosse stato ancora una volta l’ideatore di un importante progetto nella vita di Giustiniana. Lei aveva da poco pubblicato a Londra i volumi di essais, il cui successo immediato è registrato nella ristampa, nello stesso , di alcuni racconti su “The European Magazine” e nelle diverse edizioni italiane di uno di essi. L’influenza di Memmo sulla revisione delle lettere, a mio avviso, non si sarebbe limitata al suo ruolo di ideatore di un’edizione a stampa e riguarderebbe anche la memoria di lui giovane, l’oggetto del desiderio della giovane Giustiniana, l’altra metà silenziosa nei discorsi delle sue lettere. Gli indizi su cui si fonda la mia supposizione vanno cercati in una delle lettere di Giustiniana, dove tale influenza è celata da un codice segreto. I codici erano sempre stati presenti nella loro relazione, sin dagli inizi, e pare fossero sopravvissuti sino al momento in cui Giustiniana approntava un’edizione delle lettere. Qui, occorre chiarire il retroscena: molto prima che Giustiniana partisse da Venezia, Memmo aveva ideato un linguaggio segreto fatto di gesti e di sguardi da usarsi negli incontri in pubblico, e un protocollo amoroso costituito da un alfabeto in codice, utilizzato nelle comunicazioni scritte più compromettenti. Inoltre, i due innamorati erano abituati a pensare per apologhi, dei quali si erano nutriti negli anni della loro educazione. Raccontini aneddotici ricchi di significati nascosti, gli apologhi costituivano un’altra forma di messaggio in codice. L’apologo era stato uno degli strumenti pedagogici preferiti dall’abate francescano Carlo Lodoli, l’istruttore amato e stimato, nonché carissimo amico sia di Memmo che di Giustiniana. Più tardi nella vita, precisamente nel , Giustiniana avrebbe pubblicato un essay in lode dell’apologo e Memmo, due anni dopo, avrebbe pubblicato una raccolta degli apologhi di Lodoli. L’indiscutibile influenza che il Lodoli esercitò sia su Giustiniana che su Memmo e la passione per gli apologhi che egli trasmise loro portano la nostra attenzione su SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI una lettera in particolare della corrispondenza di Giustiniana con Memmo. Si tratta di una lettera che Giustiniana scrisse a Parigi durante l’inverno del . Sotto l’egida di Memmo, la ragazza attuava il suo piano volto a conquistarle un posto nel cuore di Monsieur de la Pouplinière. Negli anni della vecchiaia, quest’ultimo aveva sviluppato una forte ma volubile ammirazione per giovani bellezze, e quando infine le scartava, provvedeva a sistemarle dal punto di vista economico. Giustiniana mirava più in alto: voleva un contratto di matrimonio. Se avesse giocato bene le carte di cui disponeva, avrebbe risolto molti dei problemi che la facevano temere per il futuro: acquisire sicurezza economica, stabilirsi a Parigi, ora che era stata estromessa dalla “buona” società veneziana, avrebbe significato migliorare la propria posizione sociale. Esercitando tutto il fascino per cui era nota, sembrava davvero avere incantato La Pouplinière. In quella che forse è la più sottilmente seducente di tutte le sue lettere, Giustiniana scrisse a Memmo del regalo che presentò a La Pouplinière in occasione del suo onomastico: «[…] e presa una forbice, tagliai una cordella nera ch’io avea al collo, appeso alla quale era un picciol cuore d’oro smaltato ch’io avea nel seno: “Tenez [Tenete]”, gli dissi. “Il vous faira souvenir du mien [Sarà un mio ricordo]”» (Parigi, febbraio ). Il resoconto è tanto elegantemente seducente quanto lo fu il gesto stesso. Giustiniana, dipingendo a Memmo la scena, evoca il calore della pelle del suo collo e del suo seno e la rende insopportabilmente allettante; gli offre la visione di un suo gesto liberatorio nel taglio del nastro e lo provoca ancora di più quando estrae lentamente il tesoro nascosto – il piccolo cuore d’oro smaltato – dal seno. Nella sua mente, possiamo ben immaginarlo, Memmo può intendere la voce distante di lei che sussurra: «Tenete». E quindi il resoconto di Giustiniana diventa un souvenir per Memmo come in un’altra occasione lo era stato un suo ritratto, nonché un trofeo del successo nell’eseguire il piano di lui. Trent’anni più tardi, allorché Giustiniana rimaneggiava le sue lettere giovanili per farne offerta al pubblico, può averle intese anche come dono speciale per Memmo: come pegno affettuoso negli anni della maturità, suggello di ricordi cari della giovinezza. Difatti, non è quel cuoricino d’oro che Giustiniana nascondeva in seno una perfetta analogia delle lettere stesse (la preziosa narrativa del suo cuore) rielaborate (così come il cuore è smaltato) e offerte in dono? E chi meglio di Memmo, il suo eterno corrispondente in codice, poteva decifrare quel messaggio subliminale e criptico? Così è, almeno, nella mia visione. Non ci sono prove. Possiamo solo immaginarlo. La trasmissione delle lettere Pochi anni erano trascorsi dall’identificazione di Giustiniana come la misteriosa Mlle XCV delle memorie di Casanova quando negli anni Venti del Novecento, due volumi di lettere di Giustiniana a Memmo vennero alla luce nella Biblioteca Civica di Padova, la città dove Giustiniana visse gli ultimi anni della sua vita. Lo studioso Bruno Brunelli, che li aveva trovati, ne ricavò uno studio, Un’amica di Casanova . I volumi trovati da Brunelli riguardano due periodi diversi nella vita di Giustiniana: il primo presenta lettere non datate risalenti a un periodo che precede di molto la sua partenza da Venezia; il secondo riprende dopo un lasso di tempo di più di un anno, quando il mistero intorno alla scomparsa di Giustiniana a Parigi sta per svelarsi. NANCY ISENBERG Trent’anni dopo la scoperta di Brunelli, venne trovato il volume “mancante” delle lettere di Giustiniana. Il fortunato scopritore, il collezionista americano casanoviano J. Rives Childs, lo acquistò da un antiquario veneziano. Questo volume, finalmente e per la grande gioia degli appassionati di cose casanoviane di tutto il mondo, fece conoscere la versione di Giustiniana riguardo alla sua vita nel periodo antecedente la fuga in convento. Childs scovò, insieme a quest’ultimo, anche un altro volume, identico al secondo della collezione di Padova. Qualche anno dopo questa felice scoperta, venne alla luce un’ulteriore raccolta delle lettere, rinvenuta anch’essa a Venezia, che, come quella di Childs, consisteva di due volumi riguardanti il periodo di assenza da Venezia. Le due raccolte trovate a Venezia si rassomigliano moltissimo: a tal punto che ci si convince che l’una sia una perfetta imitazione dell’altra; persino la disposizione delle parole, riga per riga, è identica. Dunque, oggi conosciamo l’esistenza curiosamente simmetrica di una copia del primo volume, di due copie del secondo e di tre copie del terzo; tre raccolte, tutte incomplete, e nessuna notizia delle lettere originali. Perché le lettere furono copiate molti anni dopo in varie serie differenti, da chi e come, e perché furono incluse lettere non scritte da Giustiniana e lettere non indirizzate a Memmo? Mentre queste domande restano senza risposta, sembra chiaro che Memmo anche qui dev’essere stato coinvolto, almeno nella conservazione delle lettere di Giustiniana e di quelle su di lei indirizzategli da altri. Ci si può immaginare una restituzione: forse in occasione del matrimonio di Giustiniana con l’anziano ambasciatore imperiale Rosenberg Orsini nel , o ancora, qualche decennio più tardi quando Giustiniana era ormai divenuta una scrittrice affermata, quando la prosa epistolare di voce femminile – vera o inventata – era molto in voga. Un altro nome che non deve essere omesso, quando si parla della trasmissione delle lettere, è quello di Bartolomeo Benincasa, cavalier servente e collaboratore letterario di Giustiniana negli ultimi anni della sua vita. Quasi sicuramente la sua mano ebbe un ruolo nella redazione delle copie manoscritte. Era un personaggio inviso a molti, infastiditi dalla figura piccola e goffa, dalle sue maniere artefatte e dalla sua boria. Eppure Giustiniana lo accolse generosamente nella sua vita – forse perché la divertiva esasperare la cerchia che la circondava con la presenza di un personaggio insopportabile a tutti eccetto che a lei – ed egli le era devoto all’estremo. Sappiamo che egli assistette Giustiniana nel nella stesura del romanzo Les Morlaques e che fu lui a occuparsi, nello stesso anno, della seconda edizione, così come l’anno precedente aveva curato la seconda edizione di Alticchiero, la guida filosofica che Giustiniana scrisse alla villa del suo amico Querini. Pertanto, come non supporre che la collaborazione di Benincasa non continuasse anche per le lettere? In una lettera indirizzata a Ippolito Pindemonte nel , due anni dopo la morte di Giustiniana, Benincasa lo informava del proprio «fervidissimo» desiderio di «pubblicare una nuova edizione dell’opere della Contessa nostra, sempre cara e preziosa memoria, molto più corrette, e accresciute di un buon terzo sopra i manoscritti che mi ha lasciato». I conti tornerebbero se identificassimo in quel «buon terzo» i tre volumi delle lettere. È plausibile che le figlie di Memmo o la famiglia di Giustiniana si siano opposti alla pubblicazione di un carteggio tanto intimo e che per questo l’edizione non vide mai la luce, ma non si sa perché non uscì nessun altro volume della collezione proposta. Tuttavia, Benincasa non abbandonò il suo progetto editoriale. Lo sappiamo da SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI due lettere di Melchiorre Cesarotti, una indirizzata a Benincasa e l’altra a Francesco Rizzo. Le lettere non sono datate, ma dal contenuto si possono collocare nel . In quell’anno, Benincasa era impegnato in un nuovo tentativo per fare stampare le opere complete di Giustiniana. Scriveva agli amici, inviando loro il manifesto della pubblicazione perché potessero cercare associati all’impresa. Cesarotti, il quale figurava tra questi amici, informava poi l’amico Rizzo che «il Benincasa in Milano sta per pubblicare la collezione delle opere di Madama di Rosemberg in Tomi di forma ottava e di bella stampa». Le opere di Giustiniana fino ad allora in stampa erano cinque, se contiamo solo una volta gli essais, pubblicati sia in inglese che in francese. Aggiungendo i tre volumi delle lettere, si arriverebbe agli otto tomi di cui scriveva Cesarotti. Infatti, egli le nominò esplicitamente: «Le sue lettere saranno specialmente interessanti pel suo esteso commercio di vario genere». Quindi, oltre all’ipotesi che Benincasa avesse partecipato, in una prima fase, al progetto editoriale di Giustiniana, abbiamo la conferma che, dopo la morte della sua contessa, aveva promosso la loro pubblicazione. Averlo scoperto rese d’obbligo un confronto tra la calligrafia di Benincasa e quella delle raccolte manoscritte delle lettere: nel raffronto con i volumi che erano di Rives Childs, la scrittura si presenta indistinguibilmente tonda, chiara e regolarissima, tanto da potere supporre (la conferma definitiva richiederebbe una perizia di un esperto) che Benincasa stesso avesse trascritto quella copia. Dei tre volumi delle lettere di Giustiniana, ci siamo concentrati principalmente in questo saggio sugli ultimi due, quelli che corrispondono al periodo di assenza di Giustiniana da Venezia. E questo perché, come ho cercato di dimostrare, questi volumi sono dotati di un’autonomia e una continuità narrativa e temporale tali che si possono leggere come un romanzo epistolare. È vero che rimangono ancora tanti dubbi intorno ai manoscritti giunti a noi: quanto corrispondono alle lettere originali? Quali piccoli o grandi omissioni o ritocchi le hanno rimodellate? E per mano di chi? Possiamo in piena coscienza escludere l’ipotesi che il lavoro di trasmissione dal carteggio originale alle raccolte trascritte sia avvenuto interamente dopo la morte di Giustiniana, per mano di Benincasa? Che Memmo abbia collaborato con o promosso una tale iniziativa? In ogni caso, al di là di ogni ipotizzabile influenza, necessitata o voluta, conscia o inconscia, per mano di Giustiniana e di qualche altro revisore con un forte investimento affettivo, d’accordo con lei o dopo la sua morte, le raccolte delle lettere giunte a noi catturano l’essenza dell’esperienza personale di Giustiniana, dandole un significato intramontabile. La loro riedizione, imminente per i tipi di Elzeviro di Treviso e da me curata, porterà a termine finalmente quel progetto editoriale di renderle pubbliche desiderato, sostenuto e promosso da chi ha creduto nel loro grande valore letterario e culturale. Appendice Le opere di Giustiniana Wynne, Contessa Rosenberg Orsini, comprese le ristampe e le traduzioni (in ordine cronologico): Du sejour des comtes du Nord à Venise en janvier MDCCLXXXII. Lettre de M.me la comtesse douairiere des Ursins, et Rosenberg à M.r Richard Wynne, son frere, à Londres. [Venezia]. NANCY ISENBERG [Du sejour]. Del soggiorno dei Conti del Nord a Venezia in Gennaro del MDCCLXXXII. Lettera della Contessa Giustiniana degli Orsini e Rosenberg a Riccardo Wynne, suo fratello, a Londra. Dal francese recata in italiana [Venezia]. [Du sejour] Del Soggiorno de’ Conti del Nord in Venezia nel Gennaio MDCCLXXXII. Lettera di Madama la contessa Vedova degli Orsini di Rosenberg al Signor Riccardo Wynne suo Fratello a Londra. In Vicenza nella Stamperia Turra. Moral and sentimental essay on miscellaneous subjects, written in retirement, on the banks of the Brenta, in the Venetian state, by J. W. C.-t-ss of R-s-g. London, printed for J. Robson, New Bond Street. Piece morales & sentimentales de Madame J. W. C—t—sse de R—s—g. Ècrites à une Campagne, sur les Rivages de la Brenta, dans l’État vénitien. A Londre. Chez J. Robson, New Bond Street. “The Talisman of Truth: A Tale”, from the Countess of Rosenberg’s “Moral and Sentimental Essays”, in “The European Magazine”, (July), pp. -. Deo and Bettina: A Venetian Story’ from the Countess of Rosenberg’s “Moral and Sentimental Essays”, in “The European Magazine”, (September), pp. - [prima parte]. Deo and Bettina: A Venetian Story’ from the Countess of Rosenberg’s “Moral and Sentimental Essays”, in “The European Magazine”, (October), pp. - [seconda parte]. Deo and Bettina: A Venetian Story’ from the Countess of Rosenberg’s “Moral and Sentimental Essays”, in “The European Magazine”, (November), pp. - [terza parte]. [Deo and Bettina] Il trionfo de’ gondolieri; ovvero, novella viniziana plebea, scritta in idioma francese da Madame G. W., C—t—ssa di R—s—g. Recata nell’italiano da L[odovico] A[ntonio] L[oschi]. In Venezia nella stamperia Graziosi a S. Apollinare. [Deo and Bettina] Il trionfo de’ gondolieri; ovvero, novella viniziana plebea, scritta in idioma francese da Madame G. W., C—t—ssa di R—s—g. Recata nell’italiano da L[odovico] A[ntonio] L[oschi]. In Bologna, per il Longhi. [Deo and Bettina] Il trionfo de’ gondolieri; ovvero, novella viniziana plebea, scritta in idioma francese da Madame G. W., C—t—ssa di R—s—g. Recata nell’italiano da L[odovico] A[ntonio] L[oschi] e pubblicata dall’abate Chiari, Napoli, nella stamperia Avelliana. [?] Alticchiero, a M. Huber de Genève. Par Madame J. W. C. D. R. [s.l. s.d.]. À André Memmo Chevalier de l’Étole d’or et procurateur de St. Marc, à l’occasion du mariage de sa Fille Ainée avec Louis Mocenigo. Venezia, aprile : Stamperia Giuseppe Rosa. Alticchiero. Par Mad.e J. W. C. D. R. à Padoue [ma Venezia, per i tipi di Nicolò Bettinelli]. Les Morlaques par J. W. C. D. U & R. S.l. Les Morlaques, roman historique, descriptif, et poëtique en prose. Par J. Wynne Comtesse des Ursins et Rosenberg, et B. B. À Modène, Société typographique. - [Les Morlaques] Die Morlaken, von J. Wynne, Gräfin von Ursini und Rosenberg aus dem Französischen übersetzt von S. G. Bürde, voll.: vol. I , Breslau; vol. II Halberstadt. [Deo and Bettina] Novella Viniziana, nella Biblioteca di villeggiatura, Napoli, G. B. Mobande. [Les Morlaques] traduzione di Giandomenico Stratico, rimasto inedito, ora perduto [V. Rudolf Maixner, Traductions et imitations du roman “Les Morlaques”, in “Revue des études slaves”, , , p. , anche per altre possibili traduzioni, adattamenti e imitazioni]. [Les morlaques] Jella, oder, Das morlachische Mädchen. Leipzig, Sommer. [Les morlaques] Costumi dei morlacchi. Padova, Conzatti A. S. Bartolommeo. SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI [Pièces] Riflessioni morali, e sentimentali di Madama Giustiniana Wynne Contessa di Rosenberg per la prima volta recate nell’idioma italiano. Roma, Pagliarini. [Pièces] Capitoli morali e sentimentali di Madama Giustiniana Wynne contessa di Rosenberg Orsini. Roma, Pagliarini [cfr. Libreria Antiquaria Gutenbert, Catalogo , Sezione , n. , ° semestre ]. [Pièces] Opuscoli morali e sentimentali di Madama F. [sic] W. Contessa di Rosenberg. Versione dal francese del professore Giovanni Barili. Sondrio, da Giovanni Battista della Cagnoletta. [ c.] [Deo and Bettina] La gran regata di Venezia. Milano, Venezia e Verona coi tipi di Paola Ripamonti Carfano. [Deo and Bettina] Nane Deo e Bettina, o sia la gran Regata. Novella Plebea [senza autore]. Milano-Venezia, Ripamonti. [Du sejour] Du sejour des comtes du Nord à Venise en Janvier MDCCLXXXII. Lettre de M.me la comtesse Douairière des Ursins, et Rosenberg à M.r Richard Wynne, son frère, à Londres, Elibron Classics (Adamant Media Corporation) Chestnut Hill (MA). Facsimile dell’edizione del . Note . Tra i pretendenti di Giustiniana ci fu il console britannico a Venezia Joseph Smith, bibliofilo e collezionista d’arte, ricordato oggi per avere creato il gusto inglese per l’arte veneziana e la fama di Canaletto in Inghilterra. Erano suoi, prima che li vendesse al proprio re, i libri e gli oggetti d’arte che oggi costituiscono il nucleo iniziale delle collezioni reali presso la British Library e il British Museum. Ci furono poi le attenzioni di Alexandre le Riche de la Pouplinière, che oltre a essere l’uomo più ricco di Parigi, contribuì in modo incisivo all’innovazione della cultura musicale in Francia promuovendo e dando spazio a molti nuovi artisti. Nei concerti della sua casa parigina e della sua villa a Passy vennero presentate alcune tra le opere più importanti del secolo. Ancora, il principe Dmitrij Galitzine, grande sostenitore dei contatti culturali franco-russi e scienziato di fama internazionale; il ministro prussiano Dodo Knyphausen, intermediario a Londra tra Federico il Grande e William Pitt nei negoziati dell’alleanza anglo-prussiana; il conte Philip Joseph Rosenberg Orsini, ambasciatore imperiale a Venezia; Giacomo Casanova, la cui grandezza sta forse nelle sue capacità di grande raconteur; Andrea Memmo, uno degli ultimi grandi statisti della Repubblica di Venezia. . Cfr., ad esempio, L. Wolff, Venice and the Slavs: The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment, Stanford University Press, Stanford (in particolare, The Morlacchi and the Discovery of the Slavs: From National Classification to Sentimental Imagination, p. ) che ricorda come la Wynne abbia scritto «per il pubblico cosmopolita d’Europa». . G. Gugitz, Eine geliebte Casanova’s, in “Zeitschrift für Bücherfreunde”, , pp. -, ristampato e ampliato in Id., Casanova und sein Lebensroman, Strache, Wien , pp. -. . «La ragazza, pur avendo solo quindici anni, era una bellezza e univa alle grazie del corpo quelle spesso ancora più seducenti della cultura» (G. Casanova, Storia della mia vita, a cura di P. Chiara e Federico Roncoroni, Mondadori, Milano , vol. II, cap. XIII, p. ). . J. Casanova de Seingalt, Histoire de ma vie, édité par F. La Cassin, Laffont, Paris (a ed. Leipzig-Paris -), vol. V, capp. VIII-XI. . Ho scelto di usare il nome di battesimo della Wynne in questo saggio per la consonanza con la figura della scrittrice da giovane innamorata e con il suo carteggio intimo. . Non tutti sanno che fu la madre di Memmo a denunciarlo presso gli Inquisitori per plagio dei figli; a quella denuncia seguirono l’arresto e la chiusura nei Piombi, la fuga e il celebre racconto. . Knopf, New York ; tradotto in tutte le principali lingue del mondo, in Italia con il titolo Un amore veneziano, Mondadori, Milano . . Ambasciatore imperiale a Venezia dal al . Rimasto vedovo nel , sposò Giustiniana Wynne il novembre . . Tuttavia il matrimonio le creò anche qualche difficoltà. Né i parenti di Roseberg Orsini né le autorità austriache si convinsero che Giustiniana potesse essere una moglie accettabile per un NANCY ISENBERG uomo del suo rango. Giustiniana produsse documenti e scrisse lettere nel tentativo di provare il proprio status sociale, ma non fu mai ricevuta alla corte austriaca. Cfr. B. Brunelli, Un’amica del Casanova, Sandron [Palermo ], pp. -. . Queste ultime fanno parte di una raccolta in due volumi che è decisamente una rarità editoriale, in quanto Giustiniana pubblicò la raccolta simultaneamente in inglese e in francese (quattro volumi in tutto) con il medesimo editore londinese J. Robson: Moral and sentimental essays e Pieces morales & sentimentales, . . Les Morlaques (), dedicato a Caterina la Grande, attirò l’attenzione, tra gli altri, di Johann Wolfgang Goethe (Italienische Reise, ), e di Charles Nodier (Mélanges tirés d’une petite bibliothéque, , pp. -). Madame de Staël attinse a Les Morlaques per alcune pagine di Corinne (cfr. R. Maixner, Traductions et imitations du roman “Les Morlaques”, in “Revue des études slaves”, , , p. ). Nelle parole dell’anonimo recensore nel “Nuovo giornale enciclopedico” (luglio , p. ), Les Morlaques era «un’opera originale, che lasciamo ai Dottori la cura di trovarle un nome, e di adattarla ai loro definitori […] perché non appartiene precisamente a verun genere […] Ella ha tutta la vericità della storia, e tutto il verosimile e l’unità artifiziale che si domanda alla favola, la schiettezza della prosa, e la sublimità della poesia». Per una riflessione sull’importanza culturale di quest’opera, cfr., ad esempio Wolff, The Morlacchi and the Discovery of the Slavs, cit. e S. Bassi, The Moor (lacco) of Genoa: Ethnicity and loyalty in an Illyrian Othello, in M. Procházka (ed.), Shakespeare’s Illyrias: Heterotopias, Identities, (Counter)histories, in “Litteraria Pragensia”, , , , p. . . Alticchiero [a ed. ?] porta la dedica al compagno di Voltaire, il pittore Jean Huber. L’inventore del romanzo gotico inglese, Horace Walpole, ne possedette una copia che più tardi passò nella biblioteca di William Beckford, il ricchissimo, eccentrico scrittore, autore del gotico Vathek (il volume si trova ora nella biblioteca della Yale University, New Haven). . Cfr. infra, Appendice, la bibliografia completa delle sue opere, incluse le ristampe, le traduzioni e gli adattamenti per il teatro. . Anonimo, Cantate di un accademico fervido filodrammaturgo […] edizione seconda accresciuta e corretta dall’autore, dalle stampe di Silvestro Gatti, Venezia , p. . . Melchiorre Cesarotti a Francesco Rizzo [s.l. s.d. ()], pubblicato in Dell’epistolario di Melchiorre Cesarotti, Firenze , vol. XXXIII, p. . . Nel , quando Philippe Monnier scrisse il suo celebre Venise au XVIIIe siècle, nell’introduzione al suo lavoro citò tre grandi autorità letterarie su Venezia; tra queste figure, Ugo Foscolo e Francesco Algarotti sono sopravvissuti nel canone della letteratura italiana; la terza era «la comtesse Wynne de Rosenberg» (ivi, pp. -). . La partenza della famiglia Wynne fu giudicata degna di nota da Lady Mary Montagu, come testimonia una lettera da lei scritta alla figlia, Lady Bute ( ottobre ): «Three fine ladies (I should say including the Signora Madre) set out for London a few days ago» (in R. Halsband, ed., The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu, vol. III, -, Clarendon, Oxford , p. ). . Cfr. di Robilant per un resoconto completo dell’episodio, basato sulle lettere inedite in suo possesso scritte da Memmo a Giustiniana. . Richard Wynne veniva da Folkingham, nel Lincolnshire, e fu sposato con Susanna Church, la quale morì nel (cfr. A. Fremantle, The Wynne Diaries, vol. I, -, Oxford University Press, London , pp. -). . Anna Gazzini, figlia di Ser Filippo, nacque nell’isola di Santa Maura, nel mare Ionio, nel . . Maria Elisabetta (“Bettina”) ; Teresa Susanna (“Tonina”) ; Riccardo ; Guglielmo ; Anna Amalia . . Tra le ventiquattro famiglie fondatrici della Repubblica veneziana, i Memmo assieme ad altre undici famiglie, le cosiddette famiglie “apostoliche”, rivendicarono le proprie origini nella Roma antica. Andrea di Piero Memmo (-), nelle sue vesti ufficiali, si affermò negli anni con diverse imprese civiche. Cfr. G. Torcellan, Una figura della Venezia settecentesca, Andrea Memmo. Ricerche sulla crisi dell’aristocrazia veneziana, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma . . Memmo in particolare, ma anche tanti altri figli dei patrizi veneziani, era cresciuto sotto la guida intellettuale di Carlo Lodoli, abate francescano assai anticonformista per opinioni e per metodo d’insegnamento, nel modo di vedere le cose e di insegnarle ai suoi allievi. In futuro si SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI riveleranno forti le influenze di Lodoli su di lui anche per ciò che concerne il buon governare, l’architettura e l’urbanistica, ma per ora sono i suoi atteggiamenti spregiudicati e libertini che contraddistinguono il carattere del giovane, nella sua voglia di vivere intensamente e passionalmente (cfr. M. Infelise, Introduzione a C. Lodoli, Della censura dei libri -, Marsilio, Venezia , p. ). . Joseph Smith (-) fu console d’Inghilterra a Venezia dal al , ma è più noto come commerciante d’arte, bibliofilo e mecenate (cfr. supra, nota ). Rimasto vedovo nel , avrebbe voluto sposarsi in seconde nozze con Giustiniana; invece, nel sposò Elizabeth Murray, sorella di John Murray, ambasciatore inglese a Venezia. Secondo Vivian, «la sua casa diventa un punto d’incontro per la cultura veneziana e per gli stranieri colti, di passaggio sulle lagune»; «era amico di Memmo, Cesarotti, Lodoli, Goldoni, Algarotti» (F. Vivian, Il console Smith, mercante e collezionista, Neri Pozza, Vicenza , pp. , ). . Pare che la madre di Giustiniana avesse nascosto il più a lungo possibile la compromettente verità sul suo atto di nascita. Un commento riportato in una lettera di Giustiniana sembra alludere a tale rivelazione, pronunciata nel tentativo di distogliere la figlia da quel disgraziato amore: «[…] cara Giustiniana […] tu non puoi essere sua moglie. Ti paleso una cosa che non avresti saputa mai di tua vita ma, cara figliuola, il contratto non passa […] vuoi essere fuggita da tutti, non ammessa in alcun luogo nobile, oltre all’essere odiata dalla famiglia del Memmo, che farebbe ammogliar un altro de’ suoi fratelli, e dar a quel pover uomo tanto danno? E tanto ai figliuoli che da voi nascessero?» (J[ustine] W[ynne], C[ontessa] R[osenberg] O[rsini], Lettere ad Andrea Memmo, vol. I, lettera CXLII [s.d.], ms. presso la Biblioteca Civica di Padova). . Cfr. le lettere inedite di Memmo, citate passim in di Robilant, Un amore veneziano, cit. . La “lettera di lamento” era divenuta popolare in Europa con Lettres portugaises () che avrebbe avuto un seguito ancora più determinante per Giustiniana, in Lettres d’une péruvienne () di Mme de Grafigny. Il registro della scrittura di Giustiniana subito dopo la partenza mima con una tale intensità i suoi modelli letterari da fare sembrare le sue lettere al lettore moderno quasi una parodia. . «[…] io non so che parlarti tuttavia d’amore. Ah, permetti ch’io ceda qualche momento al mio eccesso. Tacerò! Ti dirò “amico”, sarai mon cher frère ma sarai poi tutto» (Vicenza, ottobre ). . Philadelphia (amore fraterno) era una forma di amore in cui l’affetto e la passione erano controllati dalla ragione. A proposito di questo concetto è interessante notare che i volumi delle lettere di Giustiniana presso la Biblioteca Civica di Padova portano sul frontespizio la parola “Filadelfia”, come immaginario luogo di pubblicazione. Non era inusuale trovare luoghi fittizi di pubblicazione indicati su libri stampati a Venezia come altrove in Europa; era un modo per aggirare i controlli e la censura (cfr. Infelise, Introduzione, cit., pp. XIV-XV). L’analisi che qui propongo della concezione di amore fraterno nel Settecento offre la chiave per spiegare il significato di “Filadelfia” sui volumi manoscritti, che aveva finora lasciato perplessi gli studiosi. . Per una descrizione approfondita di questa trasformazione culturale, cfr. E. Henderdorn Cook, Epistolary Bodies: Gender and Genre in the Eighteenth-Century Republic of Letters, Stanford University Press, Stanford , pp. -. Sull’uso esteso del termine “fratello”, cfr. N. Tadmore, Family and Friends in Eighteenth-Century England: Household, Kinship, and Patronage, Cambridge University Press, Cambridge (in particolare The Language of Kinship, pp. -). . Una certa preoccupazione riguardo al fenomeno dell’incesto aveva trovato espressione in molti testi letterari di quel periodo, dal Mohamet di Voltaire () al Joseph Andrews di Fielding () e Le fils naturel di Diderot. Negli anni della metà del XVIII secolo, Lettres d’une péruvienne di Mme de Graffigny aveva ancora un vasto pubblico, così come Moll Flanders di Defoe. Nel , un anno dopo l’inizio del nostro carteggio, Love Letters between a Noble-man and His Sister () di Aphra Behn era arrivato alla settima edizione. Cfr. C. Daniels, Negotiating Space for Women: Incest and the Structure of Graffigny’s “Lettres d’une péruvienne”, in “Romance Languages Annual”, , , pp. -, e W. Daniel Wilson, Science, Natural Law, and Unwitting Sibling Incest in Eighteenth-Century Literature, in “Studies in EighteenthCentury Culture”, , , p. . Sui rapporti tra fratello e sorella, cfr. W. Bannour, P. Berthier (éds.), Eros philadelphe, Colloque de Cerisy, Paris e, in particolare, il saggio di J.-J. Hamm, Désirs et complicités: écriture et liaisons épistolaires entre frères et soeurs, ivi, pp. -; cfr. anche J. Stephens Mink, J. Doubler Ward (eds.), The Significance of Sibling Relationships in Literature, Popular Culture Press, Bowling Green . NANCY ISENBERG . Per una più ampia discussione del concetto, cfr. P. Brooks, Reading for the Plot, Design and Intention in Narrative, Knopf, New York (trad. it. Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo, traduzione di D. Fink, Torino, Einaudi , p. ). . Per un’approfondita trattazione delle convenzioni del romanzo epistolare, cfr. in particolare J. Gurkin Altman, Epistolarity: Approaches to a Form, Ohio State University Press, Columbus (Ohio) . . La lettera è riportata per intero in H. Watzlawick, La confession de Giustiniana Wynne, in “L’Intermédiaire des casanovistes”, XX, , pp. -. . Le testimonianze di Giustiniana riguardo all’imminente matrimonio con La Pouplinière sono supportate da documenti d’archivio che riportano delle azioni legali da lui intraprese affinché Giustiniana venisse “naturalizzata” come cittadina francese. Cfr. Archives Nationales, Secrétairerie de la Maison du Roi , ff. , , datati marzo e aprile , pubblicati in F[rancis] L Mars, Pour le dossier de Miss X.C.V., in “Casanova Gleanings”, V, , pp. -. . Molti di questi errori sono documentati nelle note dell’edizione italiana, G. Casanova, Storia della mia vita, a cura di P. Chiara, F. Roncoroni, vol. II, -, Mondadori, Milano , capp. XIII-XVI. . Cfr. C. Cusset, The Lesson of Libertinage, in Ead. (ed.), Libertinage and Modernity, in “Yale French Studies”, , , pp. -. Riporto due brevi citazioni per il confronto con il narrare di Casanova: «Libertinage, in a way, is nothing but the acknowledgement of the decisive role that vanity – the ego – plays in the affairs of human beings» (ivi, p. ); «Libertine eroticism implies an esthetic relation among words, the imagination, and the reader. Libertinage is not an erotic practice but something that happens in language» (ivi, p. ). . In una lettera da Parigi datata gennaio , disse a Memmo a proposito di Casanova: «[…] non mi piac[e] la sua compagnia e cred[o] che non ci convenga […]. Egli è pien di sé e scioccamente fastoso, in somma, insoffribile». . Tuttavia, ciò non accade, come si apprende in una lettera successiva. . Le lettere di Giustiniana sono sempre ricche di commenti sul mondo del teatro: l’opera, i concerti, le commedie italiane e francesi, oltre a notizie e opinioni su cantanti, musicisti, ballerine, attori. Per questa ragione, le sue lettere costituiscono una testimonianza d’inestimabile valore sulla vita e gli itinerari di questi artisti. . Ci sono buoni motivi per credere che il console Joseph Smith e l’ambasciatore John Murray fossero i responsabili dell’avvio di una delle prime logge a Venezia. Vennero in Italia ambedue appoggiati da Robert D’Arcy, Lord Holderness, segretario di Stato di Sua Maestà, anche egli sicuramente coinvolto in attività massonica in Italia (cfr. R. Targhetta, Ideologia massonica e sensibilità artistica nel Veneto settecentesco, in “Studi veneziani”, XVI, , p. ; Ead., La massoneria veneta dalle origini alla chiusura delle logge (- ), Del Bianco, Udine , pp. -). Poiché Holderness, per volontà di Richard Wynne (anch’egli sotto la sua protezione), divenne tutore dei suoi ragazzi quando rimasero orfani del padre, non sembra azzardato supporre che pure il padre di Giustiniana condividesse le stesse tendenze. Memmo era sicuramente attratto dalle idee massoniche ma, diversamente dai suoi amici, i cui nomi compariranno più tardi in connessione alla loggia di rio Marin, egli ne rimase sempre fuori. Altre figure nominate da Giustiniana, di cui si trova menzione anche nelle carte che documentano attività della libera muratoria, sono: il cardinale FrançoisJoachim de Pierre de Bernis (-), già ambasciatore francese a Venezia (-) e ministro degli Esteri; il principe di Clermont, Louis de Bourbon-Condé, -); Casanova; e, ancora, gli amici veneziani di Memmo, Marchetto Donà e Alvise Contarini. . Il dicembre , Giustiniana scriveva a Memmo: «Abbiamo col mezzo del Principe di Clermont avuta la permissione di rimaner qui quanto ci piacerà». Clermont era un massone. . La celebre cortigiana Catherine (Kitty) Mary Fisher era l’ispiratrice della filastrocca: «Lucy Locket lost her pocket, / Kitty Fisher found it […]». Intelligente, arguta, esigente, la Fisher attrasse l’attenzione non solo degli aristocratici più altolocati, ma anche quella di pittori come Joshua Reynolds e di scrittori come Samuel Johnson. Mentre i giornalisti pubblicarono versi osceni riferiti a lei e le tipografie diffondevano la sua immagine, le donne copiavano il suo modo di vestire. . Maria Gunning, moglie di George William, VI conte di Coventry, possedeva una bellezza leggendaria, ma altrettanto leggendari erano la sua ignoranza e il suo parlare sciocco. . Giustiniana morì nel , Memmo nel . SEDUZIONI EPISTOLARI NELL’ ETÀ DEI LUMI . Va detto, tuttavia, che, diversamente dal rapporto di Giustiniana e Memmo, quello narrato qui termina con la morte per uccisione dell’amato; cfr. Du sejours, ; Moral and Sentimental Essays, ; À André Memmo Chevalier de l’Étoile d’or, ; Les Morlaques, . . My First Travels, in Moral and sentimental essay on miscellaneous subjects, written in retirement, on the banks of the Brenta, in the Venetian state, by J. W. C.-t-ss of R-s-g, J. Robson, London , pp. -. . Memmo rimase scapolo per nove anni dopo il ritorno di Giustiniana a Venezia, poi nel sposò Elisabetta Piovene. Il loro piatto matrimonio finì alla morte improvvisa di lei, nel . Memmo si trovava a Costantinopoli in quel periodo, in qualità di ambasciatore di Venezia. . È lo stimato scienziato, Lazzaro Spallanzani, che ce lo dice in una lettera datata il agosto scritta all’abate Alberto Fortis. Riferiva che, mentre si trovava in visita all’Altichiero, aveva incontrato «la valorosa Contessa Rosemberg che vi si trovava col Procuratore Memmo», pubblicato in L. Spallanzani, Epistolario, a cura di B. Biagi, Sansoni, Firenze , vol. IV, pp. -. . Giustiniana scrisse di Memmo nella sua pubblicazione londinese, Moral and Sentimental Essays, nel . Senza menzionarlo esplicitamente, ricordò che «a passion that I was inspired with by a young gentleman…, swallowed up all the others. I loved him to distraction» (ivi, p. ). L’anno seguente fu la volta di Memmo: dichiarò pubblicamente la totale devozione che aveva nutrito a suo tempo per Giustiniana. Nel suo libro, Elementi dell’architettura lodoliana (Pagliarini, Roma ), pubblicato durante l’impegno diplomatico a Roma, Memmo colse «l’occasione di dichiarare anche colle stampe essere ella stata l’oggetto della mia intera consacrazione, non solo per le rarissime doti che nel primo fior di gioventù costituivano il di lei animo sublime, che per il di lei spirito originale e coltissimo, oltre i tant’altri ornamenti di grazie, che la singolarizzavano tra le poche più pregevoli, unione assai rara che mi conservò senza nessuna interruzione, e colla maggior pienezza e compiacenza, suo costante e perfettissimo amico» (p. , corsivi miei). . Lettera a Giulio Perini da Roma, maggio , Archivio di Stato di Firenze, Acquisti e doni, , . . Il codice di Memmo sopravvive in molte delle sue lettere a Giustiniana, compresa quella in cui gliela insegna. Cfr. di Robilant, Un amore veneziano, cit. . Per celebrare l’ingresso al nuovo incarico di Procuratore di San Marco nel , Memmo aveva pensato di fare un omaggio a Carlo Lodoli, pubblicando un volume dei suoi apologhi. Lodoli, appunto, narrava quei brevi racconti enigmatici carichi di significati nascosti, ma non li aveva mai pubblicati. Memmo li custodiva ancora nella memoria, e ora li metteva per iscritto. . Dobbiamo ricordare, a questo punto e in altri della storia di Giustiniana, che era comune, accettabile e necessario nella società del suo tempo che le donne usassero le attrattive del loro sesso e della loro giovinezza (e anche del loro charme e intuito, se li possedevano) come merce di scambio per conseguire una migliore posizione sociale. Tuttavia, quando il patto di matrimonio di Giustiniana sembrò concludersi, la giovane iniziò a rendersi conto di quanto le sarebbe costato veramente: «Per quanto ricca sia egli per rendermi, non potrà però mai pagare quanto io gli dono. La mia felicità per danaro! Ha ella forse un prezzo?» (Parigi, marzo ). . Brunelli tradisce una forte propensione a credere a Casanova e una certa tendenza a confondere i fatti con l’immaginazione. Perciò, nonostante il costante rimando alle fonti d’archivio, la sua selezione di citazioni dalle lettere e i suoi commenti limitano e distorcono l’immagine proiettata di Giustiniana in modo molto irritante per un lettore, o meglio per una lettrice moderna. Cfr. Brunelli, Un’amica del Casanova, cit. . La raccolta acquistata da Rives Childs si trova ora presso la biblioteca del Randolph Macon College, Ashland, Virginia. L’altra raccolta, composta dai voll. II e III, fu acquistata da Bruno Brunello e ora appartiene a un collezionista italiano. La raccolta conservata presso la Biblioteca Civica di Padova, consistente nei voll. I e III, sembra una copia successiva della altre due. Lo suggerisce, ad esempio, il fatto che nella lettera del vol. II manchi un passo («che non penseressimo, dico, a maritarci»), presumibilmente per un errore di distrazione da parte del copista. . Tra queste, una di Giustiniana all’ambasciatore di Sua Maestà presso la Serenissima, John Murry, e un’altra a suo zio materno. A queste si possono aggiungere quelle indirizzate a Memmo dall’ambasciatore veneziano a Parigi, Niccolò Erizzo, da Tomaso Farsetti e dal francese “F—”, e ancora una lettera inviata da Erizzo a suo cugino a Venezia. NANCY ISENBERG . Esiste a dire il vero, una testimonianza tra le relazioni agli inquisitori del confidente Pedrini in cui si ipotizza un rapporto ancora più intimo tra i due (cfr. Archivio di Stato di Venezia, Inquisitori di Stato, busta , ottobre ) ma in assenza di prove più fondate, questa rimane una mera congettura. . Cfr. la lettera di Benincasa ad Alberto Fortis, dicembre (Biblioteca Correr, Epistolario Moschini) «La ringrazio per parte della Contessa delle carte sì prontamente e sì gentilmente mandate: saranno da noi custodite, sinch’ella ritorni, o ne disponga: intanto gioveranno molto all’uopo nostro. Si sta ora mettendo l’ultima mano all’opera». . Una prova ulteriore dell’attività di Benincasa come “mediatore letterario” sta nel suo tentativo di pubblicare un’edizione italiana di alcuni lavori di William Beckford (cfr. Wm. Beckford, Dreams, Waking Thoughts and Incidents, edited by R. J. Gemmett, Fairleigh Dickinson University Press, Rutherford , pp. -). Benincasa presumibilmente frequentò quest’ultimo a Venezia tramite Giustiniana, la cui amicizia con Beckford è documentata in Dreams e da alcuni scambi epistolari (cfr. William Beckford Manuscripts, Bodleian Library, Oxford). . agosto . Pubblicata in Appendice a E. M. Luzzitelli, Il viaggio d’Ippolito Pindemonte verso la “virtù”, in “Critica storica”, XIX, , , pp. -. . La lettera continua dando altri dettagli sulla pubblicazione che confermano un interesse per Giustiniana non confinato geograficamente: «La stampa si fa in Berlino sotto gli occhi ben veggenti, e per l’amicissimo zelo del Conte d’Haugwitz che Vi debb’essere noto almen per fama, Ministro attuale degli affari interni di quel Gabinetto». . Cfr. supra, nota . . Lettera citata (cfr. supra, nota ). Cfr. pure, nella stessa raccolta, vol. V (), pp. -, la lettera di Cesarotti a Benincasa, anch’essa [s.l. (ma Venezia) s.d. (ma )]. . Ho potuto consultare presso l’Archivio di Stato di Venezia alcune relazioni scritte da Benincasa in qualità di informatore degli inquisitori. . Negli anni in cui ho lavorato sul carteggio di Giustiniana, ho beneficiato del generoso aiuto e sostegno di moltissime persone e istituzioni. Tradurrò la mia sentitissima riconoscenza nei ringraziamenti a stampa che accompagneranno l’edizione critica delle lettere. Qui però non posso non ringraziare Alessandra Zuliani per la cura e l’attenzione con le quali ha controllato e preparato questo testo per la stampa. NOTE SULLA RELAZIONE INTERMEDIALE TRA LETTERATURA E CINEMA* di Maddalena Pennacchia Fin dal momento in cui Georges Méliès, nell’inventare la tecnica del montaggio, rivelò al cinema la sua vocazione narrativa, i cineasti cominciarono ad attingere al patrimonio letterario come a un inesauribile magazzino colmo di storie e personaggi. Il fenomeno del trasferimento di storie e personaggi dal libro al film, noto con il nome di “adattamento cinematografico”, è stato spesso percepito dai detrattori del cinema in termini negativi. Quando il cinema cominciò a imporsi come mezzo di comunicazione di massa, infatti, diversi letterati – come Frank Raymond Leavis in Mass Civilization and Minority Culture () – si preoccuparono che una forma nata come fenomeno popolare poche decine di anni prima (convenzionalmente il dicembre , ad opera dei fratelli Lumière) potesse non solo assottigliare le file dei lettori, ma viziare la pratica della lettura e di conseguenza rallentare il corso di quel progetto di acculturamento delle masse che avrebbe trovato pieno riscontro in Inghilterra solo con la politica postbellica del welfare state. I primi cineasti che cercarono di assicurare al cinema la dignità di arte teorizzarono, di contro, un’affinità elettiva fra pagina e schermo, ricostruendo genealogie atte a fondare l’autorevolezza del mezzo più giovane: famoso è il richiamo a Charles Dickens del regista e teorico sovietico Sergej M. Ejzenštejn. Questi aveva individuato nelle tecniche narrative del romanziere vittoriano il seme delle innovazioni cinematografiche introdotte da David Wark Griffith nel secondo decennio del Novecento, come per esempio il montaggio parallelo. Ejzenštejn arrivava a suggerire che il film costituisse per il pubblico novecentesco il mezzo privilegiato del racconto, così come il novel (forma popolare ormai culturalmente accreditata) lo era stato per quello dell’Ottocento. Una metafora utile a illustrare il rapporto tra letteratura e cinema a partire da queste considerazioni preliminari è quella della “migrazione”. La “migrazione”, infatti, in senso ampio, indica uno spostamento in massa di individui della stessa specie da un luogo originario a un altro spesso più ricco al livello di risorse naturali. In questo caso si tratterebbe del massiccio trasferimento di testi letterari dalla pagina allo schermo: a questo nuovo habitat la letteratura dovrebbe “adattarsi” per * Questo contributo, originariamente in lingua inglese, è stato presentato in teleconferenza al Convegno internazionale “ESSE ” (European Society for the Study of English) tenutosi a Londra ( agosto- settembre ) nell’ambito della tavola rotonda intitolata “Literature and Film: Transformations, Interactions, Mirror Effects” coordinata dal prof. Gilles Menegaldo (Università di Poitiers). Mi sono qui limitata a tradurre il testo che pertanto risente irrimediabilmente della sua destinazione orale. MADDALENA PENNACCHIA sopravvivere. Nel contesto metaforico della migrazione il termine “adattamento” acquista addirittura una coloritura darwiniana. La metafora della migrazione, tuttavia, si applica con successo a un sistema mediatico inteso come insieme di mezzi di comunicazione nettamente separati tra di loro, in cui il movimento dei messaggi segue di preferenza un unico senso di marcia. Il funzionamento del sistema mediatico è, tuttavia, più complesso. La relazione cinema/letteratura appartiene, per esempio, alla lunga storia del rapporto parola/immagine che vede nell’esempio dell’illustrazione uno dei casi più evidenti della necessità di affiancare alla comunicazione concettuale tipica della scrittura una comunicazione, per così dire, più immediatamente percettiva e che si può far risalire addirittura alla tradizione dei codici miniati. Ebbene, nel testo illustrato il movimento dell’occhio non è indirizzabile secondo una direttrice; piuttosto è un movimento oscillante: dalle parole all’immagine e dall’immagine alle parole. Il movimento oscillatorio “fra” i mezzi di comunicazione è ciò che si è accentuato enormemente oggi, a causa del continuo aggiornamento delle tecnologie digitali e della loro vertiginosa diffusione su scala mondiale. Parole, suoni, immagini statiche o in movimento, ricodificati nel linguaggio binario circolano rapidamente in mezzi di comunicazione tanto diversi tra di loro quanto la stampa, la fotografia, la radio, il cinema, la televisione, il computer, il telefono cellulare ecc. rendendo il processo di significazione al contempo più complesso e più personale. “Intermediale”, allora, si potrebbe definire la relazione fra mezzi di comunicazione diversi, laddove il prefisso “inter” sottolinea l’importanza di quel “fra”, concetto filosofico che i post-strutturalisti (e penso soprattutto a Derrida) hanno indagato a fondo e che ci è utile qui per mettere in evidenza la modalità eterarchica del sistema mediale contemporaneo, dove l’attraversamento dei confini, lo scavalcamento delle barriere diventa costitutivo del sistema stesso. Il rapporto tra letteratura e cinema non si può allora definire solo nei termini di una “migrazione”. Sarà forse più opportuno parlare di “nomadismo” del messaggio letterario, usando una metafora cara alla filosofa Rosi Braidotti e che indica un movimento permanente, senza approdi definitivi. Esempi come quello di Harry Potter o di Bridget Jones’s Diary sono significativi della condizione nomadica del messaggio letterario: il libro in questi casi non è che uno stadio del racconto ed è già predisposto a farsi film per poi tornare a farsi libro e così via. Ma altri esempi di circolazione si possono riscontrare nella popular culture: si pensi al fenomeno della novelization che si verifica quando un film che ha avuto un grande successo di botteghino viene trasformato da scrittori professionisti in romanzo, com’è stato per la saga di Star Wars. Si tratta di un processo che assume nuove valenze nel momento in cui entrano in gioco i personal media e Internet. È il caso della fan-fiction, la narrativa scritta e pubblicata sul web da dilettanti che per estendere il piacere della visione di alcuni film o della lettura di romanzi da loro particolarmente amati, senza distinguere tra le due forme (Lord of the Rings, per esempio, è conosciuto da molti solo nella sua versione cinematografica) li riscrivono o li ampliano o li serializzano. La fan-fiction è una scrittura radicalmente democratica e globale, la realizzazione pratica della lettura “scrivibile” teorizzata da Roland Barthes. Scrittori e cineasti professionisti spesso consultano a loro volta questi siti per capire il trend del momento e riorientare la loro produzione. Si tratta, è evidente, di una condizione comunicativa molto fluida. NOTE SULLA RELAZIONE INTERMEDIALE TRA LETTERATURA E CINEMA Si potrebbe obiettare che tutti questi esempi non riguardino la “Letteratura” con la maiuscola. Ma mi chiedo cosa intendiamo oggi con il termine “letteratura”. Non sembra infatti che esista un’idea di letteratura condivisa da tutti, nemmeno da tutti quelli che se ne occupano per professione. Si potrebbe forse riflettere sull’etimologia della parola “letteratura” che, nelle culture occidentali, deriva dal latino litera. La “lettera”, un singolo segno scritto che sta per un suono; in inglese il sostantivo literacy indica la capacità di leggere e scrivere, che in italiano è resa dall’aggettivo “alfabetizzato”, con riferimento alla capacità di distinguere i segni dell’alfabeto. Un messaggio letterario, allora, almeno nella tradizione occidentale, ha forse ancora a che fare con la sua forma scritta, qualunque sia l’esperienza immaginativa che esso veicola. Con questo non intendo certo sostenere una contrapposizione fra la civiltà della scrittura e quella dell’immagine: la scrittura appartiene con pieno diritto alla civiltà dell’immagine, essendo un mezzo visivo. La scrittura, però, è stata la prima tecnologia umana volta a immagazzinare e diffondere informazioni; inventata per fare memoria di ciò che si riteneva degno di essere ricordato, essa ha trasformato la nostra percezione del mondo, insegnandoci a riflettere e selezionare, a inventare un ordine per il caotico flusso della vita. La scrittura fa dunque parte del codice genetico dei mezzi di comunicazione inventati successivamente a essa, che la ri-mediano, ovvero la incorporano in modo più o meno esibito, più o meno agonistico (Bolter, Grusin, ). In questa prospettiva acquista rilievo il fatto che non sono solo gli adattamenti letterari o i film girati da cineasti “letterati” a essere strettamente correlati al testo scritto. Lo script, la sceneggiatura, è, infatti, alla base di qualunque film e solo tramite una serie di passaggi intersemiotici complessi la scrittura si trasforma in immagini (si pensi allo story-board, per esempio) e in suoni. Tutti i film, pertanto, conservano la traccia della scrittura, una traccia che spesso affiora in dettagli minimi ma significativi. Un caso esemplare è, fra i tanti, quello di Cast Away, regia di Robert Zemeckis, sceneggiatura di William Broyles jr (USA, ). È la storia di Chuck Noland (Tom Hanks) manager della Fed-Ex unico sopravvissuto di un disastro aereo che, con un canotto di emergenza, approda su un’isola deserta dove resterà per cinque lunghi anni prima di riuscire a tornare alla civiltà. Si tratta, naturalmente, di un libero adattamento del Robinson Crusoe di Daniel Defoe del , un testo che a partire da The Rise of the Novel () di Ian Watt è stato considerato il primo romanzo realistico della storia letteraria inglese. È significativo, in primo luogo, che negli Stati Uniti si sia avvertita la necessità con l’inizio del nuovo millennio di riscrivere la storia di Robinson in un mezzo di comunicazione, il cinema, particolarmente congeniale alla società americana. Il novello Robinson, d’altra parte, ha il corpo di Tom Hanks che da anni incarna l’uomo comune della società statunitense nelle sue svariate sfumature geografiche. Molto ci sarebbe da dire su questo personaggio, a partire dal suo suggestivo cognome, “No-land”, ma mi limiterò a segnalare che se nel romanzo di Defoe Robinson conserva la sua identità civilizzata soprattutto grazie alla scrittura di un diario, nel film non pratica alcun tipo di scrittura. A differenza del Robinson inglese, l’americano Chuck non trova carta e inchiostro nel relitto della nave, eppure da uno dei pacchi della Fed-Ex portati a riva dalla marea dopo il disastro aereo vengono fuori alcune cassette audiovisive, che Chuck guarda con aria interrogativa. Si tratta di una sequenza di pochi secondi presto dimenticata dallo spettatore. Solo dopo quasi MADDALENA PENNACCHIA un’ora di proiezione, in cui il regista allestisce una narrazione iper-realista, senza altra colonna sonora che i suoni della natura ostile e quelli inarticolati prodotti da Chuck in momenti di dolore o sconforto, le videocassette riappaiono, per pochi secondi. Noland usa, infatti, i nastri registrati per legare i pali della zattera con cui lascerà l’isola. Dal mio punto di vista l’assenza del diario e la presenza delle videocassette sull’isola sono il segno di una relazione agonistica tra romanzo e film; mi sembra infatti che regista e sceneggiatore ripropongano in forma creativa l’argomento ormai classico di Ejzenštejn citato già all’inizio di queste pagine, ovvero che il mezzo di comunicazione più adatto a narrare agli uomini realistiche storie di altri uomini è, nel nuovo millennio, il cinema. Una conclusione addirittura scontata, se si considera il fatturato dell’industria cinematografica negli States e che questo film è stato distribuito tra l’altro da th Century Fox insieme a Dreamworks, due delle majors americane più potenti. Una visione meno ideologica della relazione cinema/letteratura non potrà, invece, prescindere dalla consapevolezza che non si tratta di un legame regolato gerarchicamente, ma di una relazione di produttiva intermedialità. Note . Sul punto rimando al saggio di Henk Oosterling () e alla mia Introduction al volume Literary Intermediality. The Transit of Literature Through the Media Circuit (Pennacchia Punzi, ed., in corso di stampa). . Il fenomeno riguarda anche scrittori “letterari”. John Updike, per esempio, ha riscritto nel suo romanzo Gertrude and Claudius () la storia dei due famosi amanti shakespeariani, sollecitato per sua stessa ammissione dalla versione cinematografica di Hamlet () di Kenneth Branagh. Claudio è espressione nel romanzo, proprio come nel film, di una umanità ricca di chiaroscuri, divenendo una figura ben diversa dall’usurpatore incestuoso e assassino del dramma originale. Bibliografia BOLTER J. D., GRUSIN R. (), Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge (MA) and London. CORTELLAZZO S., TOMASI D. (), Letteratura e cinema, Laterza, Roma-Bari. FUMAGALLI A. (), I vestiti nuovi del narratore. L’adattamento da letteratura a cinema, Il Castoro, Milano. MANZOLI G. (), Cinema e letteratura, Carocci, Roma. OOSTERLING H. (), Sens(a)ble Intermediality and Interesse. Towards and Ontology of the In-Between, in “Intermédialités”, , pp. -. PENNACCHIA PUNZI M. (ed.) (in corso di stampa), Literary Intermediality. The Transit of Literature Through the Media Circuit, Peter Lang, Bern and New York. «BETWEEN MIMICRY AND MOCKERY»: STRANIAMENTO E AUTOPARODIA NELLA LETTERATURA DELLA MIGRAZIONE di Paola Splendore Inglan is a bitch dere’s no escapin it Inglan is a bitch fi true is whe wi a goh dhu bout it? Linton Kwesi Johnson La difficoltà sta nel fatto che il nesso tra oggetto comico e uomo che ride non è né scontato né automatico. Là dove uno ride un altro non ride. Vladimir J. Propp Metamorfosi del soggetto coloniale Nel furgone cellulare che lo porta verso un centro per immigrati illegali, Saladin Chamcha scopre che il suo corpo ha subito una mutazione: corna, peli, zoccoli lo hanno trasformato, sotto lo sguardo beffardo dei poliziotti, in un caprone. Non serve a niente implorare, spiegare a chi lo ha arrestato che si tratta di un abbaglio, che lui non ha cercato di entrare illegalmente in Inghilterra, che è cittadino britannico e che ha perso i documenti perché è precipitato sul suolo inglese da un aereo esploso in cielo a diecimila metri di altezza. È una storia a cui nessuno crede e che anzi suscita l’effetto opposto: sarcasmo, scherno e una buona dose di violenza. Il giorno dopo Saladin si risveglia in una sala-dormitorio, circondato da un gran numero di esseri dalla forma ibrida: «Chamcha glimpsed beings he could never have imagined, men and women who were also partially plants, or giant insects, or even, on occasion, built partly of brick or stone; there were men with rhinoceros horns instead of noses and women with necks as long as any giraffe» (Rushdie, , p. ). Un uomo-tigre, digrignando tre file di denti, gli spiega il fenomeno come l’effetto di una metamorfosi dovuta a una sorta di adattamento – quasi un’inconsapevole sottomissione del corpo – allo sguardo e alla percezione degli inglesi: siamo diventati quello che loro vogliono, incarniamo, letteralmente, quello che essi descrivono: «“But how do they do it?” Chamcha wanted to know. “They describe us”, the other whispered solemnly. “That’s all. They have the power of description, and we succumb to the pictures they construct”» (ivi, p. ). Questo episodio, tratto da The Satanic Verses di Salman Rushdie (), romanzo noto soprattutto per essere, all’indomani della sua pubblicazione, all’origine della condanna a morte pronunciata dall’ayatollah Khomeini nei confronti del suo autore con l’accusa di blasfemia, offre una rappresentazione dell’immigrazione tra le più PAOLA SPLENDORE ferocemente visionarie e “disumanizzate”, e per questo efficaci, riscontrabili nella letteratura in lingua inglese. Nelle immagini ibride di Rushdie riverbera lo spirito anticolonialista di Frantz Fanon (il cui nome è spesso evocato nelle pagine del romanzo) quando, analizzando nei Dannati della terra la logica manichea del colono, ne denuncia la tendenza a utilizzare, nella caratterizzazione del colonizzato, un linguaggio “zoologico”: «Si fa allusione ai movimenti serpeggianti dell’indocinese, agli effluvi della città indigena, alle orde, al puzzo, al pullulare, al brulicare, ai gesticolamenti. Il colono, quando vuole descrivere bene e trovare la parola giusta, si riferisce costantemente al bestiario» (Fanon, , p. ). Tali espressioni sono tese a privarlo della sua umanità e giustificare così il suo bisogno di guida e protezione esterna: «Il colonizzato sa tutto questo e ride di cuore ogni volta che si scopre animale nelle parole dell’altro. Perché sa di non essere un animale. E appunto, al tempo stesso che scopre la sua umanità, comincia ad affilare le armi per farla trionfare» (ivi, p. ). Nell’intricata struttura narrativa di The Satanic Verses la vicenda di Saladin Chamcha e di Gibreel Ferisha, due attori indiani “piovuti dal cielo” sul suolo inglese dopo un incidente aereo, è certamente quella principale ed è in base a essa che il romanzo di Rushdie si colloca oggi tra quelli più importanti sul tema dell’emigrazione. Saggi di autorevoli critici, come Gayatri Spivak, Homi Bhabha, Sara Suleri, Milan Kundera, hanno indicato proprio in questo il fulcro principale di interesse del libro, prendendo così le distanze dalla lettura tendenziosa che ne è stata fatta di “attacco all’islamismo” e indirizzandola invece nella direzione maggiormente corrispondente alle intenzioni dell’autore, la disamina in chiave comica di una condizione di sradicamento che coinvolge un’alta percentuale di umanità. Nel saggio In Good Faith, un intervento di autodifesa che Rushdie scrisse all’epoca, egli dichiara infatti che tema centrale del libro è l’emigrazione, una condizione poco rappresentata in letteratura benché emblematica del XX secolo: «If The Satanic Verses is anything, it is a migrant’s-eye view of the world. It is written from the very experience of uprooting, disjuncture and metamorphosis (slow or rapid, painful or pleasurable) that is the migrant condition» (Rushdie, , p. ). Nelle parole dell’autore, il romanzo «celebrates hybridity, impurity, intermingling, the transformation that comes of new and unexpected combinations of human beings, cultures, ideas, politics, movies, songs. It rejoices in mongrelization and fears the absolutism of the Pure. Melange, hotch-potch, a bit of this and a bit of that is how newness enters the world […]. It is a love-song to our mongrel selves» (ibid.). Se i personaggi del romanzo mettono il lettore di fronte a una «taxonomy of migration» (Spivak, , p. ), è in particolare l’idea di trasformazione e metamorfosi del soggetto coloniale sotto lo sguardo deformante del colono a interessare Rushdie che, nei personaggi di Gibreel e Saladin – «embodiments of two opposing Indian desires» (Suleri, , p. ) –, raffigura due diverse strategie di appropriazione della cultura della “madrepatria”, quella di chi aspira a diventare una copiaperfetta-o-quasi dell’originale e quella di chi invece si sforza di mantenere una forma di continuità con il passato e le proprie radici. Ambedue sono esempi di mimicry, la condizione che, nelle pagine del romanzo The Mimic Men, Vidiadhar Surajprasad Naipaul presenta come “fantasia coloniale”, una forma di sterile duplicazione: «We pretended to be real, to be learning, to be preparing ourselves for life, we mimic men of the New World» (Naipaul, , p. ) – ma che Bhabha interpreta come destabilizzante per l’autorità coloniale: «For the repetition of the “same” can in fact be its own displacement, can turn the authority of culture into its own non-sense « BETWEEN MIMICRY AND MOCKERY »: STRANIAMENTO E AUTOPARODIA precisely in the moment of enunciation… culture’s double returns uncannily – neither the one nor the other, but the imposter – to mock and mimic» (Bhabha, , p. ). Per Bhabha infatti «the discourse of mimicry is constructed around an ambivalence; in order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, its excess, its difference» (ivi, p. ), una differenza che equivale a un rigetto. Personaggio dalle forti risonanze autobiografiche, Saladin Chamcha, doppiatore e voce fuori campo della pubblicità, ha sempre desiderato assimilarsi agli inglesi, diventare in tutto e per tutto come loro, assumendo quella identità di «goodandproper Englishman”, ovvero, per Bhabha «as a subject of a difference that is almost the same, but not quite» (ivi, p. ) che si presenta come grottesco e parodia: […] he would be English, even if his classmates giggled at his voice and excluded him from his secrets, because these exclusions only increased his determination, and that was when he began to act, to find masks that these fellows would recognize, paleface masks, clown masks, until he fooled them into thinking he was okay, he was people-like-us (Rushdie, , p. ). La “mutazione” di Salahuddin Chamchawala è iniziata dunque fin dall’infanzia, poi sostenuta dall’anglicizzazione del nome in Saladin Chamcha e il matrimonio con una donna inglese. Ma è in particolare la trasformazione in caprone, e la conseguente assunzione di attributi satanici, a rendere visibile la sua ibridità e allo stesso tempo a demonizzare la condizione di immigrato. Condizione che Saladin invano rinnega rifiutando di avere a che fare con gli asiatici che abitano il ghetto indo-pakistano di Brickhall (dalla compressione in un unico nome di Brick Lane, Brixton, Southall, tre zone di Londra di alto insediamento di immigrati): «I’m not your kind… you’re not my people. I’ve spent half my life trying to get away from you» (ivi, p. ). Invano, come gli fa notare la sua amante indiana: «You know what you are, I’ll tell you. A deserter is what, more English than, your Angrez accent wrapped around you like a flag, and don’t think it’s so perfect, it slips, baba, like a false moustache» (ivi, p. ). Profondamente estraneo a se stesso, «I’m not myself» (ivi, p. ), Saladin riuscirà a “ritrovarsi” solo con il ritorno in India e a una vita di «delicate sensibilities» (ivi, p. ). Differente è l’atteggiamento di Gibreel Ferisha, famoso divo del cinema di Bombay, che si sforza di mantenere a ogni costo la propria identità camaleontica: «for all his stage-name and performances; and in spite of born-again slogans, new beginnings, metamorphoses; – has wished to remain, to a large degree, continuous – that is, joined to and arising from his past» (ivi, p. ). L’affinità con l’Arcangelo Gabriele, in cui ritiene di essersi reincarnato, il suo essere un good immigrant non serviranno tuttavia a porlo al riparo da un profondo malessere che lo spinge infine al suicidio. Se, come afferma Gillian Gane, «the novel’s surreal metamorphoses into devil and angel are metaphors of migrant identity – compressed, dramatized analogues of how migrant change» (Gane, , p. ), nella scena farsesca in cui Gibreel indossa i panni di un ex proprietario terriero coloniale, Sir Henry Diamond, egli si trasforma in «the avenging migrant», in quanto la sua replica di miti patriottici e mascolini si presenta, secondo Bhabha, come parodia della storia, «depriving those narratives of their imperial authority» (Bhabha, , p. ). Nessuno dei due atteggiamenti, esplorati da Rushdie a partire da un sé itinerante e diasporico, è tuttavia privo di contraddizioni: «For are they not conjoined opposites, these two, each man the other’s shadow? – One seeking to be transformed into PAOLA SPLENDORE the foreignness he admires, the other preferring, contemptuously, to transform» (Rushdie, , p. ). Se Saladin ha scelto di diventare «a creature of selected discontinuities, a willing re-invention» (ivi, p. ), Gibreel, rimasto «at bottom, an untranslated man» (ivi, p. ), è invece colui che trasforma, come quando in uno dei suoi deliri onirici decide di “tropicalizzare” Londra: «[…] floating on his cloud [he] formed the opinion that the moral fuzziness of the English was meteorologically induced» (ivi, p. ). Nella schizofrenia dei due personaggi, letta come metafora della «postcolonial plurality», Gayatry Spivak identifica uno dei temi centrali del romanzo: «The postcolonial divided between two identities: migrant and national» (Spivak, , p. ); l’altro tema è l’identità dell’artista la cui funzione nel testo viene di continuo messa in crisi dall’autore stesso attraverso forme autoriflessive di «dramatic irony» (ivi, p. ). È sull’uso destabilizzante di un linguaggio ironico e sarcastico nella letteratura della migrazione che voglio soffermarmi in questo articolo, per dimostrare quanto spesso questo registro sia presente affiancando e rafforzando il piano realistico della testimonianza e della denuncia. In particolare, intendo registrare lo sguardo obliquo di quegli scrittori che, pur adottando il medium linguistico dell’inglese (non necessariamente nella versione standard), osservano l’Occidente da outsider rilevandone debolezze e iniquità e la sua mancanza di rispetto della dignità altrui, per consegnarcelo “deformato” in testi “carnevaleschi” che, mentre stemperano la drammaticità della materia trattata, producono una visione capovolta del reale, o una sua versione straniata, ai limiti del surreale. Tale ribaltamento avviene su piani diversi, attraverso l’ironia del linguaggio e delle immagini o attraverso forme di “creolizzazione” della lingua e del genere letterario adottato: metodi e strategie ricorrenti nelle cosiddette letterature “migranti” che stanno emergendo nelle maggiori lingue europee. Processi evidenti anche in un romanzo della recente produzione letteraria italofona, Scontro di civiltà per un ascensore in piazza Vittorio, opera di Amara Lakhous (), scrittore algerino trapiantato in Italia che ha adottato la lingua italiana. In parte ispirato a un modello letterario “alto” quale Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda e in parte alla commedia all’italiana, il romanzo racconta, in un linguaggio ibrido, ricco di inflessioni popolari e dialettali, di un condominio “multietnico” i cui abitanti sono sempre in lite per l’uso dell’ascensore, negato agli “extracomunitari”. La comicità grottesca delle situazioni è esasperata dall’incomprensione e dall’intolleranza reciproca: Questa mattina Iqbal mi ha chiesto se conoscevo la differenza tra il tollerante e il razzista. Gli ho risposto che il razzista è in contrasto con gli altri perché non li crede al suo livello, mentre il tollerante tratta gli altri con rispetto. A quel punto si è avvicinato a me, per non farsi sentire da nessuno come se stesse per svelare un segreto, e mi ha sussurrato: «Il razzista non sorride!» (Lakhous, , p. ). “Colonization in reverse” Secondo Susheila Nasta, l’adozione del registro comico nella letteratura della diaspora asiatica non è semplicemente il veicolo di satira politica, «but masks instead « BETWEEN MIMICRY AND MOCKERY »: STRANIAMENTO E AUTOPARODIA the ironic presentation of […] the tragic or near-tragic» (Nasta, , pp. -). È il caso ad esempio della notissima poesia della giamaicana Louise Bennett, Colonization in reverse, in cui il suo alter ego poetico, Miss Lou, saluta l’arrivo a frotte in Inghilterra di giamaicani negli anni del dopoguerra come i nuovi colonizzatori dell’impero: «What a joyful news, Miss Mattie; / Ah feel like me heart gwine burs – / Jamaica people colonizin / Englan in reverse» (Bennett, in Procter, , p. ). In un’inversione parodica dell’impresa coloniale, Bennett esalta l’intraprendenza e la lealtà dei suoi connazionali nei confronti della madrepatria i quali, mettendo da parte ogni timore per il lungo viaggio, sono arrivati numerosi per capovolgere il corso della storia «An tun history upside dung!»: “colonizzare” l’Inghilterra, in reverse. L’adozione di una forma particolare di inglese “creolizzato”, una lingua che ribalta il senso di impotenza e di emarginazione dell’immigrato, dà dell’immigrazione di massa degli anni Cinquanta una rappresentazione carnevalesca, irriverente e alternativa. Bennett non è stata la prima a utilizzare in forma scritta la nation language . La “creolizzazione” dell’inglese è alla base del progetto narrativo di Sam Selvon (), il cui The Lonely Londoners “importa” la cultura orale e folklorica di Trinidad – quella del carnevale e del mercato – all’interno dell’opera scritta, “creolizzando” la forma e il linguaggio del romanzo. La lingua adottata da Selvon è in realtà “inventata”, un miscuglio di suoni e ritmi di gruppi di provenienza diversa delle isole caraibiche: in questa lingua volutamente antiletteraria, Selvon propone una nuova formula di romanzo urbano dove le voci di strada, i pettegolezzi, le dicerie si intrecciano ai modelli e ai registri più disparati persino nelle parti descrittive. È per questi motivi che John Thieme considera il romanzo profondamente innovativo, «the seminal West Indian carnival text, since it combines an oral narrative voice with the parodic, egalitarian and subversive comedy of Bakhtinian carnival» (Thieme, , p. ). Se l’immagine e l’ethos irriverente del Carnevale sono particolarmente frequenti nella letteratura della prima generazione di scrittori immigrati, nel romanzo di Selvon il riso non è solo strategia di sopravvivenza per gli immigrati “solitari” – affettuosamente ironizzati nel titolo nella loro condizione di solitudine e sradicamento –, ma una vera e propria strategia narrativa, «a comi-tragic attempt to subvert and demythologize the colonial dream of a bountiful city» (Nasta, , p. ). Alla base della costruzione di Lonely Londoners c’è il calypso, forma della cultura musicale popolare caratteristica dell’isola di Trinidad, in particolare nel periodo del Carnevale, i cui autori, i calypsonians – paragonabili ai cantastorie del Sud Italia – commentano liberamente qualsiasi aspetto della vita politica e sociale fondendo citazioni di discorsi politici, proverbi, sermoni, pettegolezzi, discorsi d’occasione, umorismo e satira politica e di costume, fino a rappresentare, nelle parole di Stuart Hall (), «the repository of that year’s distilled popular knowledge and wisdom – the informal “court” before which every powerful figure fears being ultimately judged». A imitazione della struttura aperta del calypso e in assenza di una vera e propria trama, la forma di The Lonely Londoners si articola sulla base di una serie di aneddoti e scene liberamente concatenate tra loro. Coscienza centrale e unificante del romanzo è Moses Aloetta, emigrato della prima ora, dalla cui prospettiva Selvon presenta i momenti topici della condizione definita emigrazione, l’arrivo alla stazione Victoria, «with one set of luggage, no place to sleep, no place to go» (Selvon, , p. ), la ricerca dell’alloggio e del lavoro, e l’altalena di sentimenti di disorien- PAOLA SPLENDORE tamento, delusione, rabbia, speranza. In un incipit che ricorda Bleak House e Heart of Darkness, Moses entra in scena in un paesaggio nebbioso tipicamente londinese eppure ignoto in cui la città non è più riconoscibile: «As if is not London at all but some strange place on another planet» (ivi, p. ), per andare ad accogliere i nuovi arrivati dai Caraibi e per i quali resterà la figura più importante di riferimento, novello Mosè trasformato in “mediatore culturale”. La sua prospettiva, intimamente condivisa con i vari personaggi di immigrati, e l’uso particolare della lingua tendono verso una rappresentazione straniata e autoironica in cui la lingua diventa una sorta di bene-rifugio, il riso la valvola di sfogo di ogni delusione e frustrazione: «As if the boys laughing, but they only laughing because they fraid to cry» (ivi, p. ). I giovani arrivati sono definiti semplicemente the boys, senza alcuna specificazione di provenienza e, come nella tradizione del calypso, sono identificati solo da soprannomi – Cap, Galahad, Big City, Five-Past-Twelve – indicativi della loro particolare capacità di adattamento e particolare nota comica. Al cupo realismo di Moses fa da contrappunto l’idealismo ingenuo di Galahad, che abbraccia l’avventura londinese carico di aspettative ma è subito spaventato alla vista di un sole freddo, fermo in cielo come «a force-ripe orange» (ivi, p. ). Galahad è protagonista di vari episodi in chiave comica del romanzo, come quando, spinto dalla fame, decide di catturare un piccione a Trafalgar Square, suscitando l’indignazione dei passanti inglesi, per i quali fa scandalo la morte del piccione ma non la fame degli immigrati, o come quando l’esclamazione ingenua e spaventata di una bambina, «Mummy, look at that black man!», lo porta per la prima volta a prendere coscienza di sé come oggetto di discriminazione razziale e a riflettere sul problema. Rivolgendosi alla sua mano come fosse altro da sé, Galahad esclama: «Colour, is you that causing all this, you know. Why the hell can’t be blue, or red or green, if you can’t be white? […] it’s not me, you know, is you!» (ivi, p. ). La scena può leggersi come variante in chiave comico-grottesca dell’esperienza “primaria” descritta da Fanon in Peau noire masques blancs, un saggio pubblicato in Francia nel , solo pochi anni prima del romanzo di Selvon, in cui l’autore identifica all’origine del comportamento schizofrenico del nero proprio il suo “incontro” con lo sguardo bianco. Ogni incontro, ogni esclamazione del tipo «Guarda, un negro!» produce nel nero una certa difficoltà «nell’elaborazione del suo schema corporale» – afferma Fanon (, p. ) – fino a disorientarlo del tutto, a farlo allontanare da sé, a generare in lui una sorta di oggettivizzazione e infine il ripudio della propria differenza. In una riflessione sull’ effetto degli stereotipi razziali sui colonizzati Bhabha torna sul testo di Fanon per ribadire come questi siano all’origine di «a grotesque mimicry or “doubling” that threatens to split the soul and whole, undifferentiated skin of the ego» (Bhabha, , p. ). Ma Galahad non si fa schiacciare da tanta ostilità e andrà avanti perseguendo i suoi semplici piaceri. Gli bastano un po’ di soldi in tasca, la prospettiva di un incontro femminile e il magnetismo della metropoli a fargli dimenticare ogni problema: «This is London, this is life oh lord, to walk like a king with money in your pocket, not a worry in the world» (Selvon, , p. ). Un altro elemento interessante di presa di distanza ironica e di autoparodia è quello contenuto nella pratica della ibridazione o “creolizzazione” del linguaggio e delle forme canoniche della tradizione letteraria. Si pensi ad esempio al romanzo Midnight’s Children di Salman Rushdie (), l’opera che ha per prima attirato l’attenzione del pubblico internazionale sull’esistenza di una letteratura anglofona « BETWEEN MIMICRY AND MOCKERY »: STRANIAMENTO E AUTOPARODIA espressa da autori dal doppio background culturale, un’opera che resta tra gli esempi più riusciti di innesto e contaminazione di forme, in cui si mescolano la forma epica del poema indiano, con i suoi caratteri di circolarità, digressione, ripetitività e l’anti-romanzo europeo di impronta sterniana e joyciana. Ma è propriamente sul piano del linguaggio che Rushdie realizza, con indubbio intento satirico, il sostrato multilingue dei suoi personaggi, non solo interpolando termini urdu e hindi (di cui rifiuta di fornire un glossario finale) accanto a quelli inglesi, ma utilizzando l’inglese come lingua franca nella maniera inadeguata e imperfetta dei suoi personaggi, e soprattutto del narratore. Osserva Robert Fraser in proposito: «What the reader absorbs, by and large, is a language in which Saleem the narrator is supposed to be incompetent: English, offered up to us not because, as in Kipling, it is superior, and not, as in Forster, because it is the cherished vehicle of certain values, but because it is neutral» (Fraser, , p. ). La lingua letteraria creata da Rushdie nel romanzo ha avuto un forte impatto sugli scrittori indoinglesi successivi, da Amitav Ghosh, a Shashi Tharoor, da Arundaty Roy a Vikram Seth, che ne hanno imitato l’audacia della contaminazione linguistica e strutturale. Neelam Srivastava afferma che «Midnight Children was the work that canonized the use of Indian English as an innovative literary language, and effectively introduced the Western reading public to contemporary Indian fiction» (Srivastava, , p. ). Come risulta evidente anche dalle varie citazioni proposte da The Satanic Verses, l’uso della lingua in una dimensione eteroglossa ha un’importanza strategica nel romanzo: «Rushdie uses linguistic diversity primarily in the negative – to destabilize claims of ownership of space and culture – but not to support the actively polyglot world he invokes in his defence» (Kalliney, , pp. , ). Da ventriloquo della narrazione Rushdie alterna registri e codici linguistici nella stessa pagina, ciascuno dei quali viene appropriato e parodizzato allo scopo di ridicolizzare varie tipologie razziali e stereotipi. L’effetto comico e satirico è certo, come ad esempio nel dialogo tra Saladin e la hostess dell’aereo che lo porta dall’India in Inghilterra: […] emerging from the dream, [Saladin] found his speech unaccountably metamorphosed into the Bombay lilt he had so diligently (and so long ago!) unmade. «Achha, means what?» he mumbled. «Alcoholic beverage or what?» And, when the stewardess reassured him […] he heard once again, his traitor voice: «So, okay, bibi, give one whiskysoda only» (Rushdie, , p. ). “Write Black, Write British” Le generazioni successive di scrittori anglofoni raggruppati nella denominazione collettiva Black British si trovano a operare in un contesto culturale completamente diverso che li trasforma, nel giro di pochi anni, in un fenomeno editoriale di grande successo: è questa di fatto la provenienza di gran parte della letteratura che si produce oggi in Inghilterra e che l’Inghilterra “esporta” sul mercato internazionale. Tra i motivi del successo è certamente il fatto che i suoi temi – la società multiculturale inglese con i suoi conflitti e contraddizioni, i confronti e gli scontri generazionali, l’intolleranza e il razzismo tra i vari gruppi etnici presenti in Gran Bretagna e gli inglesi – sono diventati di interesse globale, e i vari paesi europei che si trovano oggi PAOLA SPLENDORE ad affrontare i problemi sociali e politici della cosiddetta “società multiculturale” guardano all’Inghilterra come al paese che l’ha sperimentata per prima. Il successo della letteratura Black British capovolge completamente la situazione di “vuoto” in cui venne a trovarsi la letteratura nera degli anni Cinquanta e Sessanta, un fenomeno marginale e non assimilabile nella cultura mainstream, che continuò a ignorarla e con essa la presenza degli immigrati. Tra questi due estremi ci sono stati lo sviluppo degli studi culturali, con le analisi influenti di Stuart Hall e di Paul Gilroy; prese di posizione importanti come quella di Salman Rushdie che, all’indomani dell’assegnazione del Booker Prize (per Midnight’s Children ), rifiuta la ghettizzazione di “scrittore del Commonwealth” (); ma soprattutto l’emergere di una nuova leva di scrittori di seconda generazione che affermano in maniera prepotente la propria appartenenza alla new breed dei Black Britons, i quali pur rappresentando l’eredità coloniale, «may or may not have visited the country of their parents birth but yet are faced with re-imagining the borders of cultural space and national identity» (Oyedeji, , p. ). Hanif Kureishi è stato tra i primi a dare voce all’esigenza di riconoscimento e di appartenenza da parte degli scrittori di seconda generazione. Nel folgorante e provocatorio incipit di Buddha of Suburbia il giovane protagonista si presenta come un nuovo tipo di Englishman con ambizioni e aspettative tutte sue: «My name is Karim Amir, and I am an Englishman born and bred, almost […] Englishman I am (though not proud of it), from the South London suburbs and going somewhere» (Kureishi, , p. ). Rivisitando la formula del romanzo di formazione in chiave multiculturale, Kureishi dava voce alle inquietudini e alle ambizioni di un ragazzo meticcio di periferia, ribaltando luoghi comuni e pregiudizi diffusi all’epoca sull’identità dei giovani di seconda generazione. Non sorprende risentire l’eco delle sue parole in quelle del giovane protagonista di Allah superstar dello scrittore algerino francofono, Y. B. (pseudonimo di Yassir Benmiloud), un ragazzo arabo della banlieu parigina determinato a sua volta a diventare una celebrità, a esibirsi in teatro o magari alla televisione: «Io voglio diventare o star del cinema, o comico alla moda … ma per gli Arabi è più facile entrare ad Al-Qaeda che alla televisione per colpa del numero chiuso» (Y. B., , p. ), e più avanti: «A me quello che m’interessa non sono le radici, sono i rami. Come ti ho già detto l’importante non è da dove vieni, ma dove vai. E io lo so dove vado» (ivi, p. ). Ma il registro dominante del romanzo di Y. B. lo rende diverso dal Buddha per la forza provocatoria e dissacrante del linguaggio e per la scelta di perseguire l’effetto comico nel ritratto caustico e “politicamente scorretto” degli ideali del protagonista. Kamel prepara uno sketch sullo stereotipo del musulmano/kamikaze in cui un arabo si presenta in un ufficio pubblico parigino a chiedere una sovvenzione per il circolo ricreativo Gioventù e jihad e, ottenendo un rifiuto, si slaccia la tuta e si fa esplodere. Lo sketch non fa molto ridere, ma il ragazzo spera così di attirarsi almeno una fatwa e raggiungere in breve tempo l’agognata notorietà: «È più veloce del Grande fratello, dura di più, viaggi per il mondo intero, tieni conferenze, sbarchi nei palazzi, sali sul palco con gli U, ti fai un tè col Papa» (ivi, p. ). Motivati dalla necessità di denunciare e capovolgere lo stereotipo e il pregiudizio che spesso circondano l’identità di chi è nato da genitori immigrati, gli scrittori di seconda e terza generazione, meno interessati alla sperimentazione linguistica e all’innovazione formale, puntano sempre più spesso sullo stereotipo e l’autoparodia, adottando il linguaggio deformato ed estremizzato della comicità e della satira, per deco- « BETWEEN MIMICRY AND MOCKERY »: STRANIAMENTO E AUTOPARODIA struire la fissità dello stereotipo e smitizzare il pregiudizio. Cinema, teatro, televisione sfruttano a pieno il filone, con opere che riscuotono grande successo. Si pensi alla commedia teatrale East is East, poi diventata film nel (diretto da Damien O’Donnell), e ai film di Gurinder Chadha, Bhaji on the Beach () e Bend it Like Beckam (), oppure alla fortunata sit-com Goodness Gracious Me, prodotta dalla BBC e andata in onda tra il e il , opera di un team di scrittori anglo-indiani, tra i quali Meera Syal, il cui registro prevalente è quello della satira e del black humour. Protagonista una famiglia indiana di immigrati “anglicizzati”, che ha scelto di trasformare il proprio cognome da Kapoor a Cooper, preferisce il roast lamb al curry e intrattiene gli ospiti discutendo di cricket e del tempo atmosferico. Nell’episodio intitolato An invitation to dinner, due famiglie indiane si scambiano cortesie nel corso di una conversazione da salotto, secondo lo stile dei nativi inglesi. E quando un mattone, scagliato da un gruppo di punk, entra dalla finestra, accompagnato dal biglietto, «Pakis go home», dopo un attimo di sgomento, tutti si trovano d’accordo nel commentare: «Quite right». Con una flemma tipicamente inglese la padrona di casa si china a raccogliere il mattone e va a riporlo in cima a una pila che colleziona assieme ai vari biglietti di insulto. Tra le opere narrative comiche di maggiore impatto va menzionato il fortunato romanzo White Teeth dell’allora poco più che ventenne Zadie Smith (), che individua nei denti la metafora centrale per stigmatizzare gli atteggiamenti razzisti degli inglesi. Lo fa non solo utilizzando nelle titolazioni dei capitoli termini come «molars», «canines» e «Root Canals» e sfruttando ogni assonanza e valenza metaforica (roots/routes), ma anche con episodi che rivelano profondi pregiudizi razziali, a volte inconsapevoli, come ad esempio nello stereotipo del bianco abbagliante della dentatura dei neri, «marker of Blackness as well as an identifier of difference» (Thompson, , p. ). Particolarmente significativo in tal senso l’episodio in cui tre bambini, due dei quali figli di immigrati dal Bangladesh e la terza figlia di un inglese e una giamaicana, si recano a consegnare una borsa di cibo al vecchio reduce Mr Hamilton come parte di un servizio sociale per la comunità. Dopo qualche incertezza e diffidenza iniziali, il vecchio li lascia entrare e offre ai bambini tè e biscotti. Ben presto, tuttavia, l’impressione iniziale dei bambini di trovarsi davanti a una sorta di bird man, un essere elegante e gentile, è destinata a trasformarsi in quella minacciosa dell’orco delle fiabe. Il vecchio Mr Hamilton, ormai sdentato, scopre di non potere utilizzare i doni dei bambini perché ha problemi di masticazione e, mentre tenta di incoraggiarli a prendersi cura dei propri denti, insinua subito dopo che non sempre una dentatura smagliante è cosa saggia per i neri: «When I was in the Congo, the only way I could identify the nigger was by the whiteness of his teeth, if you see what I mean. Horrid business. Dark as buggery, it was. And they died because of it, you see? Poor bastards. […] See a flash of white and bang! […] The decision of the gun. So quick, children. So brutal. Biscuit?» (Smith, , pp. -). Anche la poesia adotta il linguaggio della satira per rovesciare stereotipi e pregiudizi: nella raccolta The Fat Black Woman’s Poems, ad esempio, Grace Nichols (), sulla base di una fantasia ricorrente nell’immaginario bianco nei confronti della donna nera, crea il personaggio della Fat Black Woman, «Heavy as a whale / eyes beady with contempt» (The Assertion, p. ), trasformandola in una nuova icona di bellezza, pigra e sensuale, che brinda all’ipotetica vittoria al concorso di Miss Mondo di una PAOLA SPLENDORE donna “in carne”, se non proprio grassa e nera, «will some Miss (plump at least / if not fat and black) uphold her name» (Looking at Miss World, p. ). La rivendicazione di un diverso canone estetico: «If my fat/was too much for me/ I would have told you / I would have lost a stone / or two. […] But as it is / I’m feeling fine. […] Come up and see me sometime» (Invitation, p. ) si esprime in altre poesie come asserzione di un fat self: «Fat is / as fat is / as fat is/ Fat does / as fat thinks / Fat feels / as fat please / Fat believes…» (…And a Fat Poem, p. ), oppure nelle riflessioni sarcastiche sulla cultura occidentale: Steatopygous sky Steatopygous sea Steatopygous waves Steatopygous me O how I long to place my foot on the head of anthropology to swig my breasts in the face of history to scrub my back with the dogma of theology to put my soap in the slimming industry’s profitsome spoke (Thoughts drifting through the Fat Black Woman’s head while having a full bubble bath, p. ) Un altro stereotipo – quello dell’angoscia di identità dell’artista nero – viene preso a bersaglio in una poesia di Benjamin Zephaniah (), Knowing Me, in cui il poeta fa la satira della mercificazione dell’angry black poet, confuso e frustrato per la perdita delle radici, mentre lui si sente perfettamente a suo agio («I am all that Britan is about / I’m happening as we speak»): According to de experts I’m letting my side down, Not playing the alienation game It seems I am too unfrustrated […] I have now reached the stage Where I am sick of people asking me if I feel British or West Indian, African or Black, Dark or Lonely, Confused or Patriotic. The thing is I don’t feel lost. […] I don’t need an identity crisis to be creative, I don’t need an identity crisis to be oppressed. (Zephaniah, , pp. -) Nella poesia di Zephaniah, attraversata da una forte vena di ironia e autoironia in cui spesso il creolo o l’uso “improprio” dell’inglese sono utilizzati come arma di disturbo del canone linguistico standard, emerge con chiarezza la rivendicazione di una appartenenza e l’affermazione dell’identità Black British. Allo stesso tempo « BETWEEN MIMICRY AND MOCKERY »: STRANIAMENTO E AUTOPARODIA Zephaniah non abbassa la guardia nel denunciare le conseguenze nefaste dell’imperialismo e del colonialismo occidentale e la capacità dell’establishment di indebolire la combattività e la lucidità critica degli artisti neri con premi e onorificenze. Ha fatto scalpore il suo rifiuto dell’ambita onorificenza OBE (Order of the British Empire) con una lettera a Tony Blair, pubblicata sul “Guardian” del novembre , in cui attacca senza mezzi termini chi osa premiarlo associando il suo nome alla parola “impero”. Gli argomenti vengono ripresi nella poesia Bought and Sold, rivolta agli artisti neri affinché non facciano il gioco del sistema e si trasformino in parodie di se stessi, esibendo il look esotico dell’artista rasta o del «ghetto blaster» per compiacere il pubblico, sottovalutando la perdita di autonomia critica che ne deriva: «Smart big awards and prize money / Is killing off black poetry. […] The empire strikes back and waves, / Tamed warriors bow on parades. […] You look like a dreadlocks Rasta, / You look like a ghetto blaster, / But you can’t diss your paymaster / And bite the hand that feeds you» (Zephaniah, , p. ). L’interesse maggiore della letteratura della migrazione e delle sue più recenti propaggini – almeno per la critica letteraria – risiede nella sua dirompente carica innovativa rispetto al canone, manifestata fin dalle origini nell’adozione di un linguaggio ibrido, irriverente, trasgressivo. Un linguaggio che ha contribuito a forzare i confini delle letterature nazionali, spesso capovolgendone valori e significati, e che è servito a riconfigurare – con ironia, senso della satira e autoparodia – l’esperienza stessa della migrazione. Note . Il richiamo a Fanon non è casuale: in quegli anni in Inghilterra si manifestò un rinnovato interesse per le idee di Fanon soprattutto da parte degli artisti neri. Cfr. il Convegno presso l’ICA di Londra del , i cui atti sono pubblicati in A. Read (ed.), The Fact of Blackness: Frantz Fanon and Visual Representation, London ICA-Bay Press, Seattle . . Tre gli intrecci principali del romanzo: il primo ha per protagonisti i due attori indiani; il secondo riguarda il profeta Mahound e la sua nuova religione; il terzo il pellegrinaggio attraverso l’India condotto dalla giovane profetessa Ayesha, la ragazza farfalla. Il bizzarro ingresso dei due uomini in Inghilterra è di per sé metafora della migrazione come processo di morte e rinascita: l’essere sopravvissuti al disastro aereo rappresenta una nuova nascita, l’ingresso nel nuovo mondo. . «Literally “spoons”, the chamchas are for Rushdie those collaborators under independence who have propped up the post-colonial status quo; even after the departure of the Raj, Rushdie observes, the Empire continues to grow fat by being “spoon-fed”» (Brennan, , p. ). . Rushdie ricorre spesso alla pratica joyciana delle parole portemanteau, risultato di compressioni o di disarticolazioni, come nei vari nomignoli per Londra: «Ellowen Deeowen» dalla sillabazione delle lettere che compongono London e «Babylondon», dalla contrazione di Babylon e London. . Nation language è la lingua parlata in gran parte dell’arcipelago caraibico, in cui si esprimono le diverse componenti dell’area sommersa del dialetto legate alla radice africana e all’oralità. «We in the Caribbean have a […] kind of plurality: we have English, which is the imposed language on much of the archipelago. It is an imperial language, as are French, Dutch and Spanish. We also have what we call creole English, which is a mixture of English and an adaptation that English took in the new environment of the Caribbean when it became mixed with the other imported languages. We have also what is called nation language, which is the kind of English spoken by the people who were brought to the Caribbean, not the official English now, but the language of slaves and labourers, the servants who were brought in» (Brathwaite, , pp. -). PAOLA SPLENDORE . «I wrote a modified dialect which could be understood by European readers, yet retain the flavour and essence of Trinidadian speech» (Fabre, , p. ). . «The term “Black” was coined as a way of referencing the common experience of marginalisation in Britain and came to provide the organising category of a new politics of resistance among groups and communities with, in fact, very different histories, traditions, and ethnic identities» (Hall, , p. ). . Sebbene questa letteratura esista da più di mezzo secolo, solo recentemente si è cominciato a parlare di una letteratura Black British e della sua tradizione. Il cinquantenario dell’arrivo in Inghilterra, a Tilbury, della nave SS Empire Windrush dalle Indie Occidentali, con il suo carico di immigrati, è stato accompagnato da molte celebrazioni (tra cui un serial televisivo trasmesso dalla BBC) e da una ricca fioritura di opere critiche che hanno fatto emergere in tutta la sua varietà una tradizione di letteratura dell’immigrazione in larga parte ignorata. Gli studi di Bruce King, James Procter, Sushela Nasta, per citare alcuni degli studiosi più importanti nel settore, hanno non solo recuperato un archivio di testi letterari, saggistici e poetici, scritti a partire dalla fine degli anni Quaranta del XX secolo ai nostri giorni, ma anche ricostruito il contesto culturale in cui è stata prodotta la letteratura scritta in inglese da autori di origine caraibica, asiatica, africana, stabilitisi in Inghilterra. . Cfr. i saggi della raccolta curata da S. Hall, P. du Gay, Questions of Cultural Identity, Sage, London e P. Gilroy, There Ain’t No Black in the Union Jack, Routledge, London . . Cfr. in proposito l’articolo di S. Campagna, Can the “Subaltern” Laugh? A Weightless Migrant Metaphor, in Monti, Douthwaite (eds.) (). . «Her controlling metaphor of teeth is original; moreover, by naming her flashback chapters “Root Canals”, she hints at the roots/routes duality of migrancy» (Ball, , p. ). . Secondo Molly Thompson: «The notion of white teeth in the book’s title is therefore a novelistic absent centre that satirically subverts its own significance by suggesting that these attributes are not innate but are artificially constructed» (Thompson, , p. ). Bibliografia BALL J. C. (), Imagining London, University of Toronto Press, Toronto. BHABHA H. K. (), Dissemination, Time, Narrative, and the Margins of the Modern Nation, in Id. (ed.), Nation and Narration, Routledge, Abington and New York. ID. (), The Location of Culture, Routledge, London and New York. BRATHWAITE K . E . (), History of the Voice: The Development of Nation Language in Anglophone Caribbean Poetry, New Beacon Books, London. BRENNAN T. (), Salman Rushdie & The Third World, Macmillan Press, London. FABRE M. (), Samuel Selvon: Interviews and Conversations, in Nasta (ed.) (). FANON F. (), I dannati della terra, Einaudi, Torino (ed. or. Les damnés de la terre, La découverte, Paris ). ID. (), Il negro e l’altro, Il Saggiatore, Milano (ed. or. Peau noire masques blancs, Seuil, Paris ). FRASER R. (), Lifting the Sentence. A Poetics of Postcolonial Fiction, Manchester University Press, Manchester. GANE G. (), Migrancy, the Cosmopolitan Intellectual, and the Global City in “The Satanic Verses”, in “Modern Fiction Studies”, Spring , pp. -. HALL S. (), New Ethnicities, in Procter (ed.) (). ID. (), Calypso Kings, in “The Guardian”, Friday June. KALLINEY P. (), Globalization, Postcoloniality, and the Problem of Literary Studies in “The Satanic Verses”, in “Modern Fiction Studies”, , , Spring , pp. -. KUREISHI H. (), The Buddha of Suburbia, Faber and Faber, London. JOHNS ON L . K . (), Mi Revalueshanary Fren. Selected Poems , Penguin Books, Harmondsworth. LAKHOUS A. (), Scontro di civiltà per un ascensore in piazza Vittorio, E/O, Roma. « BETWEEN MIMICRY AND MOCKERY »: STRANIAMENTO E AUTOPARODIA (eds.) (), Migrating the Texts: Hybridity as a Postcolonial Literary Construct, L’Harmattan Italia, Torino. NAIPAUL V. S. (), The Mimic Men, Penguin Books, Harmondsworth (a ed. ). NASTA S. (ed.) (), Critical Perspectives on Sam Selvon, Three Continents, Washington (DC). ID. (), Home Truths. Fictions of the South Asian Diaspora in Britain, Palgrave, London. NICHOLS G. (), The Fat Black Woman’s Poems, Virago Press, London. OYEDEJI K. (), Prelude to a Brand New Purchase on Black Political Identity, in Sesay (ed.) (). PROCTER J. (ed.) (), Writing Black Britain, Manchester University Press, Manchester. PROPP V. J. (), Comicità e riso, Einaudi, Torino. RUSHDIE S. (), The Satanic Verses, Viking, London. ID. (), In Good Faith, in Id., Imaginary Homelands, Granta, London. SELVON S. (), The Lonely Londoners, Longman, London. SESAY K. (ed.) (), Write Black, Write British, Hansib, Herford (a ed. ). SMITH Z. (), White Teeth, Hamish Hamilton, London. SPIVAK G. (), Outside in the Teaching Machine, Routledge, New York and London. SRIVASTAVA N. (), The Multi-Lingual Context of Indian Fiction in English, in “Anglistica”, , -, pp. -. SULERI S. (), The Rhetoric of English India, The University of Chicago Press, Chicago. THIEME J . (), «The World Turn Upside Down»: Carnival Patterns in “The Lonely Londoners”, in Zehnder (ed.) (). THOMPSON M . (), «Happy Multicultural Land?». The Implications of an «Excess of Belonging» in Zadie Smith’s “White Teeth”, in Sesay (ed.) (). Y. B. (), Allah superstar, Einaudi, Torino. ZEHNDER M. (ed.) (), Something Rich and Strange. Selected Essays on Sam Selvon, Peepal Tree, Leeds. ZEPHANIAH B. (), Too Black, Too Strong, Bloodaxe Books, Tarset (Northumberland). MONTI A ., DOUTHWAITE J . SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE E TRADUZIONE: LA PROSA ACUSTICA DI EVADNE PRICE IN NOT SO QUIET… di Barbara Antonucci Il romanzo Not So Quiet… Stepdaughters of the War () nasce dal progetto di un editore inglese, Albert Marriott, di pubblicare una versione al femminile del celeberrimo romanzo di Remarque, Im Westen nichts Neues (), noto al pubblico inglese con il titolo All Quiet on the Western Front. Marriott propose a Evadne Price, personaggio estremamente versatile e popolare, di scriverne una parodia dal titolo All Quaint on the Western Front. L’autrice, dopo aver letto il testo di Remarque, decise di prendere con estrema serietà il progetto di stesura. Non avendo vissuto in prima persona l’esperienza della prima guerra mondiale (nella seconda lavorerà, invece, come corrispondente al fronte), si servì del diario di Winifred Young per raccontare l’esperienza sul fronte occidentale dell’autista Helen Zenna Smith. Price mantenne il legame con il testo di Remarque contrapponendo al suo All Quiet un provocatorio Not So Quiet, “trascinandoci” in un coinvolgente e funambolico gender reversal. Laddove, infatti, il testo di Remarque si esprime con la voce femminilizzata, a tratti melodrammatica, del soldato in trincea costretto all’immobilità, Price dà sfogo alla voce arrabbiata e mascolinizzata di una donna al fronte. Paul is feminized by war; Helen is masculinized. […] Remarque writes the claustrophobia of the falsely domestic trench/hearth and Price writes the agoraphobia of the mine-trapped open space, blinding snow and wind, bombs falling from the sky. Unhoused, she must learn to operate Outside. Housed in holes of trenches, the German soldiers must learn containment, self-control, and all the female virtues of the aware and alert Inside. Woman makes noise; man maintains silence. The entrenched and the un-trenches warfare experience profound gender traumas. The speaker becomes the listener; the listener becomes the speaker (Marcus, , p. ). Sfidando un’opera di grande fama, la Price mostra la dislocazione del soggettodonna nel territorio di guerra, traducendola in una prosa dai tratti murderous rispetto al tono “pacato” dell’opera tedesca. La forma, dalle cornici mobili, di Evadne Price ha poco in comune con la compattezza e la levigatezza stilistiche di Remarque. In entrambi i romanzi si fa progressivamente vivida la percezione di un distacco insanabile fra ciò che si era, prima della guerra, e ciò che si è diventati, a causa della guerra. Nel romanzo inglese, però, la disgregazione dell’idea romantica del conflitto e lo scontro generazionale si dispiegano sulla pagina attraverso una frattura con la figura materna (e non paterna, come in Remarque) e, soprattutto, per mezzo del linguaggio. BARBARA ANTONUCCI È contro la Madre che si scaglia, violenta, la prosa di Price: la nuova generazione, quella che fa la guerra, si ritrova a parlare un’altra lingua rispetto all’old block, la generazione che vuole la guerra, ed è il linguaggio a segnare l’allontanamento fra madre e figlia, fra vecchie e nuove forme del pensare e dello scrivere. La voce narrante disimpara il suo linguaggio e ne forgia un altro capace di dare corpo e ritmo alla sua esperienza del fronte. Il linguaggio diventa luogo e margine della divisione, mezzo per “negoziare” l’allontanamento: estraniandosi dall’idioletto pulito e raffinato della madre, la protagonista del romanzo abbandona le convenzioni sociali, morali e linguistiche di un mondo a cui sente di non appartenere più. Se la donna dell’upper class, prima del conflitto, poteva muoversi solo all’interno di una selezionata e ristretta scelta lessicale, in guerra il suo modo di esprimersi si sveste della patina di perbenismo per diventare perturbante, osceno e all’occorrenza volgare: «Once I was a sweet girl, happy and interested in local things, now I’m bitter and snappy and sarcastic and with a tongue like an adder, yes, and not above swearing, either, actually swearing. Goodness knows where I picked up such language, certainly not at home…» (Price, , p. ). Il testo di Evadne Price è impregnato della corruzione e dello spazio brutalizzato che le donne attraversano, insozzato dal fango delle trincee. I punti di sospensione, che si affollano nervosi sulla pagina, rappresentano il non detto, celano rabbia, rivelano un’autocensura. Compito del lettore sembra essere quello di riempire gli spazi vuoti, di dare una voce ai silenzi imposti dai punti di sospensione. La parola si fa strumento, si scompone, vibra e si carica di rabbia per colpire quelli che la guerra l’hanno voluta. La traduzione «Il miracolo della traduzione non ha luogo tutti i giorni, c’è talvolta deserto senza attraversamento del deserto» (Derrida, , p. ). Un’affermazione, quella di Derrida, che non incoraggia il traduttore che si avvicina a un testo per “trascinarlo”, forse rovinosamente, nella propria lingua ma che, in un certo senso, spinge a intraprendere la sfida. Se la traduzione è di frequente «un deserto senza attraversamento del deserto», resta comunque la sensazione di aver tentato il laborioso passaggio da una lingua all’altra, di essersi messi alla prova nel delicato processo di trascodificazione e di «rifecondazione della vecchia lingua, sedotta dagli appetiti giovani di un’altra» (Razza, , p. ). Nel caso di Not So Quiet… Stepdaughters of the War, un romanzo di matrice modernista, l’attraversamento più difficile, nel passaggio dall’inglese all’italiano, è stato quello relativo alla valenza acustica conferita alla parola. La prosa di Evadne Price, sperimentale sotto molteplici punti di vista, saggia diverse tipologie di registri e linguaggi e fa un uso assai audace di segni diacritici, suoni onomatopeici, allitterazioni e ripetizioni, voluti e meticolosamente selezionati per imprimere alla narrazione il ritmo marziale della guerra. Jane Marcus, una delle prime studiose a occuparsi della “riscoperta” dell’opera di Evadne Price, individua in tali alterazioni l’essenza di questa scrittura singolare: The reader is reading as much as silence as text, constantly filling in the blanks, supplying the left-out words, decoding the war-time message […]. The diacritical marks SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE E TRADUZIONE make the text look like noise. It crackles across the page. The rapt reader also feels drowned by noise, the noise in Helen’s head and the battle noises around her. […] Our eye contact with the fragmented text makes us feel the disorientation of the body at war, and it activates the reading “ear” […] (Marcus, , pp. -). Non solo l’autrice racconta di un’esperienza a pochi nota, la vita delle donne al fronte durante la Grande Guerra, ma lo fa con l’intenzione di mostrare, con veemenza, «the exhibits straight from the battlefield» (Price, , p. ). Tre sono i sensi che vengono coinvolti nella lettura del romanzo attraverso il sottile intersecarsi dei sistemi rappresentazionali: la vista, l’udito e l’olfatto. Not So Quiet… è un romanzo, come annuncia il titolo, rumoroso: il sibilo delle granate e le grida dei soldati prendono sostanza nell’incessante ripetersi di parole monosillabiche e onomatopeiche. Gli orrori del fronte sono imposti agli occhi del lettore/spettatore con lo stesso implacabile realismo di un reportage di guerra. Niente viene risparmiato al lettore, costretto perfino ad annusare l’odore della guerra attraverso una perizia descrittiva che non lascia nulla all’immaginazione: dalle ferite macilente sembra propagarsi il tanfo della cancrena e l’odore del sangue. La parola-involucro di Evadne Price riesce a far transitare tutto il carico che trasporta, sia esso suono, odore o immagine. Limiti estremi sono infatti sfiorati nelle scelte lessicali, nella carica vibrante e nella pressione drammatica delle parole che attingono a sistemi rappresentazionali di sfere diverse, sovrapposti. Nel rendere in italiano i diversi livelli di scrittura che si intersecano nel romanzo, si è tentato di preservare, laddove possibile, la sfumatura acustica conferita alla parola. La traduzione di una scrittura così sperimentale ha tuttavia sollevato diversi quesiti di tipo linguistico: se questa operazione implica di per sé una perdita in ambito semantico e fonetico, limitare al minimo i danni è stata un’ardua impresa e ha spesso comportato un indebolimento nella sfera della sonorità. Il sarcasmo, il cinismo e la violenza semantica contenuti nelle parole sono stati conservati, ma nei lemmi italiani tale veemenza appare inevitabilmente dilatata, diluita in lunghezze eccessive a fronte della sinteticità delle parole monosillabiche inglesi. Il passo è stato scelto perché illustra nel modo più manifesto il momento della frattura, linguistica ed emotiva, fra madre e figlia. Il dialogo immaginario, a tratti beckettiano, su cui è intessuta la trama narrativa, si fa progressivamente violento: la parola monta di veemenza fino a condurre alla rottura. La voce narrante scandisce il dialogo attraverso l’uso di imperativi e la ripetizione costante di frasi interrogative rivolte alla madre e alla signora Evans-Mawnington. La pacatezza del tono di apertura: «Come with me. Stand just there» (ibid.) va man mano scomparendo, soffocata nella visione, imposta da Helen alle due donne, dello spettacolo della guerra («Let me show you the exhibits straight from the battlefield», ibid.). Benché la scrittura sembri mantenere un suo equilibrio, l’assillante ripetizione di «Mother and Mrs Evans-Mawnington» conferisce al passo una regolarità quasi catatonica. Con l’uso reiterato dell’apostrofe, la ragazza trattiene a sé le due donne («See, the train has stopped», «Look closely, Mother and Mrs EvansMawnington» ibid.). Tuttavia, con l’aumentare dei feriti che vengono “scaricati” dal treno e la descrizione puntigliosa delle loro ferite, la narrazione diviene più concitata e prepara il BARBARA ANTONUCCI momento culminante del brano: la rottura tra la figlia e la doppia figura di madre, o meglio, di matrigna, che rifiuta di guardare, anche solo per una volta, ciò che la ragazza è costretta a guardare ogni giorno, «What? You won’t try the experiment? You can’t watch him? Why not? Why not? […]. Damn your eyes» (ivi, p. ). La ripetizione della domanda e il corsivo in seconda battuta segnano il vacillare degli argini; è questo il primo cenno di collasso, seguito, tuttavia, da un recupero, «Forgive me, Mother and Mrs Evans-Mawnington. That was not the kind of language a nicely-brought-up young lady from Wimbledon Common uses. I forget myself. We will begin again» (ibid). La richiesta di perdono e la ritraduzione di ciò che ha precedentemente detto in un linguaggio più consono al suo uditorio segnano un breve momento di recupero nel corpo testuale, un “ricomporsi” attraverso la ricomposizione della scrittura, seguito, poco più avanti, da un nuovo crollo; una frattura che stavolta non lascia spazio al recupero. Il ritmo comincia ad accelerare, segnato dall’incalzare di aggettivi che fotografano i corpi dilaniati dei feriti man mano caricati nell’ambulanza. Le due donne non resistono oltre e Helen è costretta a congedarsi da loro: «What? You cannot stick it any longer? You are going?», ma lo fa con un’indignazione assertiva («I didn’t think you’d stay. But I have got to stay, haven’t I?… I’ve got to stay. You’ve got me out here, and you’ll keep me out here», ivi, p. ). Sulla pagina cala il sipario, reso con una serie di punti in grassetto, che segnano la fine di questo primo atto e concedono al lettore un momento di riposo. La scrittura recupera lucidità. Se nei punti di sospensione che hanno chiuso il passo precedente si leggeva fra le righe la stanchezza e l’esasperazione di Helen, all’inizio del secondo atto la voce narrante sembra aver riacquistato energia, attraverso frasi brevi e cadenzate. Helen è pronta a partire non appena le viene assegnato l’ospedale da campo dove trasportare la sua “triste merce”. «Number Eight. A lucky number! A long way out, but a good level road, comparatively few pot-holes and stone heaps» (ivi, p. ). Inizia il viaggio lungo la strada innevata, nella notte fonda e gelida (all’epoca le ambulanze erano aperte nella parte del guidatore e coperte da teli nella parte posteriore). Il linguaggio si fa nuovamente luogo di sperimentazione: dal dialogo, immaginato, si passa al soliloquio e un doppio flusso di pensieri cattura e trascina il lettore lungo tutto il tragitto, un espediente stilistico di grande impatto. The technique of dramatic monologue, of inner and outer soliloquy and mental scene-making are superb examples of what Bakhtin calls “dialogism” in fiction. […] Evadne Price here shapes a new form of cinematic, dialogic, and dramatic interior monologue for modernism, a very tightly controlled but daring form, very different from James Joyce, Dorothy Richardson or Virginia Woolf (Marcus, , p. ). La giovane donna non riesce a sostenere le grida ferine che provengono dall’interno dell’ambulanza e da esse si dissocia attraverso le reminiscenze del ballo delle debuttanti: «I must fix my mind on something… What? I know – my coming-out dance» (Price, , p. ). Ripercorrendo con il pensiero le varie tappe dell’iniziazione alla femminilità, riesce a preservare l’integrità che le consente di arrivare all’ospedale da campo, la conclusione di un rito d’iniziazione di ben altro tipo. SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE E TRADUZIONE Il lessico domestico, e un tempo familiare, del ballo, la descrizione del vestito sfavillante, dell’acconciatura, dei guanti e delle scarpe di raso (con una scelta terminologica pertinente al mondo effimero dell’eterno femminino) si alternano alle grida lancinanti dei feriti. L’autrice segnala, attraverso l’uso del corsivo, i due diversi livelli narrativi, creando un’alternanza fra l’uso di parole forbite e complesse («a shining frock of sequins and white georgette, high-waisted down to my toes… […] Satin slippers with buckles on the toes – little pearl buckles shaped like a crescent», ivi, p. ) e le parole, semplici, ripetute, ma dal suono penetrante, che giungono dall’ambulanza («“Did I hear a scream from inside?” […] “Did I hear a scream […]” “don’t let them start screaming”. […] “Was that a scream from inside?” […] “Was it a scream?” […] “Oh, God, a scream this time”. […] “another scream – the madman has started, the madman has started. I was afraid of him. He’ll start them all screaming”», ivi, p. ). Si assiste a una dissociazione, a un vero e proprio “scollamento” nel linguaggio e nel flusso di pensieri di una fanciulla passata dai salotti bene di Wimbledon Common agli orrori del fronte. Si giunge quasi a uno stadio di allucinazione nel passaggio veloce dal corsivo al tondo. Il linguaggio si spezza, le parole vengono troncate e inciampano fra punti di sospensione e pause; la frase, che si fa a tratti telegrafica, sembra tratteggiare una versione testuale del campo di battaglia. Se il linguaggio, come sostiene Jane Marcus, rappresenta «the first war casualty» (Marcus, , p. ), il corpo del testo, potremmo aggiungere, costituisce the second war casualty. La resa in italiano ha tentato una mediazione nel rispetto delle scelte stilistiche di Evadne Price. Tuttavia, procedere senza l’ausilio di monosillabi e onomatopee, tipici dell’inglese, ha provocato comunque un rallentamento di ritmo, un indebolimento della sonorità delle parole e spesso una perdita delle allitterazioni. Laddove è stato possibile mantenere l’allitterazione, si è dovuto ricorrere a un allungamento della struttura frastica, come mostrano gli esempi [] e [.]: [] Men with hopeless dying eyes who don’t want to die… men with hopeless living eyes who don’t want to live. [.] Uomini dagli occhi disperati, con la morte dentro, che non vogliono morire… uomini dagli occhi disperati, pieni di vita, che non vogliono vivere. Negli esempi proposti, non poter trasporre in italiano, con pari sinteticità, le parole monosillabiche di cui abbonda l’inglese, ha comportato un allungamento del periodo che ha dilatato il ritmo della frase. Questo non ha però compromesso l’esito letterario, in quanto le assonanze sono state rispettate nel modus che era loro proprio: dying/die e morte/morire, living/live e vita/vivere. Un’altra perdita che ha inevitabilmente subito la traduzione, ha riguardato le allitterazioni, di cui il testo fonte è ricco. [] Sweaty sock and feet swollen to twice their size… purple, blue, red… big black blisters filled with yellow matter. BARBARA ANTONUCCI [.] Calzini sudati e piedi gonfi a dismisura… viola, blu, rossi… grosse vesciche scure, piene di roba gialla. Negli esempi [] e [.] la versione italiana ha perso l’allitterazione data dalle tre occlusive bilabiali di «big, black, blisters», che sembrano dare corposità alle vesciche, ma si è recuperata sonorità con «grosse vesciche scure» riproducendo almeno il rumore prodotto dalle fricative contenute in blisters. In altri momenti è stato invece possibile recuperare le sonorità del testo fonte, attraverso l’uso dei verbi lessicali, di cui entrambe le lingue offrono vasta scelta. [] They are all screaming now. Moaning and shrieking and howling like wild animals… [.] Adesso urlano tutti. Gemono, strillano e ululano come bestie feroci… Negli esempi [] e [.] è stato possibile recuperare il suono ovattato e morbido delle nasali m e n nel primo lemma, il suono pungente della fricativa in «shrieking», reso in modo forse più secco nella combinazione della fricativa s con l’occlusiva italiana t («strillano») mentre il suono “cavo” di «howl» è stato “sciolto”, con esito altrettanto convincente, nelle laterali di «ululano». Un’altra delle problematiche più ricorrenti nel testo fonte è stata la resa dei verbi, spesso ripetuti in sequenze di tre o quattro unità, un espediente che in italiano avrebbe condotto a una forzatura disarmonica. Nell’esempio che segue, il quarto verbo è stato tradotto per mezzo di un sostantivo: [] The shell-shocked man will yammer and twitch and jerk and mouth. [.] L’uomo con lo shock da granata, si torcerà nel delirio, si dimenerà e bestemmierà. I quattro verbi lessicali inglesi, brevi ed esplosivi, sono stati allungati dalle desinenze italiane del tempo futuro: la traduzione fedele – «delirerà, si torcerà, si dimenerà e bestemmierà» – avrebbe condotto a una forzatura eccessiva sulla lingua d’arrivo e a uno sgradevole fuori tempo. La perdita si avverte anche nell’impossibilità di rendere in italiano tutte le ripetizioni contenute nel testo, che nella nostra lingua sarebbero apparse banali, se non fanciullesche. [] Scream, scream, scream. Three different sets of screams now – [.] Gridano, là dentro, gridano. Tre tipi diversi di grida, ora – La scena è scandita su un ritmo marziale, il ripetersi del suono scream, scream, scream imprime al passaggio la cadenza di un rito, ma la proposta della triplice ripetizione del verbo gridano avrebbe macchiato il passo di ingenuità. Nel complesso, a traduzione ultimata, il testo di arrivo sembra essere riuscito nel riproporre la carica eversiva di una prosa dissacrante, a tratti ipnotizzante, SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE E TRADUZIONE trascinando nel testo di arrivo il sarcasmo affilato che attraversa il romanzo di Evadne Price. Se il risultato è un tradimento, è comunque un tradimento d’amore: il piacere risiede nella sfida, nell’esitazione della scelta, nell’incontro con un testo che si rispetta, che si ama e che si intende in un certo senso trascinare, a livello conscio non rovinosamente, nella propria lingua e cultura. Poiché non esistono verità ontologiche capaci di risolvere l’enigma della traduzione, al mediatore linguistico resta il piacere e il gusto di stare tra due lingue che si amano, di trovarsi «nella sconnessione che accompagna invisibilmente la congiunzione» (Berto, , p. XIII). L’impresa del tradurre è ardua ma, come sostiene Ortega y Gasset: «L’esistenza dell’uomo ha un carattere sportivo, di sforzo che si compiace in se stesso e non nel suo risultato. […] Queste nozze della realtà con l’incubo dell’impossibile forniscono all’universo gli unici accrescimenti di cui esso è suscettibile» (Ortega y Gasset, , pp. -). QUALCOSA DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE… FIGLIASTRE DELLA GUERRA Una guerra per porre fine alla guerra scrive mia madre. No, non è mai così. Fra vent’anni tornerà. E vent’anni dopo ancora. E poi ancora, ancora, finché alleveremo donne come mia madre e la signora Evans-Mawnington. E le stiamo crescendo. Etta Potato e B. F. – due su sei. Due come mia madre e la signora Evans-Mawnington. Madre venite con me, venite anche voi signora Evans-Mawnington. Permettete che vi mostri lo spettacolo direttamente sul campo di battaglia. Avrete qualcosa di originale da raccontare alle signore del comitato, mentre sferruzzano chilometri di sciarpe color kaki… qualcosa da declamare dal palco ai vostri comizi di reclutamento. Venite con me. Mettetevi lì. Ecco a voi il convoglio che entra lento in stazione, lento, lento. Fra un minuto scaricherà la sua triste merce. La mia ambulanza ha le porte aperte, pronta ad accogliere. Ecco. Il treno si è fermato. Osservate, fra le tende socchiuse di qualche finestrino, le barelle sistemate lungo i corridoi. Guardate attentamente, madre e signora Evans-Mawnington e vedrete quel che vedrete. Ciascuna di quelle barelle contiene qualcosa che un tempo era un uomo… gli eroi che hanno fatto la loro parte al servizio del Re e della nazione… gli eroi che hanno marciato festosi per le strade di Londra intonando Tipperary, mentre voi applaudivate e sventolavate isteriche le vostre bandiere. Non cantano, adesso, ve ne sarete accorte. Tappatevi le orecchie, madre e signora Evans-Mawnington, così le loro urla non si insinueranno per sempre nella vostra mente, come nella mente della figlia che avete spedito quaggiù, a fare la guerra. Osservate i portantini che sollevano le barelle una a una e le infilano con perizia nella mia ambulanza. Via, via, toglietevi di lì, madre e signora Evans-Mawnington – sollevate l’orlo delle vostre vesti di seta… un uomo sputa sangue, il movimento lo ha finito, gli ha dato il colpo di grazia… Morirà sulla strada per l’ospedale, o magari prima ancora che finiscano di riempire l’ambulanza… Lo so… La conosco bene questa storia. Spiacente per l’accaduto. Non è gradevole vedere un eroe che sputa le sue ultime gocce di sangue in pubblico, vero? Molto più romantico vederlo sulle foto dei giornali mentre riceve la medaglia al valore, anche se privo di un arto o due. Che spiacevole inconveniente! Come dite? Quello legato con le cinghie? Quella creatura delirante che bestemmia e urla oscenità di cui vi sfugge il significato… parole che vostra figlia, madre, utilizza nelle conversazioni di ogni giorno, un’abitudine contratta da contatti volgari di questo tipo. Oh, è solo impazzito, madre e signora Evans-Mawnington. Forse ha visto un corpo senza testa correre su e giù, con il sangue che schizzava dal tronco. Lo scricchiolio dei cadaveri congelati dal freddo, BARBARA ANTONUCCI incastrati uno accanto all’altro tra le assi di legno delle trincee, potrebbe avergli lentamente compromesso il senso della ragione. Tante sono le cose che possono ridurti in questo stato, me lo raccontano i feriti che mi siedono accanto nei lunghi viaggi notturni. No, non si tratta di shock da granata. Di solito un soldato con lo shock da granata è più calmo, a meno che non gli si faccia prendere uno spavento. Un momento e vi trovo un esempio. Ecco, quell’uomo che stanno tirando fuori ora. Quello che fissa il nulla… che ha scatti continui; ogni pezzo in una direzione diversa, come un burattino manovrato da fili impazziti. Guardate, tutte e due. Terribile, madre, non è vero? Non è vero, signora Evans-Mawnington? Quello è shock da granata. Se all’improvviso vi cadesse la borsa per terra, inizierebbe a dimenarsi come un pazzo, come l’altro. Come? Non volete tentare l’esperimento? Non riuscite a guardarlo? Perché no? Perché no? Eppure io devo farlo, ogni sera. Perché diamine voi non potete farlo per una volta? Siano maledetti i vostri occhi. Perdonatemi, madre e signora Evans-Mawnington. Non è certo questo il linguaggio che di solito usa una ragazza per bene, cresciuta a Wimbledon Common. Ho perso il controllo. Ricominciamo da capo. Vedete l’uomo che stanno infilando nella parte bassa dell’ambulanza? Ha una brutta tosse. No, non è polmonite. Neanche tubercolosi. Niente di così pittoresco. Piano, signori, piano… è quasi morto. Sputa grumi di una roba disgustosa fra il rosa e il verde. Sono solo i suoi polmoni, madre e signora Evans-Mawnington. Ha una bella tosse, stasera. È il gas. Avete sentito parlare del gas, vero? Brucia e fa marcire i polmoni fino a… alla lordura che vedete sul pavimento dell’ambulanza. Ha più o meno l’età di Bertie, madre. Gli somiglia pure, con quegli occhi marroni, gentili, e i capelli chiari, ricci… Bertie avrebbe la stessa aria supplichevole se dovesse sputar fuori i polmoni… Il figlio che con tanta generosità avete offerto alla guerra. Il figlio che siete così impaziente di spedire in trincea prima di Roy Evans-Mawnington, per paura che la signora Evans-Mawnington vi batta al prossimo comizio di reclutamento…«Ho dato il mio unico figlio maschio». Tossisci, biondino mio… tossisci, Forse da qualche parte tua madre ti sta pensando… vantandosi della vita che con tanta nobiltà ha donato… la vita che pensavi fosse tua ma che invece è sua e allora può buttarla via quando più lo ritiene opportuno. «Il mio ragazzo non è un debole, grazie a Dio». Tossisci, ragazzo mio, tossisci. Che importa? Purché tua madre non debba affrontare la vergogna di un figlio codardo. Quelli, invece, sono i feriti meno gravi. L’uomo che stanno facendo sedere accanto a me e gli altri due nell’ambulanza. Ferite da rimpatrio… braccia rotte e piedi incancreniti dalla trincea… sciocchezze. L’odore? Disgustoso, vero? Calzini sudati e piedi gonfi a dismisura… viola, blu, rossi… grosse vesciche scure, piene di roba gialla. Una bella combinazione di colori, vero? Vi ho fatto venire il voltastomaco? Vi chiedo nuovamente perdono. Il mio linguaggio si sta facendo di giorno in giorno meno raffinato. Sputo, vomito e sudore… Avevo dimenticato che non si usano parole di tal fatta nei salotti bene di Wimbledon Common. Ma sto perdendo tempo. Fra un minuto devo andare. Il carico è quasi completo. La barella che stanno spostando di lato? Oh, uno spettacolo fra i più comuni,… un uomo sofferente, per il quale il minimo movimento significa l’inferno… una semplice scorpacciata di granate. Lo stanno accantonando per il prossimo giro. Non è urgente come quella cosa disperata che sta lì, quel tronco senza braccia e gambe, quello che resta di un essere umano, che non può nemmeno implorare che qualcuno metta fine alla sua sofferenza, perché ha la mascella spappolata… No, non incrociate il suo sguardo, è troppo vivo. Parte della sua malevolenza potrebbe restarvi dentro fino alla fine dei vostri giorni… i vostri giorni pieni di comizi e ferri da calza. Ammirate gli eroi che hanno nobilmente difeso le vostre tradizioni, madre e signora Evans-Mawnington. Guardateli bene… Gli eroi su cui ricamerete finché la pace non sarà stipulata e che, dopo, lascerete morire di fame, nei secoli dei secoli, amen. Non andatevene madre e signora Evans-Mawnington. Date un’occhiata alla mia ultima barella,… a quella cosa senza bende, farneticante, a quel grumo di carne viva che si agita su SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE E TRADUZIONE un collo. Quella era una faccia non molto tempo fa, da non crederci. Ora potrebbe essere qualunque cosa… un pezzo di fegato, fegato crudo e sanguinolento, è a questo più che altro che somiglia, no? Impossibile capire la sua età ma i gemiti di sofferenza sembrano quelli di una voce giovane. Simile ai gemiti laceranti di un neonato malato… un neonato torturato… gemiti confusi. Chi sarà mai? Per quanto ne sapete, signora Evans-Mawnington, potrebbe essere il vostro Roy. Potrebbe essere chiunque, e dunque perché non il vostro Roy? Un pezzo informe di fegato crudo è come un qualsiasi altro pezzo informe di fegato crudo. Come dite? Perché non lo fasciano con le bende? Che diavolo ne so io? Me lo sono chiesta spesso… ma non lo fanno. Perché vi voltate? È solo gas liquido. Avete sentito parlare di gas liquido, vero? Oh sì. Ricordo la vostra lettera… «Ho sentito che abbiamo cominciato a usare il gas liquido. Così i tedeschi imparano. Spero che ne useremo tanto». Sì, avete scritto così. Eravate contenta che i chimici che fanno la guerra avessero inventato una nuova diabolica tortura. Eravate deliziata all’idea che la pelle del viso di qualche povero figlio di madre tedesca fosse dilaniata dal gas liquido… Proprio come qualche madre tedesca, ugualmente patriottica, avrà gioito nel sentire che i figli di madri inglesi sarebbero stati bruciati e torturati dai nuovissimi arnesi di guerra, freschi di laboratorio. Non andate via, madre e signora Evans-Mawnington,… non andatevene. Il mio carico è al completo ma ci sono più di trenta ambulanze da riempire. Camminate lungo il binario. Non andatevene, a meno che non vogliate che vi perdoni l’assenza perché avete urgenza di vomitare, come spesso faccio io. Sono troppe le barelle che non avete ancora visto… Uomini dagli occhi disperati, con la morte dentro, che non vogliono morire… uomini dagli occhi disperati, pieni di vita, che non vogliono vivere. Aspettate, aspettate, ho così tanto da mostrarvi prima che torniate ai vostri comitati e ai comizi di reclutamento, prima che aggiungiate altre reclute alla vostra lista… quelle giovani reclute che arruolate con l’orgoglio, con i discorsi patriottici, le coccarde rosse, bianche e blu, le piume bianche, i vostri insulti, le vostre bugie… bugie utili ad assicurarvi una nuova vittima. Come? Non ce la fate più? Ve ne andate? Sapevo che non sareste rimaste. Ma io devo restare, vero?… Io devo restare. Mi hai mandato tu quaggiù, e mi ci farai restare. Mi hai beatificato. Io sono una delle Giovani Splendide Donne che stanno vincendo la Guerra… «Carica. Sei barelle e sei feriti lievi!». Parto. Rallento al cancello della stazione. Il sergente è lì che aspetta con lista e matita. Ripeto, «sei barelle e sei feriti lievi». «Numero Otto». Depenna la mia ambulanza. Supero il cortile. … Numero Otto. Un numero fortunato! È lontano ma la strada è buona, tutto sommato poche buche e pochi sassi. Avanti, piano, avanti. Ci trasciniamo a passo di lumaca… un’enorme macchia scura che striscia lungo la strada, di un bianco accecante. Avanti, piano, avanti. Il ferito accanto a me si abbandona sullo schienale, immobile. Esausto o addormentato, dopo il lungo viaggio. Ha il braccio chiuso nelle stecche, la testa bendata e il piede sinistro avvolto in una goffa pantofola dell’esercito. Si abbandona sullo schienale; nell’oscurità il suo volto è invisibile, come se un muro di mattoni ci separasse. Il vento taglia come un lama. Avrà senz’altro freddo, non ha il cappotto e ha una manica strappata. Si è avvolto intorno alle spalle la coperta dell’esercito, lasciando le gambe in balia della notte gelida. Nevica di nuovo. Gli enormi fiocchi di neve friggono non appena sfiorano il radiatore. Dico al mio passeggero che può trovare sigarette e fiammiferi nella tasca del mio cappotto, dalla sua parte. Li ho messi lì di proposito… la mia esca per farlo parlare. BARBARA ANTONUCCI Voglio che parli. Non risponde. Voglio che parli. Riuscire a far parlare un ferito serve per soffocare la disperazione. L’ho scoperto qualche tempo fa. Ripeto l’invito, un po’ più forte stavolta. Nessuna risposta. È sfinito. Troppo sfinito anche per fumare. Non ho fortuna stasera. Avanti, piano, avanti. Come procede lenta questa macchia pesante ed enorme. Lenta. A guardarla, è difficile credere che si possa guidare un’ambulanza di questa portata così lentamente… Avanti, piano, avanti. Era un urlo quello che ho sentito venire dall’interno? Devo concentrarmi su qualcosa… Ma cosa? Ecco, sì. Il mio ballo di debutto in società. Il vestito del mio primo ballo da grande, un vestito di georgette bianco, sfavillante di lustrini, in stile impero, lungo fino ai piedi… Era un urlo?… ricavato da una sottoveste… non urlare, se no inizieranno anche gli altri… una sottoveste di raso… Scarpe di raso abbinate, non proprio piccole; ho sempre avuto i piedi un po’ grandi, come le mani… Era un urlo dall’interno?… Quanto c’è voluto, a mia madre, per trovare guanti bianchi della mia misura, lunghi fino al gomito… Era un urlo?… I capelli raccolti per la prima volta… oddio, un urlo di sicuro… i capelli raccolti in piccoli boccoli sulla nuca… un altro urlo – il matto ha cominciato, il matto ha cominciato. Lo temevo. Li farà urlare tutti… trentuno piccoli boccoli come tanti salamini. Era venuta una parrucchiera professionista: c’erano volute circa due ore per farli, mentre Trix e mia madre guardavano e Sarah veniva a sbirciare. Non far urlare anche gli altri; non far urlare anche gli altri… trentuno salamini di capelli, uno sull’altro, e i capelli erano tutti miei; copiati da una cartolina di Phyllis Dare o Lily Elsie. Quale era delle due?… L’uomo con lo shock da granata ha cominciato a lamentarsi. Per colpa del matto, ha cominciato a guaire come un cane impazzito… Credo fosse Lily Elsie… Ma che combinano là dentro? «Fatemi uscire. Fatemi uscire». È il matto che parla. Lily Elsie, credo fosse proprio lei. Lily Elsie… «Smettila di gridare. Non sei l’unico che patisce le pene dell’inferno». Questa era una voce diversa. Deve essere uno dei feriti lievi… Scarpe di raso con le fibbie sulle punte – delle fibbiette di madreperla a forma di mezzaluna. Me le aveva date la zia Helen, o Trix. «Falla finita o ti ammazzo a colpi di stampella, bastardo. Falla finita». Cos’ è questo rumore? Fanno a botte là dentro… strillano, strillano, strillano… «Sto morendo. Oddio, mi ha ammazzato. Sto morendo». Che succede? Si stanno ammazzando? Dovrei fermare l’ambulanza; dovrei scendere a guardare. Dovrei fermarli… dovrei. Un’autista la scorsa notte ha fermato l’ambulanza, un ferito era impazzito e stava colpendo alla testa un poveraccio sulla barella. Ma lei è riuscita a bloccarlo e l’ha legato di nuovo. Tosh, è stata lei…. Ma Tosh è coraggiosa. Io non riuscirei mai a farlo. Devo andare avanti… Adesso urlano tutti. Gemono, strillano e ululano come bestie feroci… tutta sola con un’ambulanza di uomini deliranti, lontana mille miglia da tutto, nel buio totale… matti deliranti che urlano e strillano. Io rischio di impazzire… Vai a vedere… vai a vedere… vai a vedere. No, non lo faccio. Non ci riesco… Il cuore mi martella dentro. Ho le mani e i piedi congelati ma il sudore scende a rivoli per la schiena. Ho già guardato una volta, non ho il coraggio di rifarlo. Che posso fare di buono? L’uomo che sputava sangue sarà steso lì, morto… gli occhi vitrei fissi sulla porta dell’ambulanza mi accuseranno appena metto il naso dentro,… occhi morti e freddi, che se la prenderanno con me… ma io non ho nessuna colpa. …Il matto imprecherà contro di me, mi urlerà contro terribili maledizioni, griderà e cercherà di strappar via le cinghie che lo tengono fermo… se non se le è già strappate. Cercherà di strapparle per strangolarmi. L’uomo con lo shock da granata, si torcerà nel delirio, si dimenerà e bestemmierà. L’uomo con la faccia come fegato crudo si metterà a gemere… Non ci vado a vedere. Non ci vado. SPERIMENTAZIONI LINGUISTICHE E TRADUZIONE Avanti, piano, avanti. Numero Otto, dove sei? Forse non ti ho visto lungo questa strada innevata, sempre uguale. Sono ore che viaggio. Vado troppo piano? Potrei accelerare un po’… coprire la distanza più in fretta. Lo faccio. Un altro urlo non appena prendo un sasso… Ho fatto male a qualcuno. Rallento di nuovo. Gridano, là dentro, gridano. Tre tipi diversi di grida, ora – gli strilli del matto, il lamento ferino, monotono, dell’uomo con lo shock da granata, e ora un urlo stridulo e secco come la lama appuntita e lucente di un coltello conficcata nel mio cervello. Urla… uno, due, tre, quattro, staccato. Questo chi è? Non è il biondino. Lui sarà troppo impegnato a morire soffocato per poter strillare. Se ne è aggiunto uno nuovo… È l’inferno. Si stanno battendo di nuovo… si sono scatenati i diavoli dell’inferno. Vai a vedere, vai a vedere… Non ci vado a vedere. Non ci vado. Avanti, piano, avanti. Il mio passeggero continua a dormire. Gli si è posato sul grembo un mucchietto di neve. Ci siamo persi il Numero Otto. Con la neve, non ho visto la svolta. Il tronco d’albero nero sulla sinistra che porta al Numero Otto… coperto dalla neve. Con la neve, non ho visto la svolta. Avanti, piano, avanti. Le urla si sono placate, sostituite da un lamento angosciante. Oo-oo-oh… oo-oo-oh… un canto funebre, regolare, si solleva oltre il suono del motore e si propaga nella notte. Oo-oo-oh… oo-oo-oh… è straziante nella sua disperazione. Ho già sentito un uomo lamentarsi così. L’ultimo lamento di un uomo che avrebbe di lì a poco smesso di lamentarsi, per sempre. Oo-oo-oh… disperazione, solitudine. Le lacrime mi straziano il cuore… lacrime tragiche che mi tormentano ma che non devono salirmi agli occhi; si congelerebbero sulle guance fino a incollarmi le ciglia e non vedrei più la strada. Mi è negato anche il conforto di lacrime di compassione. Avanti, piano, avanti. Ho perso la speranza di raggiungere il Numero Otto. Andrò avanti fino a quando non trovo un posto per girare. Avanti, piano, avanti. I lamenti sono finiti. Tendo le orecchie. Il matto urla di nuovo… un monologo roco, pieno di ingiurie. Non riesco a capire quello che dice. Non voglio capire quello che dice. Eppure cerco di capire. Farà di nuovo urlare gli altri… Avanti, piano, avanti. Se solo riuscissi a trovare un posto per girare. La strada sembra farsi più stretta. Quanti viaggi farò, stanotte? Era un convoglio grande? Non ci ho fatto caso alla stazione… dimentico sempre di farci caso. Forse avrò ferite da granata al prossimo giro… granate, troppo il sangue perso per gridare, troppo esausti. Magari un passeggero che parla e fuma. …Il matto urla di nuovo… farà urlare anche gli altri. Avanti, piano, avanti. Ma quella è una luce? No… sì! Numero Otto! Il padiglione riluce fioco nell’oscurità… le tele del tendone sono già aperte… le infermiere in cuffia bianca aspettano all’ingresso. Vedono i miei fari. Gli infermieri sono lì pronti… Numero Otto… Numero Otto… finalmente ci sono. Le lacrime mi scendono giù per le guance… che scendano. Che congelino pure le mie ciglia, ora… che le congelino… Ora non importa… niente importa, ora… (Traduzione di Barbara Antonucci) Note . Personaggio discusso per la sua eterogeneità di interessi e produzione letteraria, Evadne Price pubblica, oltre a una corposa produzione di articoli, libri per bambini, sceneggiature e pièces BARBARA ANTONUCCI teatrali (a cui lei stessa prende parte) nove romanzi e fiction popolare (Society Girl, Glamour Girl, Escape to Marriage, Air Hostess in Love fra i titoli più noti). Price acquisisce fama anche come personaggio di teatro (con la commedia Big Ben scritta per il Malvern Festival nel e con la rappresentazione per il teatro e per il cinema di Once a Crook) e come personaggio della televisione intrattenendo ogni sera, per oltre venticinque anni, un vasto pubblico di spettatori con un programma dedicato agli astri curando parallelamente le rubriche dedicate all’oroscopo sulle riviste “She” e “Vogue”. Not So Quiet… () riscosse molto successo e venne seguito dalla serie Women of the Aftermath (), Shadow Women (), Luxury Ladies (), They Lived with Me (). . Il titolo scelto per la versione italiana, Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale, mantiene il collegamento con il romanzo di Remarque, noto al pubblico italiano con il titolo Niente di nuovo sul fronte occidentale. Bibliografia BERTO G. (), Introduzione a Derrida (). DERRIDA J. (), Il monolinguismo dell’altro, Raffaello Cortina, Milano (ed. or. ). MARCUS J. (), Afterword to Price (). ORTEGA Y GASSET J. (), Miseria e splendore della traduzione, il Nuovo Melangolo, Genova (ed. or. ). PRICE E. (), Not So Quiet… Stepdaughters of War, The Feminist Press, New York (a ed. ). RAZZA C. (), Introduzione a Ortega y Gasset (). DUE SCIALLI DALL’INDIA: ECHI D’OLTREMARE IN JANE AUSTEN di Maria Paola Guarducci Austen was the seventh of eight children. Since my concern is her highly individual genius, which distinguished her from her siblings and nearly everyone else in Great Britain, I begin by declaring my pragmatic disinterest in the supposed relationship between her novels and her country’s imperial policies and procedures. I have met a remarkable number of persons who teach – I will not say literature, but cultural studies – and who tell me that they never have read Mansfield Park, and yet tell me also that what matters most about Austen’s novel is its financial “dark side”, Sir Thomas Bertram’s ownership of a sugar plantation in Antigua (Bloom, , p. ). Come dimostra questo polemico passo tratto dalla voce che Harold Bloom dedica alla scrittrice nel recente Genius. A Mosaic of One Hundred Exemplary Creative Minds (), pensare a Jane Austen in chiave postcoloniale provoca perplessità e diffidenza. Gli scarni accenni al nascente impero inglese presenti nei suoi romanzi non sembrano sufficienti a giustificare tale lettura. Il metodo critico di Bloom, notoriamente svincolato da considerazioni di tipo politico nelle analisi del rapporto tra scrittori e contesti storici, si pone in maniera opposta al procedimento interpretativo della critica di derivazione marxista, in particolare di quelle postcoloniale e femminista. È sulla base di questi presupposti che, in queste pagine, mi propongo di rintracciare gli echi del nascente impero britannico nell’opera di Jane Austen; echi che formano un’immagine di per sé quasi impalpabile e a tratti contraddittoria la quale assume rilevanza, però, nell’interazione con altri temi topici dell’opera di Austen, come la questione femminile, il patriarcato e il concetto di home. È mia intenzione rinvenire i nessi esistenti tra le opere della scrittrice e un’idea di grandeur britannica che se da un lato produce ricchezza e prestigio per la nazione e il suo popolo, dall’altro genera scompensi e disarmonie essendo fondata su schiavismo, mercificazione, violenza, disuguaglianza. Jane Austen ed Edward Said Alla fine degli anni Settanta, nel seminale Orientalism, Edward Said si dichiara convinto che «society and literary culture can only be understood and studied together» (Said, , p. ) e propone la rilettura di alcuni classici con lo scopo di ricostruire un “discorso sull’Oriente” – stereotipato, paternalista e fazioso – disseminato nella letteratura occidentale moderna. Said sostiene che sebbene non si possa dire – prima di tutto storicamente – che questo discorso abbia “appoggiato” l’Europa nella sua politica coloniale, si può però dire che le ha offerto il supporto ideologico grazie MARIA PAOLA GUARDUCCI al quale intraprendere quella politica e perseverarla per almeno un secolo senza nutrire dubbi sulla sua legittimità. Dalle premesse gettate con Orientalism, il critico palestinese procede verificando i rapporti che intercorrono tra potere e cultura e sceglie Mansfield Park di Jane Austen come oggetto di indagine per una delle tesi formulate in Culture and Imperialism (Said, ). A detta di Said, «Austen […] in Mansfield Park sublimates the agonies of Caribbean existence to a mere half-dozen passing reference to Antigua. […] the metropolis gets its authority to a considerable extent from the devaluation as well as the exploitation of the outlying colonial possession» (ivi, pp. -); e ancora più chiaramente: «[…] the novel, steadily, if unobtrusively, opens up a broad expanse of domestic imperialist culture without which Britain’s subsequent acquisition of territory would not have been possible» (ivi, ). Tra tutti i romanzi di Jane Austen, Mansfield Park è l’unico in cui il tema dei possedimenti inglesi d’oltremare svolge effettivamente un ruolo cruciale: «[…] a novel based in England relying for the maintenance of its style on a Caribbean island» (ivi, p. ), lo definisce ancora Said. L’esistenza della sontuosa tenuta di Mansfield Park e il sostentamento dei suoi abitanti, la famiglia Bertram, si reggono infatti sui proventi che arrivano dalle proprietà di Sir Thomas ad Antigua, piantagioni di zucchero con tutta probabilità. Sulle origini e la longevità di questa realtà economica, i lettori non sono informati (Armstrong, , p. ). All’inizio del romanzo, Sir Thomas deve recarsi di persona ad Antigua per «some recent losses on his West India Estate» (Austen, , p. ), perdite che stanno provocando una crisi nelle finanze della famiglia. È l’epoca in cui Brasile, Mauritius e persino la barbabietola da zucchero europea, rimarca Said, stavano entrando in competizione con le produzioni caraibiche inglesi di canna da zucchero in un contesto economico che si avviava verso il libero commercio (Said, , pp. -). La tratta degli schiavi era stata formalmente abolita dagli inglesi nel , ma solo nel una seconda legge ne aveva decretato la natura criminosa definendo in maniera più severa le punizioni per gli inglesi che la praticavano. Tanto lo scambio di schiavi tra colonie che li avevano già acquisiti quanto il loro possesso fuori dall’Inghilterra non erano stati toccati da queste prime leggi. Mansfield Park è ambientato orientativamente tra il - e il : periodo cruciale per la campagna abolizionista che porterà negli anni Trenta alle leggi sull’emancipazione degli schiavi. In breve, il sistema che produce le ricchezze dei Bertram è in una fase critica e mostra i segni di un eventuale crollo per ragioni sia di carattere economico sia di carattere etico. Inoltre, sin dall’inizio del Settecento si registrano le prime significative ribellioni di schiavi nelle piantagioni caraibiche; si ricordano, proprio ad Antigua, le rivolte del e del . Per tutto il tempo in cui non è sulla scena del romanzo, Mansfield Park, Sir Thomas si trova ad Antigua, dove è possibile che debba recarsi di persona per sedare delle rivolte; ma ad Antigua il romanzo non si avventura mai e la laconicità del testo in merito a quel luogo lascia spazio solo a supposizioni su ciò che vi avviene. Secondo Said, per Jane Austen la realtà del nascente impero inglese avrebbe un carattere assumed, dato per scontato. Antigua sarebbe presente nel testo in modo schizofrenico: da una parte vi si allude appena, dall’altra essa è indispensabile all’economia del romanzo. Fondamentale ma cancellata, l’isola sembra non esistere se non in relazione alle ricchezze che da lì alimentano Mansfield Park. Il romanzo riserva un analogo destino di subordinazione anche alla sterminata India, da cui il fratello di Fanny, che come i fratelli di Jane Austen è nella marina inglese, dovrà DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN riportare a Lady Bertram un paio di scialli di seta quando vi si recherà in missione. Nella lettura di Said, Mansfield Park e Antigua sono correlati: il primo è un impero domestico in cui deve regnare l’ordine e perché questo possa avvenire deve esserci ordine anche nell’impero d’oltremare. La tranquillità e l’armonia dell’uno dipendono dalla produttività e dalla condotta dell’altro, la mera esistenza del secondo è sacrificata per la prosperità del primo (ivi, p. ). Said conferisce centralità alla figura di Sir Thomas in virtù del suo ruolo di disciplinatore at home e, con tutta probabilità, ad Antigua. Se una simile lettura di Sir Thomas ha una forte ragion d’essere, a questa dovrebbe però seguire la valutazione dei risultati che egli ottiene con il suo autoritarismo. Sui suoi risultati ad Antigua non abbiamo dettagli; quelli che produce a Mansfield Park, invece, costituiscono come vedremo il nucleo del romanzo. Su questi ultimi, però, l’analisi di Said non si sofferma. Orizzonti austeniani: dallo Hampshire alle West ed East Indies Se il disinteresse politico di Austen per il mondo fuori dalle Isole Britanniche sembra a molti un punto fermo, ugualmente radicata è la sensazione che i “temi” dell’espansione geografica, del commercio, dello sfruttamento di terre e popolazioni lontane fossero ineludibili persino nel microcosmo provinciale e apparentemente immobile in cui vive e di cui scrive Jane Austen. L’incontaminazione di questo microcosmo, è stato ampiamente dimostrato, è un falso mito. Nel , per citare un solo esempio di contatto tra la cronaca politica e il mondo della scrittrice, inizia il processo per l’impeachment di Warren Hastings voluto da Edmund Burke, il quale accusa l’ex governatore del Bengala prima () e dell’India britannica poi (-) di corruzione, omicidio e di una gestione scellerata del potere. Warren Hastings aveva fatto da padrino a Eliza Hancock, nata in India nel da Philadelphia, sorella del padre di Jane. La giovane era rientrata in Europa, aveva sposato un francese – che morirà sulla ghigliottina nel – e viveva tra Francia e Inghilterra. Eliza conosceva gli Austen e intratteneva un costante rapporto epistolare con Jane, secondo le sue stesse parole la sua cugina prediletta. Il processo ad Hastings si conclude nel con la piena assoluzione, ma l’attenzione alla vicenda tiene banco per quasi dieci anni, presumibilmente anche a casa Austen. Sono gli anni in cui l’Inghilterra sta forgiando la propria identità su una calibrata distanza politica e culturale dalla Francia e su un progetto di espansione geografica vecchio di almeno un paio di secoli. Tra il e il le conquiste in territorio indiano di Lord Wellesley gettano le basi per l’organizzazione formale dell’egemonia britannica sul continente. Di lì a poco l’Inghilterra toccherà il suo apogeo come potenza imperiale. At home, gli echi della prima rivolta di schiavi a Santo Domingo () suscitano sgomento e riflessioni, e hanno una parte decisiva nella nascita del movimento abolizionista. Il programma di espansione inglese è ambizioso e implica un’aggressività che, anche quando non è dichiarata, è messa in pratica. È un progetto che ha bisogno di appoggio, poiché esiste un’opposizione composita che fin dall’inizio ne mette in discussione modi e finalità, come dimostrano il celebre discorso ai Comuni di Edmund Burke () – la cui vulgata riecheggia nelle parole di alcuni personaggi di Sanditon () –, il processo ad Hastings e il richiamo da parte del governo inglese dello stesso Lord Wellesley nel , ammonito per l’arbitrarietà e la violenza dei suoi modi, nonché per le ingenti spese che le sue guerre indiane avevano provocato MARIA PAOLA GUARDUCCI (Wolpert, , pp. -, -). Ignorare questa nuova, permeante cultura non è più possibile. Una politica che necessita di consenso non può restare confinata nelle terre lontane dove viene esercitata senza particolari freni né scrupoli; essa contagia anche il luogo da cui il suo potere si irradia. At home, quindi, la necessità di regole e di ordine non solo si rafforza, ma l’idea di una “superiorità domestica” diventa garanzia della missione nazionale fuori dai propri confini (Perera, , p. ). Se la nazione funziona, l’impero funziona. Mansfield Park, con la figura dell’autoritario Sir Thomas, mette però in discussione la realtà appena descritta, una realtà nella quale, come si è visto, convivono tensioni e aspettative diverse rispetto al progetto imperialista e ai suoi nessi con la schiavitù. La tenuta di Mansfield Park, vedremo, dovrebbe rappresentare il luogo da cui si dirama l’autorità, ma si rivela invece un microcosmo che non funziona – forse non può funzionare, visti i presupposti su cui si fonda – e lo stesso Sir Thomas impara che il disciplinamento può anche sortire effetti opposti a quelli desiderati. Nei primi tre romanzi di Jane Austen – Sense and Sensibility (), Pride and Prejudice () e Northanger Abbey (), la cui stesura risale alla fine del Settecento, o comunque non va oltre il – non ci sono allusioni a territori inglesi d’oltremare, mentre nei romanzi che la critica considera “maturi” – Mansfield Park, Emma (), Persuasion () e l’incompiuto Sanditon – questi riferimenti compaiono. In Sanditon figura per la prima e unica volta nell’opera della scrittrice un personaggio extra britannico e legato alla realtà coloniale: la meticcia Miss Lambe. L’allargamento dell’orizzonte di Austen si spiega con il progressivo coinvolgimento dell’Inghilterra nella politica di sfruttamento e scambio commerciale con il resto del mondo, in particolare con l’India e i Caraibi, politica che fa sì che sempre più inglesi si rechino fuori dalla madrepatria e, soprattutto, vi ritornino carichi di idee e impressioni – non di rado anche con qualche figlio meticcio – che una volta at home producono nuovi significati e nuove dinamiche culturali. Mi sembra che si possa dire che i romanzi “maturi” di Austen, in particolare Mansfield Park e Persuasion, dove l’ombra del futuro impero è presente, differiscano di tono dai precedenti – si incupisce l’ironia dark ma brillante delle sue prime tre opere – anche per la maggiore consapevolezza della scrittrice rispetto a una società in piena transizione che, mentre persegue l’idea di un impero d’oltremare senza lesinare l’uso della violenza e l’impiego degli schiavi, rafforza anche le regole e il concetto di autorità all’interno dei propri confini, at home. Mansfield Park e Persuasion sono i due romanzi di Austen in cui le inseparabili nozioni di home e di patriarcato vengono poste più duramente sotto scrutinio e sono i due testi che maggiormente trasmettono un senso di inquietudine in virtù delle questioni che pongono senza risolvere. Se le figure paterne create da Jane Austen sono sempre uno dei bersagli privilegiati della critica e del sarcasmo della scrittrice, qui, più che altrove, i padri si configurano come veri e propri nemici delle figlie. Se il problema della casa e l’impossibilità delle donne di possederne una sono nodi cruciali per Austen, qui, più che altrove, le due protagoniste vengono letteralmente “rimosse” dalla dimora natale e la loro ricollocazione in una house che sia anche home appare problematica e ansiogena. Mansfield Park e Persuasion hanno in comune anche l’atipicità delle protagoniste: Fanny Price e Anne Elliot condividono quella combinazione di umiltà, timidezza e riserbo che fa il tratto distintivo del loro carattere e che le isola dai contesti in cui sono poste. Esse non rispondono alle meschinità di questi contesti con il brio, la vivacità e l’orgoglio che troviamo in Elizabeth Bennet in Pride and Prejudice o in Elinor Dashwood in Sense and Sensibility; mancano della superbia e assertività di DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN Emma Woodhouse. Più che agire, entrambe resistono, e la loro resistenza, che somiglia a una forma di sottomissione, fa sì che si ritrovino spesso a dover soddisfare desideri e capricci altrui. Il sacrificio di se stesse, l’abnegazione verso gli altri, la mancata articolazione o la censura dei propri desideri sono le modalità attraverso cui questi due personaggi stanno al mondo. Tanto Fanny quanto Anne, che pure è figlia di un baronetto e non condivide il basso statuto sociale di Fanny, ricordano Cenerentola. E come Cenerentola, nonostante, o forse in virtù della loro apparente debolezza – di “passività” parla molta critica –, esse trionfano. La loro vittoria si realizza perché prive e private di tutto, esse restano padrone di se stesse. La venatura di amarezza che getta qualche ombra sugli apparenti happy ending dei due romanzi – altro tratto che accomuna le due opere distinguendole dal resto della produzione di Austen – complica, vedremo, l’epilogo vittorioso delle loro vicende segnalando il carattere utopico, e incerto, delle nuove situazioni che entrambi i finali profilano. La “frecciata” alla tratta degli schiavi Se è vero, come sostiene Said, che «it would be silly to expect Jane Austen to treat slavery with anything like the passion of an abolitionist or a newly liberated slave» (Said, , p. ), è vero anche che il tema della schiavitù non entra nei suoi romanzi in modo neutrale. Austen critica esplicitamente, come vedremo, i presupposti della schiavitù, ma è discutibile spingere la lettura della sua opera sino a vedervi la celebrazione dell’abolizione della tratta degli schiavi, come sostiene Gabrielle D. V. White () nel suo recente studio sulla scrittrice. Rispetto alla posizione di Jane Austen nei confronti della schiavitù, è stata giustamente rilevata la frequenza con cui ella cita William Cowper, Doctor Johnson e Thomas Clarkson, tre autori che sostennero in modo aperto l’abolizionismo (Jordan, , p. ). Non è sfuggito alla critica il fatto che nella History of the Abolition of the Slave Trade () di Clarkson compaia uno schiavista di nome John Norris che potrebbe aver ispirato il personaggio di Mrs Norris – “schiavista” nel modo in cui si relaziona a Fanny – in Mansfield Park (Ferguson, , p. ). Non è parso del tutto casuale il titolo di Mansfield Park , che chiama in causa l’allora famoso “caso Somersett” (), in cui il giudice Lord Mansfield stabilì che il nero James Somersett non poteva venire ricondotto in condizione di schiavo in Virginia contro il suo volere. Con questa sentenza il giudice stabiliva – sembra suo malgrado – un importante precedente: uno “schiavo” aveva gli stessi diritti di un libero cittadino inglese e poteva accedere in un tribunale, essere ascoltato e persino vincere una causa. È lo stesso Cowper, nel poema intitolato The Task () che Jane Austen cita sia in Mansfield Park sia in Emma, a elogiare la sentenza di Mansfield (White, , pp. , ). Jane Austen era d’altronde toccata da vicino, seppure non direttamente, dalla questione della schiavitù, visto che nel , quindici anni prima che lei nascesse e in epoca di piena tratta, suo padre, il reverendo George Austen, aveva accettato di amministrare per conto di un amico una piantagione ad Antigua. Il fratello di Jane, Francis, ammiraglio della Royal Navy tanto decantata in Persuasion, era invece un noto sostenitore dell’abolizionismo e fu anche impegnato in modo attivo – come dimostrano proprio le lettere alla sorella – nel garantire che la legge del , largamente disattesa dagli stessi carghi inglesi, fosse rispettata. Vale la pena di aggiungere che, nonostante il relativo isolamento di Jane Austen, sembra difficile che alla scrit- MARIA PAOLA GUARDUCCI trice potessero sfuggire le pubblicazioni della propaganda abolizionista, tra cui A Narrative of a Five Years’ Expedition Against the Revolted Negroes of Surinam (), diario del capitano John Gabriel Stedman, un inglese assoldato dagli olandesi per sedare le rivolte di schiavi in Sud America. Il volume, illustrato da William Blake, Michele Benedetti, Thomas Holloway e Francesco Bartolozzi, fu più volte ristampato e divenne, sembra più di quanto intendesse l’autore “pentito”, un documento prezioso per gli abolizionisti. Che il dibattito sulla tratta degli schiavi, in teoria abolita ma nella pratica ancora attiva, fosse noto ad Austen è dimostrato in maniera incontrovertibile da un passo in Emma. Jane Fairfax, garbata fanciulla priva di mezzi e perciò destinata suo malgrado a impiegarsi presso qualche abbiente famiglia come istitutrice, sta tentando di scoraggiare il non richiesto interessamento alla sua sorte da parte della presuntuosa e indiscreta Mrs Elton, il cui cognato, Mr Suckling, si è arricchito in maniera imprecisata in quel di Bristol, all’epoca uno dei porti più importanti nel commercio degli schiavi: «[…] There are places in town, offices, where inquiry would soon produce something – Offices for the sale – not quite of human flesh – but of human intellect.» «Oh! My dear, human flesh! You quite shock me; if you mean a fling at the slavetrade, I assure you Mr Suckling was always rather a friend to the abolition.» «I did not mean, I was not thinking of the slave-trade,» replied Jane; «governesstrade, I assure you, was all that I had in view; widely different certainly as to the guilt of those who carry it on; but as to the greater misery of the victims, I do not know where it lies. But I only mean to say that there are advertising offices, and that by applying to them I should have no doubt of very soon meeting with something that would do.» (Austen, , p. ). Questo brano in cui si confrontano due donne di provincia e di cultura medio-bassa conferma la diffusione del dibattito e mi sembra che lasci intendere anche la posizione di Austen. Il paragone tra schiavi e donne come victims, che era già comparso negli scritti di Mary Wollstonecraft, dimostra l’inaccettabilità dal punto di vista etico per Austen sia della tratta degli schiavi sia dei meccanismi crudeli che la società attivava nei confronti delle donne sprovviste di mezzi. Emerge una critica decisa alle modalità e finalità con cui la società attribuisce i ruoli alle donne e si assicura che questi vengano mantenuti, modalità e finalità che ricordano la violenza – in questo caso solo morale – e lo sfruttamento che caratterizzano la pratica dello schiavismo. Per capire l’amarezza di Jane Fairfax, occorre però considerare anche il significato culturale del mestiere dell’istitutrice ai tempi di Austen. Lo storico sociale Lawrence Stone () rimarca che la scelta di diventare istitutrici – scelta quasi obbligata per quante, mediamente colte, erano prive di mezzi – era sì un’opzione “rispettabile”, ma condannava le donne al nubilato in una società in cui solo il matrimonio era in grado di dar loro un’identità e una posizione (fanno eccezione, ma relativamente, le donne nobili o molto ricche) e per questo era una scelta vissuta con disagio dalle stesse donne. Non proprio una serva ma decisamente non una padrona, soprattutto mai più moglie, l’istitutrice – come lo schiavo – non ha casa né famiglia, è un’esule sociale che si radica nel nuovo contesto il più delle volte suo malgrado, ben sapendo che si tratta di una scelta che la subordina ad altri e, soprattutto, di una scelta raramente reversibile. Il nubilato consacra l’istitutrice nello stereotipo della spinster (“zitella”) all’epoca essere iracondo e malvagio, destinato all’isolamento sociale, alla denigrazione, al pubblico ludibrio. Le valutazioni che spin- DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN gono la pur intelligente Charlotte Lucas, in Pride and Prejudice, a sposare l’insopportabile Mr Collins, o l’ansia di Miss Elizabeth Elliot, in Persuasion, che non vuole più aprire il libro della nobiltà, poiché non tollera l’assenza di una data di matrimonio accanto a quella della sua nascita, confermano quanto detto. Con un salto nel tempo, il personaggio di Miss Kilman, in Mrs Dalloway () di Virginia Woolf, dimostra che a distanza di un secolo nulla è cambiato nella considerazione sociale di questa reietta figura femminile cui Austen riserva in Emma, se non il disprezzo di Clarissa, la compassione di tutti gli altri personaggi e dello stesso narratore . L’istitutrice, con il suo destino incerto che la vedrà rinchiusa in qualche asilo o ospizio una volta esaurita – per malattia o vecchiaia – la funzione di servizio, rammenta alla donna la sua precarietà sociale. “Schiava” in una home di cui si prende temporaneamente cura ma che non le appartiene né le apparterrà mai, questa figura condivide alcuni tratti simbolici con gli schiavi effettivi. Nel suo saggio sui rapporti tra realtà domestica e realtà imperiale in relazione ai romanzi di Jane Austen, Maaja A. Stewart (, p. ) sottolinea come la propaganda abolizionista – la cui matrice fu nell’evangelismo cristiano – puntasse a convincere il Parlamento inglese del fatto che la sfera metropolitana e quella imperiale non sarebbero rimaste divise e che gli effetti negativi della schiavitù si sarebbero ripercossi at home. Sembrerebbe che Jane Austen abbia voluto capitalizzare su questa linea di pensiero, poiché non vi è dubbio che fosse più interessata al ruolo della donna nella società inglese che non al destino degli schiavi nelle piantagioni e che il suo desiderio fosse quello di vedere riconosciute le donne come parte integrante della nazione, piuttosto che come “schiave” di essa (Mee, , p. ). D’altronde, è un fatto storico che la campagna per le leggi sull’affrancamento degli schiavi interessò e coinvolse molto le donne – che ebbero un ruolo determinante nel boicottaggio dello zucchero caraibico, ad esempio – poiché ricordava loro l’urgenza della loro stessa emancipazione (Ferguson, , p. ). Il riferimento alla schiavitù – o piuttosto la “frecciata” – in Emma fornisce un’interessante chiave di lettura per Mansfield Park, romanzo che lo precede di solo un anno, dove non compaiono istitutrici vere e proprie, ma dietro le quinte c’è la presenza degli schiavi e al centro la vicenda di una giovane che condivide alcuni tratti con la serva per antonomasia, Cenerentola. «Such a dead silence!» Il fatto che la presenza dei territori d’oltremare e il loro sfruttamento sia data per scontata – come afferma Said e come è storicamente verosimile che fosse – non li priva di implicazioni. Osservando sia la dinamica della vicenda narrata in Mansfield Park, sia l’allusione alla tratta degli schiavi/delle donne presente in Emma, emerge un sentimento tutt’altro che neutrale da parte di Austen riguardo a questa realtà. Innanzitutto occorre ribadire che si tratta di una realtà per alcuni versi nota alla scrittrice. Riallacciandosi a una tesi di B. C. Southam (ed.) (), Frank Gibbon (-) elabora un’interessante teoria su James Langston Nibbs, il proprietario della piantagione ad Antigua che il reverendo Austen aveva accettato di amministrare in sua vece. Secondo Gibbon, Sir Thomas sarebbe ricalcato sulla figura di Nibbs, il quale si recò di persona ad Antigua con il figlio maggiore per allontanarlo dalle sue cattive amicizie at home, proprio come Sir Thomas fa con MARIA PAOLA GUARDUCCI Tom in Mansfield Park. Nibbs aveva anche un figlio meticcio, frutto della relazione con una schiava, la cui esistenza era nota a parenti e amici. Sulla base di queste considerazioni e sulla relativa certezza che anche Jane Austen ne fosse al corrente, Gibbon ipotizza che il discusso dead silence che segue la domanda di Fanny sulla tratta degli schiavi – quello che per Said marcherebbe l’inesistenza di un linguaggio comune che possa esprimere sia la realtà di Antigua sia quella di Mansfield Park – non sia un silenzio “di” Sir Thomas, bensì l’espressione di un imbarazzo da parte dell’intera famiglia. Il testo non è chiaro in merito ed è stato letto dalla critica in varie maniere, talvolta opposte tra loro. La scena segue di poco l’affermazione da parte di Fanny a Edmund che «I love to hear my uncle talk of the West Indies. I could listen to him for an hour altogether» (Austen, , p. ), poi Fanny prosegue: «[…] Did not you hear me ask him about the slave trade last night?» «I did – and was in hopes the question would be followed up by others. It would have pleased your uncle to be inquired of farther.» «And I longed to do it – but there was such a dead silence! And while my cousins were sitting by without speaking a word, or seeming at all interested in the subject, I did not like – I thought it would appear as if I wanted to set myself off at their expense, by showing a curiosity and pleasure in his information which he must wish his own daughters to feel.» (ivi, p. ). Se Sir Thomas avrebbe gradito altre domande, è evidente che non considera un tabù gli argomenti legati ad Antigua. Al contrario, pare più probabile che egli rappresenti uno dei tanti “padroni illuminati”, ipocriti, che amano parlare della propria magnanimità con gli schiavi, merce umana che non commerciano – poiché è vietato – ma che continuano a possedere nelle loro terre esotiche, dove la giurisdizione inglese ancora non arriva (Mee, , p. ). Né Fanny appare, qui o altrove, scandalizzata dai legami tra la sua famiglia “adottiva” e le pratiche coloniali – i dettagli delle quali non sono forse di sua conoscenza – visto che ci informa di quanto “ami” ascoltare i racconti caraibici dello zio. Non si spiegherebbero altrimenti neanche la sua curiosità e il suo piacere nel ricevere informazioni legate a un’attività dichiarata illegale da qualche anno e, nelle sue propaggini, al centro della prima campagna di massa inglese. È significativo, però, che la stessa vicenda di Fanny possa essere letta come l’allegoria di una deportazione, at home, e che Sir Thomas, abituato a considerare gli uomini come fossero merce per ricavarne profitto, conservi le caratteristiche del master anche nei confini domestici, dove tratta le donne della famiglia come una proprietà da sfruttare, al pari degli schiavi ad Antigua. Non esita infatti a intravedere il profitto dietro il matrimonio tra sua figlia Maria e il ricco ma sciocco Mr Rushworth, dal momento che quest’ultimo avrà un seggio in Parlamento e potrebbe diventare un suo importante alleato. Pur dichiarandosi pronto a recidere il fidanzamento nel caso la figlia abbia cambiato idea, è ben felice di lasciarsi convincere del contrario dalla stessa Maria, che non vede l’ora di liberarsi del suo padre-padrone. D’altronde, ella ha imparato proprio da lui a propendere egoisticamente per il guadagno e quindi non è disposta a rinunciare a un legame vantaggioso seppure senza amore e stima per il futuro consorte. Per quanto invece concerne Fanny, Sir Thomas dispone di lei come crede e a seconda dei suoi umori: la fa venire a Mansfield Park quando ha voglia di sentirsi un benefattore e la rimanda a Portsmouth quando vuole punirla perché la giovane rivendica indipendenza e DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN non gli obbedisce. Said vede in Fanny e nei suoi spostamenti l’emblema della schiavitù: l’analogia tra Fanny e Antigua dimostrerebbe la necessità di un sostentamento esterno per garantire la sopravvivenza ai Bertram (Said, , p. ). Il critico non sottolinea abbastanza, però, che la presentazione di Mansfield Park e dei Bertram da parte di Austen è non solo molto critica (Fraiman, ; Mee, ) ma soprattutto ben lungi dal trasmettere «positive ideas of home, of a nation and its language, of proper order, good behaviour, moral values» (Said, , p. ). Mansfield Park ritrae infatti un mondo in estinzione che non sembra potersi porre come valido modello domestico per l’impero d’oltremare. I coniugi Bertram, una madre letargica e un padre autoritario e affettivamente assente, hanno fallito nel loro compito educativo producendo due figlie vanitose e superficiali, un figlio maggiore scellerato e uno minore che la sola volta in cui è chiamato a fare una scelta per se stesso sbaglia, lasciandosi sedurre dalla mondana ma unethical Mary Crawford. Se la famiglia è il microcosmo della società, il fallimento dei Bertram esula dall’ambito privato e fa di loro degli irresponsabili. Essi sbagliano anche quando delegano a terzi la sorte dei figli e affidano la loro educazione alla sorella di Lady Bertram, Mrs Norris, altrettanto priva di risorse morali e intellettuali per gestire ciò che loro non sono riusciti a modellare con qualche regola e un po’ di buon senso. Che la vecchia generazione di aristocratici e possidenti rappresentata da Sir Thomas abbia fallito appare fuori discussione; che quella rappresentata nella sua faccia migliore da Edmund, forse il personaggio del romanzo più sopravvalutato dalla critica, sia preparata ad assumere il ruolo di ruling class sembra discutibile, incapace come è anche solo di governare se stessa. Pur procedendo dall’interpretazione della deportazione metaforica avanzata da Said, Susan Fraiman e Jon Mee sollevano nuove riflessioni e arrivano a conclusioni opposte rispetto a quelle del critico palestinese. La storia di Fanny sembra ricalcare quella degli schiavi in quanto in essa confluiscono il discorso abolizionista, che all’epoca puntava sulla considerazione della schiavitù come moral offence, e il discorso femminista, che del primo sfrutta l’aspetto simbolico tralasciandone la realtà storica (Fraiman, , pp. -). Il tema della schiavitù in Mansfield Park rivelerebbe l’ambivalenza di sentimenti da parte di una Austen nazionalista la cui visione dell’integrità inglese fatica a incorporarvi la dipendenza dalle colonie (Mee, , p. ). I due critici sono concordi nel ritenere che Jane Austen non collude in alcun modo con la realtà schiavista, ipotesi per cui sembra propendere Said pur senza attribuirne l’intenzionalità alla scrittrice. L’interesse di Jane Austen per la questione femminile e la consapevolezza dell’analogia (simbolica) tra donne e schiavi, così come si rivelano nel passo citato da Emma, confermano in modo abbastanza deciso l’infondatezza di una simile collusione. L’utopia di Thornton Lacey Se leggiamo la storia di Fanny come un’allegoria delle deportazioni troviamo da parte di Austen lo stesso atteggiamento di conservatorismo riformatore che si riscontra nel suo approccio alla questione femminile. Fanny Price, novella Cenerentola, deve affrancarsi dalla sua condizione di (metaforica) schiava, dalla subordinazione, cioè, legata al fatto di essere donna, giovane e povera, per poter “salvare” Mansfield Park, messo a rischio dagli attacchi esterni dei Crawford e dalla MARIA PAOLA GUARDUCCI sua inconsistenza endemica, ben rappresentata dalla triade Sir Thomas, Lady Bertram e Mrs Norris. Portata via, come gli schiavi, contro la sua volontà di bambina dalla casa di Portsmouth e dalla sua famiglia, Fanny viene trapiantata a Mansfield Park. Qui la si alloggia in prossimità delle stanze dei domestici e qui viene trattata con fredda cortesia dai nuovi parenti: «Nobody meant to be unkind, but nobody put themselves out of their way to secure her comfort» (Austen, , p. ). A Mansfield Park, aiutata solo da suo cugino Edmund, con lei gentile ma al contempo patronizing, Fanny attiva le sue strategie per la sopravvivenza e l’adattamento cosicché nel tempo l’ostilità del luogo e delle persone scema: «[…] the place became less strange, and the people less formidable; and if there were some amongst them whom she could not cease to fear, she began at least to know their ways, and to catch the best manner of conforming to them» (ivi, p. ). Per tutto il romanzo, muovendosi in un piccolo mondo di egoisti e profittatori, ella è, e non vuole essere altro che useful: useful come dama di compagnia per la zia Lady Betram, useful quando i cugini e i Crawford decidono di allestire un teatro in casa (lei non recita, ma funge da aiutante per le prove), useful con gli indisciplinati fratelli nella breve parentesi in cui torna a Portsmouth, useful quando viene riammessa a Mansfield Park per curare il cugino Tom malato. Non a caso, quando lascia Mansfield Park per Thornton Lacey alla fine del romanzo, i Bertram la sostituiscono con la sorella Susan, per «an inclination for usefulness» (ivi, p. ) che rende la giovane nel giro di poco «welcome, and useful to all» (ibid.). Non bisogna però fraintendere il desiderio di Fanny leggendolo come l’accettazione di una subordinazione, poiché così facendo applicheremmo categorie interpretative moderne. È in rapporto al contesto particolare di prepotente individualismo di Mansfield Park e semmai a quello generale dell’Inghilterra che vuole “dominare le onde” che, secondo me, va letta Fanny con il suo «longing to be useful to those who were wanting her!» (ivi, p. ). “Contro” quell’universo specifico di accentratori, ella è ben disposta a spendersi per gli altri: «she might have been of service to every creature in the house. She felt she must be of use to all» (ivi, p. ). Per quanto Fanny sembri priva di determinazione e di volontà propria, l’incisività del suo ruolo ai fini della sopravvivenza di Mansfield Park contraddice quest’immagine passiva. Come è noto, è proprio lei, la timida e remissiva Fanny, la sola a contrastare i tentativi di egemonia degli “amorali” Crawford su Mansfield Park. Mansfield Park è un luogo carico di valenze simboliche, che se da una parte è espressione di ciò che un’Inghilterra già imperialista, aggressiva e fagocitante produce at home, dall’altra si rivela proprio at home fragile; sorprendentemente sprovvisto di difese e moralmente impreparato agli attacchi della vita. Se Mansfield Park, come ritiene Said, è un impero, e come tale evoca l’impero britannico allora nascente, bisognerà riconoscere che alla sua estensione fisica – le tante stanze, la biblioteca, il parco, la scuderia – non corrisponde altrettanta ricchezza morale. Mansfield Park non può rappresentare la grandeur britannica, esso è semmai il simbolo della sua vuotezza e decadenza. Austen sembrerebbe quindi polemizzare con il progetto di espansione inglese, per lo meno quello che va profilandosi in quegli anni, poiché ne conosce la discutibile realtà etica, una realtà che è sotto gli occhi di chiunque voglia vederla e che suo fratello Francis non manca di documentarle. Un grande impero privo di risorse morali, che compie crimini o che collude con realtà criminali, è un impero vuoto e forse votato al fallimento: è un mondo per il quale DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN bisogna trovare soluzioni alternative. Come una nazione che non sa integrare le donne al proprio interno, a pieno titolo, e che le narcotizza attribuendo loro ruoli decorativi oppure le sfrutta “come schiave” è una nazione monca, incompleta, che necessita di essere riformata. Da questo punto di vista, il finale di Mansfield Park in cui l’eroina un tempo dimessa trionfa su tutti e riporta l’ordine dove regnava il caos illustra un’utopia nel corso della cui realizzazione emergono le debolezze, i lati oscuri e le contraddizioni di un progetto inglese che Austen sembra guardare quanto meno con circospezione. Stupisce, allora, come tanta critica non abbia speso una parola sull’inconsistenza di Edmund Bertram, ad esempio, ma abbia insistito nel valutare Fanny Price passiva, dull, immobile: «We expect heroes and heroines to be active, rising to opposition, resisting coercion, asserting their own energy: but Fanny is almost totally passive. […] a girl who triumphs by doing nothing» (Tanner, , p. ). Per Tanner l’immobilità di Fanny è una virtù che promuove «stillness rather than movement, firmness rather than fluidity, arrest rather than change, endurance rather than adventure» (ivi, p. ) in un romanzo che difende la prospettiva di un «thoughtful rest» (ibid.), una calma razionale, pensata. Ma Fanny non è passiva, semplicemente non condivide il linguaggio e il comportamento degli altri. È ferma perché non “aggredisce” la realtà, nel senso etimologico dell’ad gradi latino, cioè “camminare/andare verso”. Esistono molti modi, però, di incidere sulla realtà. La “resistenza passiva” di Fanny è una forma di azione, perché trasforma la bambina povera di Portsmouth, senza prospettive se non quella di far da serva ai parenti ricchi, nella mistress di Mansfield Park, e soprattutto perché contribuisce a conferirle un tratto caratteriale che è la sola a possedere tra tutti i personaggi del romanzo: una “padronanza” di sé che ignora i compromessi e gli interessi particolari. Fanny Price trionfa perché non si è mai arresa ai tentativi di conquista perpetrati contro di lei a Mansfield Park, cioè non è mai diventata, veramente, la “schiava” che di lei avrebbero voluto fare. Ha opposto resistenza alla colonizzazione nei suoi confronti tentata da Sir Thomas e dal suo mondo: non si è fatta vanitosa e superficiale come le cugine, sebbene sia cresciuta assieme a loro; non si è lasciata plagiare dall’amicizia interessata di Mary Crawford; non ha ceduto alle lusinghe di Henry Crawford; non ha obbedito agli ordini dello zio, quando questi violavano i suoi sentimenti. Non facendo mai ciò che a tutti sarebbe parso normale che facesse, riattivando in maniera costruttiva, e non distruttiva, l’energia negativa incamerata nel corso della sua quotidiana esistenza, Fanny ridisegna una storia inedita per sé e per Mansfield Park. Tanner insiste anche su un’altra peculiarità di questo personaggio, un tratto “insolito”, lo definisce il critico inglese, ossia il fatto che «she is never, ever, wrong» (ibid.). Una martire piuttosto che una rivoluzionaria, Fanny Price è però lì per alludere a qualcosa piuttosto che a qualcuno. Fanny è la rettitudine morale che manca ai Bertram, a Mansfield Park, alla nazione; è il rispetto di se stessi e della propria integrità contro la rapacità materiale e culturale del colonialismo; è la volontà di rendersi utili per un progetto comune contro il dilagante sfruttamento degli altri per fini egoistici. Fanny è ciò che rivela a Sir Thomas la sua debolezza, la sua quasi congenita mancanza di rispetto per gli altri, a partire dai suoi stessi figli, il suo mercenarismo, la sua attitudine mercantilistica nei rapporti umani, la sua irresponsabilità sociale in senso burkeiano; caratteristiche che lo rendono un pericolo per la comunità e che costituiscono il motivo per cui Austen ne disegna il sostanziale fallimento. MARIA PAOLA GUARDUCCI Figlie di nessuno e straniere ovunque Come in The Tempest di Shakespeare Caliban viene adottato da Prospero, in Mansfield Park Fanny viene adottata da Sir Thomas; come Caliban è ridotto in schiavitù da Prospero, Fanny viene fatta alloggiare nella zona dei domestici a Mansfield Park alla stregua di una serva. Sebbene ci si aspetti da Fanny che cresca con sentimenti fraterni per i cugini Tom ed Edmund, sentimenti che anche Prospero si auspica Caliban abbia per Miranda, ella non è considerata equal rispetto alle cugine: «[…] their rank, fortune, rights, and expectations, will always be different» (Austen, , p. ). Come Caliban viene confinato in una grotta da Prospero, Fanny viene ricacciata dallo zio nell’angusta Portsmouth per aver rifiutato la proposta matrimoniale di Henry Crawford. Come Caliban viene culturalmente corrotto da Prospero e, mentre impara l’inglese, perde la lingua-madre che lo teneva in contatto con la sua isola, così Fanny, “straniera” a Mansfield Park, si riscopre un’estranea anche una volta tornata at home. Portsmouth, da cui proviene, e in cui la sua numerosa famiglia continua a vivere, evoca una delle tante sacche di povertà tipiche dell’epoca nella cui ristrettezza – fisica, economica, emotiva, spirituale – Fanny non può più accomodarsi. Che sua sorella Susan si contenda con un’altra sorellina un piccolo coltello d’argento, lascito di una terza sorella defunta, che il padre di Fanny sia un ubriacone manesco e volgare e la madre una donna sfiancata senza più tempo per l’affetto sono elementi che concorrono a trasmettere non solo l’idea del disagio, ma anche quella di una violenza latente, pronta a esplodere negli strati poveri e degradati della società inglese, come stanno già esplodendo le rivolte degli schiavi ad Antigua e altrove. Se però Caliban, in modo maldestro e quindi inefficace, tenta il sovvertimento violento dell’ordine schiavo/padrone stabilito da Prospero, in Fanny, nonostante tutto, non c’è spazio per il linguaggio della violenza. Fanny ricorda qui, piuttosto, Desdemona, il cui silenzio secondo Nadia Fusini () non esprime sottomissione bensì il rifiuto del linguaggio maschile, basso e violento, di Othello e un rispetto verso se stessa che le fa accettare persino la morte: un omicidio che è davvero, come ella sostiene con Emilia, un suicidio, una scelta di coerenza. Pure Fanny tenta la strada dell’indipendenza etica aperta da Desdemona. Ha più fortuna dell’eroina shakespeariana, perché in questo romanzo Austen vuole anche provare a indicare un’utopia femminile. Così, per affrancarsi da quel mondo che ne farebbe un’eterna serva, o una moglie per sola convenienza, Fanny prende le distanze da due nemici, il padre naturale, che «scarcely ever noticed her, but to make her the object of a coarse joke» (Austen, , p. ), e quello adottivo, pronto a darla al migliore offerente. La sua presa di distanza da queste due figure si misura nella sua separazione dalle case di entrambi: la prima «too small for anybody’s comfort» (ivi, p. ), la seconda, da subito, «too large for her to move in with ease» (ivi, p. ). Fanny approda infatti con Edmund, – sebbene «she was of course only too good for him» (ivi, p. ), sottolinea il narratore ma non la critica – non nella casa padronale di Mansfield Park, bensì a Thornton Lacey, la canonica annessa, che grazie a lei diventa «the home of affection and comfort» (ivi, p. ), in un romanzo in cui i tre termini, home, affection e comfort non erano mai stati associati. È un lieto fine con molte riserve: non solo i due protagonisti non occupano la casa madre ma, come nota Franco Moretti (, p. ), non diventano neanche ricchi poiché Edmund è secondogenito e se poi è vero quello che il romanzo sostiene, cioè che onestà e ricchezza si escludono a vicenda, delle due qualità la coppia possiede decisamente la prima. DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN Gran parte delle eroine austeniane sono figlie di padri colpevoli, poiché disattenti, nei confronti delle loro figlie: quello di Elinor e Marianne, in Sense and Sensibility, perché morendo le lascia alla mercé economica di un fratello insensibile ed egoista; quello di Elizabeth, in Pride and Prejudice, perché vive recluso in biblioteca incurante del vincolo testamentario che assegna i suoi beni a un lontano cugino piuttosto che alle figlie, quello di Emma perché, anziano e ipocondriaco, non concede alla figlia la libertà di pensarsi, una volta sposata, lontano da lui. Rispetto ai romanzi citati, le figure paterne in Mansfield Park e in Persuasion hanno un ruolo più attivo nel determinare l’infelicità delle figlie, o per lo meno nel minare, con i mezzi a loro disposizione, la loro felicità. Abbiamo già parlato dei “padri” di Fanny e di come almeno Sir Thomas agisca contro gli interessi della giovane in maniera diretta. Anne Elliot si trova in una situazione analoga. Nei primi capitoli di Persuasion veniamo informati che otto anni prima del presente della narrazione il padre di Anne, lo sciocco e narcisista Sir Walter Elliot, pur non opponendosi esplicitamente al matrimonio della figlia con Frederick Wentworth, allora senza patrimonio, aveva manifestato «a professed resolution of doing nothing for his daughter» (Austen, , p. ), che sommata al veto di Lady Russell, l’amica di famiglia che per le sorelle Elliot fa le veci di madre, aveva portato alla rottura del legame tra i due giovani. All’inizio del romanzo, gli Elliot – come accade ai Bertram – attraversano una crisi economica. Impossibilitati a mantenere alto il loro tenore di vita per l’indolenza di Sir Walter, rimasto vedovo della sua morigerata consorte e spalleggiato nella sua incapacità amministrativa da una figlia maggiore come lui presuntuosa e inetta, sono costretti a cedere in affitto la loro tenuta di Kellynch-Hall, troppo dispendiosa, e a trasferirsi nella più conveniente Bath. Mentre Sir Elliot e la figlia Elizabeth traslocano a Bath, il percorso di Anne verso una casa che possa sostituire quella natale si allunga di giorno in giorno attraverso una serie di spostamenti che la vedono ospite qua e là, sfruttata – come Fanny – un po’ da tutti, perché – come Fanny – «glad to be thought of some use» (ivi, p. ). Sostanzialmente homeless, sposando Wentworth, nel frattempo divenuto capitano di marina, Anne si affranca da un padre che, senza mezzi termini, «had no affection for Anne» (ivi, p. ) e sceglie come dimora la Royal Navy in cui il marito è arruolato. I due formano una coppia la cui home non si situa, dunque, in alcun punto preciso della terraferma. Il rifiuto di Anne per tutto quello che la terraferma inglese rappresenta, le rigide regole della nobiltà, il potere dei padri sulle figlie, il classismo, i matrimoni combinati, è largamente motivato lungo il romanzo, così che il finale autoesilio dell’eroina non sorprende. Sorprende, però, nel contesto dell’opera di Austen, il fatto che la scrittrice non doti la sua eroina di una casa vera e propria e per questo la conclusione di Persuasion, il suo ultimo romanzo completo, infonde una certa inquietudine. Qui la scrittrice sospende il metodo dei suoi romanzi precedenti, in cui le carte venivano rimescolate nel corso dell’opera per presentare alla fine l’immagine di un mondo riformato, relativamente sicuro, ricostituito, rimoralizzato, in cui l’eroina si accomodava con agio. Terra senza mare, mari senza terre A differenza degli altri romanzi di Jane Austen, così radicati nella terraferma da far dimenticare l’insularità dell’Inghilterra – è noto che Emma non ha mai visto il MARIA PAOLA GUARDUCCI mare, mentre per le giovani Bennet esso corrisponde solo all’immagine della vacanziera Brighton –, in Mansfield Park e in Persuasion la marina inglese e il mare svolgono un ruolo cruciale. Ai tempi della stesura di Persuasion, e , la Royal Navy è per gli inglesi e per la famiglia Austen una realtà vittoriosa e celebrata. In Mansfield Park, la cui stesura e pubblicazione sono molto ravvicinate a quelle di Persuasion, la marina è chiamata in causa in termini ambivalenti, poiché ne fanno parte sia il padre di Fanny che il suo amato fratello William. In quel romanzo, anche attorno alla marina si delinea un conflitto tra vecchie e nuove generazioni. Il padre di Fanny è un tenente che imbarcandosi non ha fatto fortuna, al contrario, è rimasto “manovalanza” e la nave ha contribuito ad acuire il suo isolamento, la sua mancanza di interessi, la sua volgarità e le sue cattive abitudini. Per William, invece, che viene promosso tenente su raccomandazione di uno zio dei Crawford negli anni gloriosi della Royal Navy, la marina rappresenta una possibilità di carriera e di avanzamento sociale per lui altrimenti impensabili. È la marina a schiudergli quegli orizzonti esotici, legati alle realtà coloniali, che l’immagine dei due scialli di seta indiana commissionati da Lady Bertram riassume. La nave resta però, in Mansfield Park, un universo in cui più di tanto la scrittrice – che pure è a suo agio con l’argomento per via dei fratelli, ai quali sottopone i manoscritti perché correggano i suoi errori (Austen Leigh, , p. ) – non si avventura. La nave in cui si imbarca William a Portsmouth parte in tutta fretta prima che Fanny possa visitarla come i due avevano pianificato. Il romanzo è giocato piuttosto sulla negoziazione di uno spazio sulla terraferma per Fanny e quello che ella rappresenta. Questo tipo di negoziazione, che produce il compromesso di Thornton Lacey, risulta impossibile in Persuasion, dove la terraferma è associata a valori obsoleti, controproducenti e forse neanche più riformabili. In Persuasion l’ambiente navale è molto documentato. Compaiono liste dettagliate di navi, i nomi di porti inglesi, continentali e d’oltremare, le rotte, con le loro difficoltà e i loro successi. Nella marina sono arruolati l’eroe del romanzo, Frederick Wentworth, e suo cognato, l’ammiraglio Croft, che con la moglie prende in affitto la casa degli Elliot. Grazie alla marina entrambi hanno costruito i loro patrimoni. Le battaglie contro la Francia, sia nelle acque locali che in quelle lontane, mari in cui le due potenze si contendono il predominio, e i servizi svolti nelle Indie orientali si sono tradotti per entrambi in consistenti sostanze. Dall’arruolamento nella Royal Navy, Wentworth ha ottenuto onori, glorie e quel cambiamento di status che gli consente non solo di essere accettato dalla famiglia di Anne dopo il primo rifiuto, ma anche di superarla in ogni rispetto: Captain Wentworth, with five-and-twenty thousand pounds, and as high in his profession as merit and activity could place him, was no longer nobody. He was now esteemed quite worthy to address the daughter of a foolish, spendthrift baronet, who had not had principle or sense enough to maintain himself in the situation in which Providence had placed him, and who could give his daughter at present but a small part of the share of the ten thousand pounds which must be hers hereafter (Austen, , p. ). L’ammiraglio Croft, con la sua «very handsome fortune» (ivi, p. ) è addirittura in grado di sradicare, letteralmente, la nobiltà dalla sua terra, e di andare a occupare gli spazi che questa ancora possiede ma che dato il suo stile di vita e la sua natura parassitaria non può più permettersi. DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN Se Jane Austen non hai mai perso l’opportunità di ironizzare su improduttività e immobilità dell’aristocrazia inglese – pur salvandone spesso le nuove generazioni con provvidenziali matrimoni contratti con la parte migliore della borghesia – il disprezzo che in questo romanzo suscitano Sir Walter e la figlia Elizabeth supera persino quello provocato da Lady Catherine de Bourgh in Pride and Prejudice. Siamo dunque ben disposti verso l’ammiraglio Croft, prima ancora di vederlo entrare in scena, poiché Sir Walter è “naturalmente” maldisposto verso di lui. Mentre Anne rivela una certa consapevolezza storica riconoscendo il ruolo della marina nei confronti della nazione quando afferma che «the navy […] have done so much for us» (ibid.), suo padre disprezza i marinai, manifestando una visione limitata del mondo che si esaurisce nell’orizzonte granitico del classismo inglese dove non manca di avere anche un ridicolo côté estetico: […] it is in two points offensive to me; I have two strong grounds of objection to it. First, as being the means of bringing persons of obscure birth into undue distinction, and raising men to honours which their fathers and grandfathers never dreamt of; and secondly, as it cuts up a man’s youth and vigour most horribly; a sailor grows old sooner than any other man; I have observed it all my life (ivi, p. ). Sir Walter esprime più volte disapprovazione per la perdita di “decoro” nel fisico di chi si espone alle intemperie sulle navi e al sole di terre lontane: «[…] than I take it for granted […] that his face is about as orange as the cuffs and capes of my livery» (ivi, p. ), commenta caustico alla notizia del lungo servizio nelle Indie di colui che di lì a poco lo caccerà di casa. La stessa Lady Russell quando rivede Wentworth si stupisce di come il giovane sia riuscito a mantenersi in ottima forma: «[…] the astonishment she must be feeling that eight or nine years should have passed over him, and in foreign climes and in active service too, without robbing him of one personal grace!» (ivi, p. ). In questo romanzo che si accanisce con particolare insistenza contro la nobiltà e la gentry legate alla proprietà terriera, la marina, svincolata dalla terra, diventa sinonimo di dinamismo e mobilità. Mobilità nella sua doppia accezione, positiva, di movimento nello spazio e nella gerarchia sociale. Se in Persuasion si celebra la Royal Navy, che non fu solo lo strumento di difesa contro la Francia, ma anche quello dell’imperialismo britannico, l’attaccamento allo spazio è però condannato come provinciale (Freiman, , p. ). I Croft, forse la sola coppia sposata felice nell’intera opera di Austen, hanno viaggiato in lungo e largo e la loro energia li contrappone agli statici Musgrove, una ricca famiglia di campagna imparentata con gli Elliot. Nell’ottavo capitolo del romanzo, Mrs Musgrove ascolta i resoconti dei viaggi di Mrs Croft: quattro traversate dell’Atlantico, un’andata e ritorno dalle Indie, numerose località europee, ma, afferma l’infaticabile viaggiatrice: «[…] I never went beyond the Streights – and never was in the West Indies. We do not call Bermuda or Bahama, you know, the West Indies.» Mrs Musgrove had not a word to say in dissent, she could not accuse herself of having ever called them anything in the whole course of her life (Austen, , p. ). Questi coniugi, lui «quite the gentleman in all his notions and behaviour» (ivi, p. ), lei «a very well-spoken, genteel, shrewd lady» (ivi, p. ) sembrano rappresentare una nuova Inghilterra ancora così poco inserita nella cultura inglese da comparire MARIA PAOLA GUARDUCCI (felicemente) priva di case e di figli, ma in grado di accomodarsi nelle migliori residenze inglesi semplicemente spostando qualche mobile per questioni di gusto. Non è la Rivoluzione francese, ma pur sempre una sostituzione ai vertici. Wentworth e i Croft sono la nuova “casta” che emerge dalla realtà coloniale inglese (Perera, , p. ), questo sì un vero e proprio “nuovo mondo” da commentare – piuttosto che le terre lontane in cui Austen non è mai stata – che avanza parallelamente alla presa di consistenza dei possedimenti britannici d’oltremare. Che questi possedimenti svolgano la funzione – politicamente scorretta, se si vuole – di deus ex machina nel sistema economico e sociale inglese viene confermato in Persuasion anche da un episodio che riguarda Mrs Smith, un’amica di vecchia data che Anne ritrova, vedova e in condizioni di estrema indigenza. Questo personaggio ha un ruolo importante nell’equilibrio del romanzo, poiché è lei a rivelare ad Anne il vero carattere, opportunista e manipolatore, di suo cugino William Elliot, il quale erediterà la tenuta di Kellynch-Hall e il titolo di baronetto alla morte del padre della ragazza. Il giovane, che corteggia in maniera interessata Anne, fu amico del defunto marito di Mrs Smith e negò il suo aiuto alla vedova in una serie di questioni legali che lei non era in grado di districare, tra le quali il riscatto di una proprietà del marito nelle Indie occidentali, sotto sequestro per un’ipoteca mai pagata. Rientrare in possesso di quella proprietà costituiva e costituisce l’unica possibilità di avere una rendita per Mrs Smith, la quale, sola, malata e triste, condivide il fato delle spinster di cui si è già parlato. Alla fine del romanzo, per intercessione di Wentworth, Mrs Smith rientra in possesso di quel lontano ma fondamentale appezzamento di terreno. Recuperando una rendita, la vedova rientra nel circuito sociale da cui la povertà l’aveva espulsa: riguadagna salute, benessere e quella credibilità che le donne perdono con facilità quando non si accompagnano a un uomo e non hanno un patrimonio. Grazie ai proventi che le arrivano da una terra su cui non ha mai poggiato piede ma che per ragioni imperscrutabili le appartiene, Mrs Smith, ora vedova facoltosa, può diventare senza imbarazzo una buona amica dei coniugi Wentworth, mentre se fosse rimasta povera avrebbe avuto solo la loro caritatevole attenzione. Lo statuto sociale dei Croft, di Wentworth, della stessa Mrs Smith si giova sì delle loro buone maniere, ma è il risultato di un benessere economico ottenuto grazie ai compensi ricevuti per le guerre combattute, per i servizi prestati in terre lontane, o per le rendite che queste ultime producono. Terre cui si arriva via mare, ma dove i romanzi di Austen non approdano mai. Da “Persuasion” a “Sanditon”: l’epica di un mondo fallito? Persuasion è stato definito «the epic of a failed world, or of the failure of the self to fulfil itself in the world» (Prewitt Brown, , p. ). Per molti versi, infatti, il romanzo conclama il pessimismo culturale di cui in Mansfield Park si intravedono le ombre. L’utopia di Fanny, che rivoluziona il suo universo e quello delle persone a lei più vicine, ma solo «within the view and patronage of Mansfield Park» (Austen, , p. ), in Persuasion non trova spazio e si perde nel mare. Se infatti la terraferma risulta corrotta nei valori associati al patriarcato (Gilbert, Gubar, , pp. ), anche il futuro di affiliazione di Anne alla marina apre tanti dubbi quante questioni risolve. La proprietà di Kellynch-Hall andrà come previsto all’ambiguo Mr Elliot, che come tutti i maschi primogeniti nella linea di discendenza nulla ha mai DUE SCIALLI DALL’ INDIA : ECHI D ’ OLTREMARE IN JANE AUSTEN fatto per guadagnarsela, mentre Anne tenta di riscrivere da capo la propria storia – ma non certo quella del suo mondo – sposando un moderno self-made man e accettando i rischi dell’essere moglie di un marinaio: «[…] she [Anne] must pay the tax of quick alarm for belonging to that profession which is, if possible, more distinguished in its domestic virtues than in its national importance» (Austen, , p. ). Il quick alarm che mina il destino di Anne e adombra il finale del romanzo costituisce una nota di possibile tragedia inedita nella scrittura di Austen. Non a caso, molta critica ha parlato della modernità di questo romanzo, inquadrandolo già nell’orizzonte letterario popolato di personaggi a vario titolo “alienati”. È interpretando Anne Elliot come Fanny Price, cioè come epitome di una condizione, che riusciamo a cogliere il senso di questa alienazione epocale, e quindi anche individuale. L’allargamento di orizzonti che consente a Jane Austen di far entrare nei suoi romanzi temi storici allora scottanti come la schiavitù, in Mansfield Park, e i possedimenti d’oltremare, nello stesso Mansfield Park, in Persuasion e in Sanditon, comporta, come per Anne Elliot, l’accettazione di una “tassa”. Non mi pare, dopo quanto detto sinora, che si possa concordare con Said nella sua interpretazione di una Jane Austen che dà per scontate quelle realtà storiche e quindi, seppur inconsapevolmente, le legittima. Mi pare piuttosto che la curiosità della scrittrice la conduca a “importare” nel suo universo narrativo questi temi a lei solo parzialmente familiari per vedere cosa producono una volta che sono posti a interagire con quanto invece le è ben noto. È un peccato, infatti, anche e soprattutto da questo punto di vista, che la scrittrice non sia riuscita a concludere Sanditon, romanzo in cui il possedimento d’oltremare tornava at home non solo nella forma di denaro, ma nelle sembianze umane della «half mulatto, chilly and tender» Miss Lambe (Austen, , p. ). Viene da chiedersi quanto avrebbe prodotto l’interazione tra la giovane ereditiera meticcia e la società inglese che ella incontra a Sanditon, località di cura sul mare gestita con scaltrezza da un intraprendente borghese e dalla ricca vedova di un nobile. Un universo di malati, reali e immaginari, inglesi e no, che Jane Austen, nella fase ormai terminale della sua stessa malattia, ridicolizza con tutta la lucidità e l’acume di cui è ancora capace. Viene allora da pensare che il futuro di una società avida e ipocondriaca, o forse davvero malata, impegnata a rincorrere il miraggio dell’impero con i suoi guadagni è difficile da indovinare e l’incompiutezza del romanzo, che si ferma al capitolo dodicesimo, sembra avere una sua ragion d’essere quasi programmata: non una fatalità, ma il punto d’arrivo per consunzione. Note . In Sense and Sensibility il colonnello Brandon accenna a una sua missione nelle Indie orientali che ebbe luogo molto prima del tempo della narrazione (Austen, , p. ). Mi pare che il fatto che si tratti dell’unica allusione all’India in tutto il romanzo, che sia citata tra parentesi e che non si leghi in alcun modo ad altri elementi dell’opera la renda irrilevante ai fini di questa analisi. . Le illustrazioni di Blake sono usate dalla regista canadese Patricia Rozema nella sua versione cinematografica di Mansfield Park (), che propone un’interpretazione postcoloniale del testo. . Fa eccezione, proprio in Emma, il personaggio di Miss Taylor, la governante dei Woodhouse che sposando il vedovo Mr Weston si sottrae al destino di solitudine riservato alle istitutrici. Miss Taylor ha svolto il ruolo di madre per Emma ed è poi diventata sua amica. La stessa Emma, però, si dichiara sorpresa nel constatare quanto Miss Taylor sia una gentlewoman. . Jane Fairfax, come è noto, sposerà Frank Churchill, con il quale è segretamente fidanzata. Si tratta però di un risvolto rivelato solo verso la fine tra lo stupore, se non dei lettori, di tutti i perso- MARIA PAOLA GUARDUCCI naggi della storia. Per tutto il romanzo Jane è vista come una futura governante che sta solo rimandando, proprio per l’infelicità associata a tale destino, l’inizio dell’apparentemente inevitabile scelta di vita. Bibliografia (), Mansfield Park, Penguin Books, Harmondsworth. (), Emma, Penguin Books, Harmondsworth (a ed. ). EAD. (), Mansfield Park, Penguin Books, Harmondsworth (a ed. ). EAD. (), Sense and Sensibility, Tor, New York (a ed. ). EAD. (), Persuasion, Wordsworth Editions, Hertfordshire (a ed. ). EAD. (), “Lady Susan”, “The Watsons” and “Sanditon”, Penguin Books, Harmondsworth (a ed. ). AUSTEN LEIGH J. E. (), A Memoir of Jane Austen, Macmillan, London. BLOOM H. (), Genius. A Mosaic of One Hundred Exemplary Creative Minds , Fourth Estate, London. FERGUSON M. (), Colonialism and Gender Relations from Mary Wollstonecraft to Jamaica Kincaid. East Caribbean Connections, Columbia University Press, New York. FRAIMAN S. (), Jane Austen and Edward Said: Gender, Culture, and Imperialism, in “Critical Inquiry”, , , pp. -. FUSINI N. (), Donne fatali. Ofelia, Desdemona, Cleopatra, Bulzoni, Roma. GIBBON F. (-), The Antiguan Connection: Some New Light on “Mansfield Park”, in “The Cambridge Quarterly”, , , pp. -. GILBERT S. M., GUBAR S. (), The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale University Press, New Haven-London. JORDAN E. (), Jane Austen Goes to the Seaside: “Sanditon”, English Identity and the «West Indian Schoolgirl», in Y. Park, R. S. Rajan (eds.), The Postcolonial Jane Austen, Routledge, London-New York. MEE J . (), Austen’s Treacherous Ivory: Female Patriotism, Domestic Ideology, and Empire, in Y. Park, R. S. Rajan (eds.), The Postcolonial Jane Austen, Routledge, LondonNew York. MORETTI F. (), Il romanzo di formazione, Einaudi, Torino (a ed. ). PERERA S. (), Reaches of Empire. The English Novel from Edgeworth to Dickens, Columbia University Press, New York. PREWITT BROWN J . (), The Radical Pessimism of “Persuasion” , in J. Simons (ed.), “Mansfield Park” and “Persuasion”, St. Martin’s Press, New York. SAID E . W. (), Orientalism. Western Conceptions of the Orient , Penguin Books, Harmondsworth. ID. (), Culture and Imperialism, Chatto & Windus, London. SOUTHAM B. C. (ed.) (), Jane Austen: The Critical Heritage, Routlegde & Kegan Paul, New York. STEWART M . A . (), Domestic Realities and Imperial Fictions. Jane Austen’s Novel in Eighteenth-Century Contexts, The University of Georgia Press, Athens-London. STONE L. (), Famiglia, sesso e matrimonio in Inghilterra (-), Einaudi, Torino (ed. or. The Family, Sex and Marriage in England. -, Harper & Row, New York ). TANNER T. (), Introduction to Austen (). WHITE G. D. V. (), Jane Austen in the Context of Abolition. “A fling at the slave trade”, Palgrave Macmillan, Houndsmills-New York. WOLPERT S. (), Storia dell’India. Dalle origini della cultura dell’Indo alla storia di oggi, a cura di G. Boccali, Bompiani, Milano (ed. or. A New History of India, Oxford University Press, Oxford ). ARMSTRONG I. AUSTEN J. RECENSIONI P. Parrinder, Nation and Novel: The English Novel from its Origins to the Present Day, Oxford University Press, Oxford , pp. . I tentativi di scrivere guide innovative sul “romanzo inglese” procedono di buona lena: tra i contributi più autorevoli e recenti figurano The True Story of the Novel – un utile studio comparativo scritto da Margaret Anne Doody nel ‒, The English Novel: An Introduction di Terry Eagleton () e Nation and Novel di Patrick Parrinder. Per quanto indubbiamente graditi siano tali studi, perfino la più rapida delle letture basta a rivolgersi ancora allo storico manuale di Ian Watt. Peccato, perché per quanto pionieristico fosse nel , anno della sua pubblicazione, The Rise of the Novel: Studies in Richardson, Defoe, and Fielding di Watt mostra oggi, visibilmente, i segni dell’età. L’opera di Parrinder rappresenta un contributo serio, nonché utile sotto diversi aspetti. Traccia un percorso tematico che illustra le fasi della prosa narrativa inglese, dalle sue origini tardomedioevali alle realtà multiculturali odierne, ed esamina il legame costante tra la narrativa inglese e la nazione inglese. Secondo Parrinder: «Fictional narrative gives us an inside view of a society or nation» (p. ) e ci aiuta a definire il carattere di una nazione, che, come il carattere di un individuo, scrive George Eliot, costituisce «a process and an unfolding» (p. ). Anche se è innegabile che gran parte della narrativa di fantasia tenti di offrire in primo luogo una visione della società e, allo stesso tempo, di modellarla, è tuttavia discutibile che possa dirsi lo stesso di tutte le opere di questo tipo, appartenenti alla tradizione del romanzo inglese o di altra nazionalità. Ma questa è la linea che ha scelto di seguire Parrinder, professore di letteratura inglese presso l’Università di Reading, il quale, nel capitolo di apertura, si propone di giustificare il suo tentativo di leggere il romanzo alla luce del rapporto di questo con la spinosa questione del carattere, o dell’identità, nazionale: The nature of national identity and of its now rather unfashionable counterpart “national character” has been consistently debated by English novelists across the centuries. Secondly, novels are the source of some of our most influential ideas and expressions of national identity. Works of art which are enjoyed and appreciated by subsequent generations play a key part in the transmission and dissemination of national images, memories, and myths. Thirdly, the fictional tradition adds a largely untapped body of evidence to historical enquiry into the origins and development of our inherited ideas about England and the English (p. ). È vero che il romanzo fornisce spesso preziose informazioni sulla nazione e sul carattere nazionale che sottolinea la differenza fra i popoli: Parrinder argomenta, quindi, giu- ANGLISTICA stamente (se non con grande originalità) che il consolidamento del romanzo deve essere interpretato tenendo conto dell’origine dello Stato-nazione. Il romanzo svolge un ruolo preminente nella formazione del carattere nazionale, sottoponendolo nel contempo alla valutazione collettiva. Il romanzo attira senza dubbio un pubblico che fa della lettura un’esperienza privata, a differenza del teatro, ma almeno inizialmente dipende da lettori che ne condividono la lingua e il retaggio culturale. Attratti innanzitutto da coloro che vivono nella nazione in cui il romanzo ha origine, i lettori giungono, scorrendo le pagine, a vedersi riflessi o rifratti in un genere straordinariamente ospitale, che offre spazio a tutte le classi sociali e si presenta, pertanto, come uno specchio ampio e sfaccettato della nazione. Se, nel Settecento, la nascita del romanzo è profondamente legata all’obiettivo di creare un nuovo tipo di identità nazionale di matrice protestante (Robinson Crusoe viene letto come uno studio sul carattere nazionale inglese), l’Ottocento assiste alla differenziazione del ruolo del romanzo, che diventa spazio di autocoscienza critica piuttosto che luogo di affermazione nazionale. Tuttavia, il romanzo inglese non si limita a questo e l’esperienza della lettura e della scrittura non si ferma certo all’interesse, comunemente sentito, di conoscere la nazione. Nel caso di molti romanzieri inglesi, l’identità nazionale viene data per scontata o funge da semplice sfondo fisso (spesso non scritto) per opere legate più intimamente a tematiche individuali o familiari. Si potrebbe sollevare la stessa critica per molti dei recenti studi sulle tradizioni del romanzo scozzese e irlandese, debitori, come l’opera di Parrinder, di critici quali Fredric Jameson e Homi Bhabba e che muovono principalmente dall’analisi di come un romanzo «may contain the nation within its form, its structure, its silence». Parrinder propone interessanti argomentazioni secondo cui la tradizione irlandese e scozzese della narrativa nazionale o national allegory, sviluppatasi nelle mani di figure quali Maria Edgeworth, Lady Morgan e Sir Walter Scott come qualcosa di assai distinto dalla forma inglese più classica, sia stata di fatto preceduta da un equivalente inglese che consisteva in «Augustan essay-writing and prose satire based around such obvious national caricatures as Joseph Addison’s Tory squire Sir Roger de Coverly and John Arbuthnot’s robust English tradesman John Bull» (p. ). Qualsiasi approccio al romanzo inglese non può fare a meno di conferire centralità a Dickens e Parrinder non si sottrae a questa tendenza, cercando di trovare all’interno del suo schema generale una collocazione adeguata allo scrittore. Ma Dickens, indubbiamente il più rappresentativo dei romanzieri inglesi del XIX secolo, non offre un ricco serbatoio di materiale in termini di carattere o identità nazionale, sebbene molti, tra cui George Gissing, lo acclamino come incarnazione dello spirito della razza inglese. In definitiva, però, l’interesse di Dickens è tutto rivolto all’individuo: forse il suo maggior punto debole come romanziere – almeno nella visione marxista di Eagleton – è proprio quello di non aver sviluppato un problema morale in un programma politico. Certo, il tema dell’identità nazionale sembra occupare una posizione piuttosto modesta nel suo elenco delle priorità. Trollope offrirebbe materiale di gran lunga più interessante per questo tipo di indagine, ma Parrinder ne tiene scarsamente conto e adotta verso l’autore un approccio inutilmente polemico: il romanzo di grande complessità The Way We Live Now viene tacciato, e scartato in modo tanto disinvolto quanto ingiustificato, come «xenophobic moral fable» (p. ) mentre non si fa alcuna menzione di un altro romanzo, Phineas Finn, potenziale fonte di discussioni roventi sulle politiche identitarie inglesi. In esso, infatti, un affascinante irlandese campeggia come inquietante protagonista all’interno di uno scenario e di un cast di personaggi in prevalenza inglesi. RECENSIONI Parrinder, impegnato a perseguire con passione una lettura di tipo tematico, avrebbe sicuramente raccolto migliori risultati se non avesse fatto dell’idea di nazione la chiave privilegiata con cui aprire il romanzo inglese tout court. In alternativa, avrebbe potuto prendere le mosse da questo tema, conferendogli maggior spessore attraverso una scelta più parziale e, allo stesso tempo, più oculata degli autori e delle opere più corrispondenti al suo schema (le importanti sezioni sulla politica letteraria di Disraeli, ad esempio, sulla sua invenzione del romanticismo politico dell’imperialismo britannico dell’Ottocento e sui controversi rapporti di fedeltà di Kipling semplificano magistralmente le promesse della sua introduzione). Analogamente, gli avrebbe giovato esaminare – attraverso la reception theory – la critica storica dei romanzi di tema individuale, per trovare conferma alla sua lettura sulle politiche di identità inglese. In altre parole, sarebbe interessante scoprire se il tema dell’identità nazionale inglese nasce nella critica contemporanea del corpus di romanzi scelti da Parrinder. Viene da pensare, ad esempio, alla varietà di reazioni diverse che i romanzi di Trollope hanno sollecitato al riguardo. I commenti di Michael Sadleir al romanzo irlandese di Trollope, Castle Richmond – «It is a document, not a work of art; its appeal is to nationalist enthusiasm, not to the literary appreciation that knows no nationality» – sembrano diametralmente opposti alla descrizione che dell’opera di Trollope fa Nathaniel Hawthorne: Have you ever read the novels of Anthony Trollope? They precisely suit my taste, – solid and substantial, written on the strength of beef and through the inspiration of ale, and just as real as if some giant had hewn a great lump out of the earth and put it under a glass case, with all its inhabitants going about their daily business, and not suspecting that they were being made a show of. And these books are just as English as a beef-steak. Gli ultimi quattro capitoli del libro sono dedicati al XX secolo e si concludono con una discussione sul multiculturalismo, sull’immigrazione e sul destino degli outsider. Nella nuova Inghilterra multiculturale, così ci dice Parrinder, il romanzo inglese «will in future have to depend upon national identity for its life support if it is to survive as a distinctive form» (p. ); tale osservazione pare essere un modo inutilmente restrittivo e insulare di immaginare il futuro del romanzo tra le fluide e complesse realtà globali della letteratura europea, per non dire mondiale. Tale approccio sembra quasi escludere gli scrittori che non trattano tali tematiche – Sterne, ad esempio – e confinare ai margini outsider del calibro di Conrad o James, artefici di opere che hanno scosso l’asse del romanzo “inglese”. Questo sembra porsi in contraddizione con le affermazioni di Parrinder, contenute in una sezione dedicata ai romanzieri immigrati quali Rushdie, Naipaul, Kureishi e Zadie Smith: The creation of new identities and the surprising prolongation, or perhaps even usurpation, of older ones is at the heart of immigration fiction. In the work of these writers the implicit subject matter of the whole tradition of the English novel – the creation, maintenance, decay, and cross-fertilization of the national identity – is at last made explicit (p. ). Parrinder insiste nel ritenere l’identità nazionale il senso centrale di «the whole tradition of the English novel»: una tale affermazione lo porta a considerare solo in modo parziale un vasto numero di romanzi della tradizione inglese che non rispondono – esplicitamente o implicitamente – al programma stabilito e a comporre un ANGLISTICA corpus di opere in grado di offrire soltanto una visione frammentaria del romanzo, made in England o meglio made in the English language. John McCourt Note . G. Smyth, The Novel and the Nation: Studies in the New Irish Fiction, Pluto, London , p. . . M. Sadleir, Trollope: A Commentary, Constable & Co., London , p. . . Citato in A. Trollope, An Autobiography, edited by P. D. Edwards, Oxford University Press, Oxford , p. . Bride and Prejudice. The Bollywood Musical (), regia di Gurinder Chadha, sceneggiatura di Gurinder Chadha e Paul Mayeda Berges [ispirato a Pride and Prejudice di Jane Austen ()], Kintop-Pathé-UK Film Council, UK-USA. Notte: inquadratura in campo lungo di una costruzione esotica, meta di un flusso umano ininterrotto. Con un effetto di accelerazione il palazzo viene illuminato in pochi secondi dalla luce dell’alba che fa splendere l’oro di cui è ricoperto. La fotografia ha una qualità patinata, da “National Geographic”. L’esotismo dell’ambientazione è rafforzato dalla colonna sonora: un suggestivo canto rituale. L’immagine va in dissolvenza e il canto cessa, per lasciare spazio ai titoli di testa. Questa microsequenza iniziale del film di Gurinder Chadha, Bride and Prejudice. The Bollywood Musical () non costituisce una semplice informazione sulla location della storia. Lo svolgimento del film svelerà a coloro che non l’avessero già riconosciuta che quella costruzione è il Tempio d’Oro di Amritsar, il luogo di culto più importante della religione sikh, e che in quella cultura il tempio è al centro di cruciali dinamiche sociali, fra cui le negoziazioni matrimoniali. Non si poteva scegliere inizio più significativo se è vero che il film è «inspired by Jane Austen’s Pride and Prejudice», come informano i titoli di coda, e che proprio il matrimonio, nei suoi svariati risvolti sociali ed economici prima ancora che sentimentali, è l’elemento propulsore del famoso romanzo di Jane Austen. Già il titolo del film, Bride and Prejudice, con il suo riferimento alla “sposa”, richiama quel piccolo gioiello retorico che è l’incipit del novel: «It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife». La questione del matrimonio combinato, d’altra parte, è presente fin dai primi esperimenti cinematografici di Gurinder Chadha, regista indiana nata in Kenya, e cresciuta a Londra nel quartiere di Southall. Già in Nice Arrangement () il complesso cerimoniale del fidanzamento e delle nozze è il perno visivo e narrativo attorno al quale si annodano e si snodano le dinamiche della complessa costruzione dell’identità femminile indiana in epoca di diaspore e globalizzazione. Tanto più significativa appare, allora, dopo il successo mondiale della commedia Bend It Like Beckham (), la scelta di filmare per il grande schermo l’adattamento di un classico del canone letterario inglese qual è Pride and Prejudice. Si tratta, certo, di un adattamento sui generis, che richiede alcuni chiarimenti. Nei film studies con il termine “adattamento” ci si riferisce generalmente al passaggio a un mezzo di comunicazione diverso dalla scrittura di ciò che è trasferibile in un RECENSIONI testo narrativo, vale a dire: la storia, come insieme di personaggi e azioni. La storia, in questo caso, è quella della famiglia Bennett di Longbourn, costituita, oltre che dal padre e dalla madre, da ben cinque figlie sulle quali incombe un possibile destino di povertà: l’ancorché piccola proprietà di Mr Bennett, infatti, è destinata, alla sua morte, a passare di diritto a Mr Collins, il parente maschio più vicino in ordine di eredità, lasciando le signorine Bennett, ove non riuscissero a “combinare” un matrimonio vantaggioso, in una situazione di grave indigenza. Ma se il film della Chadha si inserisce di diritto nella collaudata tradizione dell’adattamento cinematografico, ciò avviene secondo una modalità che Geoffrey Wagner definirebbe “analogica”. Com’è noto, tre sono le principali forme di adattamento da lui individuate: la transposition, che traduce il romanzo sullo schermo in modo apparentemente pedissequo; il commentary, quando l’originale subisce una leggera alterazione attraverso l’enfatizzazione di un particolare o l’adozione di una nuova struttura; e, infine, l’analogy in cui v’è una considerevole deviazione dall’originale, usato come mero punto di partenza allo scopo di creare una nuova opera. A volersi attenere a tale tassonomia – peraltro modulata da Wagner secondo l’opinabile criterio del grado di “fedeltà” del film all’originale letterario – Bride and Prejudice sembra appunto rientrare nella categoria dell’“analogia”, istituita nel caso specifico tra l’Inghilterra dell’epoca di Jane Austen – quando il mercato matrimoniale, regolato da rigide norme sociali ed economiche, deve confrontarsi con la nascente ideologia dell’amore romantico, che esalta la libera scelta dell’individuo – e l’India contemporanea, dove la pratica del matrimonio combinato è oggi sottoposta al (pre)giudizio di un Occidente, (apparentemente) emancipato da quella stessa pratica. Ai concetti di “analogia” o “prestito” – borrowing è, per esempio, il termine coniato per questo tipo di adattamento da Dudley Andrew – può utilmente affiancarsi il concetto di “parodia” valorizzato dalla critica postmoderna. Adattamento come parodia potrebbe allora definirsi questo esperimento di Gurinder Chadha. La parodia, infatti, come riconosce larga parte della critica letteraria, è la figura retorica privilegiata della produzione postcoloniale, proprio perché realizza un incorporamento eversivo, una ripetizione differente del “già detto”; in questo caso un “già detto” che scaturisce dal cuore dell’ex impero. Nell’ingaggiare un corpo a corpo con la tradizione letteraria inglese, non solo Gurinder Chadha ha ri-mediato il romanzo di Jane Austen adattandolo per il cinema, ma lo ha declinato in un sottogenere filmico tutto indiano conosciuto in Occidente come “Bollywood musical”. Il ricorso al concetto critico di parodia ha il pregio di rimarcare una differenza significativa nell’enunciazione dei due testi, narrativo e filmico: ironia e parodia sono, infatti, le rispettive modalità stilistiche che regolano il rapporto di ciascuna delle autrici con la propria eroina. Se Jane Austen attribuisce alla protagonista del suo romanzo una «lively, playful disposition, which delighted in anything ridiculous» – caratteristica specifica anche della sua “voce” narrativa oltre che dello sguardo di Elizabeth, uno sguardo capace di distanziare criticamente gli oggetti osservati e di generare, proprio in quella distanza, l’inflessione ironica – nel film questa «giocosa disposizione» è tutta della regista, che nel focalizzare Lalita Bakshi, la Elizabeth Bennett di Amritsar, ne esagera a bella posta pose ed espressioni da fiction “rosa”. Sembra, insomma, che la regista sorrida dell’ingenuità di quel genere filmico indiano del quale l’attrice da lei scelta, Ayshwara Rai, è regina incontrastata. Eppure la consapevolezza della popularity del genere non vieta alla Chadha di abbandonarsi al piacere di praticarlo e di farlo conoscere al pub- ANGLISTICA blico occidentale. La cifra del suo filming non sembra la distanza critica necessaria all’ironia, ma una giocosa e in fondo irrisolta vicinanza caratteristica della parodia. Si ride con Jane Austen ed Elizabeth dei tic e delle manie della società cui appartengono, ma non si ride mai di Elizabeth in Pride and Prejudice. Nel film della Chadha, al contrario, non si può non sorridere insieme alla regista di una Lalita che canta, balla, si guarda bene dal baciare il partner ed è immancabilmente vestita di veli e lustrini. Ma anche se si sorride di Lalita, l’enunciazione filmica mantiene sullo spettatore una presa quasi ipnotica. Canti e colorate coreografie sono infatti il mezzo accattivante attraverso cui la Chadha si propone di offrire all’Occidente la sua versione della ricerca di un marito da parte delle quattro giovani sorelle Bakshi. Già nel romanzo di Jane Austen il ballo era uno dei pochi linguaggi consentiti per il corteggiamento e, come commenta con divertita ironia la voce narrante di Pride and Prejudice a proposito di una favoleggiata propensione di Mr Bingley per la danza, «to be fond of dancing was a certain step towards falling in love». Non è un caso, allora, che il Tempio d’Oro abbia nella riscrittura “bollywoodiana” del romanzo l’onore della già citata prima sequenza: esso è, infatti, l’equivalente postcoloniale di quella che nei romanzi di Jane Austen è l’assembly room, la sala in cui i giovani della gentry si incontravano per conoscersi e ballare sotto l’occhio vigile delle famiglie. Significativamente una delle sequenze centrali e più suggestive del film è ambientata proprio nel Tempio d’Oro, dove i giovani, accompagnati da genitori e parenti, si lanciano in una danza tradizionale con piccoli bastoni di legno che vengono fatti risuonare ritmicamente l’uno contro l’altro, come in un combattimento rituale. Qui Lalita allestisce la sua schermaglia linguistica con Darcy. A ben vedere, però, l’assembly austeniana ha subito una radicale revisione: il Tempio d’Oro infatti non è uno spazio pubblico laico, ma rimane pur sempre il luogo del rituale religioso di un’intera etnia. Maddalena Pennacchia Note . J. Austen, Pride and Prejudice, Penguin Books, Harmonsdworth , p. (a ed. ). . Negli ultimi quindici anni abbiamo assistito a una straordinaria proliferazione di film per il cinema e la televisione tratti dai romanzi di Jane Austen. Per un’utile analisi di questa produzione cfr. S. Parril, Jane Austen on Film and Television. A Critical Study of the Adaptations, Mc Farland, London . . Cfr. B. McFarlane, Novel to Film. An Introduction to the Theory of Adaptation, Oxford University Press, Oxford , p. . . G. Wagner, The Novel and Cinema, Tantivy Press, London , pp. -. . D. Andrew, Concepts in Film Theory, Oxford University Press, New York , p. . . Cfr., fra tutti, L. Hutcheon, A Theory of Parody, Methuen, London and New York . . Per il concetto di “ri-mediazione” cfr. J. D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media, MIT Press, Cambridge (MA) and London . . Austen, Pride and Prejudice, cit., p. . . Ivi, p. . . Ivi, p. . FRANCESISTICA Isa Dardano Basso Rosa Di Paolo Letizia Norci Cagiano Valeria Pompejano Luigi Magno Francesca Milaneschi Federica Sforazzini PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE. IL TABLEAU DE L’INCONSTANCE DES MAUVAIS ANGES ET DEMONS DI PIERRE DE LANCRE di Isa Dardano Basso Nel Pierre de Lancre pubblicò a Parigi presso l’editore Jean Berjon, il Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons. L’anno successivo si ebbero altre due edizioni del trattato: una presso lo stesso editore, un’altra presso Nicolas Buon; in alcuni rari esemplari dell’edizione di Jean Berjon il testo era accompagnato da un’incisione di Jan Ziarnko, Description et figure du sabbat des sorciers. La rappresentazione iconica, complessa e articolata, presenta alcune scene della cerimonia diabolica. Alla luce di quanto Lancre scrive nel trattato condurremo un’analisi della tavola illustrata: il discorso dell’autore e l’immagine che lo accompagna saranno l’oggetto del presente saggio. Il Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons è una sorta di relazione di eventi incredibili che lo stesso Lancre aveva avuto modo di osservare direttamente. Nel , con l’intento di ristabilire la pace in Labourd, una regione al confine con la Spagna che era turbata da malefici diabolici di ogni tipo, Enrico IV aveva nominato due magistrati del Parlamento di Bordeaux, Jean d’Espagnet e Pierre de Lancre, commissari di un tribunale itinerante che aveva il compito di ristabilire l’ordine in quella lontana e turbolenta provincia. I due commissari avevano pieni poteri e rispondevano del loro operato direttamente al sovrano. Mentre Jean d’Espagnet, che preferiva occuparsi di filosofia ermetica piuttosto che di streghe, si diede a regolare un contenzioso tra Francia e Spagna, Lancre si dedicò interamente alla caccia dei seguaci di Satana. L’accusa di stregoneria non lasciava scampo: molte sventurate furono torturate e, naturalmente, condannate. Come altri magistrati del suo tempo, persone colte ma prive di ogni umanità, Lancre spopola un’intera regione e poi teorizza sul suo operato. Il titolo, complesso e articolato, collega questo trattato di demonologia al precedente Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses che l’erudito aveva pubblicato nel . Com’è noto, il binomio costanza-incostanza fu uno dei temi fondamentali del dibattito culturale che si svolse in Francia tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento. Nel primo Tableau la riflessione sconsolata di Lancre, umanista devoto affascinato dalla magia bianca, era sottesa tra una visione pessimistica dell’incostanza umana e l’aspirazione a una impossibile costanza; nel secondo Tableau invece il tema viene affrontato in chiave demonologica. Satana è la creatura incostante per eccellenza, è quanto sostenevano i Padri della Chiesa e i teologi. Così, mostrandosi costante nella trattazione dell’incostanza, Lancre con il suo scritto farà rivivere le streghe alle quali egli stesso ha dato la morte; è questo il messaggio del sonetto di Jean d’Espagnet che figura tra le pièces liminaires del trattato: ISA DARDANO BASSO Pour te monstrer constant à traicter l’Inconstance, Lancre, tu nous fais voir les changemens divers Des bizarres Demons hostes de l’Univers, Par ce second Tableau que tu peints à la France. Mais quoy? ne vois-tu pas combien peu de constance On te donra, voyant sur le bord des enfers Les ombres voltiger de ce peuple pervers, Duquel tes jugemens ont faict juste vengeance. Et maintenant tu fais par un contraire sort, Que l’immortalité succede à cette mort, Ta plume leur donnant une immortelle vie. Et pour un second mal, tu feras naistre ainsi Mille et mille Sorciers des cendres de ceux-cy, Qui pour revivre auront de mesme mort envie. Con un gioco di pointes e di antitesi tra costanza e incostanza, tra vita e morte Jean d’Espagnet celebra l’operato del collega. Nel trattato l’incostanza dell’angelo ribelle che osò contrapporsi alla potenza divina s’intreccia con quella della strega che ha rinnegato Dio per stringere un patto con Satana: «Ce sont de vrays et certains discours de l’inconstance, et de la plus fine et endiablée», scrive Lancre nell’Advertissemens (Lancre, a, p. ). Il demonio era ben presente nell’immaginario del tempo. La società inquieta di quegli anni si trovava di fronte a un universo sconvolto: accanto alle stragi delle guerre di religione ardevano i roghi delle streghe. La fine dei tempi, la venuta dell’Anticristo erano ormai vicine: l’angoscia escatologica si era trasformata in un’ossessiva minaccia diabolica. In questo clima, dominato da tensioni religiose, politiche, economiche e sociali, dobbiamo contestualizzare lo scritto di Lancre. Nel Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons sono presenti due temi allora d’attualità: l’incostanza e l’ossessione diabolica, il sovrapporsi delle due tematiche costituisce l’aspetto originale di questo trattato. Privo di ogni atteggiamento critico di fronte al sovrannaturale, Lancre si sente continuamente minacciato dalla presenza del demonio. È fermamente convinto che streghe e stregoni non siano poveri malati farneticanti, ma seguaci di Satana che devono essere condannati. Così durante il processo interroga gli accusati per verificare, integrare o confutare quanto eminenti demonologhi del tempo come Bodin o Del Rio avevano affermato. Ma Lancre non è soltanto un teorico che scrive un trattato teologico e giudiziario, è anche un letterato che vuole affascinare il lettore. Il Tableau de l’inconstance des mauvais anges è dunque un trattato di demonologia e, al tempo stesso, «un formidable exercice de rhétorique baroque». Gli studiosi dei nostri giorni che si sono occupati di Pierre de Lancre hanno posto l’accento sul demonologo e, anche se non hanno preso in esame i suoi trattati di demonologia, lo hanno accostato sempre al mondo del sabba. Al tempo stesso, pur privilegiando lo studio di temi demonologici, non trascurano di sottolineare il carattere letterario di tali scritti. Così in un saggio dal titolo significativo, La fable sorcière, ou le labyrinthe des enchantements, Nicole Jacques-Jacquin, che ha curato un’edizione moderna di alcune parti del Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons, insiste sulla teatralità del sabba. Lancre è sempre presente sulla scena, PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE vuole rendersi garante della veridicità della sua esperienza e, al tempo stesso, è il primo attore della rappresentazione fantasmagorica che offre al lettore. A ben vedere, nel trattato aleggia una spettacolarità barocca. Durante i lavori della commisione itinerante i giudici venivano accompagnati dalla fastosa processione delle autorità locali e da numerosi ausiliari: confessori, interpreti, greffiers, barbieri, chirurghi, streghe pentite e redente che fungevano da testimoni, carnefici… Il crudele rituale della ricerca del segno del demonio, vale a dire della parte del corpo che era stata resa insensibile dal maleficio diabolico, era uno spettacolo che si svolgeva anche alla presenza di personalità di passaggio le quali potevano perfino intervenire direttamente. La strega, denudata e bendata, veniva punta con uno spillone in diverse parti del corpo: se la sventurata gridava stava mentendo; se invece, già provata dalla tortura, rimaneva in silenzio si aveva la prova che la zona diabolica era stata identificata. Alla crudeltà si accompagna la sensualità: si pensi allo sguardo che l’esaminatore rivolge al corpo nudo della giovane strega o alla compiaciuta dovizia di particolari con la quale si descrivono gli amplessi diabolici. Altri studiosi, è il caso di Céard (), si soffermano sul valore documentario di alcune parti del Tableau de l’inconstance des mauvais anges, una sorta di relazione di un viaggio nel paese del demonio. Nel trattato infatti Lancre presenta i diversi aspetti delle pratiche demonologiche, ma descrive anche, con la curiosità e l’interesse di un etnologo, la natura povera e selvaggia del Labourd. Poi, dall’ambiente naturale passa agli abitanti, miserabili e selvaggi anch’essi, e a più riprese, nel corso della trattazione, sottolinea la stretta relazione tra quella terra abbandonata e inospitale e l’umanità derelitta che l’abitava. Curioso e prevenuto, Lancre osserva quel mondo così diverso; ogni elemento del paesaggio e ogni aspetto della vita dei suoi abitanti sono, a suo avviso, una testimonianza di quanto egli suppone: si tratta della terra del demonio. La descrizione è il risultato di un’esperienza diretta della realtà, ma egli ha delineato, sia pure con elementi etnografici osservati dal vivo, una creazione del suo immaginario. Presenta la topografia della regione. Il Labourd è una terra selvaggia che la natura ha posto tra le montagne e il mare; le paludi si estendono per ogni dove. Il terreno non è fertile: piuttosto che coltivarlo, gli abitanti si dedicano alla pesca. L’organizzazione sociale di queste genti permette loro di godere di un’autonomia eccessiva di fronte al potere centrale. La religiosità è più apparente che reale. Le chiese, fastose se si considera la miseria del luogo, sono infestate da preti stregoni che si abbandonano a riti satanici. La lingua è un’incomprensibile mescolanza di basco, francese e spagnolo. Le donne si vestono e si acconciano in modi indecenti. Gli uomini convivono con loro prima del matrimonio, poi le abbandonano per una buona parte dell’anno: la pesca li tiene occupati in mari lontani, spingendoli fino alle coste di Terranova. Le sventurate, vittime di suggestioni allucinatorie, passano le loro giornate immobili, accovacciate, con lo sguardo perduto nel vuoto, sotto l’effetto di una droga, il Petun ou nicotiane, vale a dire il tabacco, che all’epoca era coltivato e fumato in Labourd. Questo è lo spettacolo che si presenta allo sguardo prevenuto del commissario inviato dal Parlamento di Bordeaux. In questi luoghi di trasgressione, ogni cosa mostra la presenza del demonio, che è ovunque, sempre pronto a rapire la strega e a coinvolgerla nella voluttà perversa del sabba. Tale cerimonia sacrilega si svolge di notte (ma, talvolta, anche in pieno giorno), ai crocicchi dei villaggi, nelle lande solitarie, nelle piazze, nelle chiese, nella stessa stanza del commissario. ISA DARDANO BASSO Luogo di una trasgressione estrema, il sabba è anche l’occasione per una féerie barocca in cui realtà e irrealtà si confondono. È il momento della liberazione delle pulsioni, dell’abbandono di ogni costrizione: il piacere sfrenato trionfa. La strega vola felice verso Satana; durante l’interrogatorio parla di «singulier plaisir», di «volupté admirable», di «merveilleux plaisir», dal momento che «le sabbat estoit le vray Paradis, où il y a beaucoup plus de plaisir qu’on n’en peut exprimer» (Lancre, a, p. ). Così confessa una strega al commissario, spesso soggiogato dal fascino perverso di parole che egli stesso ha estorto e suggerito. Tutto il villaggio si ritrova al sabba, cerimonia collettiva e trasposizione fantasmatica di una festa contadina: Le Sabbat est comme une foire de marchands meslez, furieux, et transportez qui arrivent de toutes parts. Un rencontre et meslange de cent mille subjects soudains et transitoires, nouveaux à la verité, mais d’une nouveauté effroyable qui offence l’oeil, et soubsleve le coeur. Parmy ces mesmes subjects, il s’en voit de reels, et d’autres prestigieux et illusoires, aucuns plaisans (mais fort peu) […]. Les autres déplaisans, pleins de difformité et d’horreur… (Lancre, a, p. ). L’atmosfera è gioiosa e, al tempo stesso, terrificante. L’orrore è dovuto al fatto che, durante la cerimonia, accanto a streghe deliranti che si abbandonavano a danze frenetiche, si ergevano inquietanti manichini immobili: De maniere que c’est un poinct notable de sorcelerie, que le Diable peut representer la figure mesme des sorciers, qui sont prisonniers, et celle de toute autre personne qu’il luy plaist, mais cette figure sera du tout sans mouvement, et n’apparoistra au sabbat faisant du poison, dançant ou autre chose, ains simplement comme celle d’un simple spectateur (Lancre, a, p. ). Altre streghe poi si trasformavano in animali per scomparire improvvisamente nel bagliore di un lampo. La realtà è divenuta ormai una fantasmagoria infernale nella quale Lancre proietta i fantasmi del suo immaginario, evocati dalle confessioni delle streghe. Egli crede di trascrivere fedelmente tali confessioni in una lingua semplice ed espressiva. Al contrario, nel trattato le sventurate recitano un discorso libresco, estraneo alla cultura contadina. Il loro racconto diviene un testo scritto attraverso la mediazione dello stesso Lancre che lo trasforma secondo i paradigmi della sua cultura letteraria e giuridica. Suggestionata e torturata, la strega è un essere mostruoso creato sulla sellette dell’interrogatorio. Convinto dell’opportunità di rappresentare concretamente le confessioni di quelle sventurate, Lancre accompagnò dunque alcune copie dell’edizione del Tableau de l’inconstance des mauvais anges del con l’incisione di Jan Ziarnko, una “mise en présence” della cerimonia mostruosa. Le due modalità della rappresentazione, il testo e la figura, sono entrambe utilizzate per mostrare al lettore la scena diabolica. Lancre è sensibile al legame tra testo letterario e icona; si compiace dell’alleanza tra parola scritta e immagine offerta da emblemi, geroglifici, simboli alchemici, scritture segrete… Nel Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses, a più riprese, mostra di essere attratto dalla raffigurazione plastica o dal procedimento dell’ecfrasi, PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE una pittura fatta di parole. Nel capitolo dedicato alla follia amorosa, quando descrive la stravagante architettura del palazzo del dio d’Amore e la sua pittoresca corte, traduce, con alcuni aggiustamenti di tiro, passi tratti da Le Pitture di Antonfrancesco Doni, un autore sovente utilizzato e mai citato in quell’opera giovanile (Dardano Basso, , pp. -). Lancre era un attento lettore di libri di emblemi e di trattati di mitografi; ma sono presenze che egli preferisce occultare. Nel Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses ebbe certamente presenti Le imagini de i dei degli antichi: in effetti il trattato di Vincenzo Cartari è tradotto a più riprese, ma è sempre passato sotto silenzio. Il discorso dedicato all’incostanza della Fortuna è, ad esempio, un centone di passi testualmente tradotti da questo e da altri mitografi italiani (Dardano Basso, , pp. -; , pp. -). Il gusto per l’immagine, per la rappresentazione plastica è una caratteristica sempre presente nelle sue opere. Nel Du Sortilege, il suo ultimo trattato, descrivendo i diversi tipi di divinazione, da quelli del mondo antico a quelli in voga nei suoi anni, presenta la processione delle Sibille: profetesse dell’antichità pagana, alcune di loro avrebbero vaticinato la nascita di Cristo. Fedele come sempre alla pratica intertestuale, qui Lancre traduce (questa volta però cita la fonte!) alcuni passi dal De divinatione et Magicis Praestigiis di Jean Jacques Boissard. Si tratta di un testo che aveva di sicuro sotto gli occhi quando si sofferma a descrivere l’abbigliamento e l’atteggiamento delle diverse Sibille, così come appaiono nelle splendide incisioni di Théodore de Bry che accompagnano il trattato. Nel pensiero e nella pedagogia dei gesuiti, l’associazione dell’immagine e della parola aveva una funzione pragmatica: doveva rendere efficace e persuasivo l’insegnamento religioso e condurre alla salvezza morale. Com’è noto, in quegli anni di profonda crisi religiosa, le illustrazioni (soprattutto quelle che accompagnavano i libri di edificazione) avevano un preciso scopo prescrittivo e didattico. L’immagine non è più un segno da decifrare, è un supplemento di significato. In perfetto accordo con la catechesi del Concilio di Trento che proponeva una valorizzazione dell’immagine, le illustrazioni che figuravano nei trattati del P. Richeome, come i Tableaux sacrés o La Peinture spirituelle, offrivano al lettore l’opportunità di profonde meditazioni. Anche Lancre, buon amico di questo padre gesuita, considera l’immagine un valido ausilio per rendere convincente il suo discorso e per sollecitare la partecipazione del lettore. Tra testo e immagine c’è una circolazione mobile e reciproca, una sorta di complementarità. Nel Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons l’immagine non ha soltanto la finalità di rendere gradevole il didascalismo di fondo e di sollecitare la riflessione, serve anche a rendere verosimili gli inverosimili fenomeni diabolici descritti nel testo. La dialettica del concettuale e del sensibile s’intreccia con la dialettica del vero e del falso. Il gusto per la raffigurazione plastica è dovuto a suggerimenti provenienti sia dal mondo della Chiesa militante, sia da quello della filosofia. Si pensi al platonismo ermetico, un indirizzo filosofico al quale il nostro fu particolarmente sensibile. Secondo i neoplatonici rinascimentali la raffigurazione era un mezzo per ritrovare l’essenza, l’immagine “vera” delle cose. Nella complessa personalità di Lancre convergono atteggiamenti diversi. C’è il magistrato crudele e disumano che deve mettere ordine in un mondo sconvolto dal delirio della possessione diabolica: crudeltà e insensibilità caratterizzarono, tranne rari casi, l’uomo del suo tempo che, smarrito, attraversava la prima delle grandi crisi della storia dell’umanità (cfr. Freud, , pp. -). C’è il cattolico di stretta osservanza, radicalmente controriformista. C’è poi l’osservatore curioso, suggestionato da ISA DARDANO BASSO una concezione magica della natura. Quest’ultimo atteggiamento appare con evidenza nel primo Tableau, allorché Lancre descrive le arcane stranezze di naturalia e mirabilia, raccolti nelle diverse Wunderkammern che visitò in occasione dei suoi viaggi. La magia bianca lo affascina; tuttavia con il passare degli anni, le credenze relative alle relazioni occulte e misteriose tra microcosmo e macrocosmo e la fiducia nella possibilità di riuscire a utilizzarle grazie a inni e formule incantatorie, si mescolarono con la pratica diabolica. La scienza moderna stava per nascere, l’illuminazione dei neoplatonici è calata in un universo matematico. Osservate alla luce fredda della ragione, le loro teorie diventarono assurde chimere. Anche Lancre le condanna, ma il suo rifiuto nasce da intendimenti diversi. Dopo l’esperienza del processo in Labourd, egli tende ad assimilare la magia bianca a un fenomeno di negromanzia. Non si dimentichi che in quegli anni non era facile segnare un confine netto tra la magia bianca e la magia nera. Nella tavola Description et figure du sabbat des sorciers, al fine di rappresentare il testo scritto, è messa in atto un’operazione di montaggio. Una serie di piccole scene, osservate da un unico punto di vista e racchiuse in una sola immagine, presentano al lettore momenti diversi della cerimonia diabolica. Ogni fase è descritta e commentata nel trattato, l’esibizione ornamentale si fonda su referenze testuali. Gli elementi costitutivi dell’illustrazione possono essere isolati e, come in uno dei tanti libri di edificazione spirituale allora in voga, le lettere che accompagnano l’immagine suggeriscono al lettore una sorta di percorso iniziatico che lo introdurrà ad alcune attività del sabba. Le scene si organizzano intorno a un’immagine centrale. In primo piano alcune streghe stanno preparando i loro decotti velenosi con animali immondi. Dal grande calderone, posto sul fuoco di un braciere, s’innalza una voluta di fumo nella quale volteggia uno sciame di streghe che sembra incupire il cielo. Alcune sono a cavalcioni di una scopa, altre aggrappate ai demoni che le accompagnano al sabba. Ci sono poi altre streghe che non si recano al luogo della cerimonia librandosi nell’aria, ma sulla groppa di un caprone. Come è stato osservato, l’associazione di questi due momenti del sabba – la preparazione dei veleni e l’avvicinarsi al luogo convenuto per la festa infernale – appare anche in altre raffigurazioni dell’epoca . Tutt’intorno sono distribuite, su piani diversi, dieci scene che presentano, con un disegno dalle linee precise e armoniche, alcune attività del sabba. Tale cerimonia segna un momento centrale nella riflessione demonologica di Lancre. Si tratta di un evento complesso che trae la sua origine dall’interazione di due gruppi sociali, il dotto mondo dei teologi e dei magistrati e quello delle grossolane superstizioni dell’ambiente contadino. L’evento era ancora vago e non ben definito nel Malleus Maleficarum (). Fu interpretato come adorazione diabolica collettiva verso la fine del XVI secolo e articolato in tutti i suoi dettagli, perversi e sacrileghi, da Del Rio allorché, nelle Magicae Disquisitiones , presentò i principali momenti di questa celebrazione satanica. Passando ad analizzare l’incisione, sarà opportuno considerare anzitutto il luogo in cui si svolge il sabba: è una landa remota e isolata nella quale si affollano personaggi umani e demoni. Non c’è traccia di paesaggio agreste, non ci sono alberi, se non l’albero magico, immagine ricorrente nel folklore popolare, intorno al quale le streghe intrecciano danze o suonano i loro strumenti. Personaggi umani e diavoli si accalcano, tuttavia le scene non presentano la dimensione surreale dei paesaggi allucinanti di Brueghel e di Bosch. Non ci sono alberi e rocce che si trasformano in mostri orribili e ghignanti, né rappresentazioni di metamorfosi in atto di esseri spa- PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE ISA DARDANO BASSO ventosi e seducenti. Generalmente tale luogo d’orrore ha un aspetto sinistro. Invece nella scena presentata da Ziarnko il paesaggio è desolato, ma non suscita angoscia. Non ci sono corpi contorti e convulsi che si agitano in un’atmosfera tenebrosa. Con un tratto netto e preciso, il bulino ha raffigurato scene reali, quotidiane, prive di forti connotazioni. L’omaggio al demonio segna il momento iniziale della cerimonia diabolica. Nella A.»), poi le legenda Lancre guida lo sguardo del lettore a osservare il demonio («A B.»), infine la scena di omaggio («C C.»). streghe («B A. Satan est dans une Chaise dorée en forme de Bouc, qui presche avec cinq cornes, ayant la cinquiesme allumée pour allumer toutes les chandelles et feux du sabbat. Satana, immagine rovesciata di Dio, è lo spirito del male e, al tempo stesso, un personaggio concreto. «Le monde est un theatre où le Diable jouë une infinité de divers et dissemblables personnages» (Lancre, a, p. ). Per ingannare e condurre alla perdizione gli uomini, il demonio, novello Proteo, si trasforma continuamente: «Il n’a point de forme constante, toutes ses actions n’estans que mouvemens inconstans, pleins d’incertitude, d’illusion, de deception, d’imposture» (ivi, p. ). Si presenta alla creatura che vuole circuire, sotto aspetti diversi: un caprone, un tronco d’albero, un enorme levriero, un grande bue, oppure in sembianze umane, ma con tratti animali, «en forme d’un grand homme noir vestu tenebreusement […] avec six cornes en la teste, parfois huit, et une grande queue derriere». Altre volte si presenta con «un visage devant, et un derriere, comme on peint le dieu Janus». La divinità romana si confuse nel tempo con il demonio, cedendogli i suoi attributi emblematici come il doppio volto. Il bifrontismo, immagine prediletta dell’incostanza, caratterizzava il dio pagano, ma era anche una maschera usata di frequente nelle feste del carnevale. Del resto il sabba non era per il nostro un’affollata festa popolare? Talvolta poi il secondo volto è situato in altre parti del corpo; una strega ha confessato al commissario che il viso posteriore del demonio era posto sotto una grande coda ed era simile al muso di un caprone. Generalmente Satana prende l’aspetto umano quando è il momento di stringere il patto con lo sventurato che vuole dannare, «mais le pacte fait, lorsqu’il veut recevoir quelqu’un à l’adoration, il se represente en Bouc» (ivi, p. ). Nell’immagine appare sotto forma di caprone, animale simbolo della lussuria, spesso presente nelle scene di baccanali. Ha quattro corna e una candela accesa sul capo. Anche nel trattato si presenta sotto questa forma: «comme un grand bouc, ayant deux cornes devant et deux en derrière; que celles de devant se rebrassent en haut comme la perruque d’une femme» (ivi, p. ). Nell’evocazione della pettinatura femminile appare l’immagine fantasmatica della donna del Labourd con i capelli acconciati in figura di fallo. Tale pettinatura aveva attirato l’attenzione e suscitato la condanna del commissario al suo arrivo in quella regione (cfr. infra, p. , nota ). B. La Roine du Sabbat couronnée à dextre, et une moins favorite à senestre. Ogni strega va al sabba accompagnata da un demonio che sarà, per così dire, il suo cavaliere durante la festa infernale. Per l’accoppiamento Satana sceglie la regina del sabba «qui est quelque sorciere qu’il a debauchée, laquelle il faict paroistre pompeu- PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE se, ornée de plusieurs faux affiquets et couronnée en royne, pour amorcer les autres» (Lancre, a, p. ). Generalmente è una delle donne più belle, scrive Lancre: «Et de vray toutes celles que nous avons veu qualifiées de ce tiltre de Roynes, estoient doüées de quelque beauté plus singuliere que les autres». C. Au dessous de sa chaire, est une Sorciere qui luy presente un enfant qu’elle a seduit. Arrivata al sabba, la strega si reca a omaggiare Satana. Tale atto nel trattato prende forme ben più scabrose rispetto a quella proposta nell’illustrazione. Nell’immagine la strega offre un fanciullo al demonio: com’è noto tra le accuse che i demonologhi rivolgevano ai seguaci di Satana figurava quella di rapire fanciulli per avviarli alle pratiche demoniache. In una pagina del Tableau de l’inconstance des mauvais anges appare la drammatizzazione della scena: en un moment elle le porte au sabbat, où elle a accoustumé de dire, le presentant au Diable: «Monsieur, voicy un beau present que je vous porte, c’est un enfant de bonne maison, il sera tout à jamais à votre service». Le Diable abbaissant le teste par forme de gratification, comme s’il vouloit tesmoigner que le present luy est de tant plus agreable que l’enfant est de bonne part, fait aussi semblant de donner en recompence à la sorciere la somme de parfois de escus et la convie à luy en mener souvent de semblables (Lancre, a, p. ). Il demonio paga la strega per i suoi misfatti. Secondo alcuni demonologhi tale denaro ben presto si trasforma in foglie secche, polvere e sterco; di diverso avviso è Lancre che, a proposito di un altro mercimonio, osserva che il compenso del diavolo è denaro vero: «cet argent se donna au sabbat et ne fut donné ny en songe ny par illusion» (ivi, p. ). Non è soltanto la curiosità per il proibito o il desiderio di evasione che spinge la strega verso Satana, ma anche la miseria e il bisogno di denaro. Lo spirito mercantile è un tema ricorrente nei racconti popolari di pratiche demoniache. Come Lancre, così anche altri demonologhi insistono su questo aspetto realistico più che diabolico. Il sabba è un vero mercato. Vorrei sottolineare che tale tratto ben si armonizzava con la sensibilità commerciale di una società come quella bordolese della fine del Cinquecento. La recente noblesse de robe, animata da spirito imprenditoriale, annoverava tra i suoi membri eredi discendenti, da due o tre generazioni, da mercanti di vino e di pesce. Si trattava di borghesi arricchiti che, grazie a una buona educazione ricevuta al Collège de Guyenne o al Collège de la Madeleine e all’acquisto di cariche pubbliche, nonché ad accorte politiche matrimoniali e a un’attenta amministrazione dei loro patrimoni, erano giunti alle alte cariche cittadine e costituivano l’élite culturale di Bordeaux. Era la classe sociale alla quale apparteneva lo stesso Lancre . D.» e «E E.», poste in basso a destra, rappresentano un Le due scene delle didascalie «D altro momento del sabba: il banchetto infernale. D. Voilà les Convives de l’assemblée, ayant chacune un Demon pres d’elle. Et en ce festin, ne se sert autre viande, que charoignes, chair de pendus, coeurs d’enfans non ISA DARDANO BASSO baptisez, et autres animaux immondes, du tout hors du commerce et usage des Chrestiens, le tout insipide et sans sel. Alcune streghe hanno confessato al commissario che durante il festino venivano serviti piatti prelibati, accompagnati da pane, vino e sale; ma la maggior parte di quelle sventurate riferisce che vengono imbandite pietanze ripugnanti, come rospi, carne di impiccati, carogne fetenti di animali infetti, carne di bimbi… Inoltre le pietanze sono insipide. Il sale, potente antidoto ai malefici demoniaci, è bandito dal banchetto diabolico. Ma si mangia veramente alla tavola del demonio? Il sabba è il luogo dell’effimero, dell’apparenza ingannatrice, in effetti al festino tutto è illusione: Si quelqu’un veut porter la main aux bonnes viandes, il ne manie aucun corps solide, et ne trouve rien au dessoubs que du vent, sauf de ces mechantes viandes qu’on ne peut manger qu’avec horreur. Ce sont faulses viandes, faux cuisiniers et faux serviteurs (Lancre, a, p. ). Nell’illustrazione, sulla mensa imbandita, appare un piatto contenente parti di un corpo umano, una testa e una gamba. Il cannibalismo appariva di frequente nel discorso cattolico e in quello protestante di quegli anni. Accanto all’eco delle atrocità commesse durante le guerre di religione, si avverte quello della barbarie degli abitanti del Nuovo Mondo, descritta da viaggiatori e missionari. Inserita nel mondo del sabba, tale pratica simboleggia la trasgressione estrema, se si pensa all’antropofagia simbolica presente nel mistero della transustanziazione, durante la celebrazione della Messa (cfr. Lestringant, a, p. ). Il cannibalismo evoca al tempo stesso anche un ricordo classico e biblico: Saturno, il dio antropofago, è stato identificato con Kronos, divinità assimilata a sua volta a Moloc, idolo al quale gli ebrei sacrificavano vittime umane. E. En ce festin ne sont admis, ces spectateurs, qui sont plusieurs povres Sorcieres rejettées aux recoings, et qui n’osent s’approcher des grandes ceremonies. Alcune streghe assistono, ma non partecipano al banchetto. Probabilmente Lancre ha voluto rappresentare in questa scena le streghe delatrici. Poiché il rituale del processo si ripete sempre identico (l’interrogatorio, la ricerca del segno del demonio sul corpo della strega, la tortura, la confessione e infine la condanna a morte), alcune streghe, più scaltre e meno esaltate, confessano di non aver partecipato al festino, ma di avervi soltanto assistito. Hanno visto ogni cosa e sono in grado di offrire alla curiosità del commissario una serie di particolari. Grazie a questa astuzia riusciranno ad avere salva la vita, saranno frustate, messe in prigione, ma non saranno strangolate e bruciate sul rogo. Al banchetto seguono le danze, un momento del festino del quale parlano diversi demonologhi quali Bodin (, II, , pp. r, r-r), Del Rio (, II, , p. ) e Boguet (, pp. -). Nel XVI secolo la danza era considerata segno di perversione, esercizio diabolico e manifestazione di riti del mondo pagano. Com’è noto, i seguaci di Bacco e di Sileno si abbandonavano a danze sfrenate che sopravvivevano ancora nelle feste popolari. Nonostante la condanna della Chiesa, Lancre si soffer- PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE ma, con particolare compiacimento, su questo tema. Gentiluomo mondano, abile danzatore e suonatore di liuto, il nostro s’intrattiene su varie tradizioni e modi della coreutica: danze antiche, guerriere, religiose. A proposito di queste ultime è contrariato dal fatto che la lussuria sia presente in movimenti del corpo che, all’origine, erano ispirati dalla devozione e che ora sono manifestazioni di una sfrenata lascivia. Ciò è accaduto in Labourd a causa di «ce mauvais et pernicieux voysinage de l’Espagne» che, invece di una cerimonia solenne e composta, ha favorito il diffondersi di scomposte acrobazie: Toutes les Pirrhyques, les Morisques, les sauts perilleux, les dances sur les cordes, la Cascata du haut des escheles, le voler avec des ailes postices, les Pyroüettes, la dance sur les demy-piques, l’Escarpolette, les Rodades, les forces d’Hercules sur la femme renversée sans toucher du dos à terre, les Canaries des pieds et des mains, tous ces bastelages sont presque venus d’Espagne. Et n’aguieres elle nous a encore donné, de nouvelle invention, la Chicona ou Sarabande. C’est la dance la plus lubrique et la plus effrontée qui se puisse voir (Lancre, a, pp. -). Nel trattato, accanto alla polemica antispagnola, appaiono ricordi di danze che Lancre stesso ha conosciuto e alle quali ha preso parte in Italia: la bergamasca, la nizzarda, la zingaresca, la gagliarda, la volta… Già nel primo Tableau de l’inconstance , dove episodi realmente accaduti si mescolano con altri di derivazione letteraria, non mancano accenni a questa passione per la danza. Accanto al ricordo di una surreale festa alla quale Lancre, giovane studente a Tolosa, fu invitato da alcune damigelle, si rievoca un episodio, avvolto invece in un’atmosfera di realistica quotidianità: a Praga, con altri due gentiluomini francesi suoi compagni di viaggio, tra boccali di vino, egli si prodigò nel mostrare alle sue padrone di casa le danze alla francese (cfr. Lancre, , pp. r, v-r). Nel successivo Tableau, si ricorda che Pietro dei Medici, in viaggio per la Spagna, soggiornò qualche tempo a Bordeaux, nei primi mesi del . Grazie alla sua buona conoscenza della lingua italiana, il nostro fu incaricato di intrattenerlo: Il eut un jour envie de voir les dames et le bal, pour voir dancer à la Françoise, si bien que me voyant dancer la volte avec une tres-belle damoyselle, il la trouva si estrange qu’il me pria de luy en donner quelque air sur le luth pour l’emporter à Florence. Sur tout il trouvoit rude, parce qu’il estoit Italien, qu’on se joignit de si prés et qu’aprés quelques tours de salle on vint aux prises, portant la main au busc, qui va un peu bien bas, pour plus aisémemt aller amont, et rehausser la femme, comme on faisoit en ce temps-là. Tale interesse per la danza è sottolineato nell’immagine: ben tre scene infatti sono F.», «G G.» e «H H.»). dedicate alla musica e alla danza («F F. Apres la pance vient la danse, car apres avoir esté repeus de viandes, ou fugitives, ou illusoires, ou tres pernicieuses et abominables, chaque Demon meine celle qui estoit près de luy à table, au dessous de cet arbre maudit, et là le premier ayant le visage tourné vers le rond de la danse, et le second en dehors, et les autres ainsi ensuivant tout de mesme, ils dansent, trepignent et tripudient, avec les plus indecens et sales mouvemens qu’ils peuvent. Scrive Lancre nel Tableau: ISA DARDANO BASSO Et quand ils ont mangé, chaque Demon prend sa disciple par la main et dance avec elle. D’autres fois ils ne se tiennent qu’avec une main, car de l’autre elles tiennent cette chandelle allumée avec laquelle elles reviennent d’adorer le Diable, et aprés cela chacune chante en honneur de son Demon des chansons tres-impudiques et sales (Lancre, a, p. ). Nei loro trattati gli altri demonologhi accennano alla danza delle streghe, ma Lancre è il solo che la descriva con precisione, seguendo le indicazioni fornite dalle interessate. La danza è licenziosa; la maggior parte delle streghe sono nude, altre sono vestite, ma si agitano in modo frenetico e scomposto, del resto i Baschi amano una danza «decoupée et turbulente» (ivi, p. ). Le streghe non danzano secondo la moda francese, «ains estant Basques et en plus belle disposition, elles font des sauts plus grands, et ont des mouvemens et agitations plus violentes» (ivi, p. ). Le danze infernali sono acrobatiche. Circondati da un alone di magia, gli acrobati sono sottoposti agli influssi della luna, come i sognatori, gli incostanti, i marinai e come tutto ciò che ha relazione con l’acqua. In quella barbara regione uomini e donne sono agili e leggeri, ma la leggerezza del corpo è un riflesso della leggerezza dell’anima. È un segno di quell’incostanza da cui il demonio trae vantaggio: Il ne faut s’estonner si par ruze et artifice, il les faict si legerement courir à cette abomination du sortilege, les y amorçant par tous les exercices de la mesme legereté, qui sont entre autres la curiosité, desir de nouveauté, les festins, la dance et les voyages sur mer, à quoy ils ont plus d’inclination que tout autre peuple qui soit en l’univers. I baschi erano famosi per la loro passione per i salti. Lancre vede nell’agilità delle loro acrobazie sul fuoco, in occasione della festa di san Giovanni, una manifestazione dei loro traffici con il demonio. «Apres la dance ils se mettent par fois à sauter, et font à qui fera un plus beau saut, jusques à en faire gageure» (Lancre, a, p. ). Il nostro ricorda di essere venuto a conoscenza di un fatto strepitoso: una strega, dopo aver fatto una scommessa, saltò giù dalla montagna de la Rhune, luogo incantato della regione e andò a cadere su una spiaggia tra Hendaye et Fontarrabie. Altre streghe hanno assicurato al commissario che avevano l’abitudine di recarsi proprio su quella spiaggia, tornando dal sabba, per riscuotere le vincite delle loro scommesse. Marie de la Parque, habitante de Handaye, aagée de à ans, et plusieurs autres deposent, qu’estant une nuict au sabbat, elles virent que Domingina Maletena sorciere, sur la montagne de la Rhune, si haute et le pied ou baze si large, qu’elle voit et borne trois Royaumes, France, Espagne et Navarre, fit, par une emulation avec une autre de laquelle elles nous dirent aussi le nom, à qui feroit un plus beau saut, si bien qu’elle sauta du haut de la dicte montagne, jusques sur un sable qui est entre Handaye et Fontarrabie, qui est bien prés de deux lieuës, et que la seconde s’en approchant aucunement, alla jusques à la porte d’un habitant de Handaye. Qu’elles le voyoient clairement, et que la plus part du sabbat se retirant, allerent vers elles, et trouverent la dite Domingina qui les attendoit, pour recueillir le fruict de la victoire et le prix de la gageure (Lancre, a, p. ). Nel passo abbiamo ancora una testimonianza del modo in cui, nell’immaginario e nella trattatistica di Lancre, reale e irreale si confondano: c’è il realismo della somma PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE scommessa che una strega va a riscuotere e il fantastico e irreale salto di un’altra strega dalla montagna al mare. G. Ce sont les joueurs d’instruments et le concert de Musique au chant et harmonie de laquelle ils dansent et sautent. Al sabba alcune streghe danzano, altre suonano e cantano. Osserva Lancre: Et comme les batailles et les assauts ne se livrent sans instrumens qui poussent et animent le monde, et encouragent les plus lasches, de mesme la dance est monstrueuse sans quelque son et harmonie, et ressent tout à faict, la folie. Qui a faict dire sagement à l’Italien: Chi balla senza son, o el è matto, o el è menchion. Sotto un albero una strega in piedi suona una tromba; la circondano le compagne, sedute, che suonano vari strumenti: quella in posizione centrale suona una mandora, accanto si distingue una suonatrice di arpa, poi una suonatrice di flauto e infine una suonatrice di viola. La scena, sia pure strettamente collegata alla successiva dedicata alla danza, mostra un concerto, immagine non usuale nell’iconografia del sabba. Lancre ama la musica, anche se riconosce che può facilmente indurre «à des voluptez pernicieuses» (Lancre, , p. ; cfr. ivi, pp. -). Dopo aver assistito all’esibizione della sua abilità di danzatore, Pietro dei Medici gli chiese «quelque air sur le luth pour l’emporter à Florence», come abbiamo già ricordato. Ma c’è ancora una testimonianza degna d’attenzione a proposito degli interessi musicali di Lancre: l’amicizia con Pierre Trichet, un collega al Parlamento di Bordeaux. Musicofilo e collezionista di strumenti musicali, questo magistrato fu in corrispondenza con Mersenne, del quale è nota la passione per la musica (cfr. Mersenne, , pp. -). Non è solo l’amore per la musica ad accostare Lancre e Trichet. Quest’ultimo, appassionato di magia bianca, aveva collezionato naturalia e mirabilia di ogni tipo nella sua Wunderkammer. A ciò si aggiunge l’interesse per la stregoneria. Trichet fu infatti autore di un poema dedicato a questo tema. Poeta non privo di eleganza, scrisse versi sia per il cardinale di Sourdis, il battagliero arcivescovo di Bordeaux, grande amico di Lancre, sia per Jean d’Espagnet, l’altro commissario nella spedizione in Labourd e dedicò al nostro un Tumulus Petri Anchorani Senat[tori] Burd[igalensi] nel quale celebra l’amico scomparso: […] Linquite Parnassum Musae, et decora alta sepulti, Effusis iunctim concelebrate comis. Dicite quam vestras fuit hic proclivis ad artes, Quam tersus, solers, eloquioque potens. […] H. Au dessous se void une troupe de femmes et filles qui dansent toutes le visage en dehors le rond de la danse. Le pratiche stregonesche sono divenute spettacolo. Per soddisfare la sua curiosità perversa, Lancre fece eseguire più volte ad alcuni discepoli di Satana sulla via della redenzione la danza del sabba: ISA DARDANO BASSO Nous fismes en plusieurs lieux dancer les enfans et filles en la mesme façon qu’elles dançoient au sabbat […]. C’estoient des enfans et filles de bon aage, et qui estoient desja en voye de salut avant nostre commission […]. Or on dict qu’on y dance tousjours le dos tourné au centre de la dance, qui faict que les filles sont si accoustumées à porter les mains en arriere, en cette dance ronde, qu’elles y trainent tout le corps, et luy donnent un ply courbé en arriere, ayant les bras à demy tournez. Si bien que la plupart ont le ventre communement grand, enflé et avancé, et un peu penchant sur le devant. Je ne sçay si la dance leur cause cela, ou l’ordure et meschantes viandes qu’on leur fait manger (Lancre, a, pp. -). Si tratta probabilmente del passo che ha ispirato l’illustrazione. In questa scena le streghe non sono accompagnate da demoni alati con zampe di caprone come nella F.», ma danzano rivolte, tutte, verso l’esterno. Le streghe ora sono nude. La scena «F nudità che caratterizzava la danza cultuale nell’antichità, ha perduto il carattere religioso per trasformarsi in uno spettacolo acrobatico e voluttuoso. Le osservazioni relative all’aspetto fisico della strega mostrano con quanto interesse e con quanta attenzione Lancre osservò la performance che lui stesso aveva organizzato. Nella raffigurazione della strega, accanto all’osservazione diretta del commissario, si avverte la presenza di uno stereotipo proposto dalla trattatistica e dall’iconologia dell’epoca. La strega è rappresentata come una vecchia megera dal corpo sfatto e appesantito. Nell’illustrazione non si rintraccia la contrapposizione tra streghe giovani e vecchie, presente, ad esempio, in immagini del sabba realizzate nei Paesi Bassi. Corpi acerbi e corpi sfatti erano accostati, quali rappresentazione simbolica della fugacità della bellezza femminile (cfr. Löwenstein, ). Tuttavia il contrasto tra le giovani e le vecchie streghe, evidenziato nella raffigurazione delle diverse parti del corpo, si annullava nella rappresentazione del ventre che mostrava, nei due gruppi, identiche particolarità (cfr. Palou, , p. ). Si trattava di un ventre gonfio e prominente, con caratteristiche simili a quelle sottolineate da Lancre. Finite le danze, ha inizio l’orgia satanica. L’erotismo ha un ruolo importante nel mondo della stregoneria, coinvolge giudici e accusati. Ognuno dal canto suo sottolinea gli aspetti scabrosi della relazione diabolica. Le streghe si soffermano su descrizioni minuziose del sesso del demonio e dell’accoppiamento, che è una delle condizioni del patto sottoscritto. I giudici compiaciuti trascrivono tali confessioni, senza nulla omettere. Di tali descrizioni, che avrebbero potuto suggerire svariate realizzazioni grafiche, non è rimasta traccia nell’iconografia. Il pudore ha prevalso. Nell’incisione di Jan Ziarnko la centralità della scena è riservata alla preparazioK.»). Si tratta di due ne dei veleni e al trasporto della strega al sabba (cfr. «II.» e «K momenti della festa sacrilega che Lancre intende mettere in evidenza: con la scena della preparazione dei veleni vuole sottolineare il pericolo delle pratiche diaboliche sul piano sociale. Con i suoi malefici che colpiscono uomini, animali e raccolti la strega predispone la rovina del genere umano e distrugge l’ordine stabilito. Quanto al trasporto della strega, il problema è di natura teologica: a differenza di altri demonologhi, Lancre è convinto che essa partecipi al sabba anche con il corpo. I. Voila la Chaudiere sur le feu pour faire toute sorte de poison, soit pour faire mourir et maleficier les hommes, soit pour gaster le bestail. L’une tient les serpens et crapaux en main, et l’autre leur couppe la teste, et les escorche, puis les jette dans la chaudiere. PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE Le streghe sono ora intente a preparare i veleni per i malefici e l’unguento con il quale si cospargeranno prima di recarsi al sabba. A tal fine stanno scuoiando animali immondi come serpenti e rospi. Utilizzano anche altre sostanze: uova covate e putrefatte, lingue di bue, cervelli di bimbi… Lo zelante commissario, nonostante abbia approfondito l’indagine, non è riuscito a scoprire esattamente quali ingredienti vengano utilizzati, dal momento che le deposizioni delle streghe erano discordanti a tale proposito. Le adepte di Satana tacevano, tuttavia: Il y en eut quelques autres qui nous descouvrirent les secrets de leur poudre et de leur poison, qui sont dignes de quelque autre consideration. Et nous dirent qu’au Sabbat on faisoit du poison avec des crapaux, lezards, araignes, et qu’estant faict, il estoit distribué dans l’assemblée par des Sorcieres qui le font, comme des boulangeres du sabbat (Lancre, a, p. ). Poi le streghe nascondono sotto terra i vasi che contengono i veleni e gli unguenti. Lancre organizzò spedizioni per la ricerca di tali vasi. Nel corso di un interrogatorio era venuto a conoscenza del luogo, non facilmente raggiungibile, dove alcuni di questi vasi erano stati sotterrati: Nous y fusmes en assez belle compagnie, le juillet . On fit effort de monter à la cime de ce rocher, que quelque enfant de ceux qui avoient esté au sabbat et qui y alloit toutes les nuicts, nous avoit revelé, mais il ne fut jamais possible d’y monter, tant le precipice et la pente en estoit perilleuse. Tellement qu’on ne fit autre chose pour ce jour que donner l’alarme à ceux de Fontarrabie, voyant tant de chevaux et de peuple qui paroissoit sur la coste. On y retourna pour la seconde fois, et on trouva la place du pot marquée par son assiette, que les sorcieres avoient enlevé la nuict precedente (Lancre, a, p. ). K. Pendant cet entretien plusieurs Sorcieres arrivent au Sabbat sur des bastons et balais, d’autres sur des Boucs, accompagnées des enfans qu’elles ont enlevés et subornés lesquels elles viennent offrir à Satan. D’autres partant du Sabbat, et transportées en l’air, s’en vont sur la mer ou ailleurs exciter des orages et tempestes. Dal braciere si innalza una colonna di fumo nella quale volteggiano diavoli e streghe discinte e seminude. Per un’errata interpretazione del Canon Episcopi alcuni demonologhi ritenevano che il trasporto della strega avvenisse in spirito e che il corpo non subisse alcuno spostamento. Lancre è di diverso avviso. Nel Tableau e nelle opere demonologiche successive ritiene impossibile una scissione tra il corpo e l’anima, mentre si è ancora in vita. Insomma lo spostamento della strega avviene con il corpo e con lo spirito: non è effetto del sogno, del delirio o dell’immaginazione. Il demonio trasporta realmente la strega: del resto non fu capace di sollevare Cristo sul pinnacolo del tempio per indurlo in tentazione, come raccontano le Scritture? Si bien que le Diable par la permission de Dieu les transporte quelquefois reellement en corps et en ame. Et neantmoins afin qu’on croye que le transport n’est veritable, et que ce n’est qu’illusion, il laisse là parfois le corps de la sorciere, non pas le vray corps, ains la figure et simulachre d’iceluy. Mentre i manichini che le rappresentano ingannano il commissario, i corpi leggeri delle streghe si librano nell’aria e il loro volo, divertente e gioioso, sembra quasi un ritorno ai giochi dell’infanzia: ISA DARDANO BASSO et ce transport se fera non seulement sans douleur et lassitude, frayeur, crainte, ny peril, qu’au contraire il n’y aura que plaisir. Ayant veu cent personnes qui confessoient avoir esté portées au sabbat, ores par le Demon, ores par les femmes qui les enlevoient, si vistement et en lieu si haut, comme vous pourriez dire au sommet de la montagne de la Rhune en Labourt, qu’ils n’y avoient que plaisir, ne sentant nulle violence, bien que ce fut comme d’un seul sault, ains ils y avoient le mesme plaisir que les enfans prennent communement, quand assis à chevauchons sur une perche en egal contrepoix et chacun en son bout, ils se levent et abbaissent chacun à son tour, comme ceux qui vont se branslant et rondoyant sur l’Escarpoulette (Lancre, a, pp. -). Se alcune streghe arrivano, altre si allontanano dal festino: Or elles volent et courent eschevelées comme furies à la mode du pays, ayant la teste si legere, qu’elles n’y peuvent souffrir couverture. On les y voit nues, ores graissées, ores non. Elles arrivent ou partent (car chacune a quelque infauste et meschante commission) perchées sur un baston ou balay, ou portées sur un bouc ou autre animal, un pauvre enfant ou deux en croupe, ayant le Diable ores au devant pour guide, ores en derriere et en queue comme un rude foüeteur (ivi, p. ). Si tratta probabilmente del passo che ha ispirato l’illustrazione. Nell’immagine della «furie à la mode du pays» si scorge in controluce sia l’immagine della strega delirante e scarmigliata, così com’era raffigurata nell’antichità classica, sia l’immagine della donna basca quando, novella Iride, scioglie sulle spalle i capelli scintillanti al sole (cfr. infra, p. , nota ). Le ultime due scene rappresentano personaggi che, per motivi diversi, non partecipano all’orgia. L. Ce sont les grands Seigneurs et Dames, et autres gens riches et puissans, qui traictent les grandes affaires du Sabbat, où ils paroissent voilez, et les femmes avec des masques, pour se tenir tousjours à couvert et incogneus. La stregoneria è un fenomeno rurale e popolare. Ma, col passare del tempo, anche gli esponenti della nobiltà locale cominciarono a frequentare tali festini: Anciennement on ne cognoissoit pour Sorciers que des hommes vulgaires et idiots, nourris dans les bruyeres et la fougiere des Landes; mais maintenant les Sorciers qui confessent, deposent qu’on y void une infinité de gens de qualité que Satan tient voilez et à couvert pour n’estre cognus, rejettant les povres aux recoings et extremitez de l’assemblée. Uno spirito di casta aleggia sulla scena. I personaggi raffigurati hanno un atteggiamento altero e dignitoso. Immobili, in piedi, sono abbigliati riccamente; il loro volto è celato da un velo o da una maschera e assistono in disparte alla cerimonia diabolica. «Ce sont les grands Seigneurs et Dames, et autres gens riches et puissans»: Lancre apparteneva a questa classe sociale. La sua famiglia, grazie a incarichi e alleanze, aveva una posizione rilevante in Guyenne, ma era di origine basca. I suoi progenitori, originari della Bassa Navarra, si erano trasferiti a Saint-Macaire all’inizio del Cinquecento. Il loro nome era de PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE Rostéguy. Verso la metà del secolo, il padre dello scrittore, Étienne de Rostéguy, che aveva abbandonato il commercio del vino dopo aver messo insieme un patrimonio considerevole, acquistò la carica di conseiller-notaire et secretaire del re. A partire da questo momento prende il titolo di “sieur de Lancre” e figura tra i personaggi di rilievo della città. Il nome de Rostéguy scompare poco a poco dagli atti ufficiali. L’origine basca viene così dissimulata. Ma l’atteggiamento del nostro verso i nobili del Labourd che si fregiano dei titoli di sieur e di dame seguiti dal nome della località dove si trova la loro povera e misera casa e abbandonano il loro vero nome, è molto severo. Armand Communay si chiedeva perplesso se Pierre de Lancre «oubliant luimême son origine, reniant son nom patronymique, puisqu’il s’affublait de celui d’une seigneurie qui n’a jamais existé, ne se condamnait pas lui-même?». Lancre tiene poi a sottolineare che i nobili del Labourd non hanno nulla a che vedere con il popolo minuto che traffica con gli spagnoli, «car les gentils-hommes frequentant la Cour ne sont de cette humeur, ayant esté eslevez à la Françoise, bien que plusieurs ayent du bien et maisons nobles en France et en Espagne, ou Navarre». Forse nella rappresentazione dei gentiluomini baschi educati alla francese, Lancre rivede, con aria distaccata, le sue stesse origini basche. Xenofobia e spirito di casta vanno di pari passo. A questo punto è opportuno fornire alcune notizie. A causa dei disordini verificatisi in Labourd per una carestia che si pensava fosse dovuta a malefici diabolici, a più riprese i notabili locali chiesero al Parlamento di Bordeaux – questa era la giurisdizione dalla quale dipendevano – di inviare una commissione per giudicare tali casi di stregoneria. Nel era stata nominata una commissione che si era recata nella regione, ma non era riuscita a ristabilire l’ordine. I disordini continuavano e le accuse di stregoneria si ripetevano. Si trattava però di accuse che probabilmente nascondevano lotte di consorterie rivali. Due notabili locali, Jean Coupenne, signore di Saint Pée e Tristan de Gamboa e d’Alzate, signore d’Urtubie, si rivolsero allora direttamente al re, chiedendogli di inviare dei commissari per liberare la regione dai malefici diabolici. Il dicembre Enrico IV nomina una commissione il cui capo – dotato di pieni poteri – era Pierre de Lancre. Il Parlamento di Bordeaux non registra il documento e chiede al sovrano «que soit limité le pouvoir dudit commissaire» (cfr. Dusseau, , pp. -). Il gennaio , con una seconda lettera il re stabilisce «pour certaines bonnes considerations» – e noi non sappiamo quali! – che un secondo commissario, Jean d’Espagnet, doveva essere aggiunto alla commissione. Perché fu nominato Pierre de Lancre? Perché il Parlamento di Bordeaux si oppose alla nomina reale? E perché fu poi aggiunto un secondo commissario? Nel Lancre non era un esperto di magia nera. Dal Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses non risulta alcun interesse particolare per la stregoneria; di contro appare una viva curiosità per i fenomeni di magia bianca. Nel trattato sono citati Bodin e Le Loyer, ma non per faccende di streghe. Nella seconda edizione del Tableau, nel (siamo quindi a ridosso dell’esperienza in Labourd) non c’è alcuna allusione ai lavori della commissione. Lancre non fu quindi designato dal re in quanto esperto di demonologia, anche se dopo l’esperienza in Labourd era sovente chiamato dai giudici di Bordeaux per le sue conoscenze in pratiche diaboliche. La nomina fu probabilmente il risultato di traffici e intrighi promossi dallo stesso Lancre. Il suo nome potrebbe essere stato suggerito a Enrico IV da personaggi influenti quali Antoine de Villiers, presidente del Parlamento di Parigi o piuttosto dal guardasigilli Nicolas de Sillery, al quale è dedicato il Tableau de l’inconstance des ISA DARDANO BASSO mauvais anges . Quanto al ritardo con il quale i magistrati del Parlamento registrarono il documento reale del dicembre , si può supporre che essi fossero irritati per le accuse che Lancre aveva rivolto loro nel Tableau de l’inconstance et instabilité, o piuttosto che essi temessero un personaggio del quale ben conoscevano bene il carattere intrigante e autoritario. Diverse ombre si addensano sull’operato del commissario. Certamente la strega è stata le bouc émissaire di scontri e di faide locali, ma qual è stato il ruolo effettivo di Lancre? Era forse coinvolto in queste rivalità di notabili locali? M. Pres de ce ruisseau sont les petits enfans, lesquels avec des verges et houssines blanches, esloignez des ceremonies, gardent chacun les troupeaux des crapaux de celles qui ont accoustumé les mener au sabbat. Scrive Lancre nel trattato: «Le sabbat ne se faict guiere que ce ne soit prés d’un lac ou d’un ruisseau ou de quelque mare, afin de batre l’eau pour faire la gresle, et exciter des orages». Il Labourd, come del resto tutta la regione basca, era esposto a furiosi temporali e grandinate, che causavano carestie e quindi dissesti economici. A quel tempo un fenomeno meteorologico, un fatto assolutamente naturale, era considerato il risultato di sortilegi diabolici. Accanto a uno specchio d’acqua alcuni fanciulli, si direbbe dei pastorelli di una strana scena bucolica, pascolano alcuni rospi. I fanciulli condotti al sabba avevano infatti il compito di «garder la bergerie des crapaux […] ayant chacun une gaule blanche en main». Il rospo è l’animale della stregoneria. Creatura mortifera, a causa del suo veleno, era il più temibile degli animali. Le streghe lo utilizzavano per preparare veleni e unguenti. Vestiti di seta o di velluto di colori diversi e ornati di sonagli, i rospi sono accanto alla strega durante il sabba. Lancre sospetta si tratti di una trasformazione del demonio stesso oppure di un dono demoniaco, dal momento che sovente «le diable baille à chaque sorciere, comme pour ange de sa garde, des crapaux habillez de verd ou de gris». Questi animali immondi talvolta accompagnano la strega nella danza. Una di quelle sventurate riferì al magistrato di aver visto: la Dame de Martibalsarena, dancer au sabbat, avec quatre crapaux, l’un vestu de veloux noir avec des sonnettes aux pieds, qu’elle portoit sur l’espaule gauche, et l’autre sans sonnette sur l’espaule droicte, et à chaque poing un autre comme un oyseau, ces trois derniers non revestus, et en leur naturel. Durante il sabba i rospi ricevevano un battesimo sacrilego, lesquels crapaux estoient habillez de veloux rouge, et parfois de veloux noir, une sonnette au col et une autre aux pieds, avec un parrain qui tenoit la teste dudict crapaud, et une marraine qui le tenoit par les pieds, comme on fait aux creatures dans l’Eglise (Lancre, a, p. ). Nell’immagine di Jan Ziarnko i rospi sono al pascolo con i fanciulli. Satana è soddisfatto quando le streghe gli offrono nuovi seguaci: li accoglie volentieri, ma non permette loro di partecipare al festino. Per una sorta d’inspiegabile pudore, li tiene in disparte e, per non turbarli, nasconde dietro una fitta cortina di fumo le scene più sconvolgenti della cerimonia nefanda: PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE Les petits enfans et filles gardent les troupeaux du sabbat, qui sont un monde de crapaux, prés d’un ruisseau avec des petites gaules blanches qu’on leur donne, sans les laisser approcher du gros des autres sorciers. Les mediocres et ceux qui sont de bon aage parmy eux, on leur permet simplement de voir et leur en donne-on le plaisir et l’estonnement, les tenant comme en apprentissage. Pour les autres il y en a de deux sortes: aucuns sont voilez pour donner opinion aux pauvres que ce sont des Princes et grands seigneurs, et qu’aucun d’eux n’ayt horreur d’y estre et faire ce qu’ils font en adorant le Diable. Les autres disent que c’est que le diable fait semblant de vouloir imiter ce traict de S. Paul aux Corinthiens xi. qui dict qu’il faut que la femme marche le chef couvert à raison des Anges. Lancre conclude le didascalie che commentano la tavola illustrata, osservando che: Outre ce, il y a plusieurs autres choses que la petitesse de ceste figure n’a peu souffrir, qui se pourront entendre commodément par le Discours du Sabbat, qui est au Discours . du Livre second. Il discorso demonologico è divenuto immagine, ma questa non rende la complessità della trattazione, alla quale si rinvia il lettore. Probabilmente Lancre è insoddisfatto non tanto per la dimensione ridotta, quanto piuttosto per il realismo della raffigurazione che non rende quell’intreccio di realtà e irrealtà, presente nel suo immaginario. Sadico e sensuale, egli trascrive i racconti delle streghe con un linguaggio crudo, sottolineando che: Les paroles couvertes ont souvent un sens plus descouvert et malicieux que celles qui parlent clairement. Et ces gens à demy muets qui ne s’expriment qu’à demy mot, parlent plus avec silence, que les parleurs qui disent plus qu’ils ne sçavent, avec leur garrulité . Ossessionato dalla sessualità, Lancre considera il sabba come il luogo in cui si realizza ogni forma di perversione . Nel testo scritto l’orgia diabolica è di frequente evocata ed è presentata con una grande ricchezza di particolari. Appare nelle confessioni delle streghe e nelle argomentazioni del trattatista dove è corredata da una fitta schiera di testimonianze di auctores: sono demonologhi come Bodin o Del Rio, compilatori curiosi quali Strozzi Cicogna o Antonio Torquemada, teologi e giuristi, poeti antichi e moderni come Dante, Ariosto, Ronsard, Tasso . Varietà di contenuti e ricercatezza formale vanno di pari passo. Così Lancre rappresenta il festino infernale: Dancer indecemment, festiner ordement, s’acoupler diaboliquement, sodomiser execrablement, blasphemer scandaleusement, se venger insidieusement, courir après tous desirs horribles, sales et desnaturez brutalement, tenir les crapaux, les viperes, les lezards, et toute sorte de poison precieusement, aymer un Bouc puant ardamment, le caresser amoureusement, s’acointer et s’acoupler avec luy horriblement et impudamment. Ne sont-ce pas des traicts desreglez d’une legereté nompareille, et d’une inconstance execrable, qui ne se peuvent expier par autre feu que par celuy que la Justice divine a logé en enfer? (Lancre, a, Advertissemens, pp. -). ISA DARDANO BASSO In questa sequenza caotica d’immagini, ritmata dalla successione degli avverbi e degli infiniti, sono presentati i momenti più scabrosi del diabolico baccanale. Nell’incisione di Ziarnko non c’è alcuna traccia di cerimonie orgiastiche: il pudore prevale. Sono escluse dalla rappresentazione anche le scene in cui maggiormente appaiono il sacrilegio e la parodia delle cerimonie religiose. Manca quell’«abominable mystere et badinage» (ivi, p. ) che è la celebrazione della messa, non ci sono profanazioni dei simboli cristiani, né croci spezzate, né ostie nere, anche se nel trattato Lancre si era soffermato su tali particolari. L’immagine presenta una scena di banchetto, occasione di convivialità, ma con un particolare raccapricciante: alla mensa sono servite carni umane. Si mostrano streghe nell’atto di preparare veleni, ciononostante hanno l’aria di bonarie massaie intente a cucinare, non hanno nulla in comune con le streghe surreali, presenti ad esempio nelle incisioni di Hans Baldung Grien (cfr. Zika, , p. ). Alcune streghe si dilettano improvvisando una sorta di concerto campestre. Accanto c’è una schiera di nobili alteri e composti; ci sono infine fanciulli che giocano sulle rive di un ruscello, anche se pascolano animali ripugnanti. La scena, o meglio l’insieme delle scene, rivive nel tratto preciso e netto di Ziarnko: ciò dà l’impressione di una riproduzione fedele e realistica di eventi e di azioni. E tuttavia è assente quel mondo lussureggiante e fantasmagorico che Lancre, mosso da una sensibilità barocca, ha creato nel testo scritto. Con gli strumenti dell’ecfrasi o dell’ipotiposi, il trattato presenta un mondo surreale, mosso dall’esaltazione e dal delirio, un mondo assente nell’immagine. Seguendo racconti farneticanti, sollecitati dalle torture, Lancre evoca stuoli di creature dannate che volteggiano nell’aria e oscurano la luce del giorno. Alcune streghe hanno confermato il fenomeno: il cielo si oscura per la nube cupa, formata dalla fitta schiera dei seguaci di Satana. Con la rapidità di un lampo, sotto la guida dei demoni, la nube è capace di attraversare l’Oceano a una velocità incredibile . Il paesaggio diviene irreale, anche se la precisa localizzazione degli eventi conferisce alla scena un effetto di realtà. Si citano i villaggi della costa basca: Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure; il cielo è solcato da razzi e bagliori sinistri, non si tratta – come potrebbe sembrare – di fulmini o di fuochi d’artificio: sono le creature mostruose che tornano dal festino. Ecco la confessione delirante della strega: Elle nous disoit qu’on eust veu desloger du sabbat et voler l’une en l’air, l’autre monter plus haut vers le ciel, l’autre descendre vers la terre, et l’autre parfois se precipiter dans des grands feux allumez audit lieu, comme fuzées qui sont jettées par plusieurs, ou comme esclairs: l’une arrive, l’autre part, et tout à coup plusieurs partent, plusieurs arrivent, chacune rendant compte des vents et orages qu’elle a excités, des navires et vaisseaux qu’elle a fait perdre, et s’en vont de Labourt, Siboro et S. Jean de Luz, jusques à Arcachon (Lancre, a, pp. -). Durante la messa sacrilega preti-stregoni si dondolano nell’aria, «la teste en bas, et les pieds contre-mont, et le dos ignominieusement tourné vers l’autel» (ivi, p. ). Lo sguardo visionario di Lancre si sofferma, forse un po’ deluso, a rintracciare nell’incisione i fantasmi del suo immaginario. Note . La tavola è posta tra la p. e la p. , dove ha inizio la descrizione del sabba (cfr. Lancre, a, II, : Description du Sabbat, du poison qui se faict en iceluy, et quelques depositions notables de PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE certaines sorcieres fort suffisantes, qui verifient clairement ce transport, pp. -). Su Jan Ziarnko, incisore attivo a Parigi nei primi decenni del XVII secolo, cfr. Sawicka (, pp. -). . Cfr. Lettres patentes commettant MM. d’Espagnet et de Lancre pour se rendre au pays de Labourd et y juger souverainemet de tous les delits de sorcellerie, datata janvier . Poiché il Parlamento di Bordeaux tardava a registrare il documento (cfr. infra, p. , nota ), il sovrano inviò una seconda lettera, datata février : Lettres de jussion adressées par le Roi au Parlement de Bordeaux, pour qu’il ait à enregistrer, sans nouveau delai, la Commission donnée aux sieurs d’Espagnet et de Lancre. I due documenti sono riprodotti in Communay, , pp. -. Sui lavori della commissione cfr. Boscheron Des Portes (, vol. I , pp. -). Gaufreteau (-) accenna alla Commissione e rinvia il lettore curioso al trattato composto dallo stesso Lancre (ivi, vol. I, pp. -). La convinzione che i Paesi Baschi fossero il luogo prediletto del sortilegio è spesso presente in tale Chronique (ivi, vol. I, pp. -; vol. II, pp. , , -). Con la Soule e la Bassa Navarra, il Labourd è una delle tre province che costituiscono i Paesi Baschi. Tra le recenti monografie dedicate a Lancre demonologo e al processo in Labourd cfr.: Villeneuve (); Caro Baroja (, pp. -); Bordes (, pp. -); Dusseau (); Bernou (). . Gli spagnoli permettevano agli abitanti del Labourd la navigazione della Bidassoa, fiume che all’epoca segnava il confine tra Francia e Spagna, soltanto con piccole barche da pesca. Il presidente d’Espagnet visitò i luoghi, la costa, le isole costiere: «De quoy il a fait», scrive Lancre, «une carte et figure exacte, et son procez verbal qu’il envoya à Sa Majesté, ayant trouvé que la navigation sur la dicte riviere avec toute sorte de bateaux à quille, nous doibt estre permise, aussi bien qu’à eux. Et que les Isles qui sont de nostre costé nous appartiennent, aussi bien qu’aux Espagnols celles du leur» (Lancre, a, p. ). . Il numero delle condanne resta nell’ombra, anche perché gli atti del processo venivano per lo più distrutti immediatamente. Se in passato alcuni studiosi avevano parlato di diverse centinaia di persone, oggi si ritiene che la cifra sia più modesta: cfr. Villeneuve (, p. ); Dusseau (, pp. -). Anche se il numero delle vittime è stato ridimensionato, l’impatto psicologico sulla popolazione fu notevole. Il ricordo della Commissione era traumatico. È quanto riscontrò la missione di Padri gesuiti, inviata subito dopo in Labourd dalla reggente Maria dei Medici, su consiglio del P. Coton (cfr. Prat, , vol. III, pp. -). . Cfr. Lancre (). Il trattato, con l’aggiunta di un Livre nouveau de l’inconstance de toutes les nations principales de l’Europe, fu pubblicato nuovamente, a Parigi, nel . Su Lancre teorico dell’incostanza e sulla sua formazione culturale rinvio a quanto ho già scritto alcuni anni orsono: cfr. Dardano Basso (); per un aggiornamento della bibliografia critica, cfr. Dardano Basso (, pp. -). . Sonnet du dict sieur d’Espaignet au sieur de Lancre, in Lancre (a, p. ; la numerazione delle pagine delle pièces liminaires è mia); sempre in questa parte del trattato, figura un componimento in latino, dello stesso Jean d’Espagnet, in onore del nostro: Pancratium sortilegorum quae in expeditione cantabrica adsversus Sortilegos à P. Ancorano dicti Senatus consiliario et eodem Spagneto lectis Duumviris facta et eruta sunt ex veris nec ficte perstringens (ivi, pp. -). Trascrivo il testo del trattato limitandomi a sciogliere le rare abbreviazioni e a differenziare alcuni grafemi (i da j, u da v e a da à). Ho accentato la e tonica finale. Ho modificato la punteggiatura soltanto nei pochi casi nei quali era possibile un fraintendimento. Come Lancre anche Jean d’Espagnet era affascinato dal mistero. Fu autore di un trattato ermetico Enchiridion Physicae restitutae […] (Parisiis, apud N. Buon, ) che egli firmò con lo pseudonimo di “Chevalier Impérial” (cfr. Maxwell, ). Tra le curiose ricerche di questo magistrato c’è il tentativo di rendere plasticamente il mistero della Trinità, ornò infatti la sua casa di Bordeaux con misteriose sculture. Se ne veda la riproduzione in Desgraves (éd.) (, tav. XII, p. ). . Per un quadro sull’angoscia di quegli anni cfr.: Delumeau (); Jones-Davies (éd.) (); Crouzet (); Niderst (éd.) (); Closson (); Lombardi (). . Lancre non è mai sfiorato dal dubbio: la stregoneria non è «prestige, songe ou illusion»; egli ritiene piuttosto che «l’Heresie, l’Apostasie, la Sodomie, le Sacrilege, et autres crimes execrables, qui se trouvent envelopez dans le Sortilege, estans maintenant tout formellement verifiez, il ne faut desormais se tenir à cette douceur ancienne dont usoient nos Parlemens» (Lancre, a, Advertissemens, p. ). . «Or j’ay voulu loger icy ces premiers traits, pour faire gouster à tout le monde le grand besoing qu’il y a de faire voir et entendre au public tous les secrets du sortilege que nous avons peu ISA DARDANO BASSO descouvrir » (Lancre, a, Advertissemens, p. ). L’autore si propone di offrire una testimonianza delle azioni nefande delle streghe e, al tempo stesso, una gradevole lettura. I diversi strumenti della retorica saranno utilizzati con questa finalità: «il ne se peut faire autrement sans oster toute la grace de mon discours, et paraventure toute l’apparence et esclaircissement de la preuve et qualité du crime» (ivi, p. ) . Jacques-Chaquin (, p. ). Michelet non è troppo benevolo con Lancre: lo considera infatti uno sciocco vanitoso, dominato da «l’amour du merveilleux horrible», dal «plaisir d’avoir peur» e dall’«amusement des choses indécentes», tuttavia riconosce che: «Il écrit bien, il est beaucoup plus clair que tous les autres» (Michelet, , p. ). Anche Mc Gowan () sottolinea l’aspetto “letterario” della scrittura del nostro. . Lancre non è stato soltanto l’autore di trattati di demonologia, ma anche un teorico dell’incostanza, e non dei minori (cfr. supra, p. , nota ), e un attento e ben documentato osservatore delle relazioni tra il principe e il cortigiano, come risulta dal Livre des Princes. A proposito del cortigiano che Lancre presenta in tale trattato, Houdard (, p. ) scrive: «De Lancre observe les courtisans comme les sorciers basques, avec ce même radicalisme chrétien qui fait la charnière entre l’idéal de Castiglione – dont de Lancre réconnaît que les modèles sont introuvables – et l’univers des moralistes du XVIIe siècle». Altri non esitano a definire il cortigiano adulatore, presentato nel Livre des Princes, «un sorcier par métaphore» (Merlin, , pp. , ). . Tale teatralità barocca appare sul piano delle immagini e anche sul piano della scrittura: cfr. Jacques-Chaquin (, pp. -; , pp. -; ). Anche Houdard () vede nel Tableau de l’inconstance des mauvais anges «la peinture fascinée, ouverte aux merveilles d’un monde étrange auquel l’écriture, soumise aux jeux baroques de la métaphore et du concetto, essaye de se plier» (ivi, p. ; cfr. anche pp. -). . Per una ricostruzione del tribunale itinerante, non priva forse di qualche esagerazione, cfr. Bernou (, pp. -). Si pensi alla spettacolare processione per la ricerca dei vasi con i veleni, sotterrati dalle streghe (Lancre, a, p. ; cfr. supra, p. ) o al processo, alla degradazione e all’esecuzione del curato d’Arguibel, un povero vecchio delirante. Ricorda Lancre: «Et par ce qu’il faut qu’un Evesque degrade les Prestres condamnez à mort, nous nous trouvasmes en peine pour l’absence du sieur Evesque de Bayonne, qui estoit en la ville de Bourdeaux, à la poursuitte d’une affaire d’importance. Il pria luy mesme, et escrivit au sieur Evesque d’Acqs, d’en vouloir prendre la peine. Ce qu’il fit. Et affin que la chose se fit plus convenablement, et à propos, il la fit dans l’Eglise du Sainct Esprit qui est de son diocese. La mort de ce Prestre fit un grand esclat dans la ville de Bayonne, bien qu’il fut deffaict à Ascain pour servir d’exemple, et donna de la terreur à tout le pays de Labourt» (Lancre, , p. ). Le esecuzioni, sovente accompagnate da tumulti, erano spettacolari: «Il y avoit un tel desordre et une si grande foule, qu’il n’y avoit ny ordre ny seureté en ces executions. Chacun s’approchoit si librement de la sorciere lorsqu’on la menoit sur la charette, qu’à Marie Bonne de Sainct Jean de Lus estans en cest estat, sorcière insigne, qui avoit librement confessé et servi de tesmoin contre plusieurs autres, on lui porta souvent le poignard à la gorge pour la faire dedire, et descharger plusieurs personnes qu’elle avoit accusées, sans que les Bailles, Abbez et Jurats, ny les plus relevez officiers de la Justice, en peussent estre les maistres. De maniere que l’executeur, la trompette, le sergent, les interpretes, et greffiers, eurent tant de peur, qu’à peine les pouvions nous par aprés faire aller à l’execution de quelque autre, que par force» (ivi, p. ). . Si pensi alla ricerca del segno diabolico effettuata «par le sieur de Grammont, Gouverneur de Bayonne et pays de Labourt, en presence du sieur de Vausselas et sa femme, lequel par fortune s’en alloit en ce temps-là Ambassadeur en Espagne» (Lancre, a, p. ). Un intero discorso è dedicato alla ricerca di tale segno (ivi, III, : De la marque des sorcieres, pp. -). La marque du diable, prova tangibile dei traffici della strega con Satana, aveva un notevole valore simbolico. Coinvolgeva problemi teologici, pratica giudiziaria e tradizioni etnologiche: cfr. Delpech () e Demonet (). Per tale ricerca Lancre aveva «un Chirurgien estranger, mais neantmoins pour lors habitant de Bayonne, qui à force de visiter lesdits sorciers et rechercher les marques y devint merveilleusement entendu et suffisant» (Lancre, a, p. ). Accanto al chirurgo egli segnala a più riprese la presenza, tra i membri della commissione, di una giovane, Morguy, già frequentatrice di sabba. Anche la strega redenta era «merveilleusement suffisante et entendue pour connoistre et trouver la marque du diable» scriverà il nostro alcuni anni dopo (cfr. Lancre, , p. ). Questo personaggio, investito da una luce sinistra, comparirà in Michelet (, pp. -). PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE . A ben vedere egli applica la teoria aristotelica dell’influenza del clima al mondo della demonologia. Già nel Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses, trattando dell’incostanza dei diversi popoli europei, Lancre aveva esposto tale teoria; citava Olao Magno e Tacito, ma taceva su quanto Bodin aveva scritto a tale proposito nel De la Republique (I, ). Tuttavia egli conosceva questo trattato: cfr. Bodin (, pp. , ) e Lancre (, pp. v-r, v). L’opera di Bodin è ricordata ancora in Lancre (, pp. v-r, v-r, e, probabilmente, p. r), cfr. Dardano Basso (, p. , nota ). Sulla ricezione della teoria del clima in quegli anni cfr. Lestringant (b). . Cfr. Lancre (a, I, : Qu’il ne faut s’estonner, puis qu’il y a un si grand nombre de mauvais Anges, qu’il y ait tant de Magiciens, Devins et Sorciers, et pourquoy ceux du pays de Labourt ont tant d’inclination et courent si fort à cette abomination, pp. -; I, : Pourquoy il y a plus de femmes sorcieres que d’hommes et d’une certaine sorte de femmes qu’on tient au pays de Labourt pour Marguillieres, qu’on appelle Benedictes, pp. -). Sulla regione e i suoi abitanti cfr.: Michel (, pp. -); Goyeneche (), Goyenetche (, ). . Lancre mostra, fin dal suo primo trattato, una profonda diffidenza nei riguardi della donna. Al pari di Eva, tutte le donne sono incostanti, ipocrite, bugiarde e libertine. Creatura più fragile dell’uomo, la donna cede facilmente alle lusinghe di Satana. Come la maggior parte dei demonologhi, il nostro è convinto che «il y a plus de femmes sorcieres que d’hommes» (Lancre, a, p. ). In Labourd poi le donne godono di una libertà eccessiva. Sono vestite in modo indecente, la loro capigliatura e il loro modo di acconciarla stupisce il commissario: «Leur poil couvrant à demy les joües, leurs cheveux voletant sur les espaules, et accompagnant les yeux de quelque façon, qu’elles semblent beaucoup plus belles en cette naïveté et ont plus d’attraict que si on les voyoit à champ ouvert. Elles sont dans cette belle chevelure, tellement à leur avantage, et si fortement armées, que le soleil jettant ses rayons sur cette touffe de cheveux comme dans une nuée, l’escalt en est aussi violent et forme d’aussi brillants esclairs qu’il fait dans le ciel, lorsqu’on voist naistre Iris, d’où vient leur fascination des yeux, aussi dangereuse en amour qu’en sortilege, bien que parmy elles porter la perruque entiere soit la marque de virginité. Et pour le commun des femmes en quelques lieux, voulant faire les martiales, elles portent certains tourions ou morrions indecens, et d’une forme si peu seante, qu’on diroit que c’est plustost l’armet de Priape que celuy du Dieu Mars, leur coeffure semble tesmoigner leur desir. Car les veuves portent le morrion sans creste pour marquer que le masle leur deffault» (Lancre, a, p. ). Anche Montaigne segnala tale curioso modo di acconciarsi: «Les femmes mariées, icy près, en forgent de leur couvrechef une figure sur leur front, pour se glorifier de la jouissance qu’elles en ont, et venant à estre veuves, le couchent en arrière, et ensevelissent sous leur coiffure» (Montaigne, , III, , p. ). . «Or je ne sçay si cette fumée les estourdit, comme cette autre herbe les Indiens. Mais je sçay bien et est certain qu’elle leur rend l’haleine et le corps si puants, qu’il n’y a creature qui ne l’ait accoustumé qui le puisse souffrir, et en usent trois ou quatre fois par jour. Ainsi elles sentent au sauvage» (Lancre, a, pp. -). . Forse, con la sua descrizione negativa, Lancre intendeva giustificare la feroce repressione che aveva messo in atto; accanto a una finalità documentaria il suo scritto potrebbe avere quindi una funzione conativa: chi potrebbe mai dubitare della presenza del demonio in una regione così desolata e selvaggia? È quanto ritiene Cabantous (, p. ). . Nella notte tra il e il settembre del , un sabba “domestico” si svolse nel castello di Saint-Pée-sur-Nivelle, nella stanza dove Lancre era alloggiato: «On y dit deux Messes, l’une fut dite dans ma chambre par un Prestre du lieu de Sainct-Pé, et l’autre par la dame de Sansinena dans la cuisine» (Lancre, a, p. ). Alcune streghe e il demonio stesso tentarono poi inutilmente di ucciderlo. Il commissario non si accorse di nulla, ma il racconto delle sventurate durante l’interrogatorio e, soprattutto, la dovizia di particolari presenti nella loro confessione, non gli lasciarono ombra di dubbio. Sulla relazione tra habitat e luogo dove si svolge il sabba cfr. Clemens (, pp. -). . Il sabba è un luogo reale, si pensi alla descrizione precisa e dettagliata delle streghe: «D’ailleurs les sorcieres qui confessent, remarquent les lieux du sabbat, les places, les arbres, les buissons, les fleuves, les champs, les maisons, l’ordre des festins, les viandes, si les convives ne sont voilez, elles les recognoissent, elles ont aussi une cognoissance particuliere, et nomment ceux qu’elles ont rencontré en chemin qui les ont saluez et parlé parfois à eux. Force gens de bien les rencontrent allant et venant» (Lancre, a, p. ). L’insistita presenza di particolari risponde a un’esigenza ISA DARDANO BASSO necessaria per dare al sabba una parvenza di realtà, cfr. Clark (, p. ). Al tempo stesso il sabba è il luogo dell’illusione e del disincanto: «Les Sorciers faisant leur Sabbat en Allemagne, furent apperceus de quelqu’un, qui s’en voulant approcher, trouva que tout estoit disparu, et qu’il ne restoit autre chose que des plumes volant en l’air, et d’autres dont toute la terre estoit couverte. Voilà les belles visions de legereté et d’inconstance, que le diable fait voir à ceux qui se veulent tant soy peu approcher de luy, c’est la jonchée du sabbat, on n’y marche que sur la plume, parce qu’il les tient toujours sur le poinct de les transporter en l’air, et sur la terre les faire sauter, trepigner, et voler comme une plume» (Lancre, a, p. ). Il sabba si dissolve al canto del gallo (ivi, pp. , -, ). . «Ainsi le juge devient à son tour personnage de l’univers satanique, prisonnier des illusions, pris dans le tourbillon de l’inconstance, du désir et des métamorphoses» (Jacques-Chaquin, , p. ). La studiosa osserva questa partecipazione fantasmatica del commissario al rituale diabolico, considerando la sostituzione dell’“io” che sta narrando con un plurale “noi”: il giudice è ora associato alle streghe. . Durante il sabba, simulacri immobili rappresentano non soltanto la strega assente perché imprigionata, ma anche gli sventurati che dovranno essere vittime dei malefici (Lancre, a, p. ). La presenza di questi manichini è segnalata anche da Boguet (): «J’ayme donc mieux dire que les sorciers assistent quelquefois au sabbat, et d’autres non, et que lorsqu’ils y assistent, ils y vont en corps et en ame et que Satan suppose un fantosme en leur place, qui a leur ressemblance, si bien que l’homme embrasse le plus souvent un simulachre au lieu de sa femme, ny plus ny moins les poetes feignent qu’Ixion embrassa une nuée au lieu de Junon» (ivi, p. ). Tali simulacri sono una prova che la strega partecipa al sabba in corpo e in spirito. Satana ha posto immagini fallaci nel luogo dove la miserabile si trova imprigionata per ingannare i giudici (cfr. Lancre, a, pp. -, - e infra, p. , nota ) oppure nel luogo dove si svolge il sabba, al fine di ingannare i partecipanti. Quanto alla metamorfosi delle streghe in animali, Lancre è convinto che la trasformazione di un essere umano in animale non possa aver luogo effettivamente, si tratta di un astuto inganno del demonio (ivi, pp. -). Dello stesso avviso sono Bodin (, II, , pp. v-v), Del Rio (, II, , pp. -) e Boguet (, pp. -). Sul demonio e sui suoi «sinistres effets» cfr. Céard (, p. ). . Il suo intento sarebbe quello di proporre al lettore una trascrizione degli atti del processo: «Ainsi je croy qu’il sera mieux à propos que je me contente de faire voir au public les simples confessions des Sorciers et les depositions des tesmoins qui vont tous les jours au Sabbat […]. C’est pourquoy je suis resolu de me contenter du simple recit des depositions des tesmoins et confessions des accusez, lesquelles ont tant d’estrangeté en soy, qu’elles ne lairront pas de contenter le Lecteur que je les laisse en leur naïfveté» (Lancre, a, Advertissemens, pp. -). . A proposito dell’influenza che il giudice, sempre presente, esercita sul discorso della strega: Lheréthé (, pp. -); Jacques-Chaquin (, pp. -). . Sawicka () segnala l’interesse dell’incisore per il mondo della magia e della stregoneria; si pensi alla ripetuta presenza del mago Ermogene nel ciclo di immagini dedicato alla vita di san Giacomo Maggiore: su diciassette incisioni che compongono tale ciclo, sette sono dedicate al mago e al suo corteo di demoni (ivi, pp. -). Oltre a ritratti e rappresentazioni di eventi contemporanei, quali il supplizio di Ravaillac o di Concini, e a visioni topografiche di città, Jan Ziarnko si dedicò anche alla preparazione di tavole destinate a illustrare scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. . Cfr. Lancre, , pp. -. Lancre segue fedelmente la trattazione di Boissard e osserva le immagini che accompagnano il testo: «Pour l’Erithreae on la peint avec un Jesus portant sa croix» (Lancre, , pp. -, a p. ; Boissard, , pp. - [l’immagine è a p. ]); «On peint la Sybille Cumée levant la main» (Lancre, , pp. -, a p. ; Boissard, , pp. - [l’immagine è a p. ]); «Il y a une autre Sybille qu’on appelloit Cumane […]. Elle est peinte en Chrestienne» (Lancre, pp. -, a p. ; Boissard, , pp. - [l’immagine è a p. ]); «On croyoit que la cinquiesme qui est la Persique fust fille de Noé […]. Elle est peinte avec des anges» (Lancre, , p. ; Boissard, , pp. - [l’immagine è a p. ]); «La Lybique est peinte avec un Ecce homo» (Lancre, pp. -, a p. ; Boissard, , pp. - [l’immagine è a p. ]); «Quant à l’Helespontiaque, elle est peinte […]» (Lancre, , p. ; Boissard, , pp. -, [l’immagine è a p. ]); «Quant à la Phrygienne elle est aussi peinte avec un Jesus Christ qui luy montre le Ciel» (cfr. Lancre, pp. -, a p. e Boissard, , pp. - [l’immagine è a p. ]); «L’Aegyptienne est peinte avec une croix» (Lancre, , p. ; Boissard, , pp. - [l’immagine è a p. ]). Il corsivo è mio. PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE . «La textualisation et allégorisation croissantes de l’image dont les mécanismes sont régis par une rhétorique de mieux en mieux codifiée, conduit en effet à lui retirer une grande partie de son pouvoir spirituel et symbolique, pour la réduire souvent à une simple répétition didactique et mnémotechnique du texte» (Dekoninck, , p. ); cfr. Fabre () e Fumaroli (, in particolare pp. -). . Cfr. Lestringant (, p. ). Il P. Richeome (-), professore di letteratura greca al Collegio dei gesuiti di Bordeaux dal , anno in cui il Collegio fu fondato; fu poi nominato padre provinciale per l’Aquitania; nel si trasferì a Roma, con l’incarico di primo assistente del padre generale della Congregazione. Tra le sue opere: Richeome (, ). In quest’ultimo trattato il P. Richeome ricorda un esperimento, l’osservazione di un particolare tipo di formica, il myrméléon o formica-leone, al quale assistette «quelquesfois avec plaisir à Loubens, maison champestre de Monsieur de Lancre, Conseiller et noble membre du noble Parlement de Bordeaux» (Richeome, , pp. -). . A proposito dell’immagine come scrittura ideale, ancestrale cfr. Brunon (, p. ). . Sull’interesse di Lancre per le teorie neoplatoniche cfr. Dardano Basso (, pp. -, ). A proposito di cabinets di meraviglie, il nostro ricorda di aver visitato, a Napoli, quelli di Ferrante Imperato e di Giovanni Battista della Porta e, a Bologna, quello di Ulisse Aldrovandi (Dardano Basso, , pp. -), ma stranamente tace sulla collezione rudolfina, all’epoca conservata a Praga, e su quella di Ferdinando del Tirolo, conservata nel castello di Ambras, a Innsbruck. Si tratta di due località nelle quali il nostro soggiornò durante i suoi viaggi. . I demoni, presenti nella filosofia platonica, furono assimilati a Satana dai Padri della Chiesa; tale sincretismo si diffuse facilmente nella trattatistica religiosa e filosofica. Sulla demonologia in ambiente neoplatonico cfr. Walker (), Yates (), Zambelli (). . Come è stato osservato, la composizione sincronica di avvenimenti che si svolgono in momenti diversi era piuttosto frequente nelle raffigurazioni di quegli anni: Sawicka (, p. ). . Ritroviamo la stessa combinazione in un’incisione di Crispin de Passe, tratta da Martin de Vos, Saturne, patron des sorciers, dove la scena appare a sinistra, nella parte bassa di una composizione articolata in momenti diversi (cfr. Préaud, éd., , pp. -). La rappresentazione proposta de Jan Ziarnko può essere posta in relazione con La cuisine des sorcières, un’incisione di Jacques de Gheyn II, stampata da Nicolas Leclercq, dove la scena figura in primo piano (ivi, pp. , ). . Proponiamo una lettura della tavola raggruppando le scene e seguendo il percorso suggerito dalle lettere e dalle didascalie che le accompagnano: in alto a destra è rappresentato l’omaggio A.» «B B.» «C C.»), segue, in basso, sempre a destra, il banchetto («D D.» «E E.»). della strega a Satana («A La danza delle streghe occupa, a destra, la parte mediana tra i due gruppi già segnalati; altre due F.» «G G.» «H H.»). In primo piano, in posizione centrale, scene sono situate a sinistra nella parte alta («F K.»). Nelle sono rappresentate streghe intente a preparare i veleni e il viaggio verso il sabba («II.» «K due scene in basso a sinistra sono raffigurati coloro che assistono, ma non partecipano, alla cerimoL.» «M M.»). nia sacrilega («L . Cfr. Del Rio (, II, : Des sabbats et assemblées nocturnes des sorciers, et si leur transport de lieux en autre est veritable et reel, pp. -). Il trattato di Del Rio è stato redatto in latino e fu pubblicato nel ; nel corso del lavoro utilizzo la traduzione francese di André Du Chesne, che apparve nel . Anche in Boguet figura una descrizione del sabba: De ce qui se fait au sabbat, et mesme de l’offertoire des chandelles, du baiser, des danses, de l’accouplement du demon avec les sorcieres, des festins, du conte que rendent les sorciers à Satan, du battement d’eau pour la gresle, de la messe qu’on y celebre, de l’eau beniste qu’on y fait, et comme Satan se consomme en feu et reduit en cendres (cfr. Boguet, , pp. -). Nelle descrizioni offerte dai due demonologhi la successione delle diverse fasi segue uno schema piuttosto uniforme, che differisce solamente per alcuni dettagli. Anche Bodin () descrive le malefatte di streghe e stregoni, ma non le inserisce in un contesto sociale, in cerimonie collettive. Sulla nozione di sabba rinvio a Ginzburg (). . Il demonio predilige i luoghi «solitaires, sombres et opaques» (Lancre, a, p. ; cfr. inoltre ivi, pp. , , , e ), ma non disdegna di organizzare festini ovunque: «és Eglises et és places des villes, paroisses, maisons et autres lieux parce que à mon advis», scrive Lancre, «les premiers lieux qui furent descouverts, où les dictes assemblées se faisoyent, furent és landes, pour la commodité du lieu. Et d’autant qu’on y voit le plus de ces boucs, chevres et autres animaux semblables […]. Il cherche aussi parfois outre les Landes de vieilles mazures et ruines de vieux chasteaux, assiz sur les coupeaux des montagnes. Parfois d’autres lieux solitaires, où pour toutes mai- ISA DARDANO BASSO sons, il n’y a que les maisons des morts, qui sont les Cimetieres, et encore les plus escartez, comme pres des Eglises ou chappelles seules, ou plantées au milieu d’une Lande ou desert, ou sur une haute coste de la mer, comme la chapelle des Portugais à Saint Jean de Luz, appellée de saincte Barbe, si haut montée qu’elle sert d’échauguete, ou de Phare pour les vaisseaux qui s’en approchent, ou sur une haute montagne, comme la Rhune en Labourt, et le Puy de Dome en Pengort, et autres lieux semblables» (ivi, pp. -). I grandi sabba avevavo luogo quattro volte l’anno e si svolgevano sulla costa, a Hendaye, dove si riunivano fino a . persone (ivi, p. ). . È assente un’atmosfera notturna. Del resto Lancre precisa: «Quant à l’heure, il [il demonio] choisit et prend son temps lors que les plus noirs rideaux de la nuit sont tirez. C’est en la plus obscure de toutes les heures, qui est à l’heure de minuict, lorsqu’on est aux plus profondes tenebres, comme presque chacun est en son premier sommeil, et aussi à midy, qui sont les heures esquelles les Demons terrestres ont le plus de pouvoir» (Lancre, a, p. ). Accanto al mondo notturno e onirico egli vede la possibilità di realizzare un sabba anche nella piena luce del mezzogiorno, nel momento dell’accidia, come si riteneva da Origene in poi: «C’est parce qu’à midy ou à minuict, la nature tient les hommes plus oppressez de vapeurs, et le monde se trouve plus paresseux, oisif et opprimé de vin, viande, et de sommeil qu’en tout autre temps, qui faict que le Diable vague plus en ces heures, esquelles, il sçait qu’il aura plustost audience qu’en tout le reste du jour et de la nuict» (ibid.). . Sulle diverse forme assunte dal demonio per manifestarsi agli umani, cfr. Lancre (a, pp. -, -). Sarà opportuno sottolineare che, se in Lancre (a) il demonio è una presenza concreta, nei trattati successivi, Lancre (, ), diviene un’astratta entità maligna che vuole la rovina del genere umano. Non è più descritto, né rappresentato, è una malefica forza disincarnata. . Osservava Castelli (, p. ): «Questa bifaccialità o trifaccialità non è niente altro che un modo di rappresentare ciò che non ha la possibilità di esprimere qualche cosa di consistente, poiché è soltanto l’apparire di una faccia, cioè è soltanto la facciata di una faccia». . Lancre (a, p. ). Tutte le streghe concordano su questa preferenza del demonio; una di questa sventurate «disait que le Diable caressoit fort les belles femmes et ne faisoit pas grand compte des vieilles» (ivi, p. ). Tuttavia nell’orgia satanica il demonio non disdegnava l’accoppiamento con orride streghe dai corpi cadenti. Le modalità degli amplessi erano molteplici (ivi, p. ). . Cfr. ad esempio: «Bien souvent il luy faisoit baiser son derriere, puis son nombril, puis son membre viril, puis son derriere» (Lancre, a, p. ). Su tale pratica demoniaca si sofferma ripetutamente Rabelais nella sua evocazione festosa e carnevalesca del demonio. . Come Lancre, anche Montaigne e Florimond de Raemond appartenevano a questa classe sociale. Tali famiglie erano unite tra loro da legami di parentela. Nel Pierre de Lancre sposò Jehanne de Mons, nipote dell’autore degli Essais, che figura tra i firmatari del contratto di nozze (cfr. Communay, , p. ); Catherine de Rosteguy de Lancre, sorella del nostro, sposò Florimond de Raemond, del quale Lancre fu esecutore testamentario (ivi, pp. , ). Su questo erudito, autore di trattati in difesa dell’ortodossia cattolica, cfr. Tamizey de Larroque () e Darricau (). Nel Pierre de Lancre e sua moglie fecero una donazione di . scudi alle Gesuitine di Bordeaux per la costruzione di un convento e di una chiesa in rue du Hâ. L’ordine era stato fondato da Jeanne de Lestonnac, parente acquisita del nostro, perché figlia di una sorella di Montaigne (cfr. Communay, , pp. -). Sull’evoluzione delle classi sociali a Bordeaux nel secolo XVI cfr. Bernard (). . Sul banchetto cfr. Lancre (a, III, : Du festin du sabbat, et quelles bonnes viandes on y mange, pp. -). Anche Bodin sottolinea che le pietanze sono insipide «car les esprits immondes ont en horreur la purité du sel et de l’eau» (Bodin, , III, , p. r). La mancanza di sale è segnalata anche da Del Rio (, II, , p. ) e da Boguet (, pp. -). . La carne umana è il cibo prediletto dalla strega. Scriveva Bodin (, II, , p. v): «Quant à manger de la chair humaine, celà est très certain et de toute antiquité les sorcières en estoient si friandes qu’il estoit quasi impossible de garder les corps morts, ny les enfermer si bien qu’elles n’y entrassent pour les ronger jusques aux os». A proposito di Saturno-Kronos-Moloch cfr. Dictionnaire des antiquités grecques et latines, s.v. Saturnales. Sulla presenza di Saturno nell’iconografia del sabba: Préaud (, pp. -, -) e Zika (, pp. -). . Nella presentazione del banchetto proposta da Lancre si distinguono personaggi che partecipano e personaggi che assistono. Altri demonologhi si soffermano su un particolare assente nella trattazione del nostro: la disposizione dei posti dei convitati. Una società rigidamente gerarchizzata, come quella della fine del Cinquecento, era particolarmente sensibile a questioni di eti- PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE chetta. Scrive Del Rio (, II, , p. ): «Ordinairement il y a diverses tables, trois ou quatre, chargées quelquefois de morceaux friands et delicats et quelquefois insipides et grossiers, selon les dignitez ou moyens des personnes». Anche Boguet (, p. ) osserva che sulla tavola figurano cibi diversi «selon les lieux et qualitez des personnes». . Tuttavia nel Livre des Princes, stigmatizzando l’adulazione che alberga nel mondo della corte, Lancre condanna la danza come strumento di seduzione: «Et il n’y a fille si reglée dansant la sarabande, et autre sorte de dances semblables, laquelle en quelque façon n’eschappe et ne sorte du rond de la modestie et plus elle en sort, et plus elle paroist excellente. Et le débordement en est tel, qu’à Venise et en plusieurs autres lieux, on ne faict difficulté de faire dancer des filles de quinze ans toutes nuës. Ayant aprins de cette grande Dame de l’Isle d’Hayty, appelée Anacharna, laquelle pour acharner les jeunes hommes, fit une dance publique de trois cens filles toutes nuës, belles par excellence et en aage d’estre mariées» (Lancre, , p. ). . Un intero discorso è dedicato alla danza in Lancre (a, III, : De la dance des sorciers au sabbat, pp. -). Accanto a danze guerriere come la pirrica, tramandata dall’antichità o la moresca, danza di chiara derivazione arabo-spagnola in cui si mimava un combattimento tra cristiani e musulmani, Lancre evoca danze di corteggiamento amoroso, come il canario, la gagliarda e la bergamasca «la seule, de toutes les dances, venue d’Italie» (ivi, p. ) e infine danze che sono pantomime realistiche di carattere sessuale, come la sarabanda, la volta e la ciaccona. Ricorda poi danze acrobatiche, come la danza delle spade e la danza saltata e altre curiose contorsioni da equilibristi quali «le voler avec des ailes postiches» e «les forces d’Hercule sur la femme renversée sans toucher du dos à terre». Come osserva Sachs (, p. ), «magia, ginnastica, mimica, tutti gli elementi essenziali si ritrovano qui, l’uno accanto all’altro». Ringrazio la collega Maria Carella per i preziosi suggerimenti che mi ha fornito a proposito della danza. . Lancre (a, p. ); cfr. Dardano Basso (, p. , nota ). Il nostro incontrò di nuovo a Firenze nel il principe mediceo: cfr. Lancre (, pp. -). Pietro dei Medici (-), figlio di Cosimo I, granduca di Toscana e di Eleonora di Toledo, era imparentato con la reggente Caterina dei Medici. Partecipò, nell’armata spagnola, alla guerra nelle Fiandre. Nel passo citato Lancre ci ha lasciato una testimonianza interessante sul modo di danzare la volta. La sua descrizione di questa antica danza concorda con quella offerta da Sachs (, p. ). . Lancre propone una tipologia tripartita delle diverse danze del sabba: «Au reste on y dance fort peu souvent un à un, c’est à dire un homme seul avec une femme ou fille, comme nous faisons en nos gaillardes. Ains elles nous ont dit et asseuré, qu’on n’y dançoit que trois sortes de bransles, communement se tournant les espaules l’un l’autre, et le dos d’un chacun visant dans le rond de la dance, et le visage en dehors. La premiere c’est à la Bohemienne, car aussi les Bohemes coureurs sont à demy Diables. Je dy ces longs poils sans patrie, qui ne sont ny Aegyptiens, ny du Royaume de Boheme, ains ils naissent par tout en chemin faisant et passant païs, et dans les champs, et soubs les arbres, et font des dances et bastelages à demy comme au sabbat. Aussi sontils frequens au païs de Labourt, pour l’aisance du passage de Navarre et de l’Espagne. La seconde c’est à sauts, comme noz artisans font és villes et villages, par les rues et par les champs, et ce sont en rond. Et la troisiesme est aussi le dos tourné, mais se tenant tous en long, et sans se deprendre des mains, ils s’approchent de si prés qu’ils se touchent, et se rencontrent dos à dos, un homme avec une femme, et à certaine cadance ils se choquent et frappent impudemment cul contre cul. Mais aussi il nous fut dit, que le Diable bizarre, ne les faisoit pas tous mettre rangément le dos tourné vers la couronne de la dance, comme communement dict tout le monde. Ains l’un ayant le dos tourné, et l’autre non, et ainsi tout à suite jusqu’à la fin de la dance. De quoy aucuns se sont essayés de vouloir rendre la raison, et ont dit que le Diable les dispose ainsi la face tournée, hors le rondeau, ou parfois l’un tourne et l’autre non, affin que ceux qui dancent ne se voyent pas en face, et qu’ils n’ayent loisir de se remarquer aisément l’un l’autre, et par ce moyen ne puissent s’entr’accuser s’ils estoyent prins par justice: raison notoirement faulse» (Lancre, a, p. ). Sull’avversione di Lancre nei riguardi degli zingari cfr. Lancre (, pp. -). Il nostro rifiuta l’Altro, il diverso, che può manifestarsi con i tratti della strega, del grande personaggio dell’antichità, dello straniero: cfr. Dardano Basso (). . Lancre (a, p. ). Sul saltimbanco, «bouffon de Satan», cfr. Baltrušaitis (, pp. -). Lancre ricorda uno straordinario acrobata, incontrato a Firenze nel , che gli confessò di essere divenuto tale, improvvisamente, dopo aver rivolto una preghiera alla Madonna. Invece il nostro ISA DARDANO BASSO ritiene che ciò sia avvenuto perché quella persona aveva stretto un patto con il demonio: cfr. Lancre (a, pp. -). . Lancre (a, p. ). La musica accompagna il sabba in tutto il suo svolgimento: «La musique y est non seulement lors qu’on dict cette Messe, mais encore tousjours tant que le dict sabbat dure. Et nous dict-on qu’il s’y entend un monde d’instrumens accompagnez de quelques clochettes si melodieuses, qu’on n’oüit jamais une si douce harmonie» (ivi, pp. -). Tuttavia queste piacevoli musiche «ne chatoüillent que l’oreille, et ne touchent rien au coeur, consistant plus en bruit qui estourdit et estonne, qu’en harmonie qui plaise et qui resjouisse» (ivi, p. ). Anche Del Rio (, II, , p. ) osserva che: «A ces esbats ne manquent encor aucune fois les hautbois et menestriers, si quelquefois elles ne se contentent de chanter à la voix». Boguet riprende e amplifica l’immagine di Del Rio: «[…] les hautbois ne manquent pas à ces esbats. Car il y en a qui sont commis à faire le devoir de menestrier. Satan y joüe mesme de la flutte le plus souvent, et à d’autres fois les sorciers se contentent de chanter à la voix. Mais ils disent leurs chansons pesle mesle, et avec une confusion telle qu’ils ne s’entendent pas les uns les autres» (Boguet, , p. ). . Dotato di una notevole cultura, Trichet fu autore di versi e coltivò interessi scientifici. La stregoneria lo appassionava (cfr. Trichet, ) ma era anche affascinato dalla magia bianca. Collezionò oggetti rari e curiosi: fossili di animali, minerali, specchi e lenti e soprattutto strumenti musicali, nonché quadri e libri. La sua biblioteca, in cui testi scientifici si mescolavano con testi letterari, comprendeva . volumi (cfr. Synopsis Variarum tam Naturalium quam artificialium, quae in Musaeo Petri Tricheti Burdigalae reperiuntur [s.n., s.l.] ). Quanto alla sua produzione poetica cfr. Trichet (); per i versi dedicati a François de Sourdis, a Jean d’Espagnet e a Lancre cfr. ivi (pp. , -, ). Su tale autore cfr. Dezeimeris (). . Cfr. Lancre (a, II, : Du transport des sorciers au sabbat, pp. -). Le confessioni delle streghe lo hanno convinto della realtà del trasporto. Il concetto è ripetuto a più riprese, del resto: «Adjoustons-y», scrive Lancre, «que l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine, qui ne peut errer, les punit de mort. Or elle erreroit grandement d’en user si severement s’ils n’estoient sorciers et criminels que par songe. Il faut donc necessairement inferer que quiconque croit que les transports sont seulement prestiges, songes et illusions, peche contre l’Eglise, laquelle ne punit des crimes incertains, occultes et non manifestes, et ne punit comme Heretiques que ceux qui le sont veritablement et non par songe et illusion» (ivi, p. ). Si insiste sulla realtà del trasporto anche in Lancre (, pp. -). Non è la forza dell’immaginazione che suggerisce alla strega il suo racconto. A questo proposito il nostro critica quanto Montaigne aveva sostenuto nel capitolo Des boiteux (cfr. Lancre, a, pp. -). Gli stessi appunti vengono ripresi in Lancre (), dove il nostro polemizza ancora con l’autore degli Essais, questa volta a proposito dei noueurs d’aiguillettes (cfr. ivi, pp. -). . Lancre (a, p. ). E ancora: «Ainsi les transports ne se peuvent faire de l’ame sans le corps, ains le Diable transporte les sorciers en ame et en corps, et si bien le corps semble demeurer à nostre veuë, c’est un simulachre du corps que le Diable nous faict voir. Qui faict qu’on a tant de peine à les esveiller, parce que ce n’est pas le vray corps» (ivi, p. ). Cfr. supra, p. , nota . Anche Del Rio e Boguet sono convinti che il trasporto sia un fatto reale: cfr. Del Rio (, II, , pp. -), Boguet (, pp. -). . Lancre (a, Epistre, p. ). Le streghe hanno rivelato al commissario di aver visto partecipare al sabba, oltre ai preti stregoni, «autres gens de qualité de toutes sortes; tant de chefs de famille et tant de maistresses des maisons principales dudict païs, tant de gens voilez qu’elles presupposent grans, parce qu’ils se cachent et veulent estre incognus, qu’elles croyent et prennent à très grand honneur et à tiltre de bonne fortune d’y estre receuës» (ivi, p. ). . Sawicka () osserva che nell’incisione di Ziarnko «Certains détails attirent l’attention: les modes des costumes féminins de l’époque: élégants, dans la scène de gauche, bourgeois et populaiL.» che contrappone alle res, dans le festin à droite» (ivi, p. ). La studiosa si riferisce alla scena «L D.», «E E.», «F F.» e «II.». scene «D . Nel primo trattato (Lancre, ), apparso anonimo, figurano le lettere iniziali del nome dell’autore: P.D.R.S.D.L.S.D.L., vale a dire Pierre de Rostéguy, sieur de Lancre, sieur de Loubens. Lancre aveva acquistato nel il possedimento di Loubens, vicino al villaggio di Sainte-Croix-duMont (cfr. Communay, , p. ; Dusseau, , p. ). Sull’ascesa sociale della sua famiglia cfr. Communay (, pp. -), Goyheneche (, pp. -). Il nome Rostéguy, Arrosteguy, Harrosteguy era piuttosto diffuso nel Béarn e nella Bassa Navarra. PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE . A più riprese nel trattato Lancre sottolinea di non conoscere la lingua basca. Un intero capitolo (cfr. Lancre, a, VI, , pp. -) è dedicato a tale lingua che gli pose non pochi problemi durante il processo. Il basco è, a suo avviso, difficilmente traducibile, a ciò si aggiunga la difficoltà di reperire interpreti (ivi, p. ). Ma Lancre non conosceva veramente la lingua basca? Nel contratto per la fondazione della chiesa donata all’Ordine delle Gesuitine della rue du Hâ, il nostro esprimeva il desiderio di esservi sepolto (Communay, , p. ). Nel , quando morì nel castello di Loubens, fu sepolto, secondo una recente biografia, nella cappella della sua dimora (Dusseau, , pp. -). Communay () segnalava invece che fu sepolto nella chiesa di Sainte-Croix-du-Mont, davanti all’altare maggiore e che «la pierre tumulaire qui recouvrait son tombeau portait une inscription assez longue, écrite en langue étrangère et peu connue, de sorte que les antiquaires qui ont examiné ces caractères n’ont pu en donner l’explication» (ivi, p. ). Perché non ipotizzare che possa trattarsi di un’epigrafe in lingua basca, per una sorta di tardivo ritorno alle origini? . Cfr. Lancre (a, p. ). Anche nel Livre des Princes Lancre è molto critico a proposito del “furore di nobiltà” che si era impadronito dei suoi contemporanei (Lancre, , pp. -). Sul nome della sua famiglia, per il quale egli utilizza due diverse grafie “Lancre” e “L’ancre” e sulla simbologia dell’ancora, presente nel suo stemma: Lancre (, pp. r-v). Sullo statuto particolare della nobiltà basca cfr. Lafourcade (, pp. -). . Communay (, pp. -). Tuttavia Dusseau () osserva che il nome de Rostéguy viene piano piano messo da parte (ivi, pp. -); segnala infatti che nella Chronique de Bordeaux, Étienne de Cruseau si riferisce al nostro con il nome ora di «de Lancre» ora di «Rostéguy l’aîné» per distinguerlo dal fratello minore, Étienne, anche lui magistrato al Parlamento di Bordeaux, designato invece come «Rostéguy jeune» o «de Tastes» (ivi, p. ). Il titolo di “sieur de Tastes” sarà poi ereditato, nel alla morte del fratello, dallo stesso Pierre de Lancre (cfr. Communay, , pp. -). . Lancre (a, p. ). Ma Lancre non sta ora descrivendo la sua posizione sociale? . Inviata nel settembre del , la commissione, della quale facevano parte Étienne de Cruseau, Joseph de Tarneau e Desaigues “procureur general au Parlement de Bordeaux”, operò nella regione dal settembre al dicembre del . Alla fine dei lavori rimise in libertà cinque dei diciassette accusati e trasferì gli altri dodici a Bordeaux. Le cause di tale insolita procedura ci sfuggono: si trattò di ingerenze di potenti clan familiari o piuttosto di un versamento di denaro che convinse i giudici a mettere in libertà i cinque accusati? Come osserva Villeneuve (): «Laconique et peu explicite, de Cruzeau se contente de noter dans ses Mémoires qu’il s’était passé “plusieurs particularités sans honneur et sans plaisir et profit, le tout par l’indiscretion, Dieu sçait de qui”. Ce terme d’indiscrétion correspond-il à une multiplication de dénonciations anonymes lors de la venue de la commission? Sa présence en tout cas n’avait aucunement calmé les esprits» (ivi, p. ); cfr. anche Cruseau (-, vol. II, pp. -). Sulle rivalità tra i ricchi e nobili possidenti della regione cfr. Goyhenetche (, pp. -). . Cfr. supra, p. , nota . Anche in questo caso il decreto reale fu registrato con ritardo, il giugno , ciò perché i magistrati irritati consideravano tale nomina un’ingerenza del potere centrale in affari che avrebbero dovuto riguardare solamente il parlamento di Bordeaux. Il dello stesso mese i due commissari partirono per il Labourd. I lavori della commissione si conclusero bruscamente alcuni mesi dopo, per la tardiva e decisa opposizione di Bertrand d’Etchauz, vescovo di Bayonne, in conflitto con il nostro a proposito delle condanne di alcuni preti stregoni (cfr. Hee, , pp. -). Sullo svolgimento dei lavori della commissione cfr. Goyheneche (, pp. -), Villeneuve (, pp. -), Bernou (, pp. -), Dusseau (, pp. -). . Nel trattato Lancre tace sulla Demonomanie di Bodin, autore peraltro a lui noto (cfr. supra, p. , nota ); quanto a Le Loyer è ricordato a proposito di simpatie e antipatie nel mondo della natura (cfr. Lancre, , p. r; Le Loyer, , p. ). Un accenno agli inganni del demonio appare in un’altra parte del Tableau, quando, trattando della follia d’amore, il nostro si sofferma a narrare la tragica storia di Machates e Phlinion, che altri non era se non il demonio che aveva preso le sembianze di una fanciulla morta (cfr. Lancre, , pp. v-r; Le Loyer, , pp. -); Lancre trae dal Discours et histoires des spectres anche altre storie riguardanti la follia amorosa: cfr. Lancre, (, p. v) e Le Loyer (, p. ). Come in Lancre (), anche nel più tardo Livre des Princes (Lancre, ), non c’è alcun accenno al processo. . «Messieurs de la Grand-Chambre me faisoient appeller quelquefois, et encore messieurs de la Tournelle plus souvent, pour s’esclaircir avec moy de quelque point de sorcelerie, duquel ISA DARDANO BASSO nous aurions veu quelque preuve ou experience en nos procedures. Le Septembre , ils m’appellerent pour voir si je recognoistrois la marque dans l’oeil à une jeune fille de dix-sept ans. Je la recognus dés l’entrée de la Chambre, et dy qu’elle l’avoit dans l’oeil gauche, lequel estoit aucunement louche et egaré et plus hagard que l’autre. On regarda au dedans, on y trouva comme quelque petit nuage qui sembloit une patte de crapaud, et la fille confessa que sa mere l’avoit menée au sabbat» (Lancre a, pp. -). . È quanto suppone Dusseau (, pp. -). È possibile pensare a un intervento del guardasigilli, se si osserva quanto Lancre scrive nell’epistola dedicatoria: «Vous aurez donc agreable mon labeur, et puisque nous avons acquis la principale cognoissance des sorciers, par le moyen d’une commission qu’il vous pleut nous donner […]» (Lancre, a, p. ). Il nostro aveva incontrato Antoine Séguier, marchese di Villiers (-), ambasciatore francese presso la Repubblica Veneta, nel quando, nel giorno dell’Ascensione, assistette alla cerimonia dello sposalizio di Venezia con il mare. Tra gli ospiti illustri presenti alla cerimonia il nostro ricorda Nicolas Bruslart de Sillery (-) e Charles de Neufville, marchese di Villeroy (-), i due ambasciatori straordinari che tornavano da Firenze, dove erano stati inviati per le trattative del matrimonio di Enrico IV con Maria dei Medici. Cfr. Lancre (, pp. v-r). . Sull’incostanza dei giudici cfr. Lancre (, pp. v-v). Circa la perplessità dei componenti del Parlamento di Bordeaux che avrebbero voluto limitare i poteri di Pierre de Lancre, cfr. Boscheron Des Portes (, vol. I, p. ). Quanto al carattere del nostro ricordo che Étienne de Cruseau, che non aveva alcuna simpatia per Lancre, segnala diversi screzi che il nostro ebbe con altri magistrati, suoi colleghi (Cruseau, -, vol. I, pp. , ). Nel giugno del la speranza del nostro, «qui avoit brigué extremement» per far parte della deputazione che il Parlamento di Bordeaux aveva deciso di inviare a Parigi per rendere omaggio al nuovo re Luigi XIII, andò delusa. Il disappunto per l’esito sfavorevole dei suoi intrighi fu all’origine degli scontri con alcuni colleghi (ivi, vol. II, pp. -). . Su disordini e rivalità di quegli anni in Labourd cfr.: Habasque (); Boase (, pp. -); Goyheneche (, pp. -); Goyhenetche (, pp. -). Le rivalità avevano origine talvolta dal mancato pagamento di decime e pedaggi. A Urrugne, nei territori appartenenti al signore d’Urtubie, furono costruiti alcuni mulini che causarono non poche tensioni: «Le deuxième (Harostegi) [e il nome è certo significativo!] fut construit dans les années - à la condition “que le meunier qui serait établi dans le nouveau moulin ne ramasserait pas les grains dans le voisinage de celui d’Urtubie”» (Goyhenetche, , p. ). Alcuni anni dopo, durante i disordini che precedettero l’arrivo della commissione inviata nel dal Parlamento di Bordeaux, il nobile d’Urtubie tese un’imboscata a Pierre de Harostéguy, prieur di Zubernoa (si tratta forse dello stesso personaggio, citato dal nostro in occasione della testimonianza di una strega, cfr. Lancre, a, p. ). Questi riuscì a salvarsi e accusò il rivale e il suo clan di stregoneria. Il signore d’Urtubie passò allora al contrattacco e, con l’appoggio di altri notabili del luogo, nel si rivolse direttamente a Enrico IV per chiedere una commissione straordinaria. Le vicende della nomina dei commissari sono note. Quando i due magistrati stavano per arrivare in Labourd il signore d’Urtubie «alla à leur rencontre “pour leur préparer besoigne”» (Goyheneche, , p. ). Ricordo che durante il sabba “domestico” che si tenne nel castello del sieur d’Urtubie (cfr. supra, p. , nota ), alcune streghe tentarono di strangolare Lancre, tra queste il nostro segnala la «dame vieille d’Arrosteguy» (cfr. Lancre, a, p. ). . Lancre (a, p. ). Cfr. Laborde (, pp. -). Sugli sconvolgimenti meteorologici che travagliarono i paesi baschi alla fine del XVI secolo cfr. Cocula (, pp. -). . Lancre (a, p. ). Anche in altre parti del trattato si parla, e sempre con le stesse modalità, della presenza dei fanciulli al sabba, cfr. ad esempio «et là on leur baille une gaule blanche, et des crapaux à garder. Puis ayant demeuré quelque année en cet estat, on les met à un degré plus haut, et l’admet-on à la dance» (ivi, p. ). Sulla presenza di fanciulli-testimoni al sabba cfr. Monter (). . Lancre (a, p. ); e, ancora, ivi, pp. , , . . Lancre (a, p. ). La stessa confessione è presente in un’altra parte del Tableau (cfr. ivi, p. ) e tali danze con rospi compaiono spesso nel trattato. Anche Bodin () ricorda che «il y eut une Sorciere de Compieigne, qui fut trouvée saisie de deux crapaux baptisez par un prestre, dont elle usoit en ces Sorceleries, qui sembleroit ridicule, si on ne voyoit tous les jours l’experience de chose semblable» (ivi, II, , p. v). PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE . Lancre (a, p. ). Lancre si riferisce a un passo dalla Lettera prima ai Corinzi (-). Nell’epistola san Paolo ribadisce il concetto dell’inferiorità della donna rispetto all’uomo, ed è per questo motivo che la donna deve portare sulla testa un velo, segno di riconoscimento dell’autorità maritale. Analogamente i fanciulli col capo coperto mostrano la loro sottomissione al demonio. Il richiamo agli angeli rende la frase sibillina. Si tratta forse di angeli buoni, che si riteneva fossero presenti, ma non visibili, alle cerimonie religiose e che avrebbero potuto rimanere offesi dall’atteggiamento meno umile e sottomesso delle donne, se prive di velo. . Lancre (a, Advertissemens, p. ). Lancre sottolinea che il suo linguaggio sarà crudo, ma non didascalico: «Je ne veux donc, soubs pretexte de raconter simplement ce que j’ay veu recherchant les ruses de Satan pour eviter les sinistres effects, enseigner comment il les faict» (ivi, p. ). C’è poi un problema linguistico: il francese non permette quel linguaggio coperto, mascherato che è invece possibile in latino: «A quoy j’appelleray a garand la langue Françoise, l’idiome de laquelle ne peut souffrir tant de desguisement que la langue Latine et autres semblables, ny se tenir si ferme derriere le rideau de l’obscurité». Il latino poi nasconde il messaggio «principalement du costé des femmes, lesquelles neantmoins en sçavent plus que nous ne leur en sçaurions jamais apprendre» (ivi, pp. -). La crudezza del linguaggio è dovuta anche al fatto che le streghe, «quelque impudente et sordide question ou sale interrogatoire qu’on leur fasse», non mostrano alcun disagio. Il prete basco che fungeva da interprete «avait plus de honte de leur faire nos interrogatoires, qu’elles à y respondre» (ivi, p. ). Di diverso avviso è Bodin () che ripetutamente tace, omette e vela il suo messaggio (ivi, pp. v-r, r, v, v, r, r). . Si pensi alla seguente confessione di una giovane strega: «Jeannette d’Abadie, aagée de seize ans, dict: “Qu’elle a veu hommes et femmes se mesler promiscuement au sabbat. Que le Diable leur commandoit de s’accoupler et se joindre, leur baillant à chacun tout ce que la nature abhorre le plus, sçavoir la fille au pere, le fils à la mere, la soeur au frere, la filleule au parrain, la penitente à son confesseur, sans distinction d’aage, de qualité, ni de parentelle, de sorte qu’elle confessoit librement avoir esté cognue une infinité de fois au sabbat, par un cousin germain de sa mere et par une infinité d’autres”» (Lancre, a, pp. -). . Lancre si compiace della descrizione del sabba offerta dal Tasso che, «descrivant l’enchantement que fit Ismenus magicien et sorcier dans la forest de Hierusalem, semble descrire le sabbat tout de mesme que nos sorciers le nous dépeignent» (Lancre, a, p. ). Segue la citazione di alcuni versi della Gerusalemme liberata (XIII, vv. -, -) . Cfr. Lancre (a, VI, : Que le Diable en derision du plus precieux Sacrement de l’Eglise, faict celebrer au Sabbat quelque forme de Messe, pp. -). . Sono le streghe e gli stregoni che tornano da dodici diversi sabba: «Puis ils entrerent en France en si grande foule, et y en trouverent aussi en leurs sabbats en si grand nombre, qu’il estoit impossible de les nombrer, et au sortir de là, comme cette maudite troupe se rompit, l’air en estoit couvert qu’on ne voyoit autre chose» (Lancre, a, p. ). . Una strega confessò al commissario: «Qu’elle a veu les sorcieres partant du sabbat voller par l’air à troupes, et au retour se jacter avec grande joye, qu’elles en venoyent d’exciter la tempeste sur la mer, vers Terre-neuve, et qu’elles avoyent faict le voyage dans deux ou trois heures, estant guidées par le Diable, en personne, en forme de jeune homme de quinze ans» (Lancre, a, p. ). . Scrive Lancre, a proposito di un altro prete-stregone: «Et un autre habitant de Sainct Jean de Luz, aagé de quinze ans, depose avoir ouy dire la Messe six ou sept fois au Sabbat à maistre Jean Souhardibels, au lieu appellé à la Cohandia, et faisoit l’Elevation monstrant une Hostie noire, luy estant eslevé en l’air, les pieds contremont, et la teste renversée en bas devant le Diable, et demeuroit en cette posture pendant l’Elevation, autant de temps qu’on mettroit à dire un Credo. Et le tesmoing se mit luy mesme devant nous en mesme poinct, pour mieux nous en faire la demonstration, (car Satan leur apprend les plus horribles traicts qu’on ne vit jamais) et nous dict encore plus, et chose qu’il ne pouvoit exprimer, que tout le corps du Prestre estoit eslevé en l’air, si bien qu’encores que son corps fut renversé, et eust sa teste en bas, et les pieds contremont, neantmoins faisant cette Elevation, il disoit que le corps et les bras du Prestre à proportion, estoient aussi hauts, que nos Prestres les ont quand ils font la vraye Elevation en l’Eglise de Dieu, parce que le Diable faict paroistre au Sabbat toutes choses renversées, et qui semblent du tout impossibles aux hommes, mais non à luy» (Lancre, a, p. ). ISA DARDANO BASSO Bibliografia BALTRUŠAITIS J. (), Réveils et prodiges. Le gothique fantastique, A. Colin, Paris. BERNARD J. (), Les classes et l’évolution sociale, in R. Boutruche (éd.), Bordeaux de à , Fédération historique du Sud-Ouest, Bordeaux, pp. -. BERNOU J . (), La chasse aux sorcières en pays basque (Pierre de Lancre en ) , La Découvrance éditions, Bouhet (a ed. ). BOASE A. (), Montaigne et la sorcellerie, in “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, , , pp. -. BODIN J. (), Les Six livres de La Republique, J. du Puys, Paris (a ed. ). ID. (), De la Demonomanie des Sorciers, J. du Puys, Paris (a ed. ). BOGUET H. (), Discours execrable des sorciers, J. Asmont, Rouen (rist. Lafitte Reprints, Marseille ). BOISSARD J. J. (), Tractatus posthumus […] de divinatione et magicis praestigiis […], H. Galleri, Oppenheimi (a ed. ). BORDES FR. (), Sorciers et sorcières. Procès de sorcellerie en Gascogne et Pays basque, Privat, Toulouse. BOSCHERON DES PORTES C. B. R. (), Histoire du Parlement de Bordeaux depuis sa création jusqu’à sa suppression (-), Ch. Lefebvre, Bordeaux ( voll.). BRUNON CL .- FR . (), Lieux, Dispositifs, Figures. Les Figures de la Concorde selon Horapollon, in P. Choné (éd.), Le point de vue de l’emblème, Éditions Universitaires de Dijon, Dijon, pp. -. CABANTOUS A. (), La Mémoire du voyageur, in M. Collot (éd.), Les enjeux du paysage, Ousia, Bruxelles, pp. -. CARO BAROJA J. (), Brujería vasca, Txertoa, San Sebastián (a ed. ). CASTELLI E. (), Il demoniaco nell’arte, Electa, Milano-Firenze. CÉARD J. (), La Sorcière, l’Étrangère. Le voyage de Pierre de Lancre en Sorcerie, in M. T. Jones-Davies (éd.), L’Étranger: identité et altérité au temps de la Renaissance, Klincksieck, Paris, pp. -. ID. (), Le Diable singe de Dieu selon les démonologues des XVIe et XVIIe siècles, in Le Diable, Actes du Colloque Cerisy-la-Salle, - juillet , collection “Cahiers de l’Hermétisme”, Dervy, Paris, pp. -. CLARK S. (), Le sabbat comme système symbolique: significations stables et instables , in N. Jacques-Chaquin, M. Préaud (éds.), Le sabbat des sorciers en Europe (XVe-XVIIIe siècles), Actes du Colloque International ENS, Fontenay-Saint Cloud, - novembre , J. Millon, Grenoble, pp. -. CLEMENS J. (), Habitat et sabbat dans l’Aquitaine d’Henri IV, in “Revue de l’Agenais”, juillet-septembre, , pp. -. CLOSSON M. (), L’imaginaire démoniaque en France (-). Genèse de la littérature fantastique, Droz, Genève. COCULA A. M. (), La Guyenne fin de siècle, in P. Hourmat, J. Pontet (éds.), Autour de Bertrand d’Etchauz, évêque de Bayonne (fin XVIe-début XVIIe siècle), Actes du Colloque des et septembre , Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne, pp. -. COMMUNAY A. (), Le conseiller Pierre de Lancre, V. Lamy, Agen. CROUZET D. (), Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion, Seyssel, Champ Vallon ( voll.). CRUSEAU E. DE (-), Chronique de Bordeaux, publiée par la Société des Bibliophiles de Guyenne, Imprimerie G. Gounouilhou, Bordeaux ( voll.). DARDANO BASSO I. (), L’ancora e gli specchi. Lettura del “Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses” di Pierre de Lancre, Bulzoni, Roma. EAD. (), Figure retoriche e manipolazione delle fonti. Ancora sul tema della fortuna in Pierre de Lancre, in Il tema della fortuna nella letteratura italiana e francese del Rinascimento. Studi in memoria di Enzo Giudici, Olschki, Firenze, pp. -. PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE (), Pierre de Lancre, L’Altro e l’incostanza, in V. Pompejano (a cura di), L’ospitalità e le rappresentazioni dell’Altro nell’Europa moderna e contemporanea, Artemide, Roma, pp. -. DARRICAU R. (), La vie et l’oeuvre d’un parlementaire aquitain: Florimond de Raemond, in “Revue française d’histoire du livre”, -, pp. -. DEKONINCK R. (), L’image prise au mot: méditation et rhétorique visuelles jésuites, in Ch. Mazouer (éd.), Recherches des jeunes dix-septiemistes, Actes du Ve Colloque du Centre international de Rencontres sur le XVIIe siècle, Bordeaux, - janvier , G. Narr, Tübingen, pp. -. DELPECH F. (), La marque des sorcières: logique(s) de la stigmatisation diabolique, in N. Jacques-Chaquin, M. Préaud (éds.), Le sabbat des sorciers en Europe (XVe-XVIIIe siècles), Actes du Colloque International ENS, Fontenay-Saint Cloud, - novembre , J. Millon, Grenoble, pp. -. DEL RIO P. M. A. (), Les controverses et recherches magiques […], traduit et abrégé du latin par André du Chesne Tourangeau, J. Petit Pas, Paris. DELUMEAU J. (), La peur en Occident, A. Fayard, Paris. DEMONET M.-L. (), Les marques insensibles, ou les nuages de la certitude, in “Littératures classiques”, , pp. -. DESGRAVES L. (éd.) (), Bordeaux disparu, Exposition de gravures, dessins, documents et objets, présentée du octobre au décembre , Centre régional de documentation pédagogique, Bordeaux. DEZEIMERIS R. (), Pierre Trichet, un bibliophile bordelais, G. Gounouilhou, Bordeaux. DUSSEAU J. (), Le juge et la sorcière, Éditions Sud-Ouest, Bordeaux. FABRE P. A. (), Ignace de Loyola. Le lieu de l’image, J. Vrin, Paris. FREUD S. (), Essais de psychanalyse appliquée , traduit de l’allemand par M. Bonaparte, Gallimard, Paris. FUMAROLI M. (), L’âge de l’éloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Droz, Genève. GAUFRETEAU J. DE (-), Chronique bordelaise, publiée par la Société des Bibliophiles de Guyenne, Ch. Lefebvre, Bordeaux ( voll.). GINZBURG C. (), Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Einaudi, Torino (a ed. ). GOYHENECHE E. (), Le Pays basque. Soule-Labourd-Basse Navarre, Société Nouvelle d’éditions régionales et de diffusion, Pau. GOYHENETCHE M. (), Histoire générale du Pays Basque, II, Évolution politique et institutionnelle du XVIe au XVIIIe siècle, Elkarlanean, Donostia. ID. (), Histoire générale du Pays Basque, III, Évolution économique et sociale du XVIe au XVIIIe siècle, Elkarlanean, Donostia. HABASQUE F. (), Épisodes d’un procès de sorcellerie dans le Labourd au XVIIe siècle ( - ), communication faite au IVe Congrès historique et archéologique du Sud-Ouest le juillet , É. Soulié, Biarritz. HEE A. (), Les rapports ambigus d’un évêque et d’un magistrat face à la sorcellerie dans le Labourd: Bertrand d’Etchauz et Pierre de Lancre, in P. Hourmat, J. Pontet (éds.), Autour de Bertrand d’Etchauz, évêque de Bayonne (fin XVI e-début XVII e siècle), Actes du Colloque des et septembre , Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne, pp. -. HOUDARD S. (), Pierre de Lancre et le diable Protée, in Ead., Les Sciences du diable. Quatre discours sur la sorcellerie, Les Éditions du Cerf, Paris, pp. -. JACQUES-CHAQUIN N. (), La sorcière et le pouvoir. Essai sur les composantes imaginaires et juridiques de la figure de la sorcière, in “Les Cahiers de Fontenay”, -, septembre, pp. -. EAD. (), Introduction à P. de Lancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons, Aubier, Paris, (questa edizione moderna di alcune parti del trattato è stata nuovamente pubblicata nel , Éditions h, Paris). EAD. (), Vies de sorcières, in “Cahiers de Sémiotique textuelle”, , pp. -. EAD. ISA DARDANO BASSO (), La fable sorcière ou le labyrinthe des enchantements, in “Littératures classiques”, , pp. -. JONES-DAVIES, M. T. (éd.) (), Diable, diables et diableries au temps de la Renaissance, J. Touzot, Paris. LABORDE J. P. (), Les “brouches” en Béarn, Gascogne et Pays Basque. Histoire et Folklore, La Découvrance, Bouhet (a ed. ). LAFOURCADE M. (), Le statut juridique de la noblesse basque, in P. Hourmat, J. Pontet (éds.), Autour de Bertrand d’Etchauz, évêque de Bayonne (fin XVIe- début XVIIe siècle), Actes du Colloque des et septembre , Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, Bayonne, pp. -. LANCRE P. DE (), Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses où il est montré qu’en Dieu seul gist la vraye constance […], A. l’Angelier, Paris. ID. (), Tableau de l’inconstance et instabilité de toutes choses […], reveu, corrigé et augmenté, avec un Livre nouveau de l’inconstance de toutes les Nations principales de l’Europe […], veuve A. l’Angelier, Paris. ID. (), Tableau de l’inconstance des mauvais Anges et demons, où il est amplement traicté des sorciers et de la sorcellerie […], J. Berjon, Paris. ID. (a), Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons, où il est amplement traicté des sorciers et de la sorcellerie, reveu corrigé et augmenté de plusieurs nouvelles observations […], N. Buon, Paris. ID. (b), Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons, où il est amplement traicté des sorciers et de la sorcellerie, reveu corrigé et augmenté de plusieurs nouvelles observations […], J. Berjon, Paris. ID. (), Le Livre des Princes […], N. Buon, Paris. ID. (), L’incredulité et mescreance du sortilege plainement convaincue […], N. Buon, Paris. ID. (), Du sortilege où il est traicté, s’il est plus expedient de supprimer et tenir soubs silence les abominations et malefices des sorciers, que de les publier et manifester […] , par Pierre de l’Ancre, Conseiller du Roy en son Conseil d’Estat [s.n., s.l.]. LE LOYER P. (), Discours et histoires des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, demons […], N. Buon, Paris (a ed. ). LESTRINGANT F. (a), Catholiques et cannibales. Le thème du cannibalisme dans le discours protestant au temps des guerres de religion , in J.-Cl. Margolin, R. Sauzet (éds.), Pratiques et discours alimentaires à la Renaissance, Actes du Colloque de Tours de mars , Centre d’études supérieures de la Renaissance, G.-P. Maisonneuve et Larose, Paris, pp. -. ID. (b), Europe et théorie des climats dans la seconde moitié du XVIe siècle, in La conscience européenne au XVe et XVIe siècle, Actes du Colloque international organisé à l’École Normale Supérieure de Jeunes filles, septembre- octobre , ENSJF, Paris, pp. -. ID. (), La promenade au jardin ou la peinture spirituelle du P. Richeome, in J. P. Guillerm (éd.), Récits/tableaux, Presses Universitaires de Lille, Lille, pp. -. LHERÉTHÉ J.-F. (), Le juge et les sorcières: un inquisiteur laïc face à la culture populaire, in Cultura/letteratura popolare/dotta nel Seicento francese (= Quaderni del Seicento francese, n. ), Adriatica-Nizet, Bari-Paris, pp. -. LOMBARDI P. (), Il secolo del diavolo. Esorcismi, magia e lotta sociale in Francia (- ), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma. LÖWENSTEIN M. (), Peindre le pandemonium païen: images du sabbat des sorcières aux PaysBas, in N. Jacques-Chaquin, M. Préaud (éds.), Le sabbat des sorciers en Europe (XVe-XVIIIe siècles), Actes du Colloque International ENS, Fontenay-Saint Cloud, - novembre , J. Millon, Grenoble, pp. -. MANDROU R. (), Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle: une analyse de psychologie historique, Seuil, Paris (a ed. ). MAXWELL J . (), Un magistrat hermétiste: Jean d’Espagnet, président du Parlement de Bordeaux, Gounouilhou, Bordeaux. EAD. PER UNA RAPPRESENTAZIONE DEL SABBA TRA PAROLA E IMMAGINE (), Pierre de Lancre’s “Tableau de l’inconstance des demons”: The Sabbat Sensationalised, in S. Anglo (ed.), The Damned Art. Essays in the Literature of Witchcraft, Routledge-Kegan, London-Boston, pp. -. MERLIN H. (), Représentation du sabbat et représentation du politique au XVIIe siècle: du sabbat au cabinet, in N. Jacques-Chaquin, M. Préaud (éds.), Le sabbat des sorciers en Europe ( XV e-XVIII e siècles) , Actes du Colloque International ENS , Fontenay-Saint Cloud, - novembre , J. Millon, Grenoble, pp. -. MERSENNE M. (), Correspondance, vol. III, -, édité par Mme Tannery et C. de Waard, Éd. du Centre National de la Recherche scientifique, Paris. MICHEL F. (), Le pays basque. Sa population, sa langue, ses moeurs, sa littérature et sa musique, Elkarlanean, Donostia (a ed. ). MICHELET J. (), La sorcière, nouvelle édition critique avec introduction, variantes et examen du manuscrit, publiée par W. Kusters [s.n., s.l.]. MONTAIGNE M. DE (), Oeuvres complètes, Gallimard, Paris. MONTER W. (), Les enfants au sabbat. Bilan provisoire, in N. Jacques-Chaquin, M. Préaud (éds.), Le sabbat des sorciers en Europe (XVe-XVIIIe siècles), Actes du Colloque International ENS, Fontenay-Saint Cloud, - novembre , J. Millon, Grenoble, pp. -. NIDERST A. (éd.) (), Le diable, Nizet, Paris. PALOU J. (), L’anatomie de la sorcière dans la peinture occidentale, “Aesculape”, novembre, pp. -. PRAT P. J. M. (), Recherches historiques et critiques sur la Compagnie de Jésus en France du temps du P. Coton, Briday, Lyon ( voll.). PRÉAUD M. (éd.) (), Les sorcières, exposition présentée du janvier au avril , Bibliothèque Nationale, Paris. RICHEOME L. (), Tableaux sacrez des figures mystiques du très auguste sacrifice et sacrement de l’Eucharistie, L. Sonnius, Paris (a ed. ). ID. (), La peinture spirituelle ou l’art d’aimer et louer Dieu, P. Rigaud, Lyon. SACHS C. (), Storia della danza, trad. it., Il Saggiatore, Milano (a ed. ). SAWICKA ST. M. (), Jan Ziarnko, peintre graveur polonais, et son activité à Paris au premier quart du XVIIe siècle, in “Annuaire historique édité par la Bibliothèque Polonaise de Paris”, , pp. -. TAMIZEY DE LARROQUE PH. (), Essai sur la vie et les oeuvres de Florimond de Raemond, A. Aubry, Paris. TRICHET P. (), De Lygdae veneficae Praestigiis Libri tres […], P. de la Court, Burdigalae. ID. (), Epigrammatum […], A. Castera, Burdigalae. VILLENEUVE R. (), Le Fléau des sorciers. La diablerie basque au XVIIe siècle, Flammarion, Paris. WALKER D. P. (), Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella, The Warburg Institute, London. YATES F. A . (), Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Routledge-Kegan-The University Press, London-Chicago (a ed. ). YVES-PLESSIS (), Essai d’une bibliographie française méthodique raisonnée de la sorcellerie et de la possession démoniaque, Slatkine Reprints, Genève (a ed. ). ZAMBELLI P. (), L’ambigua natura della magia. Filosofi, streghe, riti nel Rinascimento, Marsilio, Venezia. ZIKA CH. (), Les parties du corps, Saturn et le cannibalisme. Les représentations visuelles des assemblées des sorcières au XVIe siècle, in N. Jacques-Chaquin, M. Préaud (éds.), Le sabbat des sorciers en Europe (XVe-XVIIIe siècles), Actes du Colloque International ENS, FontenaySaint Cloud, - novembre , J. Millon, Grenoble, pp. -. MC GOWAN M. M. LA NOSTALGIA DELLA PAROLA ARCAICA* di Rosa Di Paolo La parola persuasiva del poeta recitante e la sua voce in mutamento, simile a fluido materico, insorte dall’esilio e dai deserti del mondo, si ricongiungono al ritmo delle origini dello sciamano, quando, entrambi posseduti dalla loro antica sapienza, il loro respiro scandisce il carattere possente e rasserenante delle forze cosmiche. Il poeta e lo sciamano sono assunti come figure affini espresse nelle loro metamorfosi in sintonia con la natura, attraverso l’esperienza della parola proferita, raggiunta nei loro percorsi di solitudine; entrambi consapevoli della propria individualità e di una forza e di un potere che ne proviene, raccordati con la fase più vicina allo stato originario, in una libertà di creazione di rito e mito, e a tale proposito Romano Mastromattei, nel suo studio sullo sciamanismo, La Terra Reale, afferma che: […] non imbrigliati da un corpus dottrinale, da tradizioni strettamente codificate e da liturgie rigide, rito e mito presentano una continua riplasmazione […] riplasmazione che non ha il fine – conscio o inconscio – di creare nuove forme di religiosità, bensì di esercitare un potere magico pragmatico di intervenire sulla realtà del cosmo, di cui questa terra, la terra reale, fa parte (Mastromattei, , p. ). Nelle società tradizionali, un tempo molto più in comunione con la natura, l’uomo non ha mai accordato alla storia un valore specifico, ma, con il tramite di uomini definiti saggi o iniziati, egli ha operato un superamento della storia del presente totalmente sostituita da una sua ri-fondazione; è, ricordando Mircea Eliade, quel bisogno per le società arcaiche di rinascere periodicamente attraverso l’annullamento del tempo. Una simile rinascita, in un tempo attuale, può scorrere con la stessa necessità ed essere recitata affinché l’ascoltatore possa, a sua volta, essere anch’egli, ma diversamente nella sua individualità, protagonista di tale partecipativo avvenimento. I dialoghi con la natura del poeta e dello sciamano sono idee rimate tra le quali la parola è quell’elegia che sembra provenire da una vastità che avanza deli- * Questo saggio è stato presentato al Convegno internazionale “Tempo con-diviso. Il ritmo nelle arti e nei saperi”, Roma - dicembre , organizzato dal Dipartimento di Letterature Comparate dell’Università Roma Tre, in collaborazione con l’Ambasciata d’Irlanda presso lo Stato Italiano, l’Ambasciata di Svizzera in Italia, l’Assessorato alle Politiche culturali del Comune di Roma e l’Istituto svizzero di Roma. ROSA DI PAOLO beratamente verso di loro e l’ascoltatore, è anche invocata da molteplici forme viventi nell’universo, il quale, come il linguaggio, è forza di richiamo, è prepotenza di spettacolo. Sono dialoghi d’amore praticati in stati di rilassamento, nella ipnotica raccolta di semine trascorse, fatte di sogni, di premonizioni, nella vibrazione di flussi d’aria, delle loro note giuste, quelle predestinate; sono dialoghi intrecciati nel delirante splendore del silenzio che invoca la parola liberatrice essendo, quella, intrisa della tonalità del principio. Ed è qui, in questo svincolarsi della parola proferita, proveniente da un territorio arcadiano che la raison si fa reson, nuovo suono, superando un ostacolo di pensiero forse inevitabilmente prestabilito. Questa ragione vinta varca la soglia della risonanza, del suono rinnovato, elargitore di esperienza dell’abbandono. Cosa ci lascia la ragione nel suo insperato tentativo di tremore e libera frenesia del dire, se non il mistero svelato di una seduzione, spesso in un’esperienza heideggeriana di un nulla, dal quale emerge l’essere in una dolorosa solitudine della nascita? La parola proferita allude all’incanto, già trasceso in essa, di cui ha inevitabilmente subito la presenza di cosa rivelata e che, come inarrestabile colata lavica, andrà a solidificarsi nel verso, sia esso poetico o mitologico, comunque puntuale suono creatore. Tale magia inventa i suoi ritmi e in essa va a immergersi la durata della sonorità e spesso, con maggior vigore, tipico dell’immediatezza, va a incontrare il frammento, che è segno, traccia, bagliore e centralità. L’attimo di compenetrazione tra poesia e musica contiene l’impercettibilità dell’uno che si unisce al molteplice; a tale proposito George Steiner afferma che «la poesia trapassa in musica allorché attinge alla massima intensità del proprio essere, e questo essere può anche manifestarsi in una sola inafferrabile traccia. Il poeta», prosegue Steiner «è architetto del mito, stregone al di sopra della barbarie e pellegrino verso la morte» (Steiner, , p. ). Il verso contiene vertigine, svela l’asse di una verticalità intorno al quale si avvita la coscienza umana e il suo doppio, quella divina; vertigine come dinamismo tra la fascinazione della terra, della lettera e il suo desiderio di percorrere incessantemente il tracciato libero di quel pensiero nato per ricongiungersi al suo istante poetico, nella passione di un segno di meraviglia, pur sempre mutevole nel suo slancio estetico. Il verso è inevitabilmente un avanzamento, soprattutto se ripetizione, nell’assonanza estesa che supera se stessa per prendere forma di misticismo. Nella vertigine danza ripetutamente la parola, punto di incontro di una forza fonetica con il suo stesso nucleo, vaso contenente la sostanza vibrante di una coscienza in trasformazione che si vuole manifestare; ne può derivare, quindi, che la poesia come il dire sciamanico, quando sono liberamente tali, hanno, come sostiene Octavio Paz riferendosi specificatamente alla poesia, «fame di realtà». In tale verticalismo prende forma anche la morte, se la si vuole paragonare a quello stato di oblio del mondo, di incerta identità, di voluttuosa fluttuazione dell’essere. L’inquietudine della parola, in un dinamismo spesso parossistico, si evolve in emergenza mistica, attraverso una disciplina di amore, nella durata di quel tempo sacro durante il quale il poeta e lo sciamano hanno certezza dell’esilio. Solo quando la parola viene sfiorata dalla voce del recitante in una composizione di suoni arcaici, allora si può avvertire l’autenticità di una rinascita che va a estendersi, fino a quell’antico nutrimento sorto da una immensità simile a quella leopardiana che ha trovato in Yves Bonnefoy la magnifica fratellanza. Nella poesia del poeta francese si coglie il ritorno di quelle «presenze piene» custodite in un «Entroterra» LA NOSTALGIA DELLA PAROLA ARCAICA che la morte non può assoggettare alla sua legge poiché la verbalità poetica ha, nel suo peregrinare, subito una metamorfosi, è puro minerale, materia visibile, dato il suo rapporto con il mondo; essa riconduce quelle presenze di cui ha nostalgia. Da quella dimensione che Eliade ha definito «paradiso degli archetipi», si è trasportati in quell’arrière-pays di Bonnefoy, nel poema Thibet di Victor Segalen, e per finire, nella dimensione del Grande Parlare sciamanico, che incontreremo in seguito. Da questi territori poetici emerge quel mysticisme che contiene fatalemente, nella sua nicchia semantica, ma non solo, un sottile scisma provocato da quello stato d’animo pervaso di nebbia offuscante, di valore inafferrabile, di un limbo rivelatore di luce rinnovatrice, l’immediata e accecante visione di una realtà altra. Viene da pensare, a questo punto, che un giorno, lontano nel tempo, passato o futuro, l’aquila poteva far dono del suo sguardo e delle sue ali al poeta e allo sciamano, suoi predestinati osservanti, i quali sapevano imitarne le sue più pure significanze, quelle ascensionali, le più seduttive; sì, l’aquila, che riconoscerà l’antro oscuro dell’uomo divino, perché sia modulato reciprocamente uno stesso respiro cosmico nel bisogno di una rinascita ciclica, in una geometria di inizio assoluto. Il poeta, come lo sciamano, anch’egli antico migratore, trasforma ogni cosa in istante poetico, fino a sentirsi soggiogato dal suono che si accende, nell’influenza estatica della parola nello specifico momento di recupero del suo splendore, quando assonanti corde vocali mettono in libertà il palpitante ritmo delle origini. Di tale riappropriazione sono intrisi i canti mitologici del Grande Parlare o le Belle Parole; il dire primordiale dello sciamano, modulato dal susseguirsi di mutazioni tonali nel corso dei tempi rituali, la sua ondulazione, ne esalta sempre la centralità, il destino di risonanza e maggiormente il dire rispetta un nomadismo ritmico, tanto più accentuato sarà il suo culto, più possente la provocazione spirituale del rapporto vacante sorto tra gli elementi dell’universo e della natura e i loro cantori; il tutto in una leggera dismisura dello spazio, in una evocazione di ricordo quasi smarrito nell’estasi sovrana di un sacred weel nel cui nucleo è convogliato il respiro, ripetuto fino all’affanno dell’estrema voluttà di un’energia cosmica trionfante. Lo sciamano, come il poeta, è architetto del proprio cerchio sacro, nel quale accede dopo il compimento di dovuti rituali e disciplina creativa, su variazioni possibili e, secondo Mastromattei (, p. ): «Nulla può impedirci di avanzare l’ipotesi che ogni singolo sciamano esperisca una sua forma unica e irrepetibile di estasi». Questo dire arcaico persegue una molteplicità di direzioni e da esse le loro figliazioni conosciute come visioni, ornamento del Tutto. Se la circolarità, e pertanto la sinuosità della voce dell’iniziato restituisce all’uomo immerso nella storia, la potenza del linguaggio, allora egli viene rapito, pur non essendo complice, poiché a lui, uomo, è negato il miracolo dell’inizio; gli viene solamente elargita, quale conforto e certezza, la sfera del mondo del mito e della poesia, nella pratica vocale, nel risuono di «parole», suggerisce ancora Yves Bonnefoy, «delle origini, pilastri dell’essere al mondo fondamentale». Sono questi i due poli di forza di quel mitico asse che ridona fremito alla traccia di ogni cosa, suono, colore, atomo – e quindi parola –, imprigionati nella prosa del quotidiano e, se la storia è sofferenza, se riflette negli occhi di tanti esodi il dolore e il sangue di tante guerre, allora il poeta e il suo doppio, lo sciamano – e viceversa – devono a imitazione della natura, fare dono della loro metamorfosi fino a che l’essenza di tale differenza atavica stabilisca l’assoluto nostalgico di una prorompente ornamentazione ritmica che traduca il soffio vitale, inter- ROSA DI PAOLO pretato, per esempio, dall’aria e dalle sue correnti, dal flusso di acque eterne, come quelle nate dal monte Meru, e riversate nel Gange perché gli induisti ne imparino, attraverso i loro stessi riti, il ritmo, la vita, la certezza di un ricongiungimento a un completo esistere. L’incessante desiderio del poeta di “cavalcare” il caos della materia pulsa in una esaltazione che contribuisce sempre a darle la trionfante rinascita alla quale è riconferito il contenuto di una bellezza indistruttibile perché toccata dall’energia del soffio creatore. Nella tradizione sciamanica amerindiana – precisamente presso gli indiani Guaranì tra Paraguay e Venezuela – i cui miti e canti sacri sono stati studiati e raccolti sul campo negli anni Sessanta dall’etnologo Pierre Clastres – prevale, come sottolinea lo stesso autore: Il desiderio nonché la necessità di salvezza, di abbandonare un mondo imperfetto e di mantenere nel segreto la parte sacra del loro essere. Queste nê’ ë pora o Belle Parole risuonano ancora nel cuore della foresta e si confermano depositari assoluti dell’umano (Clastres, , p. , T.d.A.). Gli sciamani sono i veicoli per raggiungere quella che i Guaranì definiscono «la Terra senza Male», dal momento che compiono una “migrazione religiosa”. I Guayaki, tribù nomadi di ceppo Guaranì, vivevano nell’attesa di sentire parlare, tramite gli Uomini, e le Belle Parole, i loro Dei, coloro che sanno “interrogare il divino”; essi sono chiamati dagli indiani i nê’ ë jara, ossia i maestri delle parole. Clastres, nel suo saggio Le Grand Parler, fa notare, tra l’altro, che le Belles Paroles fanno uso costante della metafora, per esempio “scheletro della bruma” indica la pipa di terra dove i saggi o sciamani fumano il loro tabacco, oppure il “fiore dell’arco” per indicare la freccia. È altrettanto interessante quanto l’autore fa notare per ciò che riguarda il lavoro di traduzione compiuto per rendere il flusso di un tale dire e sottolinea che: […] l’imbarazzo del traduttore nasce piuttosto dalla difficoltà di essere padroni dello spirito che scorre segretamente sotto la tranquillità della lettera, di captare l’ebbrezza di tale spirito che lascia il marchio del suo sigillo su ogni discorso enigmatico (ivi, p. , T.d.A.). L’elaborato pensiero dei Guaranì, riproposto qui in modo molto ridotto, per dire “linguaggio” usa la parola “AYVU”, il cui suono è pienamente animico, poiché completamente vocalico, e la “Parola abitante”, ossia quella forza che abita il dire, possiede a sua volta un’anima definita nê’ ë, respiro dal profondo. Lo sciamano, pertanto, dà forma del suo sapere rivestendosi del riflesso della sostanza insita nella parola divinizzata e di quella parte di umanità di cui egli è fondamentale componente. Ne consegue una riconquista del divino in una totalità e libertà riaffermate dal rito, dal tono di voce usato, attraverso il quale egli recupera il meraviglioso della propria forza di pensiero, magnificato da una iniziale sottomissione alle entità superiori o forze cosmiche, al loro alveare di coscienza non manifestata fino a dominarne la loro possanza. Queste forze vitali vengono percepite dai sensi così come accadeva per l’artigiano del Medioevo quando, in sintonia con l’universo, forgiava i suoi strumenti, rimodellava, esorcizzandolo, il senso ritmico della terra, del vento, dell’albero e così per ogni aspetto della natura che lui stesso abitava. La parola è memoria; conoscendone il suo passato ne viene rafforzato il valore totale per cambiare il dolore, la sofferenza e i limiti dell’umano, la cosiddetta “guari- LA NOSTALGIA DELLA PAROLA ARCAICA gione”. Anche il respiro poetico è una piena che straripa non volendo confini: è ancora suono, colore, circolarità di tutti i ritmi, in una prospettiva di immagini che devono ritornare. A questo punto, se tale slancio è ritmo che salva, che riconsegna la vita, è inevitabile il mantenimento armonico di quella memoria trasportata come onda marina da uno spazio primordiale per sussurrare all’uomo ascoltatore la fermezza di riscatto da un pensiero mortale e, se questo uomo riesce anche solo minimamente a percepire il tumultuoso insorgere dell’onda poetica, a percepirsi insufflato, può anche, seduto sulla tranquillità di una roccia, acquisire la conoscenza, appena sufficiente per lui, della voce ritmata dell’universo, che il poeta e lo sciamano hanno, con coraggio della solitudine, trasfigurato a loro immagine, essendo stati attraversati come deserti che trattengono solo l’indispensabile e il supremo raccoglimento che l’uomo possa sperimentare per varcare la soglia del sopra-sensibile. Il deserto si riconferma canto dell’assoluto e del silenzio, dove l’aria ha modellato le dune come corde vocali di un universo incantatore. Esso si riafferma presenza di ignota alterità nell’uomo il quale può volersi specchio del mondo se – come nella tradizione mistica islamica che vede nello specchio, ricorda Titus Burckhardt (, p. ), «il simbolo più diretto della visione spirituale, la “contemplatio”» – egli, uomo, depone in tale forma l’espressione di congiunzione del soggetto e dell’oggetto. L’ascoltatore vive, esaltandosi, l’immedesimazione già vissuta dal poeta imitatore; la voce vive dell’unicità della sua esecuzione e la sua luminosità si rispecchia nella materia del dire recitato. L’impossibilità di transito, di accesso alla traducibilità di un tale istante il cui linguaggio è vario, può essere dovuta al fatto che la parola profetica della poesia è irripetibile nella sua velocità di esecuzione, è unicità, può essere “sentita” in una diversa corrispondenza di espressione, una nota più o meno prolungata, un arcobaleno e via dicendo, poiché non importa quale sia la matrice che la origina, essa è ormai in un’orbita e provoca la sua eco in una successione di altri fenomeni già posseduti. Il transito di cui sopra è l’immediatezza del segno, del lampo, del frammento, della luce, come lo spalto d’Islanda e l’uso della metafora accentua tale rapidità; che, a sua volta, si traduce in immobilità per essere silenzio, respiro dell’assoluto, movimento e per tornare di nuovo sulla terra come granulo di polline. […] Qui dans son coeur monte et […] dans la chaleur du glacier qui s’agrège, Se hausse en ton Royaume des Neiges. Neige mystique: Himachal! Dédaignant tout autre Je pense, je crois en Ce grand mois culminant, Nivose aux jours séculaires A ton règne enfin qui me viendra De tes Neiges, – à ce reve doux dans tes Neiges, Sommeil se réveillant dans ta mort. (Segalen, , p. ) Et par-dessous une blancheur d’abime Comme si ce qu’on nomme l’esprit tombait là, sans bruit, Comme une neige. Je tournais cependant les pages. (Bonnefoy, , p. ) N’étant plus, ni le bruit, sauf le léger Chuchotement des flocons qui bientôt ROSA DI PAOLO Se multiplent, se rapprochent, se nouent – Et je revois alors tout l’autre ciel, J’entre pour un instant dans la grande neige. (Ivi, p. ) Tale esperienza esige di essere vissuta nella sua estensione fino al sublime; non è solo punto di ritrovo, ma rigore di una nudità, di una condizione fedele a una chiamata dalla profondità del meandro che produrrà la vita della voce e animerà, mimandola, quella cosmica. Croire en soi. Se nourrir de sa substance, […] Dans le silence, enfin perçu comme un Chant, s’offrir, se dédier à cela, différent de soi, qui veut naitre. Avant l’oeuvre, sentir le Germe. (Segalen, , p. ) In questo antro che precede la scienza del respiro sono le forze ataviche di un simile germe, lo sprigionamento della spiritualità da esso derivante, vedi, per esempio, il fuoco o l’aria, ripetutamente nostalgici del registro riconciliatore del poeta, del verbum soffiato dello sciamano. Entrambi lasciano che un simile soffio compenetri nella materia per cui sono chiamati a esistere, in un rito che annulli, nel suo tempo sacro, ogni condizionamento presente. Il profetico avanzare della vita è il nodo fra lo scandire della creazione e la sua svelata composizione in un’armonia umana preesistente e che, nell’estetica antica, corrisponde all’idea platonica di entusiasmo, qualità morale che provoca un “effetto speciale”. È una seducente, fatale armonia di un meccanismo che mette in moto la maestosità dell’atto rigenerativo, senza errori ma nella ridondanza di un vissuto resistente alla vana ricchezza di un oggi, che sia proiezione nel futuro, la plénitude di una dialettica “altra”, costantemente alimentata, storicamente riformulata e pronunciata. L’esperienza della morte, non il suo fiato incombente sull’uomo, è l’estrema condizione di un’utopia che si disarticola da quella verticalità iniziale, il segreto nell’anima del verso; è l’esperienza che interroga il Non-Manifestato fiducioso di una mutazione che raccolga nuovamente, nella fàtica dell’immanenza, il frutto della premonizione, poiché sono loro gli interpreti dell’inspiegabile “cadenza”. In quella vertigine – utopia, morte, resurrezione – abitante il movimento parossistico che vede allontanare da sé ogni forma umana o di cosa conosciuta per percepire solo l’ombra errante in un crescendo e in un inseguirsi di ritmo, anche il gesto compone il dire poetico nella materia del suono, prossimo al colore. Tra l’ispirazione e la seduzione nasce l’identità di una composizione, che si può collegare all’idea di Roman Jakobson di poetica usando il termine “strutturazione” ossia l’innata facoltà di riprodurre, dandole nuove entità, qualsiasi forma arcaica senza sacrificare l’impronta della loro individualità nella straordinaria molteplicità di creazioni sempre rinnovate. Questa capacità appartiene al poeta e allo sciamano, unificatori del significante e significato; loro, i disegnatori delle forme della parola cesellata nel flusso verso la frase. Essi lasciano tracce per una fede poetica trasmessa all’osservatore-ascoltatore. Volendo, a questo punto, di nuovo tornare al verso, proiettato in un’elevatezza dalla quale il sublime può far suo, afferrandolo come da un albero mitologico del sapere, il frutto camuffato del “meraviglioso altro”, vediamo che ne deriva un’energia variabile e un tono a essa affine. Questa tonalità è chiamata a fondere il metallo alchemi- LA NOSTALGIA DELLA PAROLA ARCAICA co dell’estasi, attivando la volontà di coloro che in qualche modo si avvicinano alla musica di luce del poeta e dello sciamano. L’energia di invenzione e le onde sonore producono la dimensione di trance nella quale il ritmo compie un ritorno mitico a quell’elemento di vastità incommensurabile che ab aeterno ha scavato nelle cripte della memoria umana fino a far sorgere e sacralizzare il fulgore di quelle primordiali verità, fino a far tornare, al di sopra di tutto, in un ritmo unico, in una trance cosmica l’ordine di una vita che garantisce l’identità di una determinata cultura. A questo proposito è necessario ricordare quanto Segalen, nelle pagine dedicate alle musiche e alle danze maori, esprime relativamente al ritmo di una razza regolato da «fatti misteriosi sul cui ordine la lingua può ben poco dal momento che tali fatti s’illuminano da soli, da dentro, se lasciati evolvere e risplendere in sé» (Segalen, , p. ). È il libero trionfo di un respiro unico, nel quale si dispiega il molteplice. Il dire o recitare è senso di leggerezza e distacco celebrativi del miracolo musicale da esso prodotto, in una tecnica individuale nel tono più o meno prolungato o accentuato di una vocale o di una sillaba all’interno di una parola, per farne trasparire l’anima, l’arcaica armonia, in tecniche che esaltino o no il respiro, attribuendogli la giusta sospensione fino ad attimi di interruzioni del respiro stesso, e toccare il preludio di un compimento di “opera”. Suspendre la respiration jusqu’à l’étouffement et à l’extase – aux premiers mouvements qu’il a. […] Bondir sur le Germe, dès qu’il est né, Le sécouer et l’étirer, le serrer et l’écrouir pour connaitre s’il est, ou non, digne de la densité des Mots (ivi, p. ). Questo momento è il raggiungimento di uno stile. Come accade per l’antica letteratura vedica, presso la quale le melodie del Gandharva Veda, la musica classica dell’antica civiltà vedica, sono le melodie della natura, i suoi ritmi espressi in forma musicale e, ribadisce Wallace (, p. ): «Essi hanno pertanto una efficacia terapeutica […] i suoni di tale disciplina entrano in risonanza con i livelli materiali più sottili dell’organismo e riattivano il punto di congiunzione fra queste strutture e la sequenza della legge naturale che è alla loro base nella coscienza». La pratica poetico-sciamanica, nel suo transitare nell’estasi, deve, per estenderne il ricordo, offrire la luce della voce recitante, veicolo per ritornare in una sorgente, in una realtà extratemporale. La voce è il possente caos emergente dalla caverna primordiale, resa mito dalle corde più segrete dell’essere, dai battiti millenari di mani su pelli divenute tamburi nel fitto percorso erratico del tempo. Il silenzio è un grande maestro, è rivelatore di un fenomeno che sta per manifestarsi, è già presente nella voce, è già conoscenza del suo canto, è assonanza universale, possiede l’estensione di un’eco che vibra puntualmente nelle viscere del fenomeno parola e lo trasforma in benessere universale che non può affievolirsi fino a quando il poeta guardiano ne tiene accesa la fiamma. Ci viene da pensare che la poesia, come lo sciamanismo, sia nata nell’istante in cui l’uomo preistorico, osservando il lampo cadere nella sua spettacolare deflagrazione, ha conosciuto lo stupore, ha voluto imitarlo e, con il suono, il gesto, la parola e il loro vigore ha prodotto il fuoco e l’estasi e li ha sacralizzati. Il flusso onirico e nostalgico presente in entrambi diventa più forte nel momento in cui inizia la partenza nella fase preparatoria dell’esperienza archetipa ROSA DI PAOLO del mistero; entrambi sono condotti verso un’uscita dal proprio corpo, verso la ricostruzione, nella parola, di un passato nuovamente esplorato e rifiorito in un contatto elettrico che scuote dal suo silenzio la morte. La volta invisibile di questa parola, alla quale l’uomo spesso attribuisce valore sacrale, è simile a quella cosmica ma non può essere ogni volta quella definitiva, è comunque il luogo dove i poeti depongono le loro speranze e rinascite. Essa è anche la volta tanto celebrata dall’amore poetico che anima le pagine di Yves Bonnefoy ispirate dall’arte pittorica; è la volta che rammemora la curvatura dell’uomo di fronte al riconoscimento della conoscenza e della bellezza che la nomina eternamente mistero, avendone ereditato l’estetica di gioia mai fugata, e l’uomo è la pianta che si ripiega in un’incessante richiesta di acqua. Ici, le temps se creuse, c’est déjà l’eau éternelle à bouger dans l’écume, Je suis bientôt à deux pas du rivage. […] […] Beauté et vérité, mais ces hautes vagues Sur ces cris qui s’obstinent. Comment garder Audible l’espérance dans le tumulte, Comment faire pour que vieillir, ce soit renaiˆ tre, Pour que la maison s’ouvre de l’intérieur, Pour que ce ne soit pas que la mort qui pousse Dehors celui qui demandait un lieu natal? (Bonnefoy, , pp. -) La partenza per entrambi è rito ineluttabile che li conferma eroi del ritorno nelle cui mani è deposto lo splendore di un rinnovato dominio del sapere. L’avvenimento di un tale dinamismo ristabilisce un antico ordine, il tepore di un mondo sonoro da cui tutti proveniamo, dal quale si perpetua il nostalgico fiorire della vita, nella misura in cui, mai vinti, ne sono riformulati i passi. L’accento nel verso recitato viene distribuito dal respiro variabile connesso a un punto preciso della parola, è la sua ossessiva azione a rendere l’insieme di tanto perfetta verticalità, un processo misterioso, un riconfortante senso dell’oblio, plasmato da forze ctonie sulle movenze delle quali, ogni volta, è rinata la luminosità di una ritrovata azione che mai lascia l’uomo uguale a prima e tanto meno il poeta sulla via della perfezione. […] deux voies se séparent, et l’une d’elles Se perd, et presque tout de suite, et ce sera Tout de même l’oubli, l’oubli avide. J’aurai barré Cent fois ces mots partout, en vers, en prose, Mais je ne puis Faire qu’ils ne remontent dans ma parole. (Ivi, p. ) Poeta e sciamano hanno entrambi convissuto con l’ossessione di una passione per il mondo e per l’umanità e, posseduti dalla materia che stanno per variare, ne percepiscono l’inquietudine della sua stessa trasformazione. L’avvento di questa mutazione ristabilisce la regola di un’archeologia della parola nel folle ondeggiare di una nega- LA NOSTALGIA DELLA PAROLA ARCAICA zione e un’affermazione di senso. Nel progressivo avanzare nell’inquietudine del verso e del vivere, il poeta e lo sciamano sono immersi nella spirale del soffio di corrente ascensionale. Una molteplicità di sensazioni pervade le loro coscienze fino a fondersi, come metallo prezioso, nei loro corpi e nelle loro menti divenuti templi di una suprema significanza perseguita e raggiunta. Corpi e menti liberati dal doloroso annientamento dell’immobilità dell’attesa, riconfermando l’elegante muscolatura di abili nomadi sulle vie di metamorfosi calanti su di loro e su qualunque cosa essi depongono il loro segno, accento, il loro sussurro di risveglio. La cultura investe tutto il pensiero dell’uomo; il poeta e lo sciamano ne sono l’emblema: la loro parola è il sigillo di una verità calata sul mondo, è identità ritrovata nella centralità di un microcosmo. Il dinamismo è, pertanto, mantenuto in un rispetto universale nel quale la natura rinnova perpetuamente le sue forme di racconto, fonti di ricchezza di quelle intuizioni itineranti colte da coloro che hanno ascoltato, fondato il proprio ritmo e assimilato il valore del silenzio deciso del poeta e dello sciamano, mai fondato su di un loro umano egoismo, bensì su di una sapienza che loro appartiene e che diventa il “nutrimento”. Il ritmo è contemporaneità insorta e stabilizzata per raggiungere, come meta, un’assoluta sovranità. Il poeta sopraffatto come lo sciamano, con un’innata prescienza, conosce e sa misurare il suono del suo linguaggio; ne marca, prolungandola e frazionandola, la rigorosa muscolatura in musica, ne orchestra la calma, il furore, il tempo necessario per la inevitabile seduzione. In Yves Bonnefoy è la voce simile al soffio vitale arrivato da una dimensione primordiale, il soffio proveniente da cavità rocciose, le cui volte, di nuovo, sono ricettacoli delle sue poesie, illuminate dal bagliore di un fuoco delle origini, così come potrebbe esserlo se si potesse toccare la voce di Segalen emergente dall’immortalità di vette innevate nel suo lungo poema Thibet, preludio della sua morte, e nel quale il ritmo ha la scienza del respiro di un mantra o sacro suono, la cui forza si carica in una o più sillabe, è suono interiore per comunicare con il brama, ossia l’assoluto. Elle, la mort, Elle défait le temps qui va le monde, […] Pour offrir, o bonheur ici, dans leur brève, Les fruits, les voix, les reflets, les rumeurs, Le vin léger dans rien que la lumière. (Bonnefoy, , p. ) Toi même THIBET, rocher pur, es pénétré de ces carrares, Toi-même es veiné comme un amant. […] Voici cet éclat non sidéral: l’autre élément […] Ni d’eau, – et ni même de lumière. […] Couler en moi- même comme un Lac. Me ruissellant de haut en bas, fleuve sans flux et sans racine. […] Non seulement autour de moi, mais en moi seul, en mon domaine… Passe la Grande Caravane Qui ne monte pas, ne descend, mais d’age en age souverain Glisse et dévale la moraine Sans fond de cet effroyable glacier vertical et chutant Du Temps. (Segalen, , pp. -) ROSA DI PAOLO […] Pour emprunter ton parler haut, Thibet, tes grandes voix dans le désert. Le jet de ta rude épiphanie… […] Coule sous les langues altérées Comme un déferlé fleurissant couleur de langues et mantras. (ivi, p. ) Tu les baigneras dans la douce lumière de tes Éclairs silencieux, toi qui n’existes pas en vain. Tu le feras, jusqu’au temps de l’effondrement de l’espace. Lorsque l’espace se sera effondré, lorsque le temps nouveau Aura surgi, moi, je ferai qu’à nouveau la Parole s’écoule dans les Os du porteur de bâton-insigne. Je ferai que la Parole retrouve sa demeure. Car assurément, mon désir de savoir les choses M’épuise: je danse, je danse Et danse encore. C’est ainsi. Les belles traces que tu as laissées. Mon désir est de les connaître. Et voici: À propos de grandeur du coeur, je questionne, Dressé en mon effort, mon père karai père véritable le Petit. (Clastres, , pp. -) La poesia si proclama riflessione e musica dell’universo. La ragione, quando sa illuminarsi, sa anche ammutolirsi di fronte all’incedere fascinoso del suono arcaico verso la centralità dell’essere e rapirlo in un compimento sacro simile all’accordo di un incanto fiorito nella corrispondente centralità della parola. La disfatta del nostro secolo, analizzata da tutte le scienze contemporanee, la perduta arte del racconto e della solitudine sono troppo spesso causate da una incapacità di sguardo, di ascolto, di respiro e, di conseguenza, di traducibilità dei minimi o più elevati fenomeni decretati tali dalle remote verità, specchio della natura, del cosmo e dell’altrove, verità che hanno scandito le loro più nostalgiche note. Per concludere, se il poeta, come lo sciamano, è posseduto da forze supreme che lui interroga e governa, egli, in tale modo, fa di se stesso un essere divino in lui incarnato per distogliere e allontanare dall’uomo il volume indecifrabile dell’ignoto, esorcizzandone il peso della morte di cui l’uomo stesso conserva un atavico terrore, perché non sa come incontrarne la conoscenza, il segreto e il lusso dei suoi infiniti segni. La qualità del sublime, allora, più tende a elevarsi e più ottiene il suo platonico effetto, la brillanza del suo dispiegarsi, del suo srotolarsi, mostrando l’avida volontà poetica e sciamanica in una ierofania salvifica. Bibliografia (), Ce qui fut sans lumière, Gallimard, Paris. (), Les Planches Courbes, Gallimard, Paris. BURCKHAARDT T. (), Considerazioni sulla conoscenza sacra, Arché, Milano. BONNEFOY Y. ID. LA NOSTALGIA DELLA PAROLA ARCAICA CLASTRES P. (), Le Grand Parler, Seuil, Paris. MASTROMATTEI R. (), La Terra Reale, Valerio Levi Editore, Roma. SEGALEN V. (), Thibet, in Id., Œuvres complètes, Laffont, Paris, vol. II. STEINER G. (), Linguaggio e silenzio, Rizzoli, Milano. WALLACE K. I. H. (), Fisiologia della coscienza, Edizioni Tecniche Nuove, Milano. BORGOGNONI IN ITALIA (-) di Letizia Norci Cagiano Nei primi decenni del Settecento Digione, capitale della Borgogna, gode di notevole prestigio culturale e politico a livello nazionale ed europeo. Il Collège des Godrans, diretto dai gesuiti, rivaleggia con le scuole parigine per vastità, approfondimento e attualità degli insegnamenti. Le scuole parigine, certo, sono più alla moda, e attirano tra i loro allievi anche alcuni giovani rappresentanti delle famiglie digionesi più in vista, come i Legouz de Gerland, i Fyot de la Marche o i Castel-Crèvecœur che saranno compagni di Voltaire a Louis-le-Grand; ma anche coloro che restano in patria possono beneficiare di una impostazione letteraria e scientifica aggiornata e dei mezzi per inserirsi con cognizione di causa e anche con successo nel dibattito culturale europeo. Il Collège des Godrans si presenta come uno dei più qualificati di Francia per lo studio della matematica, della fisica e delle scienze naturali (e non per caso Buffon esce da questa scuola), dà un’ottima formazione classica e letteraria, grazie a celebri maestri, tra i quali si annovera il père Oudin, e trasmette agli allievi le conoscenze geografiche e l’interesse per le civiltà diverse, anche quelle più lontane nello spazio e nel tempo, proprio come avveniva a Parigi. I digionesi colti, stimolati anche dalla presenza dell’Académie de Dijon, non esitano dunque a inserirsi in quella fitta rete di corrispondenze, di viaggi, di scambi, di pubblicazioni e di notizie che caratterizza la République des Lettres del primo Settecento; nello stesso tempo partecipano con passione alla vita politica attraverso l’attività del loro Parlamento, istituzione prestigiosa che in più occasioni ha tenuto testa all’eccessiva autorità del re di Francia e che quotidianamente deve fare i conti col rappresentante del monarca, il governatore di Borgogna, che, nel , è LouisHenri, duca di Bourbon e d’Enghien, figlio del principe di Condé. È in tale contesto che un consigliere del Parlamento di Digione, Charles de Brosses (più noto come Président de Brosses per la carica che ricoprirà presso quello stesso Parlamento a partire dal ), insieme con alcuni suoi concittadini, decide d’intraprendere un viaggio in Italia che descriverà poi in una raccolta di Lettres familières indirizzate agli amici rimasti a casa. Queste lettere, ricchissime di informazioni e commenti di vario genere, rivelano, fra l’altro, le reazioni più o meno inconsce di questi borgognoni, nel momento in cui vengono a scontrarsi con la variegata realtà delle città italiane. Come ha osservato Marc Fumaroli in una bella conferenza sulle Lettres familières di Brosses, l’erudito europeo che porta i segni della più illustre tradizione della République des Lettres può muoversi con facilità nella società colta di qualsiasi paese e in particolar modo dell’Italia e di Roma: LETIZIA NORCI CAGIANO […] cet épicurisme lettré [proprio dell’illustre tradizione della Repubblica delle Lettere, da Lorenzo Valla fino a Gassendi, e da Erasmo fino all’abbé Du Bos] est à ce point acclimaté depuis la Renaissance dans le catholicisme qu’il sert de langage commun à Rome même entre les “libertins” laïcs comme le magistrat dijonnais et les plus doctes prélats de l’église romaine comme Passionei ou Lambertini. Il n’est pas jusqu’à cette urbanité et à ce sel attique supérieurs, si naturels dans la conversation écrite de De Brosses, qui ne trahissent le citoyen de la République des Lettres chez lui, parmi les siens, bien plutôt que l’homme du monde ou de salon (Fumaroli, , p. ). Questa osservazione mi trova perfettamente d’accordo per quanto riguarda l’aspetto erudito delle Lettres familières, oggetto della conferenza di Fumaroli; sarà anzi proprio l’appartenenza di Brosses alla République des Lettres che lo aiuterà a fare i primi passi nella società italiana; ma un rapporto letterario tra savants è ben diverso dall’impatto con usi, costumi, dialetti sconosciuti, abitudini a prima vista incomprensibili, il diverso modo di vestirsi e di conversare, gli atteggiamenti delle donne, il modo di ricevere, il cibo, l’arredamento delle case, fino agli odori e ai sapori che due secoli fa caratterizzavano molto più di adesso ogni ambiente e ogni regione. È quindi tenendo conto di tutti questi fattori che cercherò di ritracciare quei momenti del viaggio di Brosses in cui maggiormente si rivela la sua appartenenza al mondo borgognone e quindi le difficoltà o, viceversa, le agevolazioni che questa appartenenza comporta nell’incontro con situazioni o aspetti diversi della realtà italiana. Il viaggio in Italia di Charles de Brosses (maggio -maggio ) si apre con la descrizione della prima tappa, da Digione a Mâcon dove va a trovare la sorella, canonichessa a Neuville: Vous sçavez comment nous partîmes tous les deux samedy trente may sur les huit heures du jour dans ma chaise de poste qui nous mena d’une traite à Mâcon, où mes chevaux m’attendoient. J’y laissay ma chaise, mon cousin Loppin, mes hardes et mon fidelle valet de chambre le seigneur Pernet pour aller voir ma sœur. Je la trouvai s’arrangeant dans son ménage et dans sa nouvelle maison. On me fit grand-chère à souper en fruits nouveaux, fraises, petits pois et artichauds. Je fais mention de cecy, parce que j’ay apris de notre ami le Père Labat que l’on ne doit jamais omettre ce qui se mange, et que les bons esprits qui lisent une relation s’attachent toujours plus volontiers à cet article qu’à d’autres. J’y séjournai le lendemain et le juin je partis à cheval pour aller à Lyon où Monsieur Loppin avoit dû se rendre dez la veille par la diligence. La chaleur de la route étoit capable, si le chemin eût été plus long, de me faire trouver la Norvège à Rome (Brosses, , vol. I, pp. -). Queste righe ci mostrano subito la familiarità del futuro Presidente con la sua regione: lascia la carrozza e il cugino, inforca il cavallo che lo aspetta e va a casa della sorella… anche a varie leghe da Digione si sente perfettamente a suo agio. In realtà esiste un legame viscerale tra Brosses, la sua regione e la società borgognona a cui appartiene. Questo legame si rivela nella corrispondenza col cugino Loppin de Gemeaux (Lettres, ), che riguarda proprio la sua vita in Borgogna, ma anche, in modo particolarmente interessante, nelle Lettres familières. Nel passo citato la familiarità di Brosses con la sua terra si traduce in un’osservazione gastronomica, giustificata dall’esempio di Labat, ma che rivela l’importanza che egli attribuisce alla convivialità. Durante tutto il viaggio in Italia, la convi- BORGOGNONI IN ITALIA (-) vialità, che è un tratto fondamentale del carattere borgognone, assume la funzione simbolica di rappresentazione di un mondo, di un modo di vivere molto diverso da quello italiano. Il mondo borgognone traspare, in filigrana, lungo tutte le Lettres familières, come emblema di ciò che è conosciuto, solido, affidabile, in contrasto con l’ignoto, le sorprese, i tranelli di un paese nuovo. E tuttavia Brosses non è un viaggiatore ingenuo o inavvertito. Quando parte da Digione già conosce l’Italia attraverso le letture, le corrispondenze erudite, la frequentazione degli autori antichi e moderni; conosce anche un po’ la lingua e si diverte a tradurre dall’italiano sul battello che, attraverso il Rodano, lo conduce da Valence ad Avignone. Egli, come abbiamo visto, appartiene a quella élite cosmopolita, a quella “Repubblica delle Lettere” i cui cittadini si muovono facilmente nella società colta di qualsiasi paese e sarà proprio l’appartenenza a un mondo erudito e internazionale a dirigere i suoi primi passi una volta giunto in Italia: a Milano, per esempio, è alla Biblioteca Ambrosiana che annoda le prime relazioni con alcuni membri illustri della società lombarda. Tuttavia si tratta di rapporti formali tra eruditi o anche di rapporti mondani, in cui manca quella cordialità o quell’abbandono che caratterizzano l’amicizia. Soltanto a Bologna, dopo tre mesi di viaggio, Brosses comincia a penetrare nei segreti della società italiana ed entra a farne parte a tutti gli effetti. È proprio in questa città che egli doppiamente si innamora: in modo scanzonato della marchesa Gozzadini e con vera passione dell’opera buffa italiana. Ma in tutte le tappe precedenti, a Genova, a Milano, a Venezia, i suoi rapporti con la società italiana erano rimasti formali o superficiali e l’immagine della Borgogna gli si era presentata con insistenza, suscitando una nostalgia che soltanto l’incontro di alcuni compatrioti aveva provvisoriamente placato. A Pavia, per esempio, si era affrettato a far visita alla signora Bellinzoni, nata Persy de Curgis, una borgognona che lo introduce, a Milano, presso la contessa Simonetta, grande partigiana dei francesi. È qui, in un ambiente strettamente legato alla Francia, che Brosses si trova a proprio agio, molto più che dai grandi intellettuali milanesi, i Pertusati, gli Archinto, i Borromeo, che pure gli aprono le loro case. La sua soddisfazione è perfetta quando incontra, per caso, un borgognone di Tournus, che vive a Milano: L’autre jour, racconta, dans une assemblée, un grand homme bien fait m’aborde. «Ah! monsieur, vous êtes Dijonnais, faites-moi la grâce de me dire des nouvelles de mesdames de Blancey et de Quintin; et le gros Blancey, comment se porte-t-il? faites-moi le plaisir, si vous écrivez à Blancey, de l’assurer de mon obéissance, et ces dames de mon respect très humble. J’ai reçu d’elles des politesses infinies pendant un hiver que j’ai passé à Dijon, et j’ai eu l’honneur de les voir chez Messieurs de Tessé et de Montrevel, à Tournus, où je demeure». Ce Monsieur se nomme Monsieur de Laforest. Il est arrêté ici depuis longtemps par une galanterie; et en faveur de la bonne guigne de Blancey, il m’a fait présent de vin de Bourgogne, chose plus agréable ici que toutes les peintures de l’univers, car on s’épuiseroit en vain le cerveau pour imaginer à quel point les vins de Lombardie sont detestables (Brosses, , vol. I, p. ). Il vino di Borgogna accompagna dunque l’evocazione di amici lasciati a Digione, come Messieurs de Blancey et de Quintin, destinatari di alcune Lettres familières, e rappresentanti di un gruppo di intimi a cui Brosses è profondamente legato. Sappiamo d’altronde che egli viaggia con tre membri di quella stessa società: suo LETIZIA NORCI CAGIANO cugino Loppin de Montmort e «les deux Lacurne»: Edmond Lacurne et JeanBaptiste Lacurne de Sainte-Palaye, il celebre filologo. A Roma altri due viaggiatori, Legouz e Migieu – ancora due digionesi –, completeranno il gruppo dei sei borgognoni. Per il momento si tratta di quattro compagni di viaggio che mantengono i loro rapporti con la società digionese attraverso un fitto scambio di missive, una parte delle quali costituisce il nucleo originale delle Lettres familières. Questi contatti intensi, da una parte alleviano, ma dall’altra acuiscono il male della lontananza. A Venezia, dove gli stranieri non possono frequentare i nobili che rivestono cariche politiche, Brosses, stanco di vedere soltanto ambasciatori, artisti o cortigiane, si lascia sfuggire un sospiro di vero rimpianto: Je vous diray franchement qu’un des grands désagrements du voyage est de n’avoir pas, quand le soir vient, son doux objet, son gros Blancey, son bon Quintin, ses amis Maleteste et Bévy, sa dame Cortois, ses excellentes petites dames des Montots et Bourbonne, enfin tout notre petit cercle, pour tenir, les coudes sur la table, des propos de cent piques au-dessus de la place Saint-Marc et du Broglio (ivi, vol. I, p. ). Queste parole mostrano ancora una volta come dei rapporti culturali o semplicemente mondani non possano soddisfare un viaggiatore come il futuro Presidente de Brosses che, proprio a Venezia, comincia ad analizzare le sue difficoltà a inserirsi nella società lagunare. Tra le cause vi è certo la sua scarsa conoscenza dell’italiano, o piuttosto del veneziano che costituisce un serio ostacolo nel seguire le conversazioni, ma che non gli impedisce di scambiare opinioni e di raccogliere informazioni da chi ha il piacere o la pazienza di intrattenerlo singolarmente; tanto è vero che le lettere su Venezia rivelano un’ottima conoscenza delle questioni sociali e politiche della Repubblica. Ma ciò che maggiormente preoccupa Brosses è il genere di ospitalità, così diversa dalle abitudini borgognone. Les Vénitiens avec tout leur faste et leurs palais, ne sçavent ce que c’est que de donner un poulet à personne […] pour tout régal, sur les trois heures, c’est-à-dire à onze heures du soir de France, vingt valets aportent, dans un plat d’argent démesuré, une grosse citrouille coupée en quartiers, que l’on qualifie du nom d’angouri ou de melon d’eau, mets détestable s’il en fut jamais. Une pille d’assietes d’argent l’accompagne; chacun se jette sur un quartier, prend par-dessus une petite tasse de caffè et s’en retourne à minuit souper chez soi, la teste libre et le ventre creux. […] il faut s’attendre, en pays étranger, d’avoir les yeux satisfaits et le cœur ennuyé; de l’amusement de curiosité tant qu’il vous plaira, de la ressource de société aucune (ivi, vol. I, pp. -). Sono toni amari, ma destinati a cambiare una volta che, lasciata Venezia, Brosses giunge a Bologna, città notoriamente accogliente, dove quasi tutti i viaggiatori fanno un gradevole soggiorno. Qui egli partecipa appieno alla vita della società italiana che conta: ormai conosce abbastanza bene l’italiano e, per di più, è aiutato dal carattere aperto dei bolognesi e da una quantità di interessi in comune. Non mancano a Bologna potenti famiglie filofrancesi, come i Rossi o i Monti, che gli aprono le loro case dove si parla francese e ci si veste all’ultima moda di Parigi; inoltre c’è l’Istituto delle Scienze, fondato da Luigi Ferdinando de’ Marsili, con degli orientamenti molto vicini a quelli di Brosses: egli può dunque discutere aper- BORGOGNONI IN ITALIA (-) tamente di scienza, di politica, perfino di religione con membri dell’Istituto come Bartolomeo Beccari o Eustachio Zanotti, che gli appaiono non solo come persone di grande cultura, ma anche «gens de bonne société et galants auprès des dames» (ivi, vol. I, p. ). Questi caratteri piacevoli e gioviali e un’affinità d’interessi scientifici, attenuano il rimpianto per la società digionese: il futuro magistrato borgognone riscopre infatti a Bologna l’atmosfera delle conversazioni con Buffon o con il Presidente Bouhier. D’altronde quest’ultimo (a cui sono indirizzate tre Lettres familières) influisce in modo importante sul soggiorno di Brosses nella Penisola: infatti è tra coloro che contribuiscono in modo determinante a stabilire dei contatti tra il nostro viaggiatore e alcune importanti personalità italiane. Sappiamo, per esempio, che aveva fornito ai quattro borgognoni delle lettere di presentazione per il suo grande amico, il cardinale Passionei. Questo nome è sufficiente per comprendere verso quali ambienti Brosses si sarebbe rivolto di preferenza. Passionei era innanzitutto un erudito di fama europea grazie a un’eccezionale larghezza di vedute e alle sue esperienze di nunzio in diversi paesi stranieri. D’altra parte egli era anche una “creatura” di Clemente XII; apparteneva dunque, anche se con qualche riserva, a quel sistema di relazioni politiche, culturali e mondane di matrice fiorentina e bolognese che caratterizzò i pontificati Corsini e Lambertini. Non per caso dunque la società di eruditi bolognesi frequentata dal futuro Presidente era strettamente legata all’aristocrazia della cerchia del cardinale Lambertini (col quale Brosses ha frequenti incontri che gli permettono di apprezzare la larghezza di vedute e la libertà di linguaggio del futuro Benedetto XIV), la cui influenza politica si estende ben al di là della regione bolognese e che contribuirà a introdurlo in importanti ambienti fiorentini e romani. Le tre lettere su Bologna rivelano dunque una piena partecipazione del futuro Presidente alla vita cittadina. Nello stesso modo a Firenze, a Napoli e a Roma lo vedremo, ormai completamente a suo agio, intrecciare rapporti destinati a durare nel tempo con personalità filofrancesi (come il conte Lorenzi a Firenze o il principe Vaini a Roma) e con intellettuali dell’ambiente dei Corsini (Buondelmonti, Intieri, Niccolini, Bottari) o in rapporto più o meno diretto con questi: è il caso di Celestino Galliani, incontrato a Napoli, e delle famiglie bolognesi assiduamente frequentate a Roma (Bolognetti, Bentivoglio, Bevilacqua, Lanfreducci-Sampieri), con la loro cerchia di alleanze romane (Sacchetti, Patrizi). Il soggiorno romano, che si prolunga per vari mesi, permette a Brosses di inserirsi perfettamente negli ambienti diplomatici e nelle alte sfere della corte pontificia. Le sue lettere ci mostrano bene come, nella città eterna, egli s’interessi vivamente agli intrighi, agli avvenimenti, alle discussioni e alle rivalità della corte, così come a tutte le manifestazioni religiose o mondane. Ed è a questo punto che le sue evocazioni della Borgogna cambiano di tono; non che dimentichi la patria o gli amici che anzi sono sempre presenti nelle sue lettere dall’Italia, ma egli fa parte, ormai, della società italiana; non la trova forse così divertente come le conversazioni digionesi, ma si è abituato, è capace di apprezzarne i lati migliori e di comprendere, finalmente, le ragioni del fasto italiano: mentre in Francia «faire une grande figure, c’est tenir une grande table», un italiano, «après avoir amassé par une vie frugale un grand argent comptant», lo spende «à la construction de quelque grand édifice public qui […] fasse passer à la postérité, d’une manière durable, son nom, sa magnificence et son goût». E Brosses giunge a chiedersi: LETIZIA NORCI CAGIANO Ce genre de vanité n’est-il pas mieux entendu que l’autre? […] Quant au plaisir qu’on peut prendre soi-même à ces sortes de dépenses, n’y en a-t-il pas autant à voir croître sous les yeux ses ouvrages qui resteront, qu’à voir l’arrangement d’un festin qui va disparaître? […] n’y en a-t-il pas autant à se régaler les yeux qu’à se régaler le palais? Une belle colonne cannelée vaut bien une belle gélinotte (ivi, vol. II, pp. -). Queste considerazioni vanno comunque prese in senso platonico, visto che Brosses insiste a più riprese sui deliziosi banchetti che gli vengono offerti a Roma. Per l’insieme di ragioni che ho cercato di esporre, il nostro viaggiatore, a Roma, trascura dunque le espressioni di rimpianto e i confronti gastronomici col paese natale e si preoccupa piuttosto di rappresentare la patria come membro borgognone della società romana. Resta tuttavia un’eccezione per quanto riguarda il vino: l’insipido vinello di Frascati non può neppur lontanamente essere accostato al vin de Nuits, e Brosses non riesce a trattenere espressioni di autentica gioia quando, sulla tavola del cardinale de Tencin, trova abbondanza di vino di Borgogna: «L’amour de la patrie, vertu dominante des grandes âmes, me saisit toujours à l’aspect d’une bouteille de vin de Bourgogne, malgré le peu d’usage que vous sçavez que j’en fais […] le cardinal en fait servir abondament et je l’en loue» (ivi, vol. II, p. ). Il tono ironico nulla toglie al ruolo di rappresentanza che assume qui il vino di Borgogna: liquore servito sulla tavola dei cardinali a illustrare il suo paese d’origine con magnificenza pari a quella dell’ambasciatore di Francia che è, all’epoca, il duca di Saint-Aignan. Lo stesso duca di Saint-Aignan che, durante il soggiorno di Brosses a Roma, sarà nominato governatore di Borgogna fino alla maggiore età del piccolo principe di Condé. In questa occasione si rivela in pieno l’appartenenza del futuro Presidente non solo all’alta società romana, ma anche alla cerchia di un così prestigioso rappresentante della Francia e della Borgogna. Il giorno stesso della sua nomina il duca di Saint-Aignan informa Brosses e i suoi compagni che si precipitano «en corps faire compliment à son Excellence. Vous ne sçauriez croire», aggiunge il futuro Presidente, «combien il est satisfait de se voir si bien placé au sortir d’icy et la joye que luy a donnée cette circonstance d’avoir en ce moment même à Rome six gentilshommes de son gouvernement» (ivi, vol. I, p. ). Ormai la preoccupazione di Brosses nei riguardi della Borgogna non è solo di rappresentare la sua provincia, ma anche, all’occasione, di difenderla. Egli si mostra dunque fiero dell’onore ricevuto da Monsieur de Saint-Aignan, ma cerca nello stesso tempo di tutelare gli interessi della città di Digione quando il duca manifesta l’intenzione di stabilirvi la sua residenza: Le duc de Saint-Aignan m’a beaucoup surpris en me disant qu’il comptoit faire sa résidence habituelle à Dijon. […] Il m’a demandé si cela ne feroit pas de la peine a Monsieur de Tavanes et quelle maison il pouroit habiter. Je ne comprends pas trop bien ceci, car il n’est vraisemblable ni que l’on oste le commandement à Monsieur de Tavanes, ni que l’on laisse ensemble dans la même ville un gouverneur et un commandant. Vous sçavez l’effet de deux soleils en un lieu trop étroit. Je luy ai répondu qu’il y avoit quantité de belles maisons dans notre ville, mais que ceux à qui elles appartenoient les gardoient pour eux-mêmes: que sans doute si la Cour vouloit qu’il y fît sa résidence, elle luy donneroit la maison royale qu’habitoit Monsieur le duc BORGOGNONI IN ITALIA (-) dans le temps des Etats, où il y avoit deux magnifiques apartemens de représentation, mais sans commodité (ivi, vol. II, p. ). Altre considerazioni sul ruolo dei Condé in Borgogna mostrano la sollecitudine costante di Brosses per le sorti della sua patria; il fascino di Roma non offusca in alcun caso la sua consapevolezza di membro importante della società digionese. Al momento di ripartire per la Francia la preoccupazione di ben rappresentare il suo paese si traduce nel desiderio di lasciare una testimonianza duratura del suo soggiorno romano. Così egli formula il progetto di acquistare un piccolo obelisco egiziano che ha visto giacente nel cortile di palazzo Barberini, e di erigerlo davanti a San Luigi dei Francesi «comm’un éternel monument de notre séjour à Rome. […] Voyez», aggiunge, «si on pouvoit à moins de frais s’immortaliser en style lapidaire» (ivi, vol. II, p. ), e prepara le iscrizioni da incidere sulle quattro facce del piedistallo con i nomi dei sei borgognoni (ormai quasi romani) in ordine alfabetico (ibid.): M. Aurelius. Antoninus. Aug. Radium. solis. in circo. metam. posuer. Valer. Aurelianus. Imper. Reficiundum. curav. Clementis. XII. Pont. max. Ludovic. XV. Reg. christianiss. Felicibus. auspiciis. Quem. Gothi. distruxere. Burgundi. erexere. Obeliscum. posuerunt. Divisionenses. sex. Carolus. de. Brosses. Edmundus. de. Lacurne Benignus. Legouz. Germanus. Loppin. Abraham. de. Migieu. Joann. de. Sainte-Palaye. Patricii Burgund. «Voilà tout ce qu’il y a d’exécuté.», esclama Brosses con disappunto, «Mes compagnons n’ont pas voulu mordre à ce projet» (ivi, vol. II, pp. -). L’obelisco è quindi restato nel cortile di palazzo Barberini fino al , quando Cornelia Barberini lo donò al papa Clemente XIV che lo fece trasportare in Vaticano. Un secolo più tardi, nel , Pio VII ordinò di predisporre la sistemazione sul Pincio che possiamo ammirare ancora oggi. In ogni modo il Presidente de Brosses ha lasciato un monumento, una testimonianza suggestiva e durevole del suo soggiorno romano: non si tratta di un obelisco egiziano né della sua monumentale opera su Sallustio, ma di quelle Lettres familières che non hanno nulla di ufficiale o di solenne, dove l’erudizione è ben mascherata e dove la scoperta di un mondo sconosciuto accompagna l’evoluzione del rapporto dell’autore con la sua Borgogna natale. LETIZIA NORCI CAGIANO Note . Brosses è accompagnato dal cugino Germain-Anne Loppin de Montmort, marchese de la Boulaye (-). Consigliere al Parlamento di Borgogna nel , Presidente nello stesso Parlamento nel e buon geometra; il nome di Germain-Anne Loppin de Montmort figura al primo posto nella lista dei membri onorari dell’Académie de Dijon al momento della fondazione, nel . . Si tratta probabilmente di Barbe de Brosses (-), canonichessa a Neuville. Brosses aveva anche un’altra sorella, Charlotte (-), conosciuta col nome di Madame de Montfalcon, anch’essa canonichessa a Neuville. . Jean-Baptiste Labat (Paris, -), domenicano e missionario; pubblicò numerose relazioni di viaggio, fra cui un celebre Voyage du Père Labat en Espagne et en Italie (Paris , voll.). Brosses possedeva i suoi Voyages en Afrique in voll. (Paris ). . Claude-Charles Bernard de Blancey era all’epoca primo segretario degli Stati di Borgogna. Era un personaggio molto benvoluto per l’allegria e la vivacità dello spirito. La sua amicizia con Brosses presentava i caratteri della più perfetta intimità. La moglie di Blancey, che Brosses ricorda spesso nelle sue lettere, era Jeanne-Henriette Jullien, figlia di Jacques Jullien, anch’egli segretario degli Stati di Borgogna. Louis Quaré de Quintin fu procuratore generale al Parlamento di Borgogna dal al ; bibliofilo, collezionista, fu anche direttore dell’Académie de Dijon dal al . Sua moglie, anch’essa ricordata nelle Lettres familières, era Marie Butard des Montots. . Jean-Baptiste Lacurne de Sainte-Palaye (-) è autore d’importanti opere sul Medioevo, tra cui un celebre Dictionnaire historique de l’acien langage français depuis son origine jusqu’au siècle de Louis XIV. . Bénigne Legouz de Gerland (-), digionese, fu compagno di Voltaire a Louis-leGrand; ebbe varie cariche presso gli Stati di Borgogna, fu grande animatore culturale e autore di opere storiche sulla città di Digione e sulla Borgogna. Abraham-Guy de Migieu, marchese di Savigny (-), giovane figlio di un Presidente del Parlamento di Borgogna ed egli stesso Consigliere. Era appassionato di quadri e di antichità di cui possedeva una ricca collezione acquistata in gran parte in Italia. . Come è noto, le Lettres familières furono scritte da Brosses vari anni dopo il ritorno dall’Italia intorno a un piccolo nucleo di nove lettere originali (cfr. l’Introduzione a Brosses, , vol. I, pp. -). . Jean-Louis Villey de Maleteste fu Consigliere al Parlamento di Borgogna nel ; aveva una vera passione per la musica, le arti e le lettere. Joseph Joly de Bévy fu Presidente della Chambre des Comptes di Digione dal al . Madame Cortois, nata Anne de Mucie, era la moglie di Claude-Antoine Cortois, Consigliere al Parlamento di Borgogna. . Madame des Montots, nata Charlotte Suremain des Flamerans, era la moglie di Louis Butard des Montots, Consigliere al Parlamento di Borgogna; Brosses esprime spesso, nelle sue Lettres , l’attaccamento che prova per lei. Madame Chartraire de Bourbonne, nata JeanneGuillemette Bouhier, era figlia del Presidente Bouhier; nel aveva sposato François Chartraire de Bourbonne, Presidente al Parlamento di Borgogna. . Jean Bouhier (-), Presidente al Parlamento di Borgogna, celebre per la sua attività di giurisconsulto e di letterato, fu eletto, nel , all’Académie Française; alla sua morte, nel , ebbe Voltaire come successore. . Cfr. la lettera scritta da Lacurne de Sainte-Palaye al Presidente Bouhier il dicembre (BNF, mss. fr. , fol. ). . Su questo argomento cfr. Giacomelli (, cap. II, in particolare pp. -). Giacomelli illustra i rapporti che intercorrevano tra una certa aristocrazia bolognese (Bolognetti, Caprara, Bentivoglio, Lambertini) e il gruppo dirigente corsiniano (Sacchetti, Acciaioli, Buondelmonti) e anche l’affinità di questi due gruppi con alcuni intellettuali toscani (come Bottari o Intieri), bolognesi (come Bacchini, Orsi, Manfredi, Argelati) o di altre origini, ma comunque legati a queste culture (Celestino Galiani, Belloni, Muratori). . Henri-Charles de Saulx, conte de Tavanes ( -), fu comandante militare e luogotenente generale del re nella provincia di Borgogna dal al . BORGOGNONI IN ITALIA (-) . Una delle ragioni del viaggio di Brosses in Italia era la ricerca di documentazione per una ricostruzione dei libri mancanti delle Historiæ di Sallustio. Quest’opera vedrà la luce nel col titolo Histoire de la République Romaine dans le cours du VIIe siècle par Salluste, en partie traduite du latin, en partie rétablie et composée sur les fragments qui sont restés de ses livres perdus, remis en ordre, Frantin, Dijon ( voll.). Bibliografia (), Lettres familières, édition critique, Centre Jean Bérard, Napoli ( voll.). (), Les “Lettres familières” du Président de Brosses: le voyage en Italie comme exercice du loisir lettré, in J.-M. André, J. Dangel, P. Demont (éds.), Les loisirs et l’héritage de la culture classique, Latomus, Bruxelles. GIACOMELLI A. (), Carlo Grassi e le riforme bolognesi del Settecento: . L’età lambertiniana, in “Quaderni Culturali Bolognesi”, III, . Lettres du Président de Brosses à Charles-Catherine Loppin de Gemeaux (), publiées pour la première fois avec une introduction et des notes par Y. Bezard, Firmin-Didot, Paris. BROSSES CH. DE FUMAROLI M. LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR O CENT’ANNI DI NEGRITUDINE di Valeria Pompejano Nel corso dell’anno il mondo della francofonia ha celebrato, nel centenario della nascita, il suo padre fondatore: Léopold Sédar Senghor. Affiancandosi alle molteplici iniziative con cui si è voluto rendere omaggio al poeta, allo statista, all’intellettuale, con spettacoli, mostre, convegni, proiezioni, pubblicazioni e altro a Parigi e a Dakar, naturalmente, ma anche ad Alessandria d’Egitto, a Bucarest, a Ginevra, a Roma anche l’Università Roma Tre ha voluto accogliere la proposta dell’Organisation Internationale de la Francophonie, riunendo nella giornata del novembre studenti e studiosi in una riflessione sull’attualità del pensiero di Senghor e sullo stato del suo lavoro per l’affermazione dei valori e degli ideali della francofonia moderna. Sono dunque molto felice di pubblicare il testo del mio intervento a quella manifestazione in questo secondo numero del “Quaderno del Dipartimento di Letterature Comparate”, che riconosce tra le ragioni stesse della sua esistenza l’importanza del dialogo fra le culture: tema fondante dell’opera di Senghor, grande teorico della diversità culturale. Senegalese della cittadina costiera di Joal a sud di Dakar, Senghor nasce nel in una famiglia della borghesia benestante sérère, etnia minoritaria in quel paese, che conservava la tradizione di aggiungere al patronimico il cognome sérère: in questo caso Sédar, il cui significato è precisamente «colui che non si può umiliare». Dopo gli studi alla missione cattolica di Joal prima e poi presso i Padri della Congrégation du Saint-Esprit dove imparò a esprimersi in un francese perfetto, Senghor proseguì a Dakar gli studi secondari. Il suo biografo Armand Guibert () riconoscerà in questi anni di formazione i fondamenti del suo destino futuro: la serietà, il gusto di un mondo in cui il piacere non è peccato, il senso della comunità, l’attaccamento alla tradizione, un amore sensuale per il linguaggio alimentano e strutturano il suo immaginario. Dal è a Parigi, città dal cielo senza colore, città dell’esilio dalla propria famiglia umana, quella che nella sua concezione si estendeva fino a comprendere gli antenati sepolti. Ma Parigi è anche il luogo che continuamente solleciterà la sua vivacissima curiosità: con i suoi musei, biblioteche, castelli, giardini pieni di storia, di presenze; è anche il luogo dove trova, nei corsi preparatori al concorso all’Ecole Normale Supérieure, condiscepoli come Thierry Maulnier, Paul Guth, Georges Pompidou, la futura élite intellettuale francese, con i quali condividere il piacere del commercio intellettuale, della riflessione sulle ideologie sociali e politiche. VALERIA POMPEJANO Alla Cité universitaire, dove entra da studente, si lega d’amicizia con il martinichese Aimé Césaire e il guyanese Léon Gontran Damas, i futuri grandi poeti, con i quali fonda nel la rivista “L’Etudiant noir”, sulle cui pagine si svilupperà il movimento per l’affermazione della negritudine, neologismo introdotto da Aimé Césaire che ne darà la seguente definizione in un celebre testo pubblicato nel nel Cahier d’un retour au pays natal: «La négritude est la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire, de notre culture» (La negritudine è il semplice riconoscimento del fatto di essere negro, e l’accettazione di questo fatto, del nostro destino di Negro, della nostra storia e della nostra cultura). Il concetto si è poi sviluppato e arricchito nel tempo pervenendo a significare la visione del mondo dei negro-africani: il loro modo di sentire e comprendere la realtà, la natura, gli uomini, gli avvenimenti, così come il loro modo di creare. L’illustrazione di quest’idea si trova diffusa negli scritti di Césaire e di Senghor, che ne mettono in luce di volta in volta i diversi aspetti. Di Senghor si cita spesso questa sintesi: «La négritude est le patrimoine culturel, les valeurs et surtout l’esprit de la civilisation négro-africaine» (Kesteloot, , p. ) (La negritudine è il patrimonio culturale, i valori e soprattutto lo spirito della civiltà negro-africana). Questo termine godrà come è noto di una grande fortuna per il tramite di Jean-Paul Sartre () che vi riconoscerà «une certaine attitude affective à l’égard du monde» (un certo atteggiamento affettivo nei confronti del mondo), ma soprattutto attraverso il lavoro instancabile di Senghor. Nell’articolo De la négritude. Psychologie du Négro-Africain pubblicato nel sul n. della rivista “Diogène”, scriverà che il Negro è l’uomo della Natura con la quale comunica attraverso i cinque sensi, strumenti di conoscenza più immediati e non meno efficaci dell’intelligenza oggettiva di ascendenza cartesiana. Al «tutto scorre» di Eraclito, egli oppone il «tutto danza» del negro africano. Per lui è il ritmo ad animare l’universo: nelle forme, nei colori, nel movimento stesso. In tale concezione del mondo risultano sensibilmente ridimensionati l’individualismo e la razionalità: l’uomo non può essere pensato né può vivere che in gruppo, perché tutto ciò che emana da lui è un appello all’Altro, partecipa dell’esistenza dell’Altro. Ecco perché l’Arte secondo Senghor non potrà essere che impegnata, funzionale e sociale, fornendo con questo il corollario necessario alle scoperte etnografiche coeve che concordavano sull’esistenza e l’autonomia di civiltà molteplici e non meno degne della Civiltà unica di cui l’Europa aveva rivendicato per secoli il tirannico privilegio. Cittadino francese naturalizzato dal , partecipa dal alla seconda guerra mondiale arruolato nell’esercito francese. Fatto prigioniero l’anno successivo viene internato nei campi di concentramento, da cui uscirà nel per ragioni di salute. Si impegna subito nella Resistenza cui partecipa nel quadro del Fronte nazionale universitario. Nel , al termine del conflitto, torna alla sua cattedra di linguistica all’Ecole nationale de la France d’Outre-mer che occuperà fino al , l’anno dell’indipendenza del Senegal. Ma, soprattutto, dalla guerra Senghor torna poeta, poeta grande, un poeta che si è sbarazzato delle pesantezze degli anni della formazione. Avendo riconosciuto la fonte di ogni propria azione e gesto nell’aspirazione alla libertà, comincerà a libera- LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR O CENT ’ ANNI DI NEGRITUDINE re la forma poetica in una versificazione personalissima in cui la lezione di Baudelaire e di Rimbaud, filtrate al versetto di Claudel, incontrano il ritmo dei canti africani. Rompe con l’idea parnassiana dell’arte per l’arte per orientarsi presto verso una poesia di servizio, poesia impegnata in cui la lingua francese si arricchisce di nuova linfa al ritmo del vento africano o del movimento sensuale delle danzatrici. E il canto di Senghor nella lingua dell’Altro sarà sempre un inno di fedeltà e di devozione alla sua Africa. Ma la lingua dell’Altro non sarà mai intesa da Senghor come la lingua del nemico, del colono oppressore; la lingua francese al contrario sarà per lui quella della conoscenza, la lingua del paese che lo ha accolto tra i suoi, il paese verso il quale manterrà sempre un atteggiamento di lealtà sia pure all’occasione duramente critica. Questo gli verrà nel tempo variamente imputato: spesso è stato accusato dai suoi di ambiguità, laddove, passati i primi anni di reazione a scuotere «la poussière de la Civilisation», non avrebbe in fondo rinunciato mai a essere francese: «Senghor n’est vraiment sincère que lorsqu’il avoue être un métis culturel!» (Kesteloot, , p. ) (Senghor non è davvero sincero se non quando si dichiara un meticcio culturale). Nella forma di una lunga Lettre à trois poètes de l’hexagone , pubblicata in appendice alla raccolta delle Elégies majeures del , Senghor espone gli argomenti forti della sua idea di francofonia. Richiamandosi a una sorta di meticciato biologico riscontrabile nelle ascendenze africane delle popolazioni del bacino del Mediterraneo, passa a riconoscere nella poesia di Baudelaire, il primo cantore della Vénus noire, la scoperta delle misteriose corrispondenze che la conoscenza immediata e sinestetica ci rivela nella Natura, e soprattutto riconosce nella scrittura sovversiva del Rimbaud di Une saison en enfer il lucido recupero della funzione del simbolo nelle categorie conoscitive negro-africane, istintivamente orientate alla creazione di un verbo poetico accessibile a tutti i sensi: da lì Rimbaud aveva introdotto nella versificazione francese la corporeità della parola con il colore delle vocali, la forma e il movimento di ogni consonante, armonizzate secondo ritmi istintivi inediti. È noto, e Senghor ne ripercorre sinteticamente le tappe salienti, quanto importante sia stata nell’elaborazione delle categorie estetiche novecentesche la scoperta dell’arte negra e l’apporto di materiali negro-africani nel genio della lingua francese. Ma, avverte Senghor, in quel fertile passaggio la cultura francese si nutriva anche dei “valori” negri, assimilando nella lingua poetica quelle immagini analogiche della simbologia negra, complesse e polivalenti di cui è intessuta la poesia contemporanea non soltanto francese ma europea. La francofonia è dunque l’esito di questa comunicazione fertile, di questa osmosi culturale, dell’invenzione e valorizzazione di un nuovo spazio linguistico comune in perpetuo divenire, in cui continuamente si ricostruisce un’identità culturale aperta e, come voleva lui, universale. La lingua francese nell’incontro con l’alterità africana si arricchisce infinitamente, ma esce depotenziata della sua funzione di veicolo dello spirito dell’Occidente. Dichiarerà sempre con semplicità e convinzione il suo doppio amore per l’«Afrique maternelle» e per l’Europa «à qui nous sommes liés par le nombril». Il personale impegno nella lotta di liberazione della Francia occupata gli fornirà argomenti inconfutabili per la missione che si è assegnato: fare dei suoi degli uomini padroni del loro destino, e del suo popolo una nazione. E i problemi connessi al dibattito su assimilazione o integrazione per lui si troveranno superati d’un colpo: in un movimento di grandi conquiste sociali e culturali. VALERIA POMPEJANO Il gruppo di giovani che si riunisce intorno alla rivista “Présence africaine” richiama l’attenzione degli intellettuali francesi sulle rivendicazioni delle popolazioni di colore per la prima volta federate. Nel , insieme alla raccolta poetica di Hosties noires, Senghor pubblica una Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, introdotta da un celebre testo di Jean-Paul Sartre intitolato Orphée noir. L’antologia riunisce testi dei migliori talenti lirici della Martinica, di Haiti, del Madagascar, del Senegal, di tutti i paesi africani di lingua francese, rappresentando per la prima volta agli occhi del mondo la testimonianza dell’unità profonda di un’ispirazione ancestrale in un canto comune. Quell’Anthologie, come è noto, suscitò grande scalpore anche per le dichiarazioni esplosive di Sartre, il quale concludeva che la poesia negra è evangelica, che annuncia la buona novella della Negritudine ritrovata. Sarà l’atto di nascita di un movimento inarrestabile verso la pratica di un ideale: quello della coscienza dell’unità culturale del mondo nero. Nel la Conferenza di Bandung sancirà la nascita di una nuova era; nel il primo “Congrès mondial des Ecrivains et Artistes Noirs” terrà le sue assise alla Sorbonne di Parigi; tre anni più tardi, a Roma, nel corso dei lavori del secondo congresso, Senghor illustrerà le linee di forza e gli aspetti costruttivi di una cultura d’ispirazione nero-africana, ponendo l’accento sugli scambi piuttosto che sulle differenze. Liberato da ogni residuale complesso di inferiorità, il “Nègre Nouveau” non deve abbandonare la via maestra della tradizione, ma praticare la cooperazione attraverso il dialogo. Senza rinunciare agli ideali universalistici del socialismo degli anni della formazione, perverrà a quel fine assecondando il proprio personale talento attraverso una via rispettosa dell’Altro e di Sé: la via più autenticamente africana. Il resto è storia nota. Proclamato all’unanimità nel primo Presidente della Repubblica del Senegal, ha assicurato – nonostante le indubbie ombre – al suo paese vent’anni di pace, attraverso un’infaticabile attività di lavoro politico all’interno e all’estero, ma senza mai tralasciare la sua attività più intima e cara: la scrittura, motivo e nutrimento per ogni altra sua azione nella vita, contraddicendo l’opinione comunemente invalsa nel Novecento che tra colui che scrive e colui che vive c’è uno iato profondo. In Senghor ogni barriera tra politica e poesia viene infranta, la separazione tra arte e vita abolita. La sua poesia, essenzialmente simbolista, fondata sul canto e sull’incanto della parola creatrice, è tutta intrisa dell’ideale da cui pure muove, di una «Civilisation de l’Universel» in cui tutte le tradizioni culturali sono destinate a incontrarsi al di là delle differenze. Egli riconosceva dunque al linguaggio simbolico della poesia il potere di costituire il fondamento di quel progetto. La fisicità della sua poesia, l’abbandono all’evocazione sensoriale sostanziano la sua idea di negritudine nel ritmo come nella prosodia. Filologia e fisiologia, ha scritto Carlo Castellaneta, il traduttore ufficiale della poesia di Senghor nella nostra lingua, concorrono nella singolare elaborazione senghoriana della tecnica surrealista: «Al lettore si presenta una sequenza di immagini disparate da sistemare con una [faticosa] operazione associativa: il villaggio chiama il leone, l’uccello ritorna nella mitologia, il seno prende il nome del monte, il sangue è gazzella, sacrificio, libagione» (Castellaneta, ). Questo andamento a briglia sciolta che può provocare una certa esitazione nel lettore non ancora padrone del cifrario poetico di Senghor, «la sua esigenza enumera- LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR O CENT ’ ANNI DI NEGRITUDINE tiva, l’aggettivazione reiterata e aggressiva, sono anche la sua qualità di negro, il suo vigore» (ibid.). Del resto, lui stesso nella Postfazione alla raccolta delle Ethiopiques del aveva scritto che il ritmo, che nasce dall’emozione, genera a sua volta l’emozione e anche l’humour, l’altra faccia della negritudine, dimostrando la sua polivalenza. La presunta monotonia del tono, che peraltro è ciò che distingue la poesia dalla prosa, è per lui il sigillo della negritudine, l’incanto che permette di accedere alla verità delle cose essenziali, alle forze del Cosmo. A scandire la pubblicazione delle raccolte poetiche di Senghor pubblicate dal in poi – ricordo, oltre a Hosties noires () già citata, le raccolte di Ethiopiques (), Nocturnes (), Lettres d’hivernage (), Elégies majeures () – c’è stata la pubblicazione dei cinque saggi Liberté che dal in avanti sono apparsi nelle Éditions du Seuil rispettivamente con i titoli: Liberté : Négritude et Humanisme (); Liberté : Nation et voie africaine du Socialisme (); Liberté : Négritude et Civilisation de l’Universel (); Liberté : Socialisme et Planification (); Liberté : Le Dialogue des cultures (). Introducendo il primo e fondamentale di quei saggi, intitolato appunto: Liberté : Négritude et Humanisme, dichiarava che la conquista della libertà si deve intendere come il recupero e l’affermazione, la difesa e l’illustrazione della personalità collettiva delle popolazioni nere: cioè della negritudine. […] la Négritude, c’est, comme j’aime à le dire, l’ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu’elles s’expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des Noirs. Je dis que c’est là une réalité: un nœud de réalités. Ce n’est pas nous qui avons inventé les expressions «art nègre», «musique nègre», «danse nègre». Pas nous la loi de «participation». Ce sont des blancs européens. Pour nous, notre souci, depuis les années -’, notre unique souci a été de l’assumer, cette Négritude, en la vivant, et, l’ayant vécue, d’en approfondir le sens. Pour la présenter, au monde, comme une pierre d’angle dans l’édification de la Civilisation de l’Universel, qui sera l’œuvre commune de toutes les races, de toutes les civilisations différentes – ou ne sera pas. C’est en cela que cette Négritude ouverte est un humanisme. Elle s’est enrichie, singulièrement des apports de la civilisation européenne, et elle l’a enrichie. Humanisme, en ce XXe siècle de la «convergence panhumaine», ne saurait consister qu’en ce commerce du cœur et de l’esprit: en ce «donner et recevoir» (Senghor, , Introduction). (La negritudine è l’insieme dei valori culturali del mondo nero come si esprimono nella vita, nelle istituzioni e nelle opere dei Neri. I bianchi europei hanno inventato l’arte negra, la musica negra, la danza negra, nonché la legge della partecipazione. Per noi si tratta di assumerla questa negritudine, vivendola, quindi, avendola vissuta, di approfondirne il senso per poi presentarla al mondo come pietra angolare nell’edificazione della Civilisation de l’Universel, che sarà l’opera comune di tutte le razze, di tutte le diverse civiltà. Così o niente. Perciò questa negritudine aperta è un umanismo. Essa si è arricchita dei contributi della civiltà europea e l’ha a sua volta arricchita. L’umanesimo del XX secolo non potrebbe dunque non consistere in questo rapporto di dare e avere). Si deve a Senghor la promozione del concetto di negritudine tra le idee forti del XX secolo. Nel la rivista letteraria “Présence africaine” ha consacrato un numero speciale Hommage à Senghor, per celebrare il poeta, grandissimo, ma con lui il pensatore e VALERIA POMPEJANO particolarmente «l’autorité qui, plus que tout autre, a contribué à éveiller une âme à la civilisation noire dans le monde moderne» («l’autorità che più d’ogni altra ha contribuito a risvegliare un’anima alla civiltà nera nel mondo moderno»). Nessuna voce infatti, prima di quella di Senghor, aveva ricordato questa evidenza al mondo. Nessuna voce aveva saputo riconoscere l’apporto dell’Occidente a quella che lui definiva «la Civilisation de l’Universel» e al tempo stesso aveva affermato con instancabile fervore la presenza e l’identità culturali dei popoli neri come sostanziale allo sviluppo di quel grande progetto. Per primo, e non è inutile sottolineare questa specificità della sua riflessione, Senghor ha proclamato la priorità dell’indipendenza culturale sull’indipendenza politica. Sapeva bene quanto importante fosse per i neri conquistare la loro sovranità culturale. Sapeva bene che far rispettare la personalità dei neri significava contestualmente porre finalmente il problema della solidarietà culturale tra le diverse popolazioni nere, per garantire il riconoscimento e la salvaguardia dei loro valori e il rispetto della loro dignità. Il Rinascimento della civiltà nera lo interessa quanto, se non più, dello sviluppo economico del suo Senegal, perché sa che quello sviluppo è necessariamente legato alla crescita di una coscienza culturale chiara e sicura della propria capacità creativa e propositiva. Sull’intuizione dell’unità culturale del mondo nero, il politico Senghor si era così messo al servizio del poeta per promuovere la solidarietà culturale dei popoli neri. Per concludere, mi piace ricordare che l’Istituto di Francese della vecchia Facoltà di Magistero, nucleo originario della Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre, nel lontano è stato il primo Istituto universitario in Italia ad acquistare la collezione completa e ad abbonarsi alla rivista “Présence africaine”, nonché a promuovere lo studio delle letterature francofone, ad attivare gruppi di ricerca interuniversitaria intorno alle letterature dei paesi emergenti che hanno suscitato negli ultimi trent’anni filoni di studio vivacissimi di alto profilo scientifico. Dalle prime prudenti letture di quegli anni, fino agli studi che oggi vengono condotti nel vasto campo delle letterature francofone, credo di poter affermare con un margine molto basso di errore che non c’è saggio, articolo, monografia, edizione che in qualche parte del testo o anche in una piccola nota non faccia riferimento a Léopold Sédar Senghor, al cui contributo fondamentale nella rielaborazione delle categorie della cultura credo oggi tutto il mondo intellettuale senta di dovere e di volere con profonda gratitudine rendere omaggio. Bibliografia CASTELLANETA C. (a cura di) (), Introduzione a Senghor. Antologia lirica, Sansoni-Accademia, Milano. (), Cahier d’un retour au pays natal, in “Volonté”, n.s. (con una Préface di André Breton, Bordas, Paris ). EMINA A. (a cura di) (), Nuit d’Afrique ma nuit noire/Notte d’Africa mia notte nera, traduzione di testi poetici di L. Sédar Senghor, l’Harmattan Italia, Torino. GUIBERT A. (), Léopold Sédar Senghor, l’Homme et l’Œuvre, Présence africaine, Paris. CESAIRE A. LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR O CENT ’ ANNI DI NEGRITUDINE ID. (), Hommage à Léopold Sédar Senghor, Homme de Culture, Présence africaine, Paris. KESTELOOT L . (), Les écrivains noirs de langue française: naissance d’une littérature, Université Libre de Bruxelles-Institut de Sociologie, Bruxelles. (), Anthologie négro-africaine. Panorama critique des prosateurs, poètes et dramaturges noirs du XXe siècle, Gérard et C., Verviers. SÉDAR SENGHOR L. (), Chants d’ombre, Seuil, Paris. ID. (a), Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, précédée d’Orphée noir de J. P. Sartre, PUF, Paris. ID. (b), Hosties noires, Seuil, Paris. ID. (), Chants pour Naett, Seghers, Paris. ID. (), Ethiopiques, Seuil, Paris. ID. (), Nocturnes, Seuil, Paris. ID. (), Liberté : Négritude et humanisme, Seuil, Paris. ID. (), Elégie des alizés, Seuil, Paris. ID. (), Liberté : Nation et voie africaine du socialisme, Seuil, Paris. ID. (), Lettres d’hivernage, Seuil, Paris. ID. (), Paroles, Les NEA, Dakar. ID. (), Liberté : Négritude et civilisation de l’universel, Seuil, Paris. ID. (), Elégies majeures, suivi de Dialogue sur la Poésie francophone, Seuil, Paris. ID. (), La poésie de l’action, Stock, Paris. ID. (), Liberté : Socialisme et planification, Seuil, Paris. ID. (), Œuvre poétique, Seuil, Paris. ID. (), Liberté : Le dialogue des cultures, Seuil, Paris. ID. LA TENTAZIONE, IL VOLO E LA VISIONE: TRE TEMPI DE L’IMAGE D’UN MAGE OU LE SPIRITUEL DI ANDRÉ MAGE DE FIEFMELIN di Luigi Magno La rovina degli ideali e dei miti di prosperità fioriti in epoca rinascimentale consegue alla congerie di conflitti politici, militari e religiosi che la Francia conosce, in un contesto di crisi europea generale, nella seconda metà del XVI secolo. Quella felice congiuntura storica che aveva nutrito gli ideali dell’harmonia mundi e della dignitas hominis si spezza nell’autunno del Rinascimento, lasciando proliferare rizomi di crisi che determineranno il crollo progressivo delle concezioni umanistiche. La circolazione di vecchie intuizioni e nuove idee (Copernico e l’eliocentrismo), la scoperta di nuovi continenti e l’idea di nuove dimensioni possibili (Bruno e l’infinità dei mondi), i progressi della stampa e dei suoi circuiti di distribuzione determinano, tra altri fattori, una scossa relativistica nei campi del sapere. La centralità dell’uomo nel cosmo si perde, le certezze decadono rivelando tutti i limiti della conoscenza, mentre angosce metafisiche riappaiono nell’immaginario collettivo e le verità sembrano cedere il passo all’informe, al proteiforme e all’instabile. In un universo così sconvolto le idee entrano in fermento e gli uomini di lettere, tra incertezza gnoseologica e inquietudine ontologica, danno voce alla disparità delle loro attese. Le correnti di pensiero si incrociano tuttavia in modo inestricabile e le tendenze letterarie evolvono nel senso di una continua ibridazione; la contraddittorietà di quegli anni appare più complessa delle categorie che usiamo per descriverla, rendendo così spinoso ogni tentativo tassonomico. La produzione dei poeti francesi della fine del XVI secolo è sintomatica della frattura profonda tra, da un lato, la pienezza epistemologica e il culto delle certezze sull’uomo che il Rinascimento aveva coltivato, e, dall’altro lato, l’epoca di crisi in cui questi valori si annientano, si frammentano, si dislocano. Allo scollamento metafisico tra terra e cielo fa eco la rottura linguistica tra cose e parole (Foucault, ) che fa piombare il furore poetico rinascimentale nei labirinti di una «poétique de crise» (Clément, ). Il paradosso generalizzato domina l’epoca e spinge i poeti alla riflessione: la poesia non è più il luogo della verità (modello “omerico”) ma lo spazio del questionnement, il luogo dove si pongono domande, dove si cercano, eventualmente, soluzioni o risposte. Certo, il primo interrogativo è di tipo autocritico, e riguarda la poesia stessa, le sue condizioni di possibilità e di validità, la sua influenza, il suo statuto (può ancora la poesia pretendere di dire il vero?). Forse i suoi strumenti non sono proprio intatti: prova ne è la sfiducia nel segno linguistico, nelle sue capacità di dire, di trasmettere, che dà impulso a tutte quelle pratiche sincretiche come gli emblemi, i rebus (il bisogno di allegare l’immagine per avallare le potenzialità del verbo) o i carmi figurati. In queste condizioni, se alcuni poeti propongono un abbandono vitalistico, sensualistico, all’incostanza, altri si interrogano alla ricerca LUIGI MAGNO di soluzioni, di quelle certezze o quella costanza a cui appigliarsi (non dimentichiamo qui coloro che, come ad esempio Montaigne, propongono il sincretismo e il relativismo quale chiave possibile allo smarrimento delle coscienze, e pensano il compromesso come soluzione pacifica ai conflitti). I poeti protestanti trovano il loro saldo appiglio in Dio, principio e termine di ogni cosa, attorno al quale tutto si organizza. Nei versi di alcuni le brutalità delle vicissitudini contingenti si riverberano in modo più diretto, conferendo ai loro componimenti una caratura visibilmente militante (si pensi alle Tragiques di Agrippa d’Aubigné). In altri poeti riformati, invece, quella stessa inquietudine prende la via della meditazione introspettiva, della riflessione personale e intima, dunque una forma sostanzialmente lirica (e di effusione con Dio e la sua chiesa). I versi di questi ultimi danno voce a una lotta interiore, solo apparentemente disancorata dagli avvenimenti circostanti: si tratta infatti in entrambi i casi di formule poetiche differenti che rimandano a una stessa militanza in favore della chiesa riformata e della dottrina protestante. La lettura di alcuni sonetti di André Mage di Fiefmelin non sarà che una delle possibili interpretazioni della sua raccolta di liriche, dunque una lettura parziale. Scegliendo tre momenti significativi de Le spirituel (la tentazione mondana, il volo e la visione), si è voluto riprendere, nell’ordine, l’orchestrazione evidente che organizza l’opera in sette essays. Si tratta di un percorso classico che dalla realtà mondana corrotta giunge all’esaltazione di Dio, passando dalla celebrazione dell’anima (L’ame humaine) o ancora attraverso il canto del dramma personale del credente (Saincts souspirs). Nella raccolta dei suoi versi, il tono generale è quello della meditazione (sul mondo, Dio, il peccato, la grazia), ma il percorso che il poeta organizza è lontano dall’essere una traiettoria in linea retta. La simbolica ascesa dell’anima dal mondo a Dio si svolge infatti nell’opera secondo forme e modi che potrebbero evocare piuttosto l’immagine di una linea serpentinata: continue riprese o anticipazioni deviano dalla naturale progressione verticale di tale percorso senza tuttavia sconvolgerne i presupposti. Si dirà altrove di questa mancanza di linearità e della varietà polifonica (o forse atonale) de Le spirituel. Qui ci limiteremo alla lettura di quattro sonetti di cui si cercherà di mettere in luce forme e motivi non senza richiamare alla mente, sotto forma di fil rouge, quella contiguità imitativa Fiefmelin-Sponde che, se ben funziona sul piano dell’elocutio, meno si adatta, a volte, agli esiti finali della poesia di Fiefmelin. Quest’ultimo non è stato il poeta creatore di sistemi simbolici originali (parlare di originalità per la produzione dell’epoca è senza dubbio fuorviante e restrittivo) che si segnalino per i loro tratti distintivi. Fiefmelin resta un emulo di Sponde ma la sua poesia, come tenteremo di mostrare, non converge sempre con le posizioni spondiane. Peccati mondani Il monito biblico del «vanitas vanitatum et omnia vanitas» (Qohelet, I, ) e, più in generale, tutti i contenuti dell’Antico Testamento costituiscono, nella loro eterogeneità, la fonte maggiore di quei temi come il contemptus mundi, il taedium vitae, o ancora la miseria hominis, motivi attorno ai quali una copiosa tradizione di pensiero antico ha meditato. LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE Jean Delumeau (, pp. -) ha ampiamente mostrato in che modo i motivi del disprezzo del mondo e quello della svalutazione dell’uomo, affondando le proprie radici negli scritti biblici (Salmi, Vangeli), siano stati declinati congiuntamente dalla tradizione letteraria e religiosa già in epoca medioevale. Ora, quello stesso pessimismo ha alimentato anche la dottrina protestante, che ha ripreso con grande virulenza i temi dell’odio del corpo e della decadenza/corruzione del mondo, inquadrandoli in una radicale sfiducia circa la natura umana e l’uomo. La diagnosi dei riformati è allarmante e perentoria. La natura umana non è altro che peccato e quindi morte dell’anima. La morte è il prezzo da pagare per la colpa prima da cui solo la grazia di Dio – che istilla fede nei credenti, ed è dunque amore – può liberare. Gli uomini, tutti parimenti macchiati dal peccato, si dividono tra gli eletti – i rigenerati – a cui Dio accorda la grazia destinandoli alla salvezza dell’anima, e i reprobi, che, malgrado eventuali opere di pentimento, nulla potranno contro la sorte cui sono stati predestinati. Solo gli eletti, tra cui il poeta protestante si annovera, hanno la capacità di comprendere le due istanze che nel mondo convivono scontrandosi, mentre agli empi privi della grazia non è dato dirimere i segni di vita (segni dell’amore di Dio che salva l’anima) e quelli di morte contemporaneamente presenti al mondo. Attorno a questa divisione prende piede una serie di dualismi o di opposizioni, sia all’interno della teologia protestante sia nella poesia che a essa si ispira. Quella stessa opposizione tra virtù e fortuna che tanto aveva fatto dibattere il Rinascimento torna adesso sotto i termini di costanza e incostanza, carne e spirito, bene e male, cielo e terra. Nel secondo essay de Le spirituel (L’homme naturel) André Mage consacra i suoi versi ai temi del peccato e del male mettendo particolarmente in luce la decadenza fisica dell’uomo nel mondo. Tale posizione rientra certo nei dogmi della teologia riformata e protestante ma, come osserva Marcel Raymond (b, p. ), in L’homme naturel gli aspetti fisici e materiali dell’abiezione umana fanno di questa sezione la parte più fisica della sua opera. Vi si susseguono descrizioni di malattie, di sofferenze, di deformazioni fisiche e quant’altro il corpo umano può conoscere nelle sue forme più abiette di corruzione, suggerendo una relazione diretta tra corruzione morale (peccato) e corruzione fisica. In un suo sonetto, definito da Marcel Raymond (b, p. ) come «le plus moderne» di tutti i sonetti di Fiefmelin, André Mage esemplifica questa coscienza del peccato attraverso la descrizione dell’uomo alle prese con la tentazione carnale: Ja la nuict couvroit l’air de ses aisles humides, Et l’amour annuictoit de mon esprit les yeux: Quand je sors en la rue, et cours me perdre ez lieux Où m’appelloit la femme ayant ses feux pour guides. Homme de cœur failly, mais de sens non timides! De jour je craignois l’œil du monde vitieux, Non l’œil de Dieu jamais. Dont Christ, voyant des Cieux Mon naufrage, m’en sauve, et jette aux ports Hermides. Puis me dardant à vie un œil de foudre clair, Dont en l’eau de sa grace avoit trempé l’esclair, Qui les sens m’esblouit et me foudroya l’ame: LUIGI MAGNO Va-t’en, dit il, en paix: ne peche. Et au dedans M’eslança mille coups et mille feux ardens. Donc en iray-je en paix tout en sang et en flamme? Fiefmelin orchestra qui il récit di un «je» in modo stilisticamente travagliato, attraverso il ricorso a uno stile spezzato. Il taglio sintattico delle frasi non rispetta infatti la struttura strofica: se la prima quartina forma una frase, la seconda quartina contiene almeno due frasi (o forse tre, se si considera il v. come una frase nominale, anche se questo verso pare essere piuttosto un’apposizione in forma esclamativa del «je» del v. ); una terza frase si estende sulla prima terzina occupando le prime otto sillabe del v. ; la quarta frase, tramite un enjambement, occupa le ultime quattro sillabe del v. e tutto il v. , mentre il v. conclude il sonetto con un’interrogativa retorica. Il ricorso alla figura dell’enjambement e la pratica sistematica della rottura delle frasi rispetto alle misure dettate dai versi o dalle strofe drammatizza e anima il racconto. L’intento è quello di far esperire al lettore una fruizione convulsa, tormentata, di quanto vive l’io della finzione poetica attraverso i quattro momenti in cui si articola il contenuto del poema, ovvero: il richiamo carnale esercitato dalla donna (vv. -); l’intervento di Cristo (vv. -); l’immagine del peccatore «foudroyé» ma destinato ad andare via «en paix» (vv. -); infine, l’impossibilità di vivere questo stato contraddittorio (i due emistichi del v. formano una sorta di ossimoro in cui la «paix» si oppone al «sang» e alla «flamme» quali immagini di guerra simbolica). Le opposizioni e le antitesi strutturano tutto il sonetto. La divisione tra la notte e il giorno, per esempio, è l’opposizione che polarizza una serie d’antitesi. Nei primi due versi, attraverso la corrispondenza di due soggetti («la nuit» e «l’amour»), due verbi («couvroit» e «annuictoit») e due complementi oggetto («l’air» e «les yeux de mon esprit»), si stabilisce un parallelismo sintattico nel quale la notte è metafora dell’amore fisico. La notte s’associa alla tentazione carnale, dunque alle tenebre del male, fino a confondersi con lo stato di peccato: questa immagine, condensando la metafora della vita mondana come tenebra, fa coincidere di fatto la vita macchiata dal peccato con la morte dello spirito. Al contrario, alla vita eterna ultramondana è associato il simbolismo solare della luce, identificabile con la redenzione mediata dalla grazia di Dio. Alla notte infatti si oppone il «jour» (v. ), da intendersi come luce in senso lato: quella solare, che rende il poeta timoroso («je craignois», v. ), ma anche quella prodotta dai fuochi o da altre fonti («foudre clair», v. ; «l’esclair», v. ; «foudroya l’ame», v. ). Oltre la dialettica tra il giorno e la notte, altre opposizioni sono orchestrate attorno ad accezioni diverse della stessa immagine. Si consideri il tema dell’acqua. Nel sonetto, più che indicare l’eterno passaggio e diventare il simbolo della mobilità incessante o dell’inconsistenza per eccellenza, questa immagine è orchestrata in un raffinato gioco di antitesi tra le sue connotazioni . L’immagine sottesa alle «ailes humides» del v. è quella ben nota della notte personificata, secondo un luogo comune poetico, dal pipistrello. Nell’iconografia del Rinascimento questo uccello simboleggia la donna feconda, essendo l’unico volatile provvisto di mammelle, così come nella tradizione biblico-alchemica esso è un animale impuro, ibrido (androgino), demoniaco (Chevalier, Gheerbrant, , s.v.). L’umidità di queste ali pare essere un riferimento a non meglio definite viscosità femminili, sintomatiche della biblica impurità che la legge mosaica fa pesare sulla donna. Ora, sfruttando la polisemia dell’immagine, l’umidità carnale e peccaminosa è in antitesi con la funzione salvifica LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE dell’acqua, funzione evidente in almeno due luoghi del sonetto: i «ports Hermides» del v. e «l’eau de sa grace» del v. . L’orchestrazione del sonetto si complica attraverso il ricorso all’immagine del fuoco. Se nel v. i «feux» sono appannaggio della donna, dunque fuochi della passione e invito per la carne, al v. i «feux ardens» (a cui si associano forse pleonastici «coups») ripropongono la stessa immagine nel suo risvolto spirituale. Nella terzina infatti sono i fuochi santi, la forza incendiaria di Dio, che creano le condizioni necessarie affinché il peccatore possa redimersi: Acqua (porto/vita) Fuoco (tentazione/morte) Fuoco (salvifico/non morte) Acqua (naufragio/non vita) Si potrebbe obiettare che, nell’economia della prima strofa, la presenza dei fuochi al v. invalidi l’interpretazione proposta circa l’umidità delle ali; allo stesso tempo, la doppia declinazione di queste immagini conferisce al sonetto quella densità che la struttura sintattica dello stesso tradisce. Nella seconda quartina il v. oppone, nei suoi due emistichi, il «coeur» ai «sens» attraverso un’avversativa («mais») anche se l’idea che le due parti del verso esprimono è identica: si tratta di dire il peccato («failly») e il diabolico perseverare del peccatore nel male («non timides»). Alla fine della strofa interviene già il motivo della salvezza (preannunciando quello della grazia) che è centrale nelle terzine. Si tratta, al v. , della metafora della salvezza (e di una nuova antitesi) che il peccatore trova, dopo il «naufrage» (perdizione), nei «ports Hermides». L’immagine dei «ports Hermides» è senza dubbio metafora della salvezza dell’anima, approdo di quella navigazione tribolata in acque sempre insidiose, minata perennemente dal peccato che solo gli eletti sanno riconoscere. Resta tuttavia impossibile determinare in modo univoco il significato dell’aggettivo «Hermides». L’attributo, se etimologicamente connesso al greco eremos (solitario, deserto), potrebbe evocare l’idea di un luogo remoto e pacifico: questi porti sarebbero in tal senso la meta agognata e, allo stesso tempo, la ricompensa sperata dal fedele. Si potrebbe altresì leggere «Hermides» come un nome proprio che rimanderebbe a una tradizione antica: in questa direzione, si è pensato di interpretare l’attributo come «sous la protection de Saint-Elme» (Raymond, a, p. ). Il fuoco di sant’Elmo appare come un’immagine assai pertinente nell’economia del sonetto perché, in quanto sinonimo di meteora, dunque di guida luminosa, essa ripristina nei versi l’isotopia della luce. Si tratterebbe tuttavia, in senso lato, di un hapax, del solo rinvio a un santo presente nelle Œuvres di Fiefmelin. Si potrebbe supporre allora che l’aggettivo «Hermides» rimandi a un mistero pagano che, malgrado la sua incommensurabile distanza con le verità delle Sacre Scritture, offre tuttavia al lettore una strada allegorica verso le verità divine. Almeno due interpretazioni si rendono così disponibili. La prima sarebbe un richiamo alla mitologia greco-romana, esemplificato dall’immagine di Cristo che si confonde con Ermes/Mercurio (dai tratti di un Giove/Zeus tonante). Questa interpretazione sembra pertinente se si pensa al dio Ermes non tanto nella sua funzione di psicopompo, quanto nelle sue vesti di messaggero degli dèi, inviato per sottrarre gli uomini da situazioni pericolose (la navi- LUIGI MAGNO gazione). Non sarebbe tuttavia da escludere che l’aggettivo «Hermides» contenga un’allusione a Ermete Trismegisto (il dio egizio Toth che i greci avevano assimilato a Ermes), il leggendario autore del Corpus Hermeticum. Non è questo il luogo per soffermarsi sull’influenza esercitata dalla filosofia e la tradizione ermetica (e dalla pratica alchemica che è arte ermetica) sulla poesia di Fiefmelin. Quello che qui si vuole sottolineare è che l’eventuale assimilazione dell’immagine di Cristo con quella di Ermete Trismegisto, il tre volte grandissimo, esemplifica un più vasto processo di sincretizzazione delle conoscenze, il quale si sviluppa in senso antiaristotelico e nel quale antiche tradizioni di origine orientale (cabala, inni orfici, profezie caldee, tradizione ermetica) si fondono con tradizioni più recenti (platonismo, cristianesimo, neoplatonismo). Lo scopo di questa filosofia religiosa, sincretica e assai intricata, è quello di trovare la chiave di conoscenze profonde, l’accesso a una religio universalis, a una conoscenza superiore che si disvela solo attraverso il ricorso a immagini complesse e costruite. Fiefmelin inserirebbe nel suo sonetto il rimando a Ermete Trismegisto non solo per dare rilievo al suo scritto (pensando all’orizzonte d’attesa di un lettore dell’epoca), ma anche per stratificare attorno all’immagine di Cristo nuovi significati: l’accesso ai «ports Hermides» non è forse salvezza dell’anima e, contemporaneamente, anche acquisizione di nuove conoscenze (come la pratica alchemica potrebbe far pensare)? L’approdo al porto, metafora anche della purificazione biblica per mezzo del lavacro dell’acqua, è seguito dall’avverbio «Puis» (v. ) che introduce non solo la prima terzina, ma inaugura contemporaneamente la seconda parte della narrazione. Il sonetto si articola così in due sequenze: un prima, momento del peccato, e un dopo, tempo della salvezza per mezzo dello choc che fulmina («foudre clair», v. ; «esclair», v. ; «esblouit» e «foudroya», v. ). I «sens» scossi (v. ) richiamano i «sens non timides» (v. ) mentre l’«ame» fulminata (v. ) fa eco al «coeur failly» (v. ), formando così un chiasmo che sottolinea il capovolgimento della situazione. Così come i «coups» e i «feux ardens» del v. si riallacciano ai «feux» della donna del v. , si insiste oltremodo sul passaggio dalla situazione di peccato a quella di redenzione, anche attraverso una sottomissione del soggetto: il «je» attivo e pervertito delle quartine diventa, nelle terzine, un soggetto passivo, redento e sottomesso ai disegni divini. Queste ultime segnano dunque la transizione da un amore carnale e peccaminoso a un amore epurato e mistico, anche alla luce di quel cambiamento direzionale che da un movimento centrifugo («je sors en la rue, et cours me perdre», v. ) passa alla vettorizzazione centripeta («au dedans», v. ). Tuttavia, l’ultimo verso, nella sua forma interrogativa, è ambiguo. Lo stato nel quale il poeta versa è certamente antitetico (pace e guerra) e riprende i termini utilizzati tradizionalmente per descrivere la condizione d’innamoramento. È pur vero che una passione ha rimpiazzato l’altra, ma il tormento descritto può comunque essere letto sia come strazio dovuto alla colpa, sia come estasi prodotta dell’amore divino. Il giorno e la notte, la fiamma della tentazione e l’acqua della grazia, il fuoco carnale suscitato dalla donna ( faux feux) e i fuochi santi ravvivati da Dio (saints feux), il naufragio e il porto, la sensualità contro la spiritualità. L’emblematico sdoppiamento ricorda i due cavalli platonici i quali, nel Fedro, trainano il cocchio alato, uno secondo un moto ascensionale, l’altro in direzione terrena e verso la caduta. La vita terrena non è che la morte dello spirito, mentre soltanto la morte del corpo è vita per l’anima del credente graziato da Dio: le opposizioni e le antitesi declinano LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE dunque il contrasto che lacera il poeta e che converge nell’interrogativa del verso finale, proposizione che non dirime la controversia e non risolve le polarità della forza duplice che dilania. Tutto il sonetto è leggibile secondo una dinamica intricata di antitesi che si sviluppano a più livelli. Su un piano generale possiamo osservare un’evidente ripresa – e conseguente rivisitazione – di quello stesso petrarchismo e delle sue coppie antitetiche che avevano informato la prima maniera poetica della Pléiade, o ancora parte della poesia della prima metà del XVI secolo. I temi e le immagini si modellano su quello stesso stampo (la distanza che separa gli amanti, l’accettazione della sofferenza come via di purificazione/espiazione) ma i termini del contrasto sono cambiati. I residui di questa fonte petrarchista, diluiti da una dose di (neo)platonismo e smorzati dagli accenti religiosi, teologici e dogmatici, si fanno ormai espressione del conflitto tra la carne e lo spirito, tra il corpo e l’anima. Si noti qui un doppio retaggio platonico: da un lato l’evocazione del vero amore che spinge, nella dottrina platonica, alla contemplazione del Bene assoluto; dall’altro l’esemplificazione di questo movimento verticale o centrifugo attraverso la vista, ovvero il senso che il neoplatonismo considerava superiore a ogni altro (Desimeur, , pp. -). Platonismo, neoplatonismo e petrarchismo convergono nel topos dello sguardo. All’antitesi tra la notte e il giorno fa infatti eco un’altra opposizione che riguarda il senso della vista: se la notte è oscurità complice del male, essa è dunque accecamento diabolico (cfr. v. ). All’impossibilità di vedere, di notte, Dio o la salvezza, si oppongono le luci del giorno che, come si è già avuto modo di osservare, non solo fanno diventare il poeta timoroso de «l’oeil du monde vitieux» (v. ), ma, nel renderlo timorato di Dio, gli consentono di respingere il male fino a farsi abbagliare dalla luce divina («dardant un oeil», v. ; «m’esblouit», v. ). Nei vv. - Fiefmelin sviluppa una metafora filée dell’occhio: l’«oeil du monde», l’«oeil de Dieu» e Cristo «voyant» (ripreso al v. con «dardant un oeil de foudre clair») ripropongono la stessa immagine che, dopo un primo riferimento alla realtà mondana, viene qui ripresa in accezione divina, salvifica. Dio, che nel sonetto è amore e amato, trasforma e plasma il credente-amante attraverso il «dard». Si tratta di un’immagine dell’occhio di Dio, il cui sguardo si dirige in linea retta verso l’io narrante, come una linea immaginaria descritta da un simbolico raggio di sole. Uno sguardo che tuttavia è quanto meno duplice: un monito per il peccatore (il ricordo di quella presenza sempre perenne quanto scomoda del peccato) ma, allo stesso tempo, il segno dell’interesse di Dio che concede la grazia alla sua creatura. L’amore di Dio per gli uomini rigenerati plasma in loro la fede fino a far loro desiderare l’accesso al Bene assoluto. Infatti, ancor prima di poter aspirare alla morte fisica del corpo, il credente deve essere definitivamente impressionato dalla fede, che non arriva al protestante tramite una sua iniziativa – le opere – ma che è concessa gratuitamente da Dio. Il martirio che il poeta deve sopportare è quello che ogni credente (amante) baciato dalla grazia di Dio (amato) accetta non senza una dose di voluptas dolendi. Tutti i supplizi e le sofferenze che l’eletto vive sulla terra sono momenti propizi che lo avvicinano al compimento della predestinazione; i dolori e le pene che ne derivano sono tappe necessarie per liberarsi dal peccato e avere accesso alla vita eterna: in questo senso, assumono essi stessi una funzione salvifica. Si tratta, come nella più LUIGI MAGNO classica topica amorosa petrarchesca, di sopportare lo stato antitetico, in cui l’amante è immerso, in attesa della ricompensa finale. Ma il fine, per il poeta riformato, non è certo l’amore sensuale: la meta è nella salvezza dell’anima, nell’accesso al regno di Dio. La donna e la voluttà non sono più, in questo senso, che una delle molteplici tentazioni da avere in avversione. Quel gioco formale di specchi che il titolo della raccolta annuncia nella sua formulazione (Image d’un mage ou Le spirituel d’André Mage) può altresì leggersi come una rivisitazione, un’insistenza, una complessificazione stilistica del topos dello sguardo. Ma non è solo quest’ultimo motivo a essere riorchestrato in chiave religiosa, o il tema dell’amore a scivolare da un ambito profano verso una dimensione divina: è forse tutta la concezione della missione del poeta a essere ripensata. Se il poeta rinascimentale, pervaso dai furores (neo)platonici, è pronto a esplorare il microcosmo come campo d’indagine i cui segni funzionano come simboli da decifrare per accedere a verità nascoste, Fiefmelin rifugge il mondo e ogni sua manifestazione per volgere lo sguardo direttamente all’extramondano che è in Dio, e da qui trarre ispirazione. Non cambia la funzione del poeta, così come continuano forme e immagini della tradizione, adattati però ai nuovi impulsi dettati dalla Riforma religiosa e dalle sue regole in fatto di estetica. Tuttavia, là dove Calvino o Bèze raccomandano una scrittura quasi iconoclasta, biblica e letterale, molte realizzazioni dei poeti protestanti daranno forma a compromessi sincretici con la tradizione poetica profana (Richter, , pp. -): la musa cristiana non sostituisce pienamente la musa pagana. Fedele alla lezione della teologia riformata, Fiefmelin traduce nella sua raccolta di liriche la necessità di esperire le contraddizioni. Soltanto il credente che ha ricevuto la grazia di Dio può prendere coscienza dello stato antitetico in cui versa l’essere umano e, inversamente, il riconoscimento di questa dicotomia sulla terra non è che un sintomo della grazia. La tentazione della donna è un aspetto peculiare di un più vasto movimento antitetico: essa è disforica nella misura in cui incarna le forze del male, ma il suo incontro è anche rivelatore di certezze perché, in sua presenza e al suo richiamo, solo l’uomo illuminato dalla grazia sarà in grado di resistere e fuggire. Alle antitesi che il poeta vive, liricamente, nei suoi poemi, fa eco un’altra opposizione che le comprende non senza farne parte. Oltre la dimensione antitetica, la tentazione carnale non è, a ben vedere, che uno solo degli aspetti di un movimento più generale al quale nulla e nessuno al mondo sfugge. Pensiamo qui all’idea di incostanza e d’instabilità delle cose del mondo. Se in epoca rinascimentale la fiducia nella corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo è ben salda, i poeti dell’autunno del Rinascimento si sentono partecipi di un mondo mutevole, dominato da incostanza e vanità. Di fronte all’evidente rottura di quei legami, se alcuni gioiscono del cambiamento incessante, altri si impiegano alla ricerca di benefiche influenze magiche che possano ripristinare quello stato di felice congiuntura ormai perduta. Influenzato dalla dottrina protestante, Fiefmelin guarda il mondo come luogo dove trionfano il peccato, il male e la morte. I porti a cui ancorare la propria nave non sono più i luoghi dell’immanenza: non resta allora al poeta che cercare la costanza nella realtà ultramondana, metafisica e trascendente, che egli trova in Dio. LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE La piuma e il volo L’incostanza che regna nella dimensione mondana è un altro dei topoi spesso presenti nella poesia coeva. Le immagini in cui questa mobilità si traduce sono state ampiamente studiate (Rousset, ): bolle di sapone, vento, aria, piume evocano fragilità, leggerezza, inconsistenza. Se alcuni poeti come Etienne Durand ( Stances à l’Inconstance) o Jacques Davy du Perron (Temple de l’Inconstance) celebrano gli effetti del cambiamento facendosi portavoce di un’incostanza bianca, altri, come Fiefmelin, ne deplorano gli effetti: Si l’homme icy vivant semble au traict empenné Qui, tiré, vole en l’air comme au champ de l’orage, Cette vie est de plume et de vent son passage, Son passage est le monde ou tout vole estant né. Comment donc tiendra roide à ce vent forcené, Qui tout roule au tombeau, la plume si volage! Non, non, suyvons ce vent qui nous porte au voyage, Et, nostre esprit ne soit de l’orage estonné. Pour le corps, non pour l’ame est la traverse faite: L’ame veille à l’abry du choc de la tempeste, Et, à l’erte à l’effroy, laisse dormir le corps. Que si par mort à temps ces traicts humains s’effacent: Suyvant Christ, non d’Helie et d’Henoc les transports, Par la porte du chef fault que les membres passent. Nella ripartizione delle quartine e delle terzine, il corpo, mortale, si contrappone all’anima, immortale. Prende forma, così, una divisione classica e simmetrica, nel rispetto della coincidenza quasi esatta tra la costruzione sintattica e la ripartizione strofica (a eccezione della seconda quartina che contiene due frasi, vv. - e vv. -, le altre tre strofe delimitano altrettante frasi). La prima strofa è composta da due principali giustapposte (vv. -) e da una subordinata apparentemente ipotetica ma che ha piuttosto un valore causale (vv. -) se si legge il «Si» come “poiché”. Una duplice similitudine si sviluppa lungo tutta la quartina: da un lato c’è l’uomo paragonato a una freccia adorna di piume («traict empenné», v. ), dall’altro la vita il cui fluire è effimero quanto la resistenza di una piuma alle forze del vento. Viene così instaurato un sistema di equivalenze (tra la vita, la freccia piumata, la piuma e il vento) che al v. prende la forma di un chiasmo («Cette vie est de plume et de vent [est] son passage») dove i due termini denotativi esterni («vie» e «passage») sono in rapporto metonimico, mentre i due termini connotativi interni («plume» e «vent») sono in rapporto metaforico. Si combinano qui i semi della leggerezza, della rapidità (il «traict» che «vole en l’air comme au champ de l’orage» evoca il lampo), della fragilità, del movimento, della vulnerabilità, della brevità, dell’incostanza, ovvero tutti i luoghi comuni della poesia dell’epoca, che continuano nella seconda quartina attraverso una metafora filée (vento, piuma, tempesta che indicano la condizione instabile dell’umanità designata qui dal «nous» del v. ). L’efficacia della quartina è dovuta anche alle ripetizioni: «vole» (v. ) ripreso al v. , «son passage» (v. ) ripreso nel verso seguente, «vivant» (v. ) ripreso da «vie» LUIGI MAGNO al v. , infine «empenné» (v. ) riproposto da «plume» al v. . Queste riprese sottolineano una gradazione di tipo metonimico: attraverso espansioni successive si passa da «l’homme ici vivant» (v. ) a «la vie» (v. ) fino al «monde» e al «tout» (v. ). Inoltre i due termini a valore deittico («icy», v. ; «cette», v. ) lasciano supporre un’opposizione in atto tra la fugace mondanità e l’inestinguibile vita dopo la morte. Il tessuto fonetico della quartina moltiplica le fricative [s], [v], [∫ ]: in particolar modo, la presenza della sonora [v] nelle tre parole chiave della strofa («vie», «vole», «vent») entra in un gioco fonetico e semantico allo stesso tempo quando il «vivant» del v. fa riecheggiare i due sostantivi «vie» e «vent» del v. , creando così una doppia equivalenza. Lo stesso procedimento è rintracciabile nella seconda quartina («ce vent forcené», v. ; «si volage», v. ; «suivons ce vent», v. ) e si ripete nei sostantivi tra loro in rima («orage», v. ; «passage», v. ; «volage», v. ; «voyage», v. ), prolungando così il campo lessicale del movimento. Riprendendo l’isotopia del viaggio e del temporale («traverse», v. ; «tempeste», v. ; «effroy», v. ), nelle terzine si afferma la superiorità dell’anima – insensibile al tempo e al movimento – sul corpo – mortale e soggetto al movimento –. Se la prima terzina posiziona «corps» e «ame» in un chiasmo opponendo le due entità nelle loro azioni (l’anima vigile «veille», v. , mentre il corpo dorme, «dormir» al v. ), l’ultima strofa è poco chiara. Se il «Que si» del v. avesse infatti il significato di et si, avremmo in questo verso una proposizione ipotetica senza principale, a meno che non si debba interpretarlo come et en effet. Di controversa lettura è anche l’espressione «mort à temps» (morte prima del tempo? Morte sopraggiunta nel momento assegnato?), che parrebbe comunque sottendere la contrapposizione tra corpo, corruttibile, e anima, immateriale e imperitura. L’allusione ai profeti Enoch ed Elia è più chiara: mentre Cristo è allo stesso tempo Dio e uomo – dunque, in quanto tale, un’entità immortale e un corpo sofferente e mortale – Enoch (Genesi, , ) ed Elia ( Re, , ) sono ambedue saliti in cielo («transports», v. ) perché rapiti misteriosamente, senza che il loro corpo dovesse prima morire in terra. Questo parallelo spiega perché l’uomo è più vicino a Cristo, il quale visse fisicamente la morte del corpo, che non ai profeti dell’Antico Testamento. L’ultimo verso rivela un nuovo nodo per l’esegesi con la metafora de «la porte du chef». Potrebbe trattarsi della testa («chef»), cioè dell’anima, di cui si ribadirebbe dunque la superiorità sul corpo («les membres»), in un contesto costruito sulla metafora del passaggio e del viaggio («transports»; «passent», v. ). Ma è forse anche probabile che «les membres» siano qui da intendersi come gli affiliati della comunità cristiana, per cui il passaggio attraverso la morte fisica è una tappa necessaria, come è stato per Cristo («la porte du chef»), ma non per Elia ed Enoch. Appare così nuovamente chiaro l’intento di celebrare Cristo che ha riscattato, attraverso la sua morte, il peccato di Adamo. Pur denunciando il passaggio e l’incostanza del mondo, Fiefmelin – come del resto altri autori – non si rassegna a cantare la fuga dell’essere e del tempo, dell’essere nel tempo, con tragica angoscia e, ancor meno, con sentimento di rivolta. La condizione dell’uomo è accettata dal poeta-credente come una situazione «antilogique» (Schmidt, , p. ), cioè di paradossale compresenza, nello scontro, tra la carne e lo spirito. La denuncia dell’instabilità – dunque del peccato – non si lega qui a una mancanza di certezze o all’espressione di incertezze metafisiche: il discorso poetico si vuole efficace, incisivo, quasi categorico, nell’opporre le verità divine al divenire fisico del mondo. Il poeta è convinto della sua doppia elezione: egli è predestinato LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE alla salvezza dell’anima – salvezza nella quale sarà sublimata l’incostanza mondana – e, toccato dalla grazia divina, è capace di discernere il male nel mondo e cantarlo in versi attraverso la sua parola. Nel sonetto appare insistentemente, tra altri espedienti retorici, la metafora della piuma. La fonte del «traict empenné» è letteralmente spondiana (l’ottavo dei sonetti della morte), così come tutto il sonetto esibisce voyeuristicamente il lavoro d’ipermediazione formale, ovvero di estrazione e di ri-elaborazione, fatto da Fiefmelin nel suo ipertesto a partire dall’ipotesto spondiano (non solo il sonetto VIII, ma anche i sonetti X e XI della stessa sezione). Importa qui notare quanto la metafora del volo sia ambivalente e polisemica, allo stesso modo delle immagini dell’acqua o del fuoco incontrate nel primo sonetto del quale abbiamo proposto una lettura. In un altro sonetto di Fiefmelin, infatti, si trova una diversa accezione dell’immagine del volo, antitetica a quella analizzata nel componimento Si l’homme icy vivant semble au traict empenné e che si può leggere quale metafora di innalzamento, di viaggio ascensionale dell’anima al cielo in vista dell’unione con Dio: C’est à ce coup qu’aislé de l’esprit qui m’inspire, Je me sens enlever plus haut que tous les Cieux: Là faict Spirituel de charnel vitieux, Je voy l’Estant qui peut à tout estre suffire. Après ce Sainct d’amours mon coeur amant souspire, D’espoir mon ame aislée aspire à si beaux lieux, De pensers de l’esprit, que ma foy fournit d’yeux, Je descouvre le sein d’où ma vie respire. Paul ne vit l’Invisible, au tiers ciel emporté, Par autre extase, sainct qu’en mon humanité Je jouys de mesme air soubs l’effort de ma flamme. La foy, l’espoir, l’amour d’esprit, d’ame, de coeur Au Pere, Fils, Esprit avive, anime, enflamme L’homme en Dieu extazé pour jouyr de son heur. Con la formula «C’est à ce coup qui» il poeta insiste sul presente dell’enunciazione e attira così l’attenzione sull’azione che è in fieri. Le metafore della piuma e del volo, ostentate nel sonetto che abbiamo precedentemente analizzato, così come l’immagine dell’ala che oscurava le malefiche atmosfere notturne nel sonetto Ja la nuict couvroit l’air de ses aisles humides, sono qui immagini che non indicano il passaggio dell’uomo o del tempo sulla terra e, ancor meno, le forze del male. Ora è il «je» a essere alato, ovvero dotato di quell’ «esprit» (v. ) vivificante che lo nutre, fornendogli ispirazione divina. Il corpo, metaforicamente reso alato dallo spirito, non si innalza tuttavia per un suo disegno personale ma vola passivamente al cielo, come calamitato o rapito («enlever plus haut», v. ). Le forze ascensionali (della stessa natura di quelle centrifughe nel sonetto Ja la nuict couvroit l’air de ses aisles humides) che il «je» sperimenta in modo quasi sensibile («Je me sens», v. ), non sono che l’immagine metaforica dell’impotenza dell’uomo senza Dio. La costruzione passiva («[je suis] faict», v. ) e l’idea del volo quale enlèvement, conducono l’io alla contemplazione dell’«Estant» (v. ), contemplazione di tipo letteralmente visivo, ottico («Je LUIGI MAGNO voy», v. ) che, dopo il sentire del v. («Je sens») e attraverso una derivazione, oppone Dio («Estant», v. ) all’uomo («estre», v. ). Le immagini, sottolineate dalla reiterazione della sibilante [s] (specie nei vv. -), ribadiscono come il credente non possa innalzarsi al cielo per una sua iniziativa, ma debba necessariamente rimettersi agli inconoscibili disegni della grazia divina. Nonostante il tema del volo si confonda qui con il rapimento estatico, la caratura profana di questi versi è innegabile. Si pensi al tema della metamorfosi, un euforico momento di rigenerazione. Il cambiamento riunisce forze e motivi diversi e contrastanti. La metamorfosi può infatti essere, da un lato, sinonimo di passaggio nel senso di una generale consunzione o esaurimento (ad esempio, la vita sulla terra che si consuma con la rapidità del bagliore di un lampo). Ma questa accezione, pur presente in Fiefmelin, non si risolve in un canto concitato e tragico, volto a esprimere un rimpianto per la dimensione terrena. La metamorfosi è qui una sorta di resurrezione, un momento iniziatico che segna la trasformazione interiore: il desiderio del fedele è quello di vedere la sua anima liberarsi dal corpo in modo tale che da «charnel vicieux» (v. ) egli divenga uomo rigenerato («faict Spirituel», v. ). Quindi, se da un lato il cambiamento conduce alla morte, dall’altro si pone come mezzo per sfuggire a essa (Longeon, ). Ma quello che più ci sollecita nell’immagine della metamorfosi è il richiamo alla tradizione alchemica. Il lirismo della devozione ha infatti annodato profondi legami, all’epoca delle guerre di religione, con l’arte di Ermete (Greiner, , pp. -). Nei versi di molti poeti (cattolici come riformati) si stabiliscono paralleli tra la realizzazione dell’opus alchemico con la ricerca di Dio. Come nota il Greiner, al di là delle loro differenze, queste due ricerche (filosofale l’una, mistica l’altra) sembrano convergere su un’identica escatologia che promette il riscatto dei corpi attraverso il riscatto dello spirito/anima. Nelle due pratiche si dispiega uno stesso immaginario di metamorfosi e sublimazioni, e Fiefmelin torna anche in un altro sonetto su questi aspetti. Nella seconda quartina un gioco derivativo («amours», «Amant», v. ), inserito però nel campo lessicale dell’amore («coeur») di tipo «Sainct», mostra ancora la contaminazione tra la tradizione profana e quella religiosa. Amori, occhi, seno, sono termini qui definitivamente connotati in senso religioso. Al v. l’immagine dell’«ame aislée» richiama l’«aislé de l’esprit» del v. e continua il programma d’ascesa, sia attraverso la presenza ripetuta del suono [s] sia attraverso la presenza del verbo «aspire» (v. , che risuona con la rima «souspire»/«respire» dei vv. e e con «inspire» del v. ). I pensieri dell’anima («pensers de l’esprit», v. ), metaforicamente forniti del senso della vista («yeux», v. ), permettono quella scoperta («Je decouvre», v. ) quasi gnostica che segue il sentire («Je me sens», v. ) e il vedere («Je voy», v. ), fino a far ricongiungere i pensieri delle cose divine con Dio (c’è infatti una sostanziale equivalenza tra l’anima, il pensiero, e Dio che è il loro oggetto di riflessione, ispirazione, aspirazione). Nella prima terzina Fiefmelin propone un accostamento tra la sua esperienza mistica e quella di san Paolo, ricorrendo a una sintassi piuttosto singolare e complessa. Si potrebbe leggere questi versi nel senso seguente: lo stato d’estasi con cui san Paolo visse la contemplazione di Dio («l’Invisible», v. ) non è affatto dissimile da quello che, allo stesso modo («de mesme air», v. ), il «je» sperimenta su di sé nella propria condizione di graziato («sainct», v. ) e di essere animato dalla fiamma dell’amore divino. L’obiettivo della ricerca mistica è identico e si risolve per entrambi nella contemplazione del divino. La differenza sostanziale risiede però nei percorsi LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE d’ascesa: mentre l’estasi del «je» resta ancorata a una dimensione esclusivamente mondana («en mon humanité»), ribadendo così una sostanziale unità tra l’anima e il corpo (l’anima nel corpo), l’estasi di Paolo si realizza negli alti cieli del Paradiso («au tiers ciel emporté»). Questa antitesi accompagna l’ossimoro della visione dell’invisibile («vit l’Invisible», v. ) di cui Fiefmelin orchestra le possibili variazioni nel sonetto Il est vray, je voy Dieu, je le voy l’Invisible, ma che già qui, come immagine metaforica, solca l’intero poema passando dal «voy» (v. ) agli «yeux» (v. ). La visione accompagna idealmente quella climax che attraverso il sentire («Je me sens», v. ), il vedere («Je voy», v. ), e la scoperta («Je decouvre», v. ), diviene un vero e proprio gioire-godere («Je jouys», v. ) fino alla scomparsa del «je» nell’ultima quartina, dove l’accesso all’estasi divina si apre a tutti i credenti graziati («L’homme en Dieu extazé», v. ). La presenza del verbo jouir si potrebbe leggere come nuova traccia di una dimensione pagana e, forse, come elemento neoplatonico. Appare chiaro, infatti, che la visione di cui si parla nel sonetto è quella degli occhi della mente (come si dice al v. in cui gli «yeux» sono quelli «de l’esprit») il che potrebbe dunque far pensare alla realizzazione di una visione mistica. Ora, la voce «je jouys» si accomuna a espressioni dell’amore, come, ad esempio, al v. , «d’amours mon coeur amant soupire», o ancora all’immagine della fiamma vivificante del v. . Una lettura conforme all’ortodossia religiosa che sostanzia il componimento potrebbe spiegare l’isotopia dell’amore con il sostegno di passi biblici. Si pensi qui a san Paolo, l’apostolo citato al v. , che, come sappiamo, insiste molto sulla centralità del tema dell’amore. Più precisamente si legga l’esperienza d’amore che san Paolo descrive nella Lettera agli Efesini (, -): troviamo qui un’idea dell’amore nel senso di caritas, nozione che i Padri della Chiesa avevano adottato mutuando e trasformando la teoria platonica dell’amore (Panofsky, , p. ). Il concetto di caritas quale amore spirituale (di Dio per la sua creatura, o viceversa) era, in ambito religioso, in aspra opposizione con la nozione di cupiditas, ovvero l’amore dei sensi (ibid.). Fiefmelin sembra invece esprimere l’amore divino non senza ricorrere a immagini (sospiri, godimento, fiamma) che possono confondersi con la tradizione profana e che lasciano quindi intravedere una possibile confluenza, o comunque una possibile confusione, tra la caritas e la cupiditas. Non sarebbe questo, tuttavia, un caso isolato. Come è già stato mostrato (Wind, , pp. -), la nozione di voluptas fu usata, in ambito neoplatonico (e ancor prima in ambito epicureo), per indicare sia le forme di piacere sensuale sia quelle più elevate dell’esaltazione mistica. La convergenza di aspetti antitetici su una stessa nozione si attua attorno a uno stesso principio di Piacere. La differenza tuttavia risiede nella transitorietà dei piaceri dei sensi: per emendare il loro carattere effimero bisogna innalzarsi verso il godimento reale, verso quel piacere supremo che travalica l’intelletto e le sue logiche, e che solo l’amore (cieco) procura. Viene così ribadita, per strade diverse, una sostanziale assimilazione dell’Amore con una suprema forma di conoscenza (che in Fiefmelin corrisponde con la visione di Dio). Anche se la lettura del sonetto Il est vray je voy Dieu je le voy l’Invisible smentirà in parte questa interpretazione, quello che si vuole mettere qui in evidenza è la contaminazione di una morale religiosa con un’esaltazione di tipo neopagano, attraverso una pluralità di letture a cui si presta qui la passio amatoria. Il sonetto si chiude con versi rapportés (vv. -). Al v. assistiamo alla ripresa di termini presenti nella seconda quartina («foy» e «esprit» al v. , «espoir» e «ame» LUIGI MAGNO al v. , «amour» e «coeur» al v. ), riorchestrati secondo un principio ternario. I tre soggetti (fede, speranza, amore) corrispondono alle tre virtù teologali che hanno Dio per oggetto formale. Dio, presente nell’ultimo verso nella sua unità («Dieu» v. ), è in questi versi consustanziale alle persone della Trinità. La costruzione in parallelo, ovvero la condensazione di termini sparsi nei versi antecedenti, offre una struttura formale adatta a esprimere sia l’ordine che è in Dio – simboleggiato del numero tre – sia la tensione ascensionale della visione estatica. Immagine del passaggio, della fugacità ma anche della debolezza e della fragilità, il volo è una metafora in uso quasi esclusivamente nella poesia d’ispirazione religiosa dove evoca il desiderio di ascesa al cielo, dunque di salvezza (Melançon, , pp. -). Esso non è tuttavia un’azione fine a se stessa, ma si pone come un mezzo d’ascesa mistica per giungere alla visione – contemplazione – come risulterà nel sonetto Il est vray, je voy Dieu, je le voy l’Invisible. Quello che torna come un’evidente costante è il lavoro di rimediazione che, nei sonetti citati, Fiefmelin opera non solo sul sostrato formale (nel senso di una complessificazione ipotattica della sintassi spondiana) ma anche su quello delle immagini. Il volo che il credente realizza per mezzo dell’intercessione della grazia divina potrebbe allora leggersi come una riscrittura di temi platonici: trasformato (redento) dal culto per la bellezza (fede in Dio), l’amante perfetto (il credente) vola negli spazi celesti, verso mondi iperuranici (la salvezza dell’anima, il regno di Dio) che gli daranno accesso alla visione (contemplazione del Bene). Le stesse immagini della tradizione profana conoscono nuovi esiti che l’ispirazione religiosa del poeta impone al componimento: gli amori saranno quelli del fedele per il suo Dio e la sua Chiesa, i piaceri saranno di natura spirituale e non più carnale, il volo non è passaggio fugace del tempo ma aspirazione mistica a Dio. Possiamo cogliere già qui una prima divergenza con Jean de Sponde. Nell’Essay de quelques poemes chrestiens, il poeta unisce il volo all’antagonismo tra chair ed esprit ma, mentre in Sponde l’ascesa al cielo tocca esclusivamente all’anima una volta liberata dal corpo, vincendolo, nel sonetto di Fiefmelin osserviamo un trattamento diverso della stessa immagine. Per Fiefmelin il volo non è sintomatico del viaggio dell’anima dopo la morte del corpo, ma è puro slancio dello spirito verso Dio, impeto che non attende la fine della dimensione mondana per realizzarsi, ma che si compie quando il corpo è ancora in vita (ivi, pp. -). Questo volo è soltanto evocato, ma la presenza delle ali impone per metonimia la sua esistenza. Allo stesso modo il poeta non tace la natura di questo viaggio: non si tratta infatti, nella prospettiva mistica espressa nel sonetto, di un volo fatto per iniziativa volontaria del credente, ma di un enlèvement, di un rapimento mistico al quale il credente non può che sottomettersi, passivamente (come abbiamo avuto modo di osservare nel poema Ja la nuit couvroit l’air de ses aisles humides, dove le forze centrifughe e dirette lontano dalla terra convivevano con la passività del soggetto). La critica ha evidenziato il lavoro intertestuale che struttura il sonetto Si l’homme icy vivant semble au traict empenné, e ne ha messo in luce la fonte spondiana. Come abbiamo già detto, non sarà questo il luogo in cui ripercorrere il problema intertestuale. Qui vorremmo porre in evidenza un altro aspetto: ci pare infatti che il lavoro svolto sulle forme della poesia spondiana, nel senso di una complessificazione delle strutture retoriche e sintattiche, abbia fatto di Fiefmelin, LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE forse implicitamente, un epigono del più noto Sponde. Al di là di questo gioco formale, Fiefmelin ci sembra però essere a tratti lontano da certi contenuti della poesia spondiana. Il sostrato religioso è certamente lo stesso – ambedue sono protestanti, Sponde almeno fino alla sua conversione –, i temi dell’incostanza o della grazia divina sembrano dar materia ai loro componimenti, e in entrambi si ritrova lo stato di perenne antitesi che il riformato sperimenta sulla terra, straziato dal combattimento intimo che si danno in lui il corpo e lo spirito. Ma, se da un lato Sponde ostenta un déchirement irrisolvibile – che arriva dall’irriducibilità tra cielo e terra, dallo scollamento tra macrocosmo e microcosmo – che lo strazia imponendogli un’impossibile ricucitura – impossibile armonia, anche se l’apirazione costante del poeta converge verso la costanza –, Fiefmelin dà voce ad accenti che fanno alternare dubbi, lacerazioni, impossibilità e nullità dell’uomo senza la grazia (in continuità con Sponde), a momenti di esaltazione mistica, di visione e trasporto nell’ambito delle certezze. Se Sponde trova dunque la sua certezza nell’ideale di costanza a cui egli aspira ma che né vede né conosce nella realtà mondana, Fiefmelin vede Dio, realizza la visione che gli infonde certezza, trovando già in terra la sua costanza, pur senza poter conoscerne o penetrare l’essenza. La visione e la gnosi La vista è il senso che prevale nel Rinascimento. Dall’ut pictura poesis al trionfo della rappresentazione pittorica, dalla produzione di emblemi e calligrammi alla pratica diffusa di figure come l’ekphrasis o l’ipotiposi, il Rinascimento sembra riportare in auge l’importanza della vista, il «più nobile tra gli organi di senso» (Panofsky, , p. ), confermandosi nuovamente in piena convergenza con l’ordine del mondo definito dalla tradizione platonica. Dare a vedere significa in qualche modo concretizzare, rendere sensibili quelle astrazioni che sono il fondamento stesso del pensiero religioso e/o metafisico. Torniamo allora sul tema della visione proponendo un’osservazione finale tratta dalla lettura di un altro sonetto: Il est vray, je voy Dieu, je le voy l’Invisible: Par la vivacité de mes pensers divins J’ay la veuë à le voir plus vive que d’un Linx Comme l’Esprit à l’ame ainsi m’est Dieu visible. Qui medite en toy tout par extase indicible, Void comme moy ta face et tes yeux plus benins: Mon ame, o Dieu, te void cerné de Seraphins En ton heureux sejour à l’œil inaccessible. Mais comme Abram, et Lot, Moyse, et Israël, Ou comme tes voyans je te voy Eternel: Et en l’object finy ne se borne ma veuë. Infiny je t’advise et tout en tout Tres grand, Dont l’essence est de toy et non d’autre cognuë: Car quel esprit crée son Createur comprend? Colpisce la ripetizione del sema voir, declinato sotto forma di variazioni lessicali e morfologiche multiple: «je voy» (due volte al v. ), «l’Invisible» (v. ), «la veuë» (v. ), LUIGI MAGNO «le voir» (v. ), «visible» (v. ), «void» (vv. -), «oeil» (v. ), «voyans» e «je te voy» (v. ), «veuë» (v. ), «je t’advise» (v. ). Fiefmelin utilizza dunque essenzialmente due figure retoriche: la figura di derivazione etimologica (voir, vue, voyants, visible, invisible) e il poliptoto (je vois, il voit, voir, voyant), quasi a voler sperimentare un’organizzazione combinatoria (tanto cara, nell’accezione magica del termine, a molti studiosi e letterati del suo tempo). Il sonetto si articola attorno al «Mais» del v. che annuncia l’antitesi tra vedere e comprendere (vedere e conoscere, o ancora visione ed essenza), opposizione che appare di fatto ai vv. -. Proprio alla fine del sonetto si manifesta, nel tessuto semantico, la separazione tra visione e conoscenza, sottolineata anche dalla rima del distico che, a differenza di tutte le altre rime del sonetto – costituite da nomi o aggettivi –, prende piede da due forme verbali. Due verbi dunque («cognuë» e «comprend») che, dal loro significato e per la loro posizione alla fine del verso, sono quasi dei sinonimi. Il poema si apre su un’affermazione forte («Il est vray…», v. ), destinata a combattere la possibile incredulità del lettore davanti al paradosso enunciato subito dopo, sotto forma d’ossimoro, dal «je le voy l’Invisible» (ossimoro contenuto ugualmente nella rima «Invisible»/«Dieu visible» dei vv. e ). Si noti anche la prosodia qui utilizzata: il v. è un tetracolon che scandisce e martella l’affermazione forte che esso veicola. L’idea contenuta nei vv. e sarà ripresa ai vv. , e -: si tratta di dire e ridire una stessa visione mentale, poiché il pensiero non è altro che una parte di Dio (come ci conferma l’ «ame» che, al v. , «void»). Una serie di chiasmi appare nella trama retorica del sonetto. Ai vv. - «vivacité» è ripreso dal termine «vive», mentre «pensers divins» è ripreso da «veuë». Allo stesso modo al v. si nota un chiasmo nella similitudine «Comme l’Esprit à l’ame ainsi m’est Dieu visible»: i due emistichi iniziano con i due termini di comparazione («comme» è ripreso da «ainsi»), all’“Esprit» del primo emistichio corrisponde «Dieu» del secondo, così come i due dativi («à l’ame» e «m[e]») si fanno eco. Ancora un altro chiasmo, raddoppiato da un ossimoro, è presente tra «Je le voy l’Invisible» (v. ) e «m’est Dieu visible» (v. ) («voy» è ripreso da «visible» mentre «l’Invisible» designa «Dieu»), così come infine, al v. , («je voy Dieu, je le voy») le due forme declinate del verbo «voir» («voy», «voy») inquadrano l’oggetto della visione («Dieu», «le»). Tutti questi chiasmi esprimono la stessa idea, ovvero l’equivalenza dell’anima (o del pensiero) e di Dio (oggetto della visione) quali entità della stessa natura. Nella seconda quartina Dio diventa l’interlocutore e, dopo un’invocazione diretta («o Dieu», v. ), ci si rivolge a lui utilizzando la seconda persona («toy», v. ; «ta» e «tes», v. ; «ton», v. ). La stessa idea della visione, che avevamo rintracciato nel sonetto C’est à ce coup qu’aislé de l’esprit qui m’inspire, torna nei «medite» o «extase» (v. ), termini equivalenti al «void» (vv. -). È l’anima qui che vede (visione estatica) e che contempla gli occhi di Dio («tes yeux», v. ) in un gioco di specchi e di rimandi (ricordiamo che il contesto della raccolta è quello, specchiante, specchiantesi, dell’Image d’un mage), che è anche un gioco d’antitesi (tra i «void» dei vv. - e «à l’oeil inaccessible», l’emistichio che conclude la strofa riprendendo la rima «l’Invisible» del v. ). La prima terzina fornisce la lista dei profeti che hanno parlato con (dunque visto) Dio: Abramo, Lot, Mosè, Giacobbe («Israël», v. ). Essi sono designati come «voyans» (v. ) e a questa ascendenza il «je» ascrive la sua visione ponendo «tes voyans» e «je te voy» in modo simmetrico, a destra e a sinistra, rispetto alla cesura LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE del v. . Si nota qui l’impossibilità di descrivere Dio la cui presenza prende piede non più attraverso tratti fisici (evocati al v. con «ta face et tes yeux»): i due emistichi «je te voy Eternel» (v. ) e «Infiny je t’advise» (v. ) formano un chiasmo che mette in evidenza due tratti salienti nella definizione di Dio, ovvero la sua estensione temporale prima e quella spaziale poi, per descriverlo in seguito come tutto e parte del tutto («et tout en tout très grand», v. ). Un altro chiasmo struttura l’ultima terzina dove in «de toy et non d’autre cognuë» (v. ) e in «quel esprit crée son Createur comprend» (v. ) il «toy» corrisponde al «Createur» mentre «autre» indica l’«esprit crée». L’ultimo verso si presenta sotto forma di massima per l’uso della forma impersonale e del presente di verità generale: la moltiplicazione dell’occlusiva [k] («car», «quel», «crée», «Créateur», «comprend») gli conferisce un aspetto perentorio, mentre la ripresa della figura di derivazione («crée», «Createur»), utilizzata in tutto il sonetto, sottolinea il paradosso iniziale: vedere l’invisibile. Jean Rousset ha osservato in che modo, tra XVI e XVII secolo, alcuni poeti, oltre ad avere posizioni diverse sul tema, abbiano esperito tecniche diverse nell’esprimere nei loro versi il motivo della visione di Dio (Rousset, , pp. -). Ad esempio, Jean de Sponde resta un poeta della meditazione religiosa, un poeta spirituale che riserva la visione di Dio esclusivamente alla dimensione ultraterrena. Per Sponde, fino a quando il corpo soggiorna vivo sulla terra l’uomo non ha la possibilità di vedere Dio: il poeta infatti, contro le tenebre mondane e secondo una metafora ampiamente esperita all’epoca, fa coincidere la visione di Dio con la visione della luce, proiettandola in una dimensione metafisica. Se dunque Sponde è portavoce di una visione impedita – così come il volo, nella sua poesia, è volo dell’anima post mortem –, Fiefmelin è il fautore di una realizzazione della visione. Poiché Dio è invisibile, pura trascendenza, la sua visione non può che risolversi, come si è visto, non tanto con espressioni paradossali (il cliché dell’epoca era l’ossimoro o la giuntura dei contrari in formule come chiara oscurità, raggio tenebroso, sole oscuro, o altre espressioni concernenti la luce) ma con formule quasi tautologiche (je vois Dieu, donc je le vois) che permettono di insistere sull’azione, sull’accadimento – la visione – pur tacendone l’oggetto – il veduto –. Importa osservare inoltre l’unione della visione con il motivo dell’espressione. Vedere coincide col dire; vedere l’invisibile o il non visibile comporterebbe dunque, quasi logicamente, il non dire. Ed è per sfuggire al non dire, per non far tacere la musa cristiana, che il poeta ricorre a una successione di versi che dicono senza dire, che ruotano tautologicamente su se stessi. Parola quanto mai riflessiva dunque, che nel sonetto di Fiefmelin trova tuttavia un esito paradossale. In questi versi non vi è infatti soltanto il ricorso a ossimori o paradossi (come il vedere l’invisibile); vi troviamo anche una sorta di esasperazione lirica, ovvero l’incessante volontà dell’io di non tacere la propria esperienza, e il conseguente impegno a darle forma per comunicarla. L’io vede l’invisibile e, come controparte, il lavoro di creazione poetica e di propaganda religiosa gli impone di dire l’indicibile. Fiefmelin non sceglie dunque il silenzio davanti alla visione mistica di Dio ma ne dà conto attraverso un’ammissione di non conoscenza. Ora, le forme tautologiche non sono che un silenzio travestito, un vuoto sonoro che non coincide tuttavia con un fallimento: l’impossibilità di dire Dio è infatti il trionfo di un percorso meditativo e di riflessione sull’uomo e su Dio. Toccando la LUIGI MAGNO più alta sfera, il tracciato ha toccato il suo fine ultimo, una sorta di arrivo di fronte al quale il silenzio della parola poetica è d’obbligo perché questa si sublima in Dio. Ma il vedere e il dire Dio, al di là delle forme retoriche adottate, sono anche momenti simbolici in cui la parola del poeta è investita dalla Parola biblica che la ispira, come se quella volesse uguagliare questa. È Dio che legittima i versi e l’ispirazione del poeta protestante, perché Dio l’ha doppiamente eletto. Se la parola divina torna a Dio (torna su Dio), essa chiude in questo modo un cerchio, simbolo di perfezione, ponendosi così in un’ottica di compimento piuttosto che di fallimento. Si è detto già come in Sponde la visione mondana di Dio sia irrealizzabile, mentre questa in Fiefmelin trova realizzazione nella visione mistica. Ora, l’impossibile visione prende in Sponde una forma particolare nel quinto dei suoi Sonnets d’amour, in cui il poeta evoca il mito di Atteone: Je suis cet Acteon de ses chiens deschiré! Et l’esclat de mon ame est si bien altéré Qu’elle, qui me devrait faire vivre, me tuë: Deux Deesses nous ont tramé tout nostre sort, Mais pour divers sujet nous trouvons mesme mort, Moy de ne la voir point, et luy de l’avoir veuë. Nel mito greco di Atteone il giovane cacciatore viene dilaniato dai cani perché colpevole di aver osato contemplare Diana nella sua nudità. Atteone ha osato sfidare l’interdetto: il suo sguardo è dunque sacrilego e grida quella nemesi che i suoi cani (simbolo dell’istinto sessuale non sublimato), sbranandolo, gli infliggono. Si tratta dunque di una visione immanente, intrisa di un desiderio carnale che passa attraverso la vista come senso corporale. In Sponde il tema mitologico non torna come tale ma appare ampiamente rivisitato. Nella sua lirica infatti la visione non può realizzarsi. Sponde insiste solo su alcune parti del mito – quelle riguardanti il tema della visione – mentre passano inosservati il motivo della nudità o quello della metamorfosi di Atteone in cervo. Tale interpretazione permette al poeta di rileggere la favola in chiave filosofica, religiosa, trascendentale. La sorte del je/nuovo-Atteone è la stessa del cacciatore («mesme mort») ma egli vi giunge per via antitetica: l’uno (Atteone) muore perché ha visto, l’altro ( je/nuovo-Atteone spondiano) muore perché non ha potuto vedere. Lo strazio del poeta muove infatti dalla seguente dinamica: egli è dilaniato dalla lotta tra il suo desiderio di accedere all’Uno e alla dimensione trascendentale (per contemplare il divino), e l’effettiva impossibilità di realizzare in vita, sulla terra, quella visione delle cose divine. La visione nell’immanenza, quella del mitologico cacciatore, è quella degli occhi, una percezione che alimenta gli amori mondani. Sponde sposta la favola mitologica in una dimensione altamente intellettuale, interamente «fondata su concetti trascendentali» (Richter, , p. ) e tesa alla chiara ricerca del metafisico, dell’astrazione, delle idee. Lontana dall’ottica concreta, la visione platonica è quella divina, è quella degli occhi della mente, dello sguardo interiore, che aspira alla contemplazione trascendentale dell’Uno. Solo nelle idee e nelle essenze Sponde vede quella costanza, tema centrale dei suoi componimenti d’amore, alla quale aspira per fuggire dal mondo proteiforme e mutevole delle apparenze. LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE Tuttavia, finché il corpo è in vita, questo slancio sarà perennemente frustrato (la vita dell’anima inizia con la morte del corpo), alimentando così lo strazio psicologico dello spirito. Tornano in questi versi, come è stato osservato (Dardano Basso, , pp. -), echi di un motivo specifico della tradizione del platonismo ermetico, il tema della cecità orfica . Il poeta dunque è cieco (come l’arciere di Montaigne), bendato, ma questa impossibilità a vedere è paradossalmente la forma più alta di conoscenza. In altri termini, la cecità orfica è la più alta forma di conoscenza perché è un vedere con gli occhi della mente, cioè una forma di gnosi che travalica la logica e i limiti della ragione (intelletto). Sponde non realizza la visione ma nel fondo egli conosce: pur senza la visione, egli comprende la natura della costanza che egli persegue e che è in Dio. Nel sonetto Il est vray, je voy Dieu, je le voy l’Invisible Fiefmelin descrive la sua visione di Dio in termini opposti a quelli spondiani (anche se gli esiti sono gli stessi, ovvero la celebrazione dello sguardo interiore). Non vi è in Fiefmelin tormento alcuno: i dilemmi cantati da Sponde vengono riassorbiti da certezze quasi rinascimentali. Fiefmelin realizza quell’armonia che non è più, nei suoi versi, un’harmonia mundi, bensì una theantropogamia, l’unione tra l’uomo e Dio attraverso l’estasi mistica (pseudo-paolina). Tutte le antitesi che gli altri sonetti ostentano vengono qui cancellate dall’uso ripetitivo e ritmico di assonanze, poliptoti, figure di derivazione (Desimeur, , pp. -). Uno dei tratti salienti di questo sonetto è il suo compiacimento estetico più che estatico. Il poeta pare realizzare questa visione di cui tuttavia non riesce a dar conto. Non troviamo infatti, come in Sponde, un’impossibilità strutturale – si legga: di pensiero – della visione; non i paradossi delle antitesi o degli ossimori (quelli di un Dio che è, di volta in volta, lucente oscurità, freddo cocente ecc.); non le trasposizioni metaforiche né descrizioni di tipo mimetico per dire Dio. La logica del sonetto gira in tondo su se stessa, diventa evidenza o tautologia che insiste sull’azione (la visione) senza dar conto del suo oggetto (il veduto). Questa logica essenziale ci dice che il «je» vede il veduto, vedendolo. La visione è per Fiefmelin l’avallo delle sue certezze di credente (la fede, l’amore di Dio e per Dio, la salvezza, la sua elezione, la predestinazione ecc.). Ma a queste conferme fa da contrappeso, negli ultimi due versi, l’impossibilità di accedere all’essenza, ovvero alla totale conoscenza o comprensione. Fiefmelin arriva a Dio per estasi mistica, o addirittura tramite un sogno, una prefigurazione profetico-divinatoria, una visione rivelatrice. L’iniziativa parte dunque da Dio, dall’occhio del divino che vede il peccatore, lo salva attraverso il «dard» (dardo/sguardo di fede) e gli permette di accedere alla visione dell’invisibile, alla visione di colui che per primo vede. Non siamo di fronte a una rivelazione totale, a una sorta di scoperta gnostica. La visione (estatica) rivela allora i suoi limiti: vedere non vuol dire infatti comprendere. Ecco dunque meglio esplicitato il punto in cui le esperienze di Sponde e quelle di Fefmelin sulla visione si separano: se Sponde non vede, o vede ciecamente, egli comprende e conosce; Fiefmelin, pur vedendo, non ha accesso alla conoscenza. Il platonismo, che, all’interno del sesto sonetto della morte, Sponde ostenta nei «Beaux séjours, loin de l’oeil, prez de l’entendement» (Sponde, , p. , v. ) e attraverso cui canta l’Essere platonico (e il Dio cristiano), lascia in Fiefmelin pieno LUIGI MAGNO posto alla teologia di Calvino, per il quale «l’uomo non possiede alcun mezzo naturale per accedere alla conoscenza di Dio» (Richter, , p. ). Ecco come la visione, per Sponde metafora di conoscenza suprema qualora vesta i panni della cecità orfica, in Fiefmelin si adatta quale metafora di una conoscenza certo superiore a quella dei sensi e a quella dell’intelletto, tuttavia insufficiente a raggiungere la comprensione (come si dice nel distico finale dell’ultimo sonetto esaminato). E anche se la presenza del verbo aviser («je t’advise», v. ), considerato nel suo valore semantico di “riconoscere”, potrebbe essere rivelatrice di quel platonismo che intende la conoscenza come riconoscenza (l’anima riconosce, nel mondo delle idee, quelle stesse idee che aveva contemplato prima d’incarnarsi in un corpo), la visione di Fiefmelin sembra avere una dinamica ben diversa da quella spondiana. Il poeta che contempla Dio, che lo vede in praesentia nel suo regno fatto d’amore, si trova innalzato a un rango dove il tutto e il nulla coincidono. Dio è visibile e invisibile allo stesso tempo, egli è dunque tutto e niente contemporaneamente, un Uno ineffabile che non si lascia delimitare da attributi che lo renderebbero finito (dunque accessibile alla ragione). In questo modo, Dio trascende tutto e, come dice Jean Rousset a proposito di Claude Hopil, «il échappe à tout concept et n’est connu que dans cet aveu d’inconnaissance» (Rousset, , p. ). Conclusioni La poesia di Fiefmelin, insieme a quella dei poeti della sua generazione, è stata per anni ascritta a una produzione di tipo minore . Il lavoro critico dispiegato da qualche decennio, vero e proprio movimento di rivalutazione della poesia dell’autunno del Rinascimento, ha invece mostrato come molto spesso questa poesia abbia eguagliato i risultati della generazione poetica che l’ha preceduta e dalla quale essa è stata influenzata. Come afferma Jacques Roubaud nella sua antologia del sonetto francese da Marot a Malherbe, è stata proprio la poesia della meditazione religiosa della fine del XVI secolo ad aver dato un contributo rilevante al processo d’innovazione delle forme poetiche, più di quanto non abbia fatto, ad esempio, la tradizione della poesia amorosa d’origine più o meno petrarchesca (Roubaud, , p. ). Il carattere marginale della poesia di Fiefmelin è in qualche misura proporzionale alla sua estensione: le poche riuscite si perdono infatti nel copioso numero di versi (circa .) di cui essa consta. Anche se ad alcune antologie va ascritto il merito di aver fatto circolare molti tra i componimenti migliori, un lavoro di lettura dei testi resta ancora sporadico. Si è voluto qui riorganizzare (o ridurre) la linearità dei sonetti attorno a classi d’equivalenze (figure, immagini, motivi) non tanto per mostrare la presenza di temi e stilemi già ampiamente descritti dalla critica a partire dalla produzione poetica protestante coeva, quanto per sondare ulteriormente i versi di Fiefmelin in modo da far dialogare le osservazioni formali e tematiche fatte in re col contesto poetico-ideologico della sua epoca. È stato possibile osservare innanzitutto quanto il rapporto Fiefmelin-Sponde non sia una filiazione diretta di tipo iperformale e scevra da altri aspetti potenzialmente rilevanti. È vero che l’evidente non linearità, dunque l’irriducibile variatio di cui dà prova Le spirituel nelle sue forme, ma soprattutto nei suoi contenuti, rendono problematici i tentativi di descrivere la raccolta poetica secondo classi o categorie stilistico-tematiche. La scelta di mettere Sponde in filigrana è stata una necessità LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE volta a sfumare le osservazioni della critica circa la contaminatio formale SpondeFiefmelin. Da Marcel Raymond a Claudio Azzolini, passando per Jacques Morel, la critica ha insistito sul raffinamento formale che nei versi di Fiefmelin subisce la poesia spondiana. Un raffinamento e una complessificazione delle strutture logico-sintattiche che però, come abbiamo cercato di mostrare, non va sempre di pari passo con un’identica orchestrazione degli stessi motivi. Nell’Image d’un mage, la ripresa di stilemi della tradizione profana rinascimentale e prerinascimentale (come quelli della poesia d’amore) e l’organizzazione del percorso spirituale del peccatore che dal mondo va verso Dio non hanno nulla di originale. Se si considera la disposizione dei poemi nella raccolta di Fiefmelin come un percorso di lettura che va dal male a Dio, è rintracciabile una struttura ternaria che corrisponde a tre tappe spirituali comuni ai poeti della meditazione religiosa (Cave, Jeanneret, , pp. -). La poesia penitenziale si fonda, in un primo tempo, sulla descrizione del mondo quale teatro dove agiscono le forze del peccato, dunque teatro di morte. La constatazione di questo degrado non impedisce al poeta eletto di celebrare la grandezza di Dio – secondo tempo –, la cui bontà è testimoniata dalla morte di Cristo sulla croce: Dio ama le sue creature e a esse accorda la grazia, la fede, la salvezza, secondo un suo disegno personale al quale il credente non può cooperare attraverso i suoi meriti (sola gratia). Il terzo tempo è infine quello della celebrazione di Dio e della sua chiesa, ma anche quello della rivelazione estatica e della visione, della sublimazione delle antitesi nella luce divina. In questo percorso, la descrizione dell’uomo e delle sue sofferenze è strettamente connessa a una riflessione su problematiche peculiari alla teologia riformata (la predestinazione, la salvezza attraverso la grazia, la tensione tra il peccato e la salvezza, lo stato antitetico che il credente vive euforicamente sulla terra ecc.). Della convergenza di temi e motivi profani nella poesia religiosa la critica si è ampiamente occupata, mostrando come, al di là di apparenti ed effettive rotture tra le epoche, ci sia anche una sostanziale continuità, ad esempio, tra Medioevo e autunno del Rinascimento. Fiefmelin non è stato soltanto il poeta militante a favore della Riforma, e dunque l’autore di un poesia austera e pienamente riconducibile ai dettami estetici di Calvino o di Bèze. Certo, troviamo nella sua poesia delle meditazioni su argomenti prettamente teologici, ma queste riflessioni non trascurano il proprio involucro retorico e formale. Infatti Fiefmelin, come altri poeti della sua generazione, non è stato affatto insensibile al richiamo di tradizioni diverse, in apparente discordanza con l’avversione per le immagini che il calvinismo professava. E se la tradizione amoroso-erotica, come il poeta stesso confessa, torna nei suoi versi, la ripresa avviene in chiave certamente religiosa – come succede, del resto, anche nei Sonnets d’amour di Sponde – facendo di questa poesia il luogo del compromesso, uno spazio in bilico tra l’ispirazione religiosa e l’assimilazione/rielaborazione di altre tradizioni. Se è dunque vero che in alcuni componimenti di Fiefmelin l’esasperazione formale sembra prendere il sopravvento sui contenuti, in altre liriche sono le tematiche a occupare una posizione di primo piano. I suoi componimenti non sono del resto soltanto un esercizio retorico ma servono a veicolare, attraverso il ricorso a quella fucina di immagini e clichés a cui il lettore è abituato, un contenuto nuovo. Si pensi ad LUIGI MAGNO esempio alla tradizione dell’esame di coscienza o della meditazione sulla morte – retaggio medioevale che dà accenti arcaici alla poesia di Fiefmelin – che nei monasteri medioevali aveva trovato voce risuonando in latino e per un pubblico di religiosi. La voga mistica torna nei versi de Le spirituel trasposta però in francese: questa, fondendosi con la tradizione letteraria laica, si indirizza adesso, in un’epoca in cui la stampa ha soppiantato il manoscritto, non più a un’élite conventuale ma a lettori laici. Se bisogna raggiungere un pubblico laico, bisogna dunque rinnovare le forme della meditazione e adattarle alla letteratura profana. Il francese soppianta il latino, le figure e i temi della retorica profana si sostituiscono a una scrittura fondata esclusivamente sulle immagini bibliche e su una retorica della linearità: la poesia speculativa di Fiefmelin (metafisica, religiosa, meditativa, dell’effusione lirica) realizza una sintesi personale dei materiali concettuali e spirituali di cui il poeta si nutre, per poi adattarli alla lingua poetica e dislocarli nei versi. Siamo qui di fronte a una vera e propria estetica dell’imitazione, ovvero a una ricontestualizzazione di quel retaggio già ampiamente esperito dai poeti precedenti, che si piega tuttavia a uno scopo dottrinale: la meditazione e la riflessione teologica si uniscono nei versi di Fiefmelin in vista della diffusione della dottrina protestante e dell’edificazione dei lettori. Per giudicare questa poesia è opportuno dunque considerare anche un parametro contestuale, cioè la propaganda religiosa che sottende la produzione e la circolazione di questi versi, che permetterebbe di riscoprirne una valenza pratica. Di diverso avviso ci appare Claude Blum. Egli afferma infatti che la poesia dei poeti protestanti non ha alcun fine pratico o didattico (Blum, , pp. -). La missione di questa poesia «n’est pas d’agir d’une façon décisive, car rien ne change de ce qui est prédestiné de toute éternité. Son rôle est plus limité, en même temps qu’il reste sans limites: il s’agit pour lui [le poète] de rendre gloire à Dieu de ce qui est» (ivi, p. ). Si tratterebbe di una poesia che non è in alcun modo «révélatrice de la Vérité» (ibid.), che nulla può contro i disegni imprescrutabili della predestinazione. La parola del poeta protestante confermerebbe all’eletto il suo stato di elezione (mentre al reprobo non potrà mostrare la sua dannazione), limitandosi così a cantare la gloria di Dio e la potenza della sua grazia, fino a ridursi alla trasmissione di un’esperienza spirituale che assecondi il disegno divino. Lo scopo di questa poesia è dunque quasi tautologico, confinato al canto letterale – dire quello che si scorge del disegno divino – di un’esperienza singolare e privata. La peculiarità del discorso poetico di Fiefmelin non può risolversi nell’autoriflessività della parola che indubbiamente, in molti versi, si autocompiace, guardando se stessa e le sue forme allo specchio. Certo, di autoriflessività questa parola è carica ma, al di là dei cardini teologici su cui Claude Blum fonda le sue argomentazioni, bisogna ricordare alcuni aspetti contestuali che attenuano questa portata. Resta per noi un’evidenza il fatto che Fiefmelin abbia scelto la via più feconda per interessare il lettore, ovvero il discorso poetico, che gli ha permesso di canalizzare una materia sacra in un contesto letterario, dunque profano, e di privilegiare così la musa cristiana su altre forme d’ispirazione. Alla fine del XVI secolo, la produzione letteraria, per quanto possa apparire, come in Fiefmelin, lontana dagli accadimenti storici, non ha spesso altro scopo che quello di accostarsi al lettore, di emozionarlo prima e convincerlo poi. Il poeta, per raggiungere questo scopo, non adotta la posizione del teologo (la trattatistica più razionale, l’identificazione di Dio con il logos) , né compie la scelta di tradurre le Sacre Scritture. Se l’autoriflessività solca i suoi versi, un’istanza LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE contraria seppur complementare convive con essa, ovvero quella primordiale scelta poetica che è un espediente di fondo per interessare il lettore, commuoverlo e convincerlo. Claude Blum sembra toccare in modo incidentale la centralità della scelta poetica quando afferma: «Le poète protestant participe, en utilisant les ressources particulières à la poésie, à la mise en valeur de la présence de l’au-delà dans ce monde» (ivi, p. ). La scelta del discorso poetico appare strategicamente compiuta in vista di un intervento mirato. Non si tratta solamente di una modalità generica per cantare Dio, ma anche di un espediente scelto per divulgare una delle forme che la Parola biblica può prendere, inserendosi così nel dibattito teologico suscitato dallo scisma della chiesa riformata. Si suggeriva prima un accostamento della poesia di Fiefmelin a un atto pratico, un gesto al servizio della propaganda religiosa, una parola che celebra Dio ma che milita, indirettamente, per la causa riformata. Non si dimentichi infatti che Dio è biblicamente un Dio della Parola; egli è il Verbo, la Parola attraverso cui si fa conoscere, crea e salva il mondo (Mehl, , pp. -). Tale identificazione assume una pregnanza tanto più evidente se si considera che in ebraico il Verbo non è scisso dall’Atto e che la Parola non è, in questa accezione, un «flatus vocis» (ivi, p. ) separato dall’azione. La ricerca del senso di tale Parola diventa lo scopo primario tanto della teologia protestante quanto della parola poetica a essa ispirata, in vista di uno stesso fine che tende alla conoscenza di Dio. Mentre l’arte poetica oscilla tra estetica ed etica. Note . In questo senso ci pare rivelatore il dibattito attorno alle categorie di barocco e di manierismo letterario, categorie estetiche che rivelano ormai un carattere non sempre operativo, come accade per la produzione di André Mage: poeta barocco, manierista o arcaico? Poeta spirituale, mistico o della meditazione? Poeta realista o metafisico? . Il modello ronsardiano e rinascimentale resta una presenza scomoda ma permanente per i poeti della fine del XVI secolo, un faro che contemporaneamente attrae e ripugna alimentando idee di perfezione ma anche di perfettibilità circa il modello stesso. . Jacques Pineaux annovera, tra i poeti «de combat», non soltanto Agrippa d’Aubigné, Antoine La Roche-Chandieu o Bernard Montméja, ma anche poeti come André du Cros, Charles de Navières, Michel Boucher de Boiscommun, dividendoli dai poeti detti «de la méditation» (cfr. Pineaux, , pp. -). Si potrebbe pensare che la suddetta separazione sia una ripartizione dettata da un’esigenza metodologica e/o di categorizzazione: questa divisione non cancella infatti la complessità concreta con cui lo studioso si confronta, conscio del fatto che gli scopi e le modalità di queste due forme-categorie poetiche si incrociano più spesso di quanto non sembri. . Conosciamo le Œuvres del signore di Fiefmelin nella loro edizione del , stampate a Poitiers per i tipi di Jean de Marnef. Si tratta di una raccolta dei versi e di altri scritti che il loro autore aveva già in parte pubblicato. . Come nota già Claude Blum (, pp. -), nella teologia protestante la presenza del peccato e della grazia divina è intesa come compresenza, come simultaneità tra il male e il bene. Invece, nei versi dei poeti protestanti questa presenza simultanea di perdizione e salvezza è letta in termini antitetici (di qui la presenza di antitesi e ossimori). Ci pare tuttavia che in Fiefmelin abbondino le riuscite (nel senso teologico del termine) dove viene resa questa simultaneità, come ad esempio nel sonetto: «D’un accordant discord s’entrechoquent en moy / Deux hommes en un homme, en un corps deux natures, / Deux formes en un estre, et en deux creatures, / Une personne humaine où un se double en soy» (Les saincts souspirs, f. v). . Viene in mente qui il trattamento che la pittura manierista fa del corpo umano: disproporzioni, deformazioni, giochi prospettici per mettere in risalto alcune parti rispetto ad altre. LUIGI MAGNO . Marcel Raymond, a proposito del sonetto, continua: «Je connais peu de poèmes où la conscience chrétienne soit plus vivement éclairée au bord extrême de la faute, où se marient avec une pareille puissance poétique le feu de l’instinct et l’eau de la grâce. Et je ne pense pas que nulle part Fiefmelin ait usé avec un si grand bonheur du rejet, de la rupture. L’intensité dramatique de ce “chant d’expérience” équivaut bien à celle des meilleurs sonnets de Sponde» (Raymond, b, p. ). . Les saincts souspirs, ff. v-r. Abbiamo letto les Œuvres di André Mage de Fiefmelin nell’edizione edita a Poitiers nel per i tipi di Jean de Marnef. L’esemplare utilizzato è quello conservato alla Bibliothèque de l’Arsenal di Parigi. La trascrizione dei sonetti e delle citazioni sarà fedele alla lezione di questo esemplare. Ci siamo limitati a ritoccare la punteggiatura, a sciogliere abbreviazioni e alcuni nessi tipografici. . «L’antithèse du jour et de la nuit ne devrait donc être qu’une opposition parmi d’autres. Sa fréquence lui confère toutefois une prédominance évidente. Elle se trouve en effet partout, dans la poésie religieuse comme dans le lyrisme amoureux […]»; «Cette dialectique du jour et de la nuit tient une place plus grande à la fin du XVI siècle qu’au début du XVII» (Melançon, , pp. -). . Sponde, ad esempio, si chiede: «Si c’est dessus les eaux que la terre est pressée, / Comment se soutient-elle encor si fermement?» (Sponde, , p. , vv. -). . Sulla navigazione come immagine del viaggio del corpo sulla terra cfr. Melançon (, pp. -). . È questa la linea interpretativa di Pierre Menanteau (, p. ) che legge l’aggettivo «Hermides» come derivante dal francese «herme», riconoscendo dunque nei «ports Hermides» un luogo deserto, abbandonato (interpretazione ripresa in Chauveau, , pp. -). . Ermes era un dio essenzialmente benefico. Messaggero degli dèi, egli guidava i viandanti nel loro cammino infondendo coraggio, allontanando i pericoli, alleviando le fatiche. Fu lui, ad esempio, che condusse Priamo da Achille quando il re andò a reclamare il corpo di Ettore (Omero, , XXIV, vv. -, -, -, -). . Su Fiefmelin e l’alchimia cfr. infra, nota . . Si pensi anche all’assimilazione che i Padri della Chiesa fecero della teoria platonica dell’amore, trasformandola in una teoria della divina caritas (o amor Dei) che si pone in aspro contrasto con la cupiditas e le diverse forme d’amore carnale. L’antitesi teologica tra caritas e cupiditas sarà in seguito abolita da alcuni attraverso l’assimilazione spirituale dell’amore carnale (presupposto, ad esempio, nei versi del Roman de la rose o, ancora, dai poeti stilnovisti italiani tra cui Dante), mantenuta da altri (si pensi a Petrarca che, seppur divinizzando e idoleggiando la sua donna, non smette di riumanizzarla e risessualizzarla). Cfr. Panofsky (, pp. -). . Sullo sguardo e la cecità cfr. Wind (). . «L’inconstance amoureuse n’est que l’une des formes de la mobilité» (Mathieu-Castellani, , p. ). . Les meditations, f. r-v. . Uno spazio a se stante meriterebbe senz’altro un lavoro di archeologia ipertestuale, sulla linea degli studi già intrapresi da Jacques Morel () per questo sonetto, e da Claudio Azzolini () per le Stances sur l’essai des Poëmes chrestiens de la mort du sr de Sponde e le Stances de la mort au Baron de la Chaulme. . Les saincts souspirs, f. r-v. . Su alchimia e tradizione protestante cfr. Secret (). . Nel sonetto che apre l’essay de La Chrestienne, intitolato Metamorphose des Spirit.[uels] ou Regen.[érés] (La Chrestienne, f. r-v), al motivo della trasformazione troviamo unita, al v. , l’immagine dell’«ardent fourneau» che richiama esplicitamente l’athanor dell’alchimista. Tuttavia, in un altro sonetto (cfr. L’homme naturel, f. v), Fiefmelin propende per un’ispirazione più nettamente religiosa: egli non manca di polemizzare aspramente con le pratiche alchemiche, accusandole di distogliere gli uomini dalla sola verità che è in Dio. . In verità, nel passo biblico da cui Fiefmelin si ispira, san Paolo non ostenta nessuna certezza circa il modo della sua visione, ma usa anzi una cautela, quanto meno retorica, per parlare dell’accadimento. San Paolo relativizza, smarrito, sulla sua visione, dicendo di non sapere se questa si sia consumata col corpo o con l’anima; al contrario Fiefmelin, ispirato dalla fiamma divina, ostenta certezze circa il perdurare dell’unione tra anima e corpo. Parlando di sé alla terza perso- LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE na l’apostolo dice: «Io so di un uomo in Cristo il quale, quattordici anni fa, se col corpo o fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito al terzo cielo. E so che quest’uomo, se col corpo o senza corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è dato all’uomo di poter esprimere. Riguardo a tale uomo io mi glorierò, ma quanto a me non mi glorierò se non delle mie debolezze. Tuttavia anche se volessi gloriarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità; ma me ne astengo, affinché nessuno si formi di me un concetto superiore a quello che vede in me o che sente da me» (Seconda lettera ai Corinzi, , -). Al di là delle differenze tra le due visioni, importa qui sottolineare come i motivi presenti in questo sonetto non abbiano quasi nulla di protestante ma siano più vicini a una lezione di tipo cattolico (la ripresa di san Paolo, l’insistenza sulla visione mistica). . Rigettando il complemento diretto («L’homme») al v. , tre verbi completano la costruzione che si può sciogliere nel modo seguente: La foi d’esprit au Père avive; L’espoir d’âme au Fils anime; L’amour de coeur à l’Esprit enflamme. . Si è detto tradizione profana greco-romana: il pensiero va qui a un’interessante osservazione fatta da Lionello Sozzi sull’immagine dell’«aele bien empanée» presente nel sonetto dell’Olive di Du Bellay. Le ali piumate (immagine non esplicitamente presente in Fiefmelin, ma che una lettura estesa de Le spirituel non manca di evocare) sono infatti per Lionello Sozzi un retaggio evidente di antiche tradizioni pre-platoniche: egli pensa più esattamente a Zoroastro e alla tradizione magica conosciuta attraverso la divulgazione fatta da Marsilio Ficino. Si tratta dunque di un échantillon di quella tradizione antica che conferisce all’immagine dell’ala piumata un’«alta tensione spirituale» (Sozzi, , p. ). . Les meditations, f. r-v. . Se «Fra i teologi rinascimentali era quasi un luogo comune dire che i misteri più alti trascendono la comprensione e devono essere appresi in uno stato di oscurità in cui le distinzioni della logica svaniscono» (Wind, , p. ), la separazione tra visione e conoscenza che Fiefmelin pare attuare nel suo poema sarebbe in controtendenza rispetto a queste posizioni. . La poesia dei poeti protestanti è, per Alioune Diané (, p. ), «l’impossible expression de la splendeur divine», un’impossibilità alla quale subentra spesso la teologia, o che spinge la poesia stessa a mettersi sulle tracce della teologia fino a deviare il poetico verso altre forme d’espressione. . Sponde (, p. , vv. -). . Atteone – com’è noto – è la sola figura mitologica presente nei versi di Jean de Sponde. . Mario Richter () scorge nel riferimento ad Atteone una duplice presenza (il poeta e il Cristo), fino a negare la presenza del platonismo nei Sonnets de la mort («aucun véritable platonisme dans tout cela», ivi, p. ), assenza che lascia spazio a una visione nettamente calvinista dell’amore. Più in generale, secondo Richter il motivo della costanza in Sponde è l’elemento che invita a leggere i versi del poeta secondo un’ottica calvinista: «On le voit, c’est là un argument crucial de la doctrine calvinienne, et pas du tout platonicienne ou stoïcienne: ce qui (la constance) pour les philosophes platoniciens et stoïciens est une vertu purement humaine […] subit dans l’optique de Calvin et de Sponde une transformation radicale, car la constance devient un “miracle” de la grâce divine» (Richter, , pp. -). Al contrario, Isa Dardano Basso ha mostrato come elementi del platonismo (ermetico) siano presenti in Sponde («Per Sponde la costanza non trova la sua definizione nelle teorie neostoiche, ma in quelle platoniche», Dardano Basso, , p. ), specie nella ripresa del mito di Atteone. . Erwin Panofsky () si è occupato del motivo dell’Amore cieco dandone un’interpretazione in senso moralistico, vedendo cioè nel dio bendato una forma irrazionale e carnale di attrazione. Per Panofsky, anche i teorici del neoplatonismo rinascimentale avevano rifiutato, come avveniva tradizionalmente, di accordare una valenza positiva alla cecità dell’Amore. Edgar Wind () ha invece mostrato come la cecità d’amore di origine orfica sia stato un elemento centrale in molti filosofi e scrittori neoplatonici quali Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Lorenzo dei Medici e, non ultimo, Giordano Bruno. Negli Eroici furori, ad esempio, Bruno sviluppa un ampio discorso sulla cecità d’amore facendo dell’accecamento sacro la più eccelsa forma di visione che consente l’accesso al divino. . L’intelletto esclude le contraddizioni – perché esso chiarifica, delimita, restringe – mentre la cecità le comprende in sé. LUIGI MAGNO . Al contrario, in altri sonetti la visione sembra negata o, come in Sponde, essere relegata all’aldilà. Cfr., ad esempio: La Chrestienne, f. r, sonetto XIV, vv. -; Je fend volant aux Cieux, l’element plein d’atome (Les prieres, f. r); Je semble au Danaïde aymant si hautement (Les saincts souspirs, f. r). . Era importante tornare su André Mage, poeta la cui opera continua a circolare in forma estremamente frammentaria e manca di un’edizione critica. Ci siamo accertati tramite carteggio che un’équipe interuniversitaria diretta dal prof. Julien Goeury (Nantes) e composta da Audrey Duru (Lyon ), Nicole Pellegrin (Ecole Normale Supérieure) e Simone de Reyff (Fribourg) lavora attualmente all’edizione critica di tutta l’opera di Fiefmelin, la cui pubblicazione è prevista, per i tipi di Champion, a partire dal gennaio . . Sull’influenza che la tradizione della poesia d’amore profana ha avuto sui versi di Fiefmelin cfr. Hill (). . Fiefmelin dichiara: «Je ne te veux celer, ains franchement advouer, Lecteur, que j’ay en ce mien dernier Essay changé quelques chants de mes amours jadis profanes en ces Airs spirituels. Ils sont remplis de mon zele envers Christ-Dieu, et de charité envers mes freres, les domestiques de la Foy, son Eglise, sous le nom de la Chrestienne de Mage. J’ay ainsi eschangé la lettre des susdites chansons amoureuses, afin que les mesmes vers qui, ci-devant tournez à l’envers, eussent peu scandalizer mon prochain, l’edifient maintenant estans contournez à leur endroict. Partant n’en seray-je blasmé des Chrestiens, ni du monde, sinon à tort. […]». (La Chrestienne, ff. v-r). Prova ulteriore è data dall’uso diffuso del mito, così come dal richiamo illustrato precedentemente alla tradizione alchemica. Questa pluralità è sintomatica di tutta l’epoca: si pensi al platonismo che, intriso di messaggi provenienti da tradizioni ermetiche, cabalistiche, orfiche o caldee, converge col cristianesimo e/o con la tradizione giudaico-cristiana. Come osserva anche il prof. Franco Giacone, che qui ringraziamo per averci accordato la sua preziosa collaborazione, tutti i sonetti presi da noi in esame sono la prova evidente di come spunti non religiosi o non tratti da problematiche della teologia proestante attraversino la raccolta di versi di Fiefmelin. . Su teologia e devozione cfr. Cave (, pp. -). . Il corsivo è nostro. Bibliografia AUDIAT L. (), Les oubliés. André Mage de Fiefmelin, Slatkine reprints, Genève (a ed. Paris ). AZZOLINI C. (), L’intertestualità barocca: Sponde e Fiefmelin, in “Il confronto letterario”, IV, , pp. -. BELLENGER Y. (), La métamorphose dans la poésie religieuse baroque (fin du XVI, début du XVII siècles) , in G. Demerson (éd.), Poétiques de la métamorphose , Publications de l’Université, Saint-Etienne, pp. -. (), La représentation de la mort dans la littérature française de la Renaissance, Champion, Paris ( voll.). CAVE T. (), Devotional Poetry in France (- ), University Press, Cambridge. CAVE T., JEANNERET M. (), Métamorphoses spirituelles. Anthologie de la poésie religieuse française, -, Corti, Paris. CHAUVEAU J.-P. (), Anthologie de la poésie française du XVII siècle, Gallimard, Paris. CHEVALIER J., GHEERBRANT A. (), Dictionnaire des symboles, Laffont/Jupiter, Paris. CLÉMENT M. (), Une poétique de crise. Poètes baroques et mystiques (- ), Champion, Paris. DARDANO BASSO I. (), Appunti sul platonismo ermetico di Sponde, in “Micromégas”, -, pp. -. DAUVOIS N. (), Le sujet lyrique à la Renaissance, PUF, Paris. DELUMEAU J. (), Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIII-XVIII siècles), Fayard, Paris. BLUM C. LA TENTAZIONE , IL VOLO E LA VISIONE (), Une lecture du Spirituel d’André Mage sieur de Fiefmelin, in “Quaderni dell’Istituto di Lingue e Letterature Neolatine dell’Università di Milano, Sezione Francese”, [Della lettura dei poeti], pp. -. DIANÉ A. (), Le modèle poétique protestant dans la littérature française du XVI siècle et du XVII siècle, thèse de nouveau doctorat sous la direction de J. Bailbé et C. Blum, Université de Paris-Nanterre. DUBIEF H. (), La réforme et la littérature française, La cause, Carrière-sous-Poissy. DUBOIS C.-G. (), La poésie du XVI siècle, Presses Universitaires de Bordeaux, Talence. FOUCAULT M. (), Les mots et les choses, Gallimard, Paris. GIACONE F. (), Histoire d’écritures. La Bible et la théologie de Marguerite de Navarre à Agrippa d’Aubigné, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma. GREIMAS A. J., KEANE T. M. (), Dictionnaire du moyen français, Larousse, Paris. GREINER F. (), Les métamorphoses d’Hermès. Tradition alchimique et esthétique littéraire dans la France de l’âge baroque (- ), Champion, Paris. HALLIN F. (), Le sonnet CXIII de L’Olive, in “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, XXXIV, pp. -. HILL C. (), André Mage de Fiefmelin: fin de siècle, fin de temps?, in P. Citti (éd.), Fins de siècle, Presses Universitaires de Bordeaux, Talence, pp. -. JEANNERET M. (), Poésie et tradition biblique au XVI siècle, Corti, Paris. LONGEON C. (), Mort et métamorphose dans la poésie baroque française, in G. MathieuCastellani (éd.), La métamorphose dans la poésie baroque française et anglaise. Variations et résurgences, Gunter Narr-Jean-Michel Place, Tübingen-Paris, pp. -. MACCHIA G. (), Il dramma di Sponde, in Id., Il mito di Parigi, Einaudi, Torino, pp. -. MAGE A. SR. DE FIEFMELIN (), L’image d’un mage ou Le spirituel, Jean de Marnef, Poitiers. MATHIEU - CASTELLANI G . (), Les thèmes amoureux dans la poésie française -, Klincksieck, Paris. MEHL R. (), La théologie protestante, PUF, Paris. MENANTEAU P. (), Images d’André Mage de Fiefmelin, poète baroque, Rougerie, Limoges. MOREL J. (), Trois sonnets en un seul. Fiefmelin abréviateur de Sponde, in “Cahiers de littérature du XVII siècle”, , pp. -. OMERO (), Iliade, Einaudi, Torino. PANOFSKY E. (), Cupido cieco, in Id., Studi di iconologia, Einaudi, Torino, pp. - (ed. or. Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance, Oxford University Press, New York ). PINEAUX J. (), La poésie des protestants de langue française, du premier synode national jusqu’à la proclamation de l’Edit de Nantes (- ), Klincksieck, Paris. PRIGENT M. (éd.) (), Histoire de la France littéraire, PUF, Paris, vol. I. PRUVOT A. (), Nouvelles lumières sur un vieux poète baroque, in “Le Flambeau”, , pp. -. RAYMOND M. (éd.) (a), La poésie française et le maniérisme -, Droz, Genève. ID. (b), Les sonnets d’André Mage sieur de Fiefmelin, in “Saggi e ricerche di letteratura francese”, IX, nuova serie, pp. -. RICHTER M. (), Jean de Sponde e la lingua dei protestanti nel Cinquecento, CisalpinoGoliardica, Milano. ID. (), Calvinisme et amour mondain: peut-on dater les sonnets d’amour de Sponde? , in “Chaiers V. L. Saulmier”, [Amour sacré, amour mondain. Poésie -], pp. -. RIEU J. (), Jean de Sponde ou la cohérence intérieure, Champion-Slatkine, Paris-Genève. RIGOLOT F. (), Poésie et Renaissance, Seuil, Paris. ROUBAUD J. (éd.) (), Soleil du soleil, Gallimard, Paris. ROUSSET J. (), La littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon, Corti, Paris (a ed. ). ID. (), L’intérieur et l’extérieur. Essais sur la poésie et sur le théâtre au XVII siècle, Corti, Paris (a ed. ). DESIMEUR M. LUIGI MAGNO SCHMIDT A.-M. (), Etudes sur le XVI siècle, A. Michel, Paris. SECRET F. (), Réforme et alchimie, in “Bulletin de la Société CXXIV, pp. -. du Protestantisme français”, SOCIETÀ BIBLICA ITALIANA (a cura di) (), La Bibbia Concordata, Mondadori, Milano. SOZZI L. (), Le ali dell’anima. A proposito di un sonetto di Du Bellay , in B. Wojciechowska Bianco (a cura di), Lettura e ricezione del testo, Adriatica Editrice Salentina, Lecce, pp. . SPONDE J. DE (), Œuvres littéraires, édité par A. Boase, Droz, Genève. WIND E . (), Orfeo in lode dell’Amore cieco , in Id., Misteri pagani del Rinascimento, Adelphi, Milano, pp. - (ed. or. Pagan Mysteries in the Renaissance, Oxford University Press, Oxford-New York ). BLAUE AUGEN, BLONDE BESTIE (UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN), OVVERO L’IRONICA SOLITUDINE DI TONIO KRÖGER, UN SALTIMBANCO SUL FILO DELLA FIN DE SIÈCLE. UNO STUDIO COMPARATO di Francesca Milaneschi A mia sorella Veronica, in memoria del giugno Cercate un onesto guadagno! Non diventate un buffone che agita sonagli! Intelletto e buon senso si fanno avanti di per sé, senza molta arte. E se avete qualche cosa da dire con convinzione, che bisogno c’è di correr dietro alle parole? Sì, i vostri discorsi così brillanti entro i quali intrecciate, per l’umanità, riccioli di carta, sono noiosi come il vento d’autunno che sussurra, apportatore di nebbia, tra le foglie secche. Johann Wolfgang Goethe, Faust Le fond de ma nature est, quoi qu’on dise, le saltimbanque. Gustave Flaubert Je ne suis qu’un clown irlandais, a great joker at the universe. James Joyce Thomas Mann: Tonio und Ich In questo articolo ci proponiamo di offrire, in una prospettiva che contempli la posizione di Thomas Mann in rapporto alla cultura del suo tempo, una lettura della novella che lo stesso autore, nel suo Saggio autobiografico del , definiva «la storia che ancor oggi, fra tutto quanto ho scritto, è forse la più vicina al mio cuore e la più amata dai giovani: il Tonio Kröger» (Mann, a, p. ). Opera composta tra il e il , e pubblicata nel numero di febbraio della “Neue deutsche Rundschau”, prima ancora di essere inclusa nella raccolta Tristano. Sei novelle, il Tonio Kröger presenta, come è stato osservato, caratteri più affini al genere del romanzo che non a quello del dramma, categoria letteraria cui generalmente si rifaceva la «tradizione novellistica dell’Europa occidentale» (Mann, , pp. XII-XII). La narrazione del Kröger, per la quale lo stesso Mann – la cui con- FRANCESCA MILANESCHI cezione di novella sembra in effetti «più vicina al racconto/romanzo che non al dramma» (ivi, p. XIII) – si riferisce utilizzando sia il termine novella che racconto, si dipana lungo nove capitoli, che presentano una struttura attentamente congegnata e un tessuto di variazioni stilistiche per nulla casuali, ma connesse al nucleo più profondo dell’estetica manniana, di cui il Kröger costituisce manifestamente una sorta di precoce espressione in nuce, per servirci di termini crociani e filosoficamente coevi al testo. Nella novella sembra anzi condensarsi una sintesi critica e consapevole della poetica che già informava l’eccezionale esordio dei Buddenbrook, la “decadenza di una famiglia” e quasi manifesto/suggello della letteratura decadente che “infestava” la tradizione europea occidentale della fin de siècle. Ed era quella decadenza nient’altro se non l’ultimo romanzo dell’Ottocento, e primo romanzo modernista en travesti: un “ballo di Natasha” a cui un Tolstoj anseatico imponeva costumi che rivelavano sin dal principio – sin dai primi passi, sin dagli epitetici Leitmotiven che accompagnano omericamente, dunque classicamente, ma con un insistere che non può non suonare grottesco, “discordante”, quasi “dodecafonico” ante litteram – la propria natura di mascherata, di carnevalesco rogo che solo a Venezia nella tragica morte dello “Scrittore” Aschenbach giungerà a scacciare il pestilenziale “fantasma del Padre”, un gigante colpevole e liquidatore, come ben sappiamo dai biografi manniani (cfr. Kurzke, ). Se il console Mann è infatti un padre che scioglie dal vincolo della pesante eredità della “ditta” e dunque disereda e concede la libertà di scelta, egli lascia i due figli Thomas e Heinrich – nella loro “cattività monacense”, soggetta alla sola legge materna e meridionale, colpevolmente “frivola” e mondana («Diese ganze bellezza macht mich nervös» dice Tonio a proposito degli italiani, custodi della bellezza e dell’arte per eccellenza, e in modo insostenibile, per la sensibilità esasperata di Tonio), – liberi e soli di fronte al dramma dell’Unordnung und frühes Leid, “disordine e dolore precoce” di un’autorità maschile che sfugge fino al generare un quadro clinico d’isteria, come insegna la parabola di quest’altra celebre novella manniana, «il Tonio Kröger del secondo Mann», secondo Ladislao Mittner (, p. ). È questo un “Fantasma del Padre” che si esprime in veste archetipicamente (almeno sotto il profilo delle ascendenze archetipiche più “letterarie”) “danese”, come il “marcio” di Amleto, geograficamente così vicino a Lubecca, e come il “marcio” che inchioda nella gita ad Aalsgard gli “occhiazzurrini” di Hans e Inge alla loro stessa natura inconsapevolmente “colpevole”. Di questa “razza bionda” e nietzscheanamente “superiore”, Mann già subodora il marcio, l’odore inspiegabile, ancora, di bruciato, che comincerà molto presto a bruciare: prima i libri, poi i corpi veri di vittime “imperfette”, imperfette per razza, per religione, per malattia, per colore politico, per inclinazione sessuale, per innata tendenza alla zingaraggine o per cultura profonda di nomadismo. «C’è del marcio in Danimarca», come pieno di marciume, per qualunque maniaco dell’igiene e della purezza, deve rivelarsi il mondo. Die Reise nach bürgerliche Kunst: nove capitoli di gestazione Per comodità di sintesi potremmo suddividere in tal modo la successione dei nove capitoli (struttura che sembra quasi enucleare il velato disegno di “gestazione” di una sorta di “parabola evangelica” sottesa al testo) del racconto del Kröger: BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) – – – – – – – – – I: Passeggiata con Hans Hansen. II: Inge e la lezione di ballo. III: Formazione artistica di Tonio. IV: Colloquio con Lisaveta. V: Annuncio a Lisaveta della partenza VI: Il ritorno a Lubecca. VII: Sulla nave verso la Danimarca. VIII: Il ballo ad Aalsgard. IX: Lettera a Lisaveta. di Tonio. I primi due capitoli sono consacrati alla narrazione di alcuni episodi dell’adolescenza del protagonista, momenti fondamentali nella sua formazione, umana prima ancora che artistica, poi completata nel capitolo III. I capitoli IV e V, collocati in posizione strutturalmente centrale all’interno del racconto, segnano il momento cruciale in cui Tonio – attraverso il colloquio con l’amica pittrice Lisaveta, dunque finalmente una creatura a lui in qualche modo affine – definisce la propria concezione dell’arte, per poi prendere la decisione di affrontare il viaggio/martirio verso la propria origine nordica, ovvero la parte di sé più remota e rinnegata, quella che potrebbe a un primo sguardo apparire la più lontana rispetto alla sua vocazione di artista. Agli ultimi capitoli è affidato il racconto di questa profonda esperienza che il protagonista accetta di affrontare, ovvero un viaggio verso la propria città natale e ancora più a nord verso una stazione balneare danese, immerso tra quelle creature estranee che non possono comprenderlo, quelle creature bionde dagli occhi azzurri che rappresentano la sana vita borghese da cui Tonio è doppiamente escluso: per la sua origine doppia, nordica e meridionale insieme, riflessa in quel suo insolito nome, e per la sua vocazione artistica, che condanna alla solitudine e all’altrui incomprensione tutti coloro i quali si consacrano all’arte e per essa sono costretti a rinunciare alla vita. Ed è alla lettera finale a Lisaveta, che costituisce l’ultimo capitolo del racconto, che Tonio affida questa sorta di suo “testamento” artistico, ovvero il senso della sua autentica identità conquistata, o forse solo ritrovata: lo scopo cioè che con questa sua arte vorrà d’ora in poi raggiungere, illuminato da una nuova comprensione delle cose e degli esseri. Forte di questa nuova comprensione, e al di là dell’antitesi che contrappone borghesia/vita e arte/solitudine, il nuovo messaggio dell’artista della crisi sarà allora proprio l’amore per il mondo borghese, la “sintesi” che di questa vita borghese farà l’oggetto della propria arte. Tonio Kröger: Einsamkeit eines Prinzen «Sa, in realtà tutti i titoli, tranne quelli costituiti da nomi propri, sono dozzinali». Così citava Mann nel suo saggio del intitolato Bilse ed io (Mann, b, p. ) pubblicato in origine sulle “Münchner Neueste Nachrichten” e composto dall’autore pro domo sua rispetto a una polemica che lo tacciava di eccessi autobiografici nel suo romanzo I Buddenbrook, paragonandolo al mediocre Bilse, autore di opere spesso circonfuse da un alone di scandalo. Mann commenta questa affermazione di un non precisato «giovane scrittore tedesco» (ibid.), con il quale egli avrebbe sostenuto una discussione a proposito dei titoli dei libri, con un netto «ottimamente», non facendo affatto mistero dell’importanza che egli stesso attribuiva al nome proprio nell’opera letteraria. Se il nome ha dunque il merito di preservare il titolo di un’opera dal rischio di attributi più dozzi- FRANCESCA MILANESCHI nali, esso investe anche, e nel Tonio Kröger in particolare, importanti funzioni di connotazione dei personaggi. Soffermandoci sulla figura dell’amico di Tonio, che incontriamo subito nel primo capitolo del racconto, osserviamo come Hans Hansen – sebbene non appaia nient’affatto superficiale o insensibile rispetto all’amico Tonio Kröger, personaggio contrassegnato da un nome in cui domina il senso del contrasto e della duplicità Nord/Sud, mondo tedesco/mondo latino – con quel suo nome così “tautologico”, non possa in ultima istanza che accostarsi ad accogliere soltanto il suo identico simile, proprio perché non può “com-prendere” ciò che esula dal limite delle sue caratteristiche. Così, nel finale, l’occhiazzurro di Hans si riflette, con modalità potremmo dire narcisista, nell’occhiazzurra Ingeborg – quasi un’apoteosi di adolescenziale narcisismo: perché un Narciso ha appunto sempre bisogno di una Eco, o di un Boccadoro, o di un’Inge che balli con lui riflettendolo, senza stridori – ma si tratta a ben vedere di un accoppiarsi spiritualmente sterile, che non genera uno scambio e una commistione tra componenti diverse. Manca cioè in tale scambio tanto la dialettica tra posizioni antitetiche, quanto lo spirito che proprio nel finale consentirà a Tonio il superamento degli opposti in una superiore consapevolezza. Sempre nel Saggio autobiografico Mann si sofferma su questa caratteristica di tali creature felici e senza ombre: È ben vero che la “bestia bionda” compare anche nelle mie composizioni giovanili, ma è quasi spogliata del suo carattere bestiale e non ne rimane altro che la biondezza insieme con l’assenza di spirito: oggetto di quell’ironia erotica e di quell’affermazione conservatrice per cui, come egli [Mann si riferisce qui a Nietzsche] sapeva benissimo, lo spirito si danneggiava in fondo così poco (Mann, -, vol. XII, p. ). Ecco che invece Tonio Kröger si rivela un essere contraddittorio e duplice già in quel suo nome, che al tempo stesso lo denota e lo connota, e grazie alla propria bipolarità, alla scissione sofferta tra mondo borghese (delle origini, benché unicamente paterne) e universo dell’arte (scelto per vocazione, dunque per necessità intrinseca al suo stesso essere), – tra lascito paterno ed eredità materna – egli è in grado di comprendere (e in un secondo momento di accettare) tanto la propria condizione, quanto quella degli “occhiazzurri”, rappresentanti del mondo da cui è per sempre escluso. Tonio è sì, da sempre e per sempre, solo come il re del Don Carlos di Schiller – e la citazione manniana non può apparirci casuale, né rispetto all’opera né rispetto al passo in questione: un re che si rispetti è sempre il più solo di tutti gli esseri. La solitudine di un re diventa allora metafora della solitudine profonda che condanna l’artista, solo come un re confuso tra la folla. «Wir sind doch keine Zigeuner in grünen Wagen»: è questo il rivelatorio Leitmotiv che accompagna il percorso di Tonio verso il raggiungimento della propria sofferta identità di scrittore borghese. Noi non siamo (o meglio: non dovremmo essere) gli zingari nel carrozzone verde; noi non siamo (o meglio: non dovremmo essere) dei ridicoli saltimbanchi, “il buffone che agita i sonagli” di cui già parlava Goethe: ma il suo Wilhelm Meister non seguiva forse Mignon in capo al mondo (ovvero «laggiù», in Italia, fino in Sicilia nella «terra dove fioriscono i limoni, tra l’oscuro fogliame rosseggiano dorate arance?» (Fertonani, Giobbio Crea, a cura di, , p. , T.d.A.)? Mann sa bene che, nel mondo della nascente società di massa, – una volta esaurite le fonti tradizionali d’ispirazione “sacra”, quali la mitologia classica o l’iconogra- BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) fia religiosa – all’artista non resta altra via, né altra mitologia sostitutiva, che quella del circo, sorta di rappresentazione simbolica di libertà. Né resta dunque altro archetipo, altro mito da incarnare (prima in letteratura, tra il e il , poi in pittura) che quello del saltimbanco, quel clown tragico «roi de dérision» (Starobinski, , p. ) di cui Jean Starobinski ha tracciato un illuminante portrait: […] le monde du cirque et de la fête foraine représentait, dans l’atmosphère charbonneuse d’une société en voie d’industrialisation, un îlot chatoyant de merveilleux, un morceau demeuré intact du pays d’enfance, un domaine où la spontanéité vitale, l’illusion, les prodiges simples de l’adresse ou de la maladresse mêlaient leur séductions pour le spectateur lassé de la monotonie des tâches de la vie sérieuse. […] A ce plaisir de l’œil se joint un penchant d’un autre ordre, un lien psychologique qui fait éprouver à l’artiste moderne je ne sais quel sentiment de connivence nostalgique avec le microcosme de la parade et de la féerie élémentaire […] jusqu’à parler d’une singulière forme d’identification. […] Depuis le romantisme (mais non certes sans quelque prodrome), le bouffon, le saltimbanque et le clown ont été les images hyperboliques et volontairement déformantes que les artistes se sont plu à donner d’eux-mêmes et de la condition de l’art. Il s’agit d’un autoportrait travesti (ivi, pp. -). In tal senso, anche Der Bajazzo può essere considerato un cartone preparatore del Tonio Kröger. Ciononostante, – nonostante la distanza e l’inevitabile isolamento da questa folla volgare che lo irride – il “principe” Tonio, sorta di anti-Amleto, è anche “con” l’altro, poiché lo capisce, perché può arrivare a conoscerlo. Grazie all’intuizione, che trasfigura nell’artista la conoscenza sensibile in esperienza estetica, Tonio conosce al tempo stesso, e saremmo tentati di dire “kantianamente”, – per via sintetica, ove cioè la negazione di un assunto non ne indichi necessariamente la contraddizione – la propria esclusione e solitudine, ma anche la felicità priva di ombre dell’altro. Così l’associazione, nella scena del ballo ad Aalsgard, dell’immagine del primo amico e della prima ragazza amata in una figura quasi ermafrodita di perfezione impossibile e crudele, appare quasi un’ulteriore espressione di quell’unità ritrovata alla fine del viaggio a ritroso alla ricerca delle origini perdute, di quell’unità platonica di cui il nome Tonio Kröger sembrava già denunciare la quête. Sebbene l’immagine archetipica dell’arte sia in Mann sempre narcisistica (basti pensare a un’opera emblematica come La morte a Venezia), il Tonio Kröger si configura davvero come un unicum nella produzione manniana, anche in ragione di un reale tentativo di superamento del narcisismo. Nel finale del Kröger, l’occhiazzurro, l’altro, non è più soltanto il rivale come in Tristan, né il riflesso narcisistico, «le dolci labbra della propria ombra», come sarà nella Morte a Venezia: è invece il diverso da sé da accettare in una comprensione più ampia, che consente anche il superamento dell’adolescenziale bisogno di accettazione che Tonio mostrava nei primi capitoli. C’è dunque un concreto passaggio, dalla “questua” patetica e disperata dell’escluso, alla quête, trascendente e quasi mistica, dell’artista autentico, per descrivere il quale Mann nell’ultima pagina del racconto si serve dell’immagine biblica della Pentecoste: Perché se c’è qualcosa che possa fare di un letterato un poeta è appunto questo mio amore borghese per l’umano, il vivo e l’ordinario. Ogni calore, ogni bontà, ogni umorismo scaturiscono da esso [cioè, guarda caso, quelle caratteristiche che definiva- FRANCESCA MILANESCHI no lo stesso spirito borghese, anzi “lubecchese”, per Mann], e mi sembra quasi che sia quell’amore stesso del quale sta scritto che si possono parlare tutte le lingue degli uomini e degli angeli, ma chi ne fosse privo non sarebbe altro che un bronzo risonante e un sonaglio tintinnante (Mann, , p. -). Di particolare rilievo appare inoltre il fatto che poche righe dopo la citazione biblica Mann aggiunga: «Ma il mio amore più profondo e segreto appartiene ai biondi e agli occhiazzurrini, ai luminosamente vivi, agli esseri felici, amabili e comuni», ovverosia a coloro che più sono distanti, secondo quanto il racconto della vita di Tonio ha mostrato, dal provare quell’amore superiore di cui Tonio ha avuto l’intuizione nella sala da ballo, quell’amore che tanto avvicina l’artista a Dio, se è vero che per Mann «Dio è spirito, e al di sopra dei linguaggi vi è il Linguaggio» (Mann, , p. ). «Er gab sich ganz der Macht»: Nietzsche, la potenza e l’ironia Nell’ambito di questa definizione dell’artista, vi è naturalmente anche un’implicita e sottesa polemica di Mann rispetto alla concezione decadente e superomistica dell’arte, tanto in voga nella cultura fin de siècle e in buona parte ispirata al pur tanto amato (di un amore tutto letterario) Nietzsche. Ecco come si esprime in proposito Mann nel suo Saggio autobiografico: Non prendevo alla lettera nessuna delle sue parole. […] Dovevo forse prenderlo “sul serio” quando esaltava l’edonismo nell’arte? Quando esaltava Bizet a scapito di Wagner? Che cos’era per me il suo filosofema della potenza e che cosa la “bestia bionda”? Quasi un imbarazzo. La sua esaltazione della “vita” a danno dello spirito, quel lirismo che ebbe conseguenze scabrose per il pensiero tedesco, non potevo assimilarli che in un modo solo: come ironia (Mann, b, p. ). Lungi dall’essere dupe, vittima di un’estetica, dunque di una metafisica – e non si dimentichi che è proprio nella Critica del giudizio, dunque nella dimensione dell’estetica, che Kant aveva ambiguamente relegato in extremis l’altrove rinnegata categoria della metafisica – che giunge facilmente ad assoggettarsi alle utopie totalizzanti, e dunque, inevitabilmente, rischiosamente totalitarie, e come ben vede Alberto Asor Rosa, proprio nella sua eterna retorica dell’“artista-borghese”, nel suo elogio della creatura normale, dei cosiddetti “poveri di spirito”, «Mann è invece fra quelli che hanno scelto proprio l’ambiguità (vorrei dire a questo punto: l’ironia; poiché l’ironia è, in certe condizioni, la migliore difesa della fede) come veicolo del proprio rapporto con il mondo» (Asor Rosa, , p. ). E in quelle parole di Tonio che tuonano contro «chi prova un entusiasmo estremo e profondo per il raffinato, l’eccentrico e il satanico, contro chi non conosce la nostalgia per le cose ingenue, semplici e vive, […] la furtiva e struggente nostalgia per l’incanto delle cose comuni» è presente in un certo senso anche una sorta di prefigurazione di quella vera e propria inflazione del genere “romanzo del romanzo” e “romanzo dell’artista” che occuperà grandissima parte della produzione letteraria del Novecento e in fondo dello stesso Mann. Così il sarcasmo che investe la figura dell’artista dilettante, persuaso che parlare di cose alte e sublimi sia sinonimo del “fare arte”, e insieme il disprezzo per l’artista non autentico, colui che autoescludendosi dalla vita non parla che di sé e per sé, sono entrambi espressioni di tale polemi- BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) ca, che inscrive in sé una compiuta poetica, di cui il racconto Tonio Kröger si fa preciso veicolo se non addirittura manifesto. È questo un coraggioso tentativo di risposta a certe pericolose derive dell’estetismo galoppante nella fin de siècle, come già sottolineava Lukács (, p. ): «I racconti che trattano della vita di artisti: Tonio Kröger e La morte a Venezia, mostrano come problema centrale della sua creazione il “contegno”, l’anarchia sentimentale domata, la trasformazione dell’attività artistica […] in professionale». La critica dell’estetismo si unisce alla critica dell’onorabilità borghese, l’autoritratto appresta (o annuncia) la trasformazione in auto da fé: «C’est une critique dérisoire de l’art et de l’artiste. La critique de l’honorabilité rangé s’y double d’une autocritique dirigée contre la vocation esthétique elle-même» (Starobinski, , p. ). Non giungerà forse Mann ad autocondannare la propria stessa scelta, quella dedizione “borghese” e ordinata all’arte, scandita da orari quasi da ufficio, nella Morte a Venezia, dove la “strada del contegno” mostra tutta la propria fragilità – da carnevalesco fantoccio, appunto, di cartapesta – e rivela il proprio inevitabile incancrenirsi, risolversi in immonda “peste”? Così dunque il “borghese sviato” di TK, l’anima gemella di Thomas Buddenbrook divenuta scrittore, par essere il vero borghese: la strada del “contegno” da lui scelta, appare essere l’etica vera della nuova borghesia. Anche qui Thomas Mann celebra un inesorabile processo a se stesso. La Morte a Venezia è il suo configurarsi. Poiché in Gustav Aschenbach è giunto a compimento quanto in TK era soltanto desiderio, aspirazione e tendenza. Egli si è costruita una vita formalmente ineccepibile e un’opera importante sulla base della morale del “contegno” […]. Tuttavia basta soltanto un piccolo conflitto, un sogno nel mezzo di questo conflitto, per il cui appianamento ancora non è accaduto alcunché di appena percettibile, ed ecco che il “contegno” crolla rovinosamente (Lukács, , p. ). Difficile dunque non rilevare proprio nell’epilogo dell’opera manniana, ovvero il Doktor Faustus, l’indubbia condanna – o comunque la messa in dubbio, la messa in discussione etica ed estetica insieme – della dodecafonia e della Germania. Tale posizione è naturalmente legata al senso profondo che Mann ha della propria rappresentatività rispetto alla Germania e alla cultura tedesca, oltre che, come dicevamo, al suo concetto di letteratura nettamente antitetico al concetto di art pour l’art: l’estetismo è infatti per Mann quanto di meno tedesco, di meno borghese (e dunque di meno morale secondo la Bildung tedesca) ci possa essere. Scrive infatti Claudio Magris a proposito dei saggi di Mann: Nei saggi si esprime quella che Mann, nel , definiva la sua vocazione, che – egli diceva – non era quella del martire, bensì del rappresentante, consapevole di esserlo […], portavoce ufficiale e autorizzato dell’umanesimo e della democrazia […]. Sino alla prima guerra mondiale, nelle opere di Mann non c’è serenità – se non quella serenità che, in qualche modo, è sempre presente nella grande poesia, anche in una poesia di morte e di tragedia, in cui c’è, nonostante l’orrore, uno stupore incantato, un respiro profondo, l’epifania di qualcosa di travolgente […]. Ma questa felicità dolorosa, che un capolavoro come i Buddenbrook certo comunica, ha poco o nulla a che vedere con la serenità e con la conciliazione dei conflitti; essa nasce invece nell’abbandono al fluire della vita al di là del bene e del male, dall’espressione poetica della sua insostenibile intensità e dall’indissolubile unità e compresenza delle sue contraddizioni, che la rendono insensata e incantevole, struggente e brutale, stupida e insondabile FRANCESCA MILANESCHI […]. I Buddenbrook incantano, sgomentano, immalinconiscono, ma non rasserenano, e neppure Tonio Kröger o La morte a Venezia (Magris, , pp. XII-XIII). Come è noto a ogni artista postromantico, l’uomo moderno vive in sé la condizione ineliminabile della contraddizione perenne e, ciò che è peggio, consapevole: l’arte non potrà perciò essere che arte intrisa d’ironia, come già la vecchia separazione romantica tra poesia ingenua degli antichi e poesia sentimentale dei moderni aveva decretato. Molti elementi nel racconto fanno pensare a un’allusività di Mann rispetto alla questione: gli stessi riferimenti a Schiller, i discorsi contrapposti di Tonio e di Hans, l’uno sul Don Carlos l’altro sui libri di cavalli, così ricchi di belle illustrazioni, la quasi ironica contrapposizione tra Stellungen e Stellen nella conversazione tra i due ragazzi: «“In allen Stellungen?” sagte Tonio höflich. “Ja, das ist fein. Was aber Don Carlos betrifft, so geht das über alle Begriffe. Es sind Stellen darin, du sollst sehen, die so schön sind, dass es einem einen Ruck gibt, dass es gleichsam knallt…”» (Mann, , p. ). Del resto, ironia e romanticismo sono quasi un tutt’uno nello spirito tedesco, e se è vero che con I Buddenbrook Mann ha già composto il canto del cigno della borghesia, la Sehnsucht che Tonio prova dalla prima volta in cui vede Hans Hansen è anch’essa una sorta di nostalgia per un’età dell’oro che ormai è per sempre scomparsa: come infatti sottolinea Ladislao Mittner, i veri dominatori della vita sono per Mann gli aristocratici della vecchia generazione Buddenbrook, «energici senza brutalità e raffinati senza debolezza» (cfr. Mittner, , pp. -). Se Hans è perfetto, anzi quanto più Hans è perfetto, tanto più tale perfezione, tale percezione di bellezza evocherà in Tonio un’intuizione immediata di cupio dissolvi, un presentimento di morte e disfacimento. Se la mitologia romantica aveva consacrato il buffone come vittima sacra – «le bouffon est devenu une victime sacrée» secondo Starobinski (, p. ), ribadendo un concetto non troppo distante in fondo dal concetto di “capro espiatorio” da cui Nietzsche faceva discendere la nascita della tragedia, o dal bouc émissaire più di recente rimesso al centro dell’antropologia letteraria da René Girard – proprio Baudelaire (rinnovatore e massimo interprete dell’archetipo del clown tragico, tradizione che, ci ricorda Starobinski, risale al secolo precedente e secondo cui l’attore nasconde sotto il trionfo e la gioia apparente un’anima disperata) aveva già sancito la natura non salvifica dell’arte, soglia aperta all’inquietudine, pantomima sull’orlo dell’abisso: «L’art, on le voit, n’est pas une efficace opération de salut, mais une pantomime sublime au bord de la tombe, voilant, pour un instant seulement, les terreurs du gouffre» (ibid.). «Ogni pintore dipigne di sé»: da Poliziano ai “peintres de la vie moderne” La personale riflessione di Mann sulla vera natura dell’artista e dell’arte si inserisce dunque nel più ampio dibattito europeo (e a dispetto forse di Mann, del Mann delle Considerazioni di un impolitico soprattutto, quanto mai “francese”) sulla modernità, termine entrato nell’uso francese solo nel , alle soglie dunque della cultura romantica, e poi divenuto il problema centrale di una delle opere fondamentali per una definizione di modernità nella nascente società di massa, ovvero il Peintre de la vie moderne di Charles Baudelaire, opera che vede la luce tra il e il . Persino la tipica antitesi manniana: BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) […] l’antitesi fra la vita, sana ma banale, e lo spirito che la comprende e raffina ma l’isterilisce, è un motivo dibattuto dalla cultura fin de siècle, che Mann riepiloga e riassume. Anche se egli, nei Buddenbrook e nelle altre grandi opere scritte prima della guerra mondiale, lo elabora con sottile intelligenza e alta poesia, non si tratta di un tema originale. Già Schiller, nel suo saggio Sulla poesia ingenua e sentimentale, prima e insuperata diagnosi della contraddittoria situazione dell’arte nel mondo moderno, aveva messo a fuoco le difficoltà che impediscono allo scrittore di rappresentare il mondo senza perderlo, l’antitesi fra la poesia che s’identifica con la vita e la poesia che, come quella moderna, sente di averla perduta e può soltanto esprimere questa mancanza e questa nostalgia (Magris, , p. XV). Tanto più importante e originale nel dibattito culturale dell’epoca appare allora il contributo di Thomas Mann, come osserva Cesare Cases (cfr. Cases, ), sottolineando il carattere epigonico delle ultime sue opere, ove l'individuo borghese non è “destinato a sopravvivere”: dramma che Mann rappresenta senza anodine edulcorazioni e che può dunque essere risolto solo nell’orizzonte del mito e della favola (o della favola-saga, come nel ciclo biblico, la tetralogia di Giuseppe e i suoi fratelli). Nessuna grazia giunge a redimere l’individuo borghese, o il personaggio manniano, nel suo viaggio dall’identità collettiva (quasi quella di una tribù, seppure di “eletti”) che si manifestava in tutta la sua tragicità “mitica” nei Buddenbrook, all’identità individuale del borghese artista, che dalla morte di Hanno Buddenbrook passa per il “dramma della scissione” del Tonio Kröger, per toccare infine l’ironia tragica e demoniaca del Doktor Faustus. E se L’eletto è il titolo di un altro tardo romanzo di Mann, di ambientazione quasi fiabesca, certamente fantastica, e investito da una delle tematiche “romantiche” per eccellenza, ovvero la tematica morbosamente scabrosa dell’incesto tra fratelli, spesso romanticamente trasposta in letteratura romantica e decadente nell’amore platonico e narcisistico tra anime “sorelle”, non è dunque l’onorabilità borghese a salvare quest'individuo ambiguamente “eletto” (eletto perché fedele fino alla fine alle ragioni dell'umanità e dell’arte, ricorda ancora Cases), ma il pervicace attaccamento a una grazia che salvi il borghese “traviato” dal crollo: il crollo che trascinava “l’onorevole” Aschenbach nella vergogna dell’attrazione più inconfessabile, nella disonorevole morte per colera (disonorevole perché ripugnante, “brutta”, antiestetica come già era stata, per mano del futuro autore del Faust, la morte del giovane Werther) è anche il crollo, il Verfall, che incessantemente travolge la “famiglia” manniana, siano essi i mercanti anseatici o la Germania intera. Ecco dunque che – tra i tanti esempi di “romanzo dell’artista” della produzione manniana, lungo una parabola che dalla condanna grottesca di un personaggio come il protagonista del Tristano giunge alla tragica condanna di Adrian Leverkühn, in questo percorso che è anche una critica del proprio ruolo, oltre che della propria funzione sociale, rappresentativa rispetto alla collettività tedesca – la figura di Tonio Kröger occupa una posizione assai peculiare, che queste parole di Mann sembrano illuminare della giusta luce: In ogni mia creazione artistica […] si esprimeva non già un qualunque virtuosismo bohémien e senza radici, ma una precisa forma di vita, appunto Lubecca come forma di vita spirituale. La vocazione artistica, signore e signori, è qualcosa di simbolico. È la nuova realizzazione, su un altro piano, di una forma di vita che abbiamo ereditata col sangue. Così Schopenhauer scriveva a Goethe che «la fedeltà e la probità», il FRANCESCA MILANESCHI retaggio dei suoi avi anseatici che avevano esercitato la mercatura nella vecchia Danzica, erano le qualità, da lui trasferite dal campo pratico in quello teorico e intellettuale, che costituivano l’essenza del suo lavoro e del suo successo. Nel divenire un pensatore o un artista si “degenera” assai meno di quanto non creda il mondo da cui si emancipa, meno di quanto, anzi, egli stesso non creda; non si cessa affatto di essere ciò che furono i padri, ma lo si è in forma diversa, più libera, spirituale, simbolicamente creativa (Mann, b, pp. -). Ritratto di Tonio Kröger come “Urfaust” Eppure, l’entusiasmo espresso da Tonio nella lettera a Lisaveta appare, specialmente a chi osservi il cammino letterario del Mann più maturo fino alla tragedia del Doktor Faustus, singolarmente, quasi sospettamente, fiducioso. Siamo invece concordi con le sopra citate parole di Claudio Magris, ove afferma che il Tonio Kröger «non rasserena»: quello che potrebbe apparire come un romanzo di formazione, a ben vedere non ne è che la cornice. Con troppo ellitticamente infide, sbrigative parole – quel «Er ging der Weg, den er gehen musste» con cui si apre il terzo capitolo – e che investono soprattutto il tracciato finale di una parabola di Lehrjahren da cui ogni dato concreto, pratico, materiale è scomparso (ovvero la materia più viva e autentica di ogni Bildungsroman che si rispetti), vengono liquidati nel capitolo gli anni della cosiddetta “formazione artistica” di Tonio; e invece con quanta glaciale lucidità attenta al dettaglio si prospetta a Tonio, nel suo viaggio di ritorno nella mercantile città natale anseatica, la necessità di definire una volta per tutte, in via ufficiale, se stesso, nella scena dell’hotel, davanti al direttore e al poliziotto cui deve rendere conto della sua professione, del suo status. Anche la biblioteca popolare in questa prospettiva non rappresenta dunque soltanto il destino della casa del padre ormai decaduta, ma anche il destino dell’arte, dell’artista nel carrozzone verde, che finisce comunque per essere istituzionalizzato, normalizzato, sacralizzato: canonizzato e dunque addomesticato una volta per tutte, e rinchiuso finalmente all’interno delle griglie della fruizione sociale: in un’utile, sana e rispettabile istituzione borghese, così come anche le pagine dell’artista più maledetto trovano ineluttabilmente la loro destinazione finale nelle teche e sugli scaffali dei buoni salotti borghesi, o nelle antologie scolastiche per i licei. Di nuovo e senza scampo prigioniero dunque, come ogni vero Pitre châtié, come ben legge Jean Starobinski nei celebri versi mallarmeani: «Selon ce poème hautement allégorique, l’artiste, à la fois exclu de la vie et séparé de l’idéal, doit rester le prisonnier d’un espace clos: “histrion”, ou “mauvais Hamlet”» (Starobinski, , p. ). L’ironia, il distacco quasi crudele con cui un Mann ancora giovane, ma già autore di uno dei suoi capolavori forse più inarrivabili, quei Buddenbrook frutto dei suoi venticinque anni, prospetta a se stesso il disegno di un destino quasi ineluttabile, che troverà il suo altrettanto ineluttabile esito in quella che Lukács individuava come la tendenza di Adrian Leverkühn a sentire sempre il lato comico di ogni cosa, ovvero la vera tragedia dell’arte moderna nei suoi esiti migliori. Adrian sarà allora il demoniaco “anti-Tonio”: ove l’uno si poneva sotto l’egida della lettera di san Paolo, l’altro non potrà sottrarsi al demonio, un demonio che si presenta senza essere mai ufficialmente invocato né invitato a presentarsi. Non era forse Die lustige Person, ovvero il Faceto, il Mefistofele stesso nel Faust, il Lucifero, l’energia prometeica e tracotante BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) che porta all’uomo la luce della consapevolezza e con essa la vertigine colpevole dell’onnipotenza? È ancora Jean Starobinski a gettare un’ulteriore luce sulla parentela profonda tra questa necessaria “maschera” (cfr. Lévi-Strauss, ), questo Hermes o Arlecchino “trismegisto” (tre volte grande), tra questo demonio insomma, e lo spirito stesso del riso, del principio ironico che era già alla base del “sileno” Socrate, che «sous une enveloppe de Silène cache un Dieu» come vuole il detto ampiamente ripreso nel saggio del critico ginevrino: Or l’on sait qu’aux origines, selon les premiers documents qui nous parlent de lui, Arlequin (sous le nom d’Hellekin) est un démon à face animale, qui conduit dans les nuits d’hiver, au fond des forêts, sa “mesnie” hurlante de trépassés. Figure qui n’est nullement celle d’un sauveur, mais au contraire celle d’une créature diabolique. […] aux cours des siècles […] on en fera une figure comique, dont le caractère essentiel de transgression se reportera sur les “tabous” de l’ordre social et de la discipline des mœurs. […] Quand Goethe, dans le prologue de Faust, présente Méphistophélès sous les dehors de la “lustige Person”, il rend manifeste cette domination joueuse du langage poétique, qui nous permet de transformer l’ombre menaçante du démon en un personnage disert, mais qui transporte l’agressivité du néant dans les tréfonds de notre rire (Starobinski, , pp. -). La colpa annidata in questo apparentemente liberatorio processo – e ha scritto Paolo Isotta che la tendenza di Leverkühn al riso non è che un’anticipazione delle risate atroci che egli sarà costretto a emettere, per l’eternità, all’inferno – è intrinseca alla condizione medesima di artista, e quasi metafora di una gnostica condizione di “caduta” insita nella stessa natura umana, resa più viva e bruciante dalla consapevolezza di chi tale condizione è chiamato a rappresentare: «Le sacrilège est de vouloir abandonner le lieu de la figuration métaphorique pour conquérir les satisfactions de la vie» (ivi, p. ). La condizione di sofferenza e sacrificio sembra dunque essere condizione necessaria e sufficiente, un totem-tabù destinato ad alimentare non poca metafisica o mitologia del cosiddetto “artista maledetto”, che diventa in tal modo sinonimo dell’artista tout court: stereotipo non meno rigido di quell’idea stereotipa della bellezza e dell’arte che il borghese si raffigura, e che trova nel Tonio Kröger una sua sofferta incarnazione nel compagno di viaggio in nave che recita poesie sulla luna, confondendo il sublime dell’oggetto cantato con il sublime della forma che lo esprime, che sublime non riesce affatto a essere. È questo naturalmente un tema che non può non legarsi alla coeva nascita della società di massa, e che sempre Lukács riconduce a un altro sommo rappresentante di quest’arte, nella vicina Francia, con qualche decennio di anticipo – proprio come con qualche decennio di anticipo si erano svolti, a voler seguire la prospettiva di una lettura marxista, certi processi storici ed economici: Finora Balzac era stato l’unico che aveva tentato qualcosa di simile […]. Balzac vide momenti determinanti e molto essenziali dell’intima problematica dei moderni mezzi di espressione artistici, e con profonda penetrazione e grande vigore rappresentò il loro tragico fallimento di fronte alla realtà da rappresentare […]. A Balzac segue la lunga serie di tragedie della vita d’artisti […]; le opere giovanili di Thomas Mann rappresentano la conclusione di questo sviluppo. […] Questo atteggiamento artistico moderno si riversa nella struttura dell’opera (Lukács, , p. ). Ed è nuovamente Lukács ad accostare i percorsi spirituali di due personaggi, apparentemente tanto distanti, nella produzione manniana come nei diversi assunti che FRANCESCA MILANESCHI sembrano informare l’una e l’altra opera, rivelando invece di quest’opera la singolare coesione interna e il forte carattere di progettualità, chissà quanto consapevole al tempo del Kröger: «Il demonio di Mann […] descrive l’esistenza umana dell’artista in un modo che ricorda in più punti le confessioni di Tonio Kröger: “L’artista è fratello del delinquente e del mentecatto… Non parlarmi di sani e di malati! La vita, da quando esiste, non se l’è mai cavata senza l’elemento morboso”» (ivi, p. ). E dice allora benissimo Starobinski (, p. ): «Car rien ramène au corps comme l’échec rencontré dans la tentative de lui échapper. Qui veut faire l’ange fait la bête». Quasi che Mann avesse già il sentore di una verità che i contemporanei più illuminati ancora non potevano vedere. Lungi dall’essere estinta, lungi dal mutare la propria decadenza in morte, la borghesia si stava invece trasformando, rafforzando: non più per essere la casta aristocratica dei dominatori della vecchia generazione Buddenbrook, ma un magma indistinto in cui tutti e tutto sono “borghesia”, in cui borghesia diviene il sinonimo stesso di umanità. Non già però, nell’accezione positiva di Mann, quell’humanitas che delinea il problema del rapporto tra l’uomo e il mondo, cui egli tende per tutta la propria esistenza, ma nel senso minaccioso di “società di massa”, di “democrazia” che tutto appiattisce, la disprezzata Zivilisation delle (assai paradossali, almeno nel titolo) Considerazioni di un impolitico. E se per Angelo Bolaffi tutta l’opera di Thomas Mann può essere letta come la rielaborazione spirituale e letteraria del cammino della Germania verso l’Occidente, questo cammino parte comunque da quel romanticismo tedesco che si incarna nel Taugenichts di Eichendorff, che nelle Considerazioni, nel capitolo intitolato Della virtù, Mann definisce autentico libro tedesco, nonostante si tratti di un’opera animata da uno spirito almeno apparentemente opposto rispetto alla morale borghese e lubecchese: E non solo è inutile lui, ma desidera vedere buono a nulla anche il mondo intero; e quando ha da curare un orticello butta via tutte le piante di patate e gli ortaggi che ci trova e lo coltiva tutto, con stupore della gente, a piante e fiori rari di cui però vuol fare dono all’altissima dama del suo cuore, piante che dunque hanno uno scopo, ma solo delicato e non pratico. […] È un genio e un artista, cosa che non sostengono né lui né il poeta e che invece è dimostrata con bella evidenza dalle sue stesse canzoni. Tuttavia la sua natura non presenta il minimo tocco di eccentricità, nulla di problematico, demoniaco, patologico. […] Benché giramondo, musicante e innamorato, non si intende granché di bohème, perché la bohème è una forma di romanticismo letteraria e lontana dalla natura, mentre lui non è affatto letterario. […] Il suo romanticismo non è dunque né isterico né tisico, né voluttuoso né cattolico, né fantastico né intellettuale. È un romanticismo per niente depravato e deviato, è umano, e il suo tono di fondo è malinconico-umoristico (Mann, a, p. ). Occorrerà forse allora soffermarci a riflettere sul significato per nulla ovvio di “opera tedesca” e su un’ulteriore ragione per la quale un’opera come il Tonio Kröger, nel suo essere intimamente legato all’universo poetico dei Buddenbrook, segna uno spartiacque nella produzione manniana, apparentemente risolvendo dei conflitti, ma in realtà inaugurando una crisi, potremmo dire “emorragica”, che porterà alla tragedia del Doktor Faustus: I Buddenbrook erano certo tedeschi in quel senso superiore, interiore-cosmopolita, erano nati spontaneamente con quell’intonazione, ma scrivere altre opere in quella scia, con la consapevolezza della tedeschità declamata e sviscerata nelle Considerazioni, BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) avrebbe voluto dire scrivere opere enfaticamente tedesche e popolari; non la musica del cuore del Buonannulla di Eichendorff o di Immensee di Storm, ma la fanfara grossolana e patriottarda di Paul de Lagarde (Magris, , p. XXIII). E l’immagine musicale qui utilizzata da Magris non è certo soltanto metaforica: Mann scopre nella musica, nella struttura musicale conferita alla propria opera, la cifra stilistica migliore, forse l’unica, capace di esprimere i conflitti senza necessariamente risolverli, poiché la musica dice l’infinito e dunque l’indicibile, il dantesco “ineffabile”. E se non molti anni prima Mallarmé esprimeva con la sua poesia la medesima tensione della parola a trasformarsi, a trasfigurarsi in musica, ecco che il romanziere Mann scopre nella musica la forma eletta a esprimere la propria modernità, e presta al volto del primo musicista dodecafonico le sue parole: Egli parla in una grande e decisiva lettera al suo primo maestro della propria “riprovevole” particolarità di sentire sempre il lato comico nei momenti musicali più importanti e commoventi: «Ho forse le lacrime agli occhi, ma lo stimolo del riso è più forte – sempre forse sono stato condannato a ridere nei momenti più misteriosamente impressionanti e spinto da questo esagerato senso del comico, mi sono rifugiato nella teologia sperando di reprimere il solletico… ma ho finito col trovarvi un mare di spaventosa comicità […]. Perché quasi tutte le cose mie si devono affacciare con la loro parodia? Perché mi deve sembrare che quasi tutti, anzi tutti addirittura i mezzi e le convenienze dell’arte possano oggidì servire soltanto alla parodia?» […]. L’originalità della musica configurata nel romanzo del Faustus non è affatto l’atonalità in sé, bensì il carattere generale della musica recente come espressione concentrata della decadenza morale e spirituale, come tragico dissidio da essa originato nell’anima di Adrian Leverkühn (Lukács, , pp. -). Mann, la musica e l’ipse dixit: si deve pensare che la musica promuove in qualche modo la virtù Già Aristotele, come è noto, attribuiva al ritmo inscritto in ogni musica una funzione catartica, dunque morale, educativa, di esortazione alla virtù, perché atta a riprodurre le leggi di armonia del creato: proprio questa “armonia”, espressa in tedesco dal verbo stimmen e dal sostantivo femminile Stimmung sarà la “grande assente” dall’universo dodecafonico che Mann condanna nel Doktor Faustus: la musica dodecafonica, che annuncia una nuova estetica, quella della “difformità”, della “disarmonia”, – e che sarà l’estetica dominante del secondo Novecento, o del cosiddetto “postmoderno” – è la grave, la tragica invenzione di Adrian, quell’arte per cui egli è condannato, quella forma “nuova” che tutto il Novecento fin dalle avanguardie storiche insegue. La musica, e inestricabilmente legato a essa il problema del tempo, non hanno ancora in Tonio Kröger il rilievo strutturale e tematico assunto poi in romanzi come la Montagna incantata o il Doktor Faustus, ma la musica era già presente nei Buddenbrook, soprattutto era già presente come elemento disgregatore (era infatti la passione della madre di Hanno, poi di Hanno stesso): è lo stesso Mann in un passo delle Considerazioni a sottolineare questo aspetto del proprio romanzo, raccontando invece nel Saggio autobiografico come l’introduzione della musica quale elemento stilistico e formale sia avvenuta nel Tonio Kröger: «[…] quel complesso musicale di rapporti che appare più tardi, su più vasta scala, nella FRANCESCA MILANESCHI Montagna incantata. Benché si sia affermato che questo è un esempio di “romanzo come architettura di idee”, la tendenza a una tale concezione dell’arte risale al Tonio Kröger» (Mann, b, p. ). Anche in Tonio Kröger, non solo la mamma di origine meridionale ama la musica e seguirà, dopo la morte del marito, un musicista italiano, ma lo stesso Tonio studia il violino (strumento per tradizione suonato dal mancino diavolo, oltre che dagli esecrati «zingari nel carrozzone verde»), e la musica è il presupposto, la conditio sine qua non di ogni scena di ballo, quelle scene chiave che sono collocate nel secondo e nell’ottavo capitolo del racconto, cioè subito dopo un ideale “prologo” e subito prima di un ideale “epilogo”: ulteriori dettagli che confermano la forte parentela strutturale fra questa novella e la forma del dramma. Da una testimonianza dello stesso Mann, riportata nel saggio Lubecca come forma di vita spirituale, sappiamo infatti che proprio all’ascolto della musica vicino al mare lo scrittore associava il ricordo della sua prima esperienza estetica, quasi un “primo amore”, o innamoramento primigenio dello spirito: […] il tempietto musicale, in cui il piccolo direttore d’orchestra Hess, un uomo dai capelli lunghi e dall’aspetto zingaresco, teneva concerto coi suoi suonatori, e sulla cui scaletta io me ne stavo seduto, nel profumo estivo del bosso, bevendo avidamente quella musica, la prima musica orchestrale della mia vita, buona o meno buona che fosse (ivi, pp. -). Riflettendo sul binomio tardoromantico che associa l’immagine della poesia al possesso di un’abilità tecnica (ma del resto era proprio techné il nome greco per definire l’arte) e il suonatore di violino come un archetipo di degradazione, Starobinski (, pp. -) evidenzia come la concezione della poesia quale abilità tecnica e assoluta maîtrise dello strumento metrico e linguistico – una definizione che non stonerebbe in bocca a un Boileau – sia già un dato essenziale nelle Odes funambolesques di quel petit romantique che era Théodore de Banville. Per Banville, esattamente come per Gautier, l’altitudine vertiginosa rappresenta una dimensione assolutamente privilegiata, nonostante il travestimento derisorio da clown che indossa ogni servitore della Musa, nonostante l’isolamento e l’asservimento nei confronti del pubblico più gretto e volgare, il pubblico borghese destinato a “comprare” la sua opera: il pubblico gretto e volgare da cui dipende la sua stessa sopravvivenza. Il destino del buffone/martire dipende in tutto o in parte dall’intervento favorevole, dall’apprezzamento, del pubblico borghese, che nel presente dell’ottocento borghese assume il ruolo un tempo rivestito dalla corte, o dal principe/mecenate (cfr. Starobinski, , p. ). Unica differenza rispetto al passato sarà allora la qualità e la quantità della committenza, nel tempo in cui (precorrendo le profezie di Adorno e della scuola di Francoforte, oggi più che realizzate) con il nascere della società di massa l’arte si va trasformando in “prodotto di mercato”, e il criterio per selezionare la “qualità” del prodotto, – spesso individuata nella mera capacità di soddisfare il bisogno immediato di consumo, dunque nella creazione di un prodotto dalla natura via via più effimera, tendenza controbilanciata dalla posa di certa arte all’assoluta “élitarietà” e dal conseguente mito della superiorità e della distanza dell’arte rispetto al suo pubblico – il suo valore “estetico”, diviene un problema di estrema complessità e per nulla ovvio, per l’artista come per la neonata categoria del “critico”: BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) Si c’est une dégradation, pour le serviteur de la Muse, que de jouer au violon debout sur l’échelle du saltimbanque, du moins peut-il ainsi répondre par l’ironie à l’avilissement d’un siècle en proie aux puissance d’argent, où l’on n’entend plus que le râteau de la roulette et de la banque. […] le poète, s’il en fait à lui-même l’application allégorique, se donne pour vocation d’affirmer sa liberté en un jeu supérieur et gratuit, tout en faisant la grimace aux bourgeois, aux «assis» (ivi, pp. -). Das Zigeunerleitmotiv Al di là dell’interessante dettaglio che ritraeva nel racconto di Mann questo direttore d’orchestra, protagonista del primo approccio dell’autore con l’arte, come una creatura «dall’aspetto zingaresco», ancor più significativo è che poi Mann sia approdato a una concezione dell’opera letteraria come costruzione musicale, concezione di cui appunto il Tonio Kröger è la prima realizzazione concreta, nonché l’occasione in cui lo scrittore perfeziona il ricorso alla tecnica del Leitmotiv mutuata dalla musica di Wagner. Se la musica non annulla, ma – come una proustiana “madelaine” ante litteram – sospende per un attimo l’irreversibilità del tempo (come vuole Elio Matassi), ecco che allora la scena dell’ultimo ballo ad Aalsgard assume un’ulteriore connotazione, quella di esperienza riparatrice rispetto a quella lezione di ballo dell’adolescenza, i cui protagonisti si riaffacciano infatti come fantasmatiche repliche. Nell’ambito della scissione di Tonio tra legge paterna e legge materna, non è un caso, ma una soluzione che possiede anche echi squisitamente letterari, che egli scelga proprio la Danimarca, terra di Amleto, per andare alla ricerca della soluzione del proprio conflitto interiore. Eppure non è il fantasma del padre che appare a Tonio, al contrario di ciò che accadeva ad Amleto, ma i fantasmi di Inge e Hans, e persino il fantasma della goffa e sensibile Magdalena, ovvero tutti i fantasmi della propria solitudine, che è però sempre ironica, affrontata cioè dall’autore con inserti che sfiorano, e spesso colgono in pieno, il grottesco. Come nella scena della lezione di ballo, con modalità “anticatartica”, (ma saremmo tentati di dire: con una precoce vena di Befremdung) la raffigurazione crudele del maestro ridicolo mitigava sulla pagina l’asprezza della sofferenza adolescenziale di Tonio, inducendo nel lettore una presa di distanza tra sé e quel giovane e goffo “brutto anatroccolo”, in cui tanto forte potrebbe essere il rischio di identificarsi (anche giocoforza, perché è il solo personaggio non “privo di spirito” che l’autore ci concede) così nella scena del ballo in Danimarca il ruolo dell’essere che si copre di ridicolo è rivestito dalla figura dell’impiegato postale. L’ambiguità, che l’autore e il suo personaggio mantengono rispetto all’onnipresente dualismo del racconto, è perfettamente incarnata in questo stile che volutamente non si decide tra accenti lirici e pose ironiche, a volte caustiche in modo davvero sferzante. Così già accadeva nel secondo capitolo, dove Mann offre una satira della provinciale alta borghesia di Lubecca, ma dove anche il ridicolo di cui Tonio si ricopre nella scena del ballo e i riferimenti alla poesia romantica di Storm, associati insieme, sembrano mettere in una luce di parodia lo stesso romanticismo adolescenziale del protagonista (nella migliore tradizione delle “educazioni sentimentali”, ovvero quella – impietosa e antiromantica quant’altre mai – di Flaubert), seppure con l’apparente partecipazione emotiva dell’autore alle sue sofferenze. FRANCESCA MILANESCHI Quella leggerezza, quell’agilità consapevole di sé e crudelmente superba, “esclusiva” come i biondi danzatori a cui Tonio non può unirsi, si lega a quello stesso mito del «clown mercuriale» (Starobinski, , p. ), espressione di un desiderio frustrato che genera insieme invidia e ammirazione, aspirazione alla comunione e coscienza dell’inevitabile ed eterna separazione. Anche in questo caso il tema si rivela d’ascendenza romantica e parnassiana al contempo, come ben mostrano i reportages dal mondo del circo di Théophile Gautier: «[…] la vertu que Gautier admire entre toutes, c’est l’agilité, le défi que le corps du clown acrobate lance à la pesanteur, la métamorphose qui lui fait rejoindre le vagabondage ailé de Puck» (ibid.). Queste parole di Baudelaire sul clown tragico, riportate da Starobinski, non stonerebbero certo se immaginate come ideale “monologo interiore” di Tonio: Partout la joie, le gain, la débauche; partout la certitude du pain pour le lendemain; partout l’explosion frénétique de la vitalité. Ici la misère absolue, la misère affublée, pour comble d’horreur, de haillons comiques, où la nécessité, bien plus que l’art, avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable! Il ne pleurait pas, il ne dansait pas, il ne gesticulait pas, il ne criait pas; il ne chantait aucune chanson, ni gaie, ni lamentable, il n’implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite (ivi, p. ). In queste scene di ballo, tanto importanti per la comprensione del racconto, la posizione di Mann, il cosiddetto “punto di vista” della voce narrante, si mantiene sempre e comunque sul filo dell’ambiguità: non è davvero chiaro cosa il narratore pensi di Tonio, di Inge o del resto. L’oscillazione del giudizio trapela dal continuo ricorso a diverse soluzioni stilistiche, – realizzando quell’assenza di separazione degli stili di cui parla Auerbach in Mimesis – dal passaggio frequente dal discorso indiretto all’indiretto libero, da forme che denotano la decisa partecipazione della voce narrante (come l’uso del du, o i periodi di lirica immedesimazione con Tonio) al distacco ironico e talvolta violentemente satirico. Se da un lato Mann riferisce con toni seri il romanticismo adolescenziale di Tonio, perché qui il protagonista è ancora un essere autentico e incorrotto, l’effetto di tutti questi slittamenti formali offre indiscutibili sfumature comiche. Hegel, Marx, il Verbo “und die lustige Person” Resta forse da chiedersi se quest’ambiguità di fondo non sia che un sofisticato escamotage per mascherare il proprio pudore rispetto a una materia tanto incandescente quanto amata, una sorta dunque di “custodia” in cui avviluppare verità altrimenti impronunciabili, così come il senatore Mann non trovava altro modo per leggere la “scabrosa” Nanà di Zola che nascondendone la copertina: in quello stesso modo Mann confessa il segreto desiderio che suo padre potesse leggere i suoi Buddenbrook, come riferisce Claudio Magris: «Così il senatore Mann aveva letto Nanà di Zola, nascondendone la copertina per non scandalizzare chi potesse trovare quella lettura disdicevole e inadatta alla “severa condotta di vita” richiesta a un grande borghese della piccola Lubecca» (Magris, , p. XI). O non è forse, quest’ambiguità, un gesto di libertà estrema, schiaffo a ogni realtà che è «mortalmente seria» (Mann, b, p. ), libertà d’artista che può per- BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) mettersi, sempre e comunque, il lusso della contradictio in adiecto? Così parlava Thomas Mann nel alla propria città natale, in Lubecca come forma di vita spirituale: «Oggi vi ha parlato un narratore borghese che in fondo non ha raccontato, in tutta la sua esistenza, che una sola storia: la storia del distacco dall’elemento borghese, e non già per trasformarsi in bourgeois o in marxista, ma per innalzarsi ad artista, all’ironia e alla libertà dell’arte, sempre pronta a volare in alto e oltre ogni confine» (ivi, p. ). L’ironia di Mann sembra apparentarsi molto all’ironia propugnata da Hegel: «Le verdict sévère de Hegel est ici applicable: la liberté ironique se rend ellemême creuse et vaine en prétendant s’élever au-dessus du spectacle de la vanité humaine. L’envol vers les régions de la pure idéalité se perd dans une abstraction sans contenu» (Starobinski, , p. ). Rovesciando tale ironia dalla testa ai piedi (come vuole il metodo di Marx) si ottiene il suo opposto, o quasi, ovvero la sarcastica serietà “socialista” di certe opere del fratello Heinrich. Per entrambi, in fondo, come già per il Pitre châtié di Mallarmé, vi è già tradimento della Musa nel mito della superiorità dell’artista, nel tentativo di vivere una sorta di “resurrezione estatica”: nel prendere insomma la “via decadente” dell’A rebours di Huysmans, (che però a ben vedere, già nel titolo denunciava una sorta di “via negativa” per il ritorno a un’arte che non fosse inutile, ingombrante, asfittica e sterile “decorazione”). Sono allora così distanti, e non invero accomunati da un’unica, bizzarra forma di “elezione” che sembra una condanna, il Doktor Faustus di Thomas con il suo Mefistofele contemporaneo, – che arriva senza nemmeno essere invocato tramite arti magiche, che arriva perché sembra inscritto nel destino – e il Professor Unrat di Heinrich, con il suo “angelo azzurro” che lo conduce alla rovina, all’agognato “degrado”, alla definitiva e irrevocabile perdita del sacro “contegno borghese”? Chi si nasconde davvero dietro queste maschere, dietro la biacca del clown, dietro il vestito tristemente bariolé del buffone, dietro il volto d’angelo di una femme fatale da rivista del dopolavoro? Le clown victime (simulacre du Christ) ne paraît rien avoir en commun avec l’Arlequin transgresseur (succédané du diable). Mais, en s’identifiant tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre, l’artiste nous indique une ressemblance possible, dans la mesure même où angélisme et satanisme se rassemblent. Se sont les directions inverses et complémentaires que prend le désir de dépasser le monde, ou plus exactement d’introduire dans le monde le témoignage d’une passion venue d’ailleurs ou visant un ailleurs. Sous l’aspect de la victime expiatoire, le clown est expulsé du monde, il emporte nos péchés et notre honte, il passe dans la mort; par son passage, il nous fait passer à notre tour dans le salut. Sous l’aspect du démon transgresseur, il surgit parmi nous comme un intrus, venu des ténèbres extérieures (ivi, p. ). L’archetipo celato dietro ogni maschera di clown deriso è quella, sublimemente tragica, del Cristo deriso, il Verbo fatto carne, il re abbandonato, irriso e martirizzato, il re solo con la corona di spine sul capo, il mito fondante e unificante dell’Occidente, e che dal romanticismo in poi si incarna nella figura del clown come Cristo moderno: quell’artista-clown, che vive nomade e solo nel suo carrozzone ambulante da circo, e che tanta fortuna ancora gode nell’immaginario estetico tra la fin de siècle e l’inizio del secolo nuovo. Leggiamo allora quello che scrive nel , con straordinaria sincronicità rispetto alla nostra novella manniana, il pittore Georges Rouault (Parigi, -) all’amico scrittore simbolista Édouard Schuré, in FRANCESCA MILANESCHI una lettera nella quale rintraccia le origini del proprio interesse per il circo come soggetto della sua arte: Pour moi, depuis la fin d’un beau jour où la première étoile qui brille au firmament m’a, je ne sais pas pourquoi, étreint le cœur, j’en ai fait inconsciemment découler toute une poétique. Cette voiture de nomades, arrêtées sur la route, le vieux cheval étique qui paît l’herbe maigre, le vieux pitre assis au coin de sa roulotte en train de repriser son habit brillant et bariolé, ce “contraste” de choses brillantes, scintillantes, faites pour amuser et cette vie d’une “tristesse infinie” si on la voit d’un peu haut… Puis j’ai amplifié tout cela. J’ai vu clairement que le “Pitre” c’était moi, c’était nous, presque nous tous… (ivi, p. ). Il carrozzone verde, cette voiture de nomades di cui Rouault scrive nella sua lettera, questa autentica ossessione del giovane Tonio, il Leitmotiv che Mann sceglie per contraddistinguerlo, l’epiteto che ci ricorda immediatamente quale sia la nota fondamentale della sua natura («Wir sind doch keine Zigeuner im grünen Wagen»), e cioè l’eterno contrasto tra vita borghese e vocazione a essere artista, non è soltanto l’emblema appunto della vocazione artistica, ma – nel suo inevitabile stato di essere “separato”, criticamente e ironicamente consapevole delle umane incongruità – è l’emblema della condizione dell’uomo moderno, del postborghese tout court: «J’ai vu clairement que le “Pitre” c’était moi, c’était nous, presque nous tous…», concludeva Rouault negli stessi anni in cui compare il Tonio Kröger. In quegli stessi anni in cui la Germania si appresta alla sua corsa all’industrializzazione e alla modernizzazione, un Mann già postborghese – perché “scacciato” da quell’eden di pacifica ignoranza della propria condizione, perché “liquidato” insieme ai fratelli e a tutta la ditta alla morte di quel padre che, sappiamo dai biografi, utilizzava coi figli singolari metodi pedagogici (come l’invitarli a ingozzarsi di dolci in una pasticceria per “uccidere” per sempre il “desiderio/frustrazione inappagato” a consumare dolciumi, inducendo in essi un “pavloviano” riflesso di autocontrollo) – lamentava la propria prigionia in quel mondo borghese cui era costretto ad appartenere, e che era costretto a “servire” rappresentandone perversioni e debolezze, ambizioni e slanci destinati al fallimento, pur ravvisandone già il “marcio” nascosto sotto la salute, la regolarità, gli orari autoimposti di scrittore/impiegato, l’ambizione alla rispettabilità. Riguardo al topos romantico del clown come sorta di “Cristo della modernità”, e in correlazione alla nuova e superiore dignità che nelle conclusioni di Tonio sul suo nuovo credo artistico viene conferita al soggetto borghese, ci troviamo qui al culmine di un processo culturale che raggiunge con Mann un alto grado di consapevolezza. Ricordiamo che Erich Auerbach osserva in Mimesis come sia stato il cristianesimo ad avviare il processo della rappresentazione dell’“umile” reale come soggetto degno di trattazione artistica: Il vero fulcro della dottrina cristiana, l’Incarnazione e la Passione, fu del tutto inconciliabile col principio della separazione degli stili. Cristo era tutt’altro che un eroe o un re. […] Il re dei re, beffeggiato, sputacchiato, flagellato e inchiodato alla croce come un volgare delinquente – oh, il racconto di queste cose, non appena penetra nel cuore degli uomini, annienta completamente l’estetica della separazione degli stili, produce un nuovo stile sublime, che non disdegna affatto il quotidiano e accoglie in sé il realismo sensibile, la bruttezza, l’indecenza, la miseria fisica (Auerbach, , pp. -). BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) Vi è dunque un nesso, più profondo e “morale” di quanto non appaia in superficie, tra la missione che l’artista assume, ovvero raccontare la vita borghese, e la parabola cristologica, il seguire fino in fondo la propria vocazione, quel Beruf inteso nella sua duplice accezione di “chiamata” ma anche di “professione”, sino all’accettazione degli inferni che da essa derivano, siano essi la solitudine e l’esclusione dal mondo dei felici per Tonio o il patto col diavolo di Adrian nel Doktor Faustus. E seppure quel diavolo Adrian non l’abbia mai chiamato a sé, mai evocato o cercato di attrarre, esso rappresenta a livello simbolico l’incontro dell’artista con il proprio talento, forza prometeica o luciferina, dunque colpevole. Non è dunque Adrian, ma la sua stessa natura, il suo stesso destino a chiamare a sé il diavolo: il diavolo, cioè il Male, è “inscritto” nel destino dell’artista come il Maligno è “scritto” dall’origine del mondo nella storia della venuta del Cristo in terra. Come la presenza del Male è necessaria al senso della salvezza (con buona pace di Jean Genet e di Georges Bataille, che fecero di tale teoria un vero e proprio cavallo di battaglia “retorica”), così la condizione di solitudine e sofferenza di Tonio è necessaria alla realizzazione della sua opera: non si tratta più però – o almeno non soltanto – dell’artista romantico incompreso dalle folle, né di quello maledetto che è artista proprio e solamente “in quanto” maledetto. Più sofisticato è il ruolo dell’artista del Novecento, dell’artista “ironico”, e Mann lo annota durante la composizione del Tonio Kröger. La letteratura è sì morte, ma anche «possibilità per raggiungere il suo contrario, la vita»: questo è l’esito finale dell’esperienza che l’artista fa del Male. In tali termini si esprime infatti Mann verso la fine del saggio Bilse ed io, del : Non si creda, infatti, che il raffinamento spirituale possa mai raggiungere un grado considerevole senza che al tempo stesso non si accresca la sua capacità di soffrire. Questa può raggiungere un grado in cui ogni esperienza si trasforma in sofferenza. Ora, l’unica arma che sia data alla sensibilità dell’artista per reagire alle cose e agli eventi esterni, per difendersene in maniera elegante, è l’espressione, la definizione poetica, e questa reazione espressiva che, a parlarne con un certo radicalismo psicologico, si può chiamare una sublime vendetta dell’artista contro la propria esperienza vissuta, sarà tanto più violenta quanto più delicata è la suscettibilità che il fenomeno esterno è venuto a colpire (Mann, b, p. ). Clown, maschere, carrozzoni verdi e traghettatori L’incruenta “vendetta” dell’arte, dell’artista rispetto alla propria stessa sofferenza, sarà allora proprio l’accento posto sulla sua funzione mediatrice (cfr. Asor Rosa, , p. ), espressa a livello archetipico dalle figure del saltimbanco, della maschera, del clown, che nell’immaginario grottesco del circo – ultimo luogo supremo della «rivelazione del bello» (Starobinski, , p. ) – si configurano tutti come garanti di un misterioso “passaggio”. I sileni, o clown cristologici del cui topos Starobinski ha ripercorso le tappe – dalle origini più remote (e ricorrendo, spesso e più o meno implicitamente, alle indagini del Lévi-Strauss di La voie des masques) fino alle soglie della fin de siècle – nell’arte della seconda metà dell’Ottocento, sono dunque, proprio come Tonio, o come la goffa Magdalene del ballo ad Aalsgard, «les héros d’un échec perpétuel […] Ils expriment la misère de la condition corporelle jusqu’à devenir eux-mêmes des fantômes, des revenants, des acteurs de danse macabre» (ivi, pp. -). FRANCESCA MILANESCHI Nella mitologia romantica e tardoromantica, la qualità più apprezzata e dunque messa in evidenza nelle rappresentazioni del saltimbanco o della ballerina era l’agilità, la leggerezza, letta anche come allegoria dell’atto poetico (secondo una concezione della poesia come maestria nella tecnica, nell’esercizio retorico). In tal senso anche lo slancio ascensionale di Tonio, il suo muovere dal Sud verso il Nord, verso Lubecca e poi verso la Danimarca, è paragonabile alla verticalità, allo slancio ascensionale dell’artista del circo, ciò che secondo il Bachelard del saggio L’air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement, accennava alla «liberazione di qualcosa che si era smarrito, attraverso la plasmazione di immagini domate» (ivi, p. ). È Baudelaire tra i primi a prendere le distanza da questa concezione, e il clown irride allora i valori borghesi di riuscita e abilità, in nome della libertà ironica dell’arte come gioco gratuito: «Può essere qui applicato il severo verdetto di Hegel: la libertà ironica si rende vacua e vana da sola, proprio quando pretende di innalzarsi sopra lo spettacolo dell’umana vanità. Il volo, spiccato verso le regioni dell’idealità pura si perde in un’astrazione senza contenuto» (ivi, p. ). Tale pretesa di libertà si rivela dunque piuttosto illusoria, ed è Mallarmé a cantare il dramma dell’artista comunque prigioniero di uno spazio chiuso, nei versi del suo Pitre châtié: tutte espressioni in cui si porta a compimento quel processo che addita la maschera del «saltimbanque» come «épiphanie dérisoire de l’art et de l’artiste. La critique de l’honorabilité rangée s’y double d’une autocritique dirigée contre la vocation esthétique elle-même» (ivi, p. ). E sono, questi corpi di saltimbanchi refrattari al contegno borghese, corpi sempre dolenti, ancora simbolici nella cultura borghese otto-novecentesca dell’alienazione dell’artista, del «suo auto-ironico allontanamento dal corpo mondano, […] del suo auto-ironico camuffamento nei panni buffoneschi del pagliaccio da circo» (Bologna, , p. ), – ed è Henri Bergson a sottolineare che «an incident becomes comic when, despite the central moral concern, it call attention to the body» (Bergson, , p. ). Questi corpi si rivelano però molto resistenti: «But the worse the situation, the greater the inventiveness and creative energy of the main character. The more terrifying the landscape, the more vital the clown» (Pearce, , p. ). Le energie vitali e inesauribili del clown sembrano partecipare del soprannaturale, e il suo ingresso in scena è sempre un momento “problematico”, “traumatico”, addirittura inquietante. Questo turbamento prodotto dall’ingresso in scena del clown, della maschera, questo freddo imbarazzato, deriva dalla consapevolezza condivisa che si tratta dell’intrusione di un essere che proviene da un “altrove”, proprio come «the alazon, the impostor and intruder of classical comedy» (ivi, p. ): Il clown […] è […] «colui che viene da un altro luogo, il maestro di un passaggio misterioso, il contrabbandiere che supera le frontiere proibite». La sua entrata in scena è, di fatto, un’irruzione cosmogonica, è l’esplosione di un seme metamorfico che consente di andare-oltre, di slanciarsi-al-di-là del confine mondano. […] «La gratuità, l’assenza di senso è […] la loro aria natale. Soltanto a prezzo di questa vacanza, di questo vuoto primario, essi potranno passare al senso che abbiamo scoperto per loro. Essi hanno bisogno di un’immensa riserva di non-senso per poter passare al senso» (Bologna, , p. ). Alla maschera del clown è affidato un «passaggio» di cui egli stesso, con il suo stesso corpo funambolico, è tramite, intermediario, traghettatore, «nocchiero infero»: il traghettatore è dunque mediatore, “interprete”, se è vero che l’interpres è, «fin dalle BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) origini, il mediatore di una transizione […], il garante di un “passaggio” e “il responsabile dell’integrità” di un messaggio che non deve subire, in linea di massima, alcuna alterazione» (ivi, p. ). Ma cos’è che deve essere preservato da questo nocchiero nel passaggio tra le due sponde, siano esse il palcoscenico e la platea, l’arte e la vita, lo studio dello scrittore e il carrozzone verde dello zingaro sporco e dai capelli arruffati? Cos’è che deve essere offerto o custodito da questo Arlecchino, servitore di due padroni? Fantasma, larva, per i latini, eidolon e phasma per i greci, era nelle culture antiche l’immagine del defunto, la sua ombra, il suo speculare riflesso, che poteva aggirarsi minacciosamente se lasciato vagare senza meta. Dice un proverbio cinese ricordato da Marcel Granet, che «l’anima-soffio dei defunti è errante: per questo si fanno le maschere per fissarla». Solo fissando l’instabilità dei fantasmi, facendo passare i trapassati nella loro immagine, mediante la maschera che riscatta e riplasma culturalmente la loro smarrita persona, si fa passare il fantasma e si riesce a portare alla luce l’idea (l’“archetipo”) che in esso sopravviveva come residuo significante. […] È Starobinski medesimo a dichiarare che il legame infero mantenuto dalle maschere attraverso tutta la loro storia coincide con il ruolo iniziatico: ben più profondo di un mero gioco di parole è il nesso fra passatori (passeurs, nel senso di “traghettatori”, in quello di “coloro che fanno passare” ecc.) e trapassati (nel senso di “morti”, in quello di “coloro che sono passati oltre un ostacolo” ecc.) La “difficile agilità” del clown e dell’acrobata […] diviene così l’ardua impresa gnoseologica di coloro che “fanno passare al senso” […], “sublime pantomima sull’orlo della tomba” (ivi, pp. -). Se è vero che, almeno a un livello di rappresentazione simbolica, il massimo dei revenants è proprio il Cristo, colui che ritorna per eccellenza, e se è vero che “clown cristologici” sono tutti i saltimabanchi-traghettatori ritratti da Starobinski, se è vero che tale funzione mediatrice è rituale, essa è anche struttura codificata in tutta la letteratura, come ci ricorda Roland Barthes a proposito della scrittura romanzesca: […] l’écriture romanesque […] a pour charge de placer le masque et en même temps de le désigner. […] Le “il” manifeste formellement le mythe; or, en Occident […] il n’y a pas d’art qui ne désigne son masque du doigt. […] Le Roman est une Mort. […] Toute la littérature peut dire: «Larvatus prodeo», je m’avance en désignant mon masque du doigt (Barthes, , p. ). Mann dal canto del cigno borghese al non-canto del “mostro” atonale Nell’epiteto, o Leitmotiv, manniano è veramente inscritta tutta l’essenza del personaggio e talvolta dell’opera stessa: così nel ripiegare come un cigno il collo di Tony Buddenbrook, in questo romanzo che rappresenta al tempo stesso il canto del cigno della borghesia tedesca e quello dell’epopea realista e borghese dell’Ottocento, il suo non plus ultra; così nel Wir sind doch keine Zigeuner im grünen Wagen di Tonio Kröger, che non è soltanto l’enunciazione del dramma dell’ambiguità borghese, ma una sorta di dichiarazione programmatica, di laconico e discreto manifesto manniano che annuncia la nascita di una nuova arte borghese. Tramontato il mito ottocentesco e romantico del clown tragico, in cui il poeta trovava la sua più compiuta identificazione, l’immagine che diceva tutto il grottesco e la malinconia della propria presenza “dissonante” in una società distante che lo respinge e ne fa poco più che il FRANCESCA MILANESCHI proprio buffone, Mann tenta una nuova via, anche in questo caso distinguendosi nettamente dal fratello Heinrich, araldo di un’arte impegnata eppur ancora debitrice (ad esempio, nel Professor Unrat) di un immaginario legato agli stereotipi romantici e grotteschi dell’universo “circense”. La malinconia di un Baudelaire o l’amarezza grottesca di un Heinrich Mann sono infatti ancora dirette figlie del romanticismo, pur già intriso di sensibilità decadente: l’ironia di Mann è in realtà meno consolatoria dell’una e dell’altra, poiché rinuncia all’intimo compiacimento di un destino di esclusiva elezione, di narcisistica separazione. Il manifesto manniano sulla nuova arte borghese investe i contenuti, ma è anche e soprattutto un discorso sulla ricerca di una “forma”: è nella ricerca di “forme nuove” – le stesse che il giovane Kostja di Čechov invocava all’inizio del quasi coevo Gabbiano) – che Tonio/Thomas si dibatte: dalla scelta dell’ambiguità stilistica a quella della struttura musicale impressa alla narrazione. Nella direzione intrapresa dal Tonio Kröger trova espressione quel desiderio dell’artista borghese “organico”: il desiderio dunque di non essere più il saltimbanco al margine della società, il clown tragico del romanticismo e del secondo Ottocento, il desiderio forse e addirittura di comunione mistica con questa umanità che gli è pur tanto inferiore per sensibilità e capacità di comprensione. Il fondamento incrollabile di tale desiderio è certamente l’aspirazione ad accogliere, a salvare lo spirito della borghesia: questo potrebbe essere il senso dell’ironia, ovvero dell’ambiguità manniana, di quell’ironia e di quell’ambiguità che cominciano con la solitudine di Tonio, con la sua nostalgia che è «ironia, cioè è spirito con un forte senso del proprio limite» (Asor Rosa, , p. ). Il già citato finale del Kröger appare, se sottoposto a un ironico rovesciamento, quasi una dialettica prefigurazione della presunta “armonia” del Siddharta di Hesse (che sarebbe comparso nel , e il cui autore non fu, come si sa, del tutto estraneo a una certa retorica «del sangue e del suolo», pur dopo aver cantato la sofferenza dell’adolescente schiacciato «sotto la ruota» della durissima educazione prussiana guglielmina), da cui scompare la lettera nella lettera, ovvero la lettera di san Paolo ai Corinzi, inserita nella lettera a Lisaveta, per lasciar posto alla “maschera”, al «volto sorridente di Siddharta». Dopo che questa maschera/Veronica mostra il vero volto con cui «sorridono i Perfetti», allora finalmente si rende possibile la ricostituzione dell’armonia degli opposti, in forma decisamente più stucchevole e “divulgativa” in Hesse, con più “virile” e ostica, ma commossa, profondità in Mann: Profondamente s’inchinò Govinda, sul suo vecchio viso corsero lacrime, delle quali egli nulla sapeva, come un fuoco arse nel suo cuore il sentimento del più intimo amore, della più umile venerazione. Profondamente egli s’inchinò, fino a terra, davanti all’uomo che sedeva immobile e il cui sorriso gli ricordava tutto ciò ch’egli avesse mai amato in vita sua, tutto ciò che nella sua vita vi fosse mai stato di prezioso e di sacro (Hesse, , p. ). Dal resto del percorso letterario manniano sappiamo che, in quel “mistico” e “spirituale” finale, Kröger stava abbracciando la sua stessa “menzogna”, la venerata menzogna dell’arte che lo porterà al demoniaco e sublime crepuscolo del Doktor Faustus, letterario e musicale auto da fé in cui brucia con se stesso tutta l’odiata genia di quella blonde Bestie che è la Germania, la colpevole Germania del secondo dopoguerra: La Germania, coi pomelli accesi, traballava allora al colmo dei suoi orrendi trionfi, in procinto di conquistare il mondo in virtù del solo trattato ch’era disposta a osser- BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) vare, e che aveva firmato col suo sangue. Oggi, avvinghiata dai demoni, coprendosi un occhio con la mano e fissando l’orrore con l’altro, precipita di disperazione in disperazione. Quando toccherà il fondo dell’abisso? Quando sorgerà dall’estrema disperazione, pari a un miracolo superiore a ogni fede, il nuovo crepuscolo di una speranza? Un uomo solitario giunge le mani e invoca: Dio sia Clemente alle vostre povere anime, o amico, o patria! (Mann, a, p. ). Se il Tonio Kröger – ove è riscontrabile una singolare confluenza di temi “europei” oltre che tedeschi e una tensione di ricerca formale largamente condivisa nella produzione coeva dei massimi rappresentanti della letteratura europea – può essere considerata un’opera “spartiacque”, essa lo è forse non soltanto nel percorso del suo autore. Quel che è certo è che per Mann, dopo il Kröger sarà varcato il confine, ci sarà allora veramente spazio per il modernismo in letteratura, per la cruciale problematica filosofica del tempo che dilaga nelle opere della prima metà del Novecento: sia esso il tempo joyciano di una giornata a Dublino, o quello kafkiano, parabola inscritta in un romanzo-parabola, di una vita trascorsa – e almeno apparentemente insensata – nell’attesa che le si schiuda di fronte la porta della Legge, o ancora, quale vittoria sull’ineluttabile trascorrere: il tempo proustiano, resuscitato per l’eternità in una tazza di tè. E prima di abbandonarsi al proprio grande romanzo sul Tempo, La montagna incantata, Mann si dedica a quell’inclassificabile riflessione sul “suo” tempo, il tempo in cui egli è stato chiamato a essere artista, che sono le Considerazioni di un impolitico. Ma l’arte la cui essenza stessa è il tempo, l’arte che supera i “linguaggi” e che forse è la più vicina all’idea divina di “Linguaggio” universale perché universalmente comprensibile, l’arte che è fatta di “tempi’, di “misure”, di “numeri”, altro non è se non la musica. Anche per questo forse, Adrian Leverkühn, l’ultimo artista di Mann, il simbolo della sua Germania e del suo tempo, è un musicista, un compositore, un essere cioè destinato a concepire in sé la musica, ma per trasformarla, per rivoluzionarne soprattutto le forme. Qui approda quel percorso intrapreso quasi mezzo secolo prima da Tonio Kröger che parte per il Nord – il Nord dell’ironia, della separazione – allontanandosi dal Sud – il Sud che è la bellezza, l’armonia delle forme e dell’arte. Allo stesso modo la concezione della musica dodecafonica segnerà non soltanto la personale rivoluzione estetica compiuta da Adrian, ma la fine inesorabile di tutta una civiltà musicale, che è culturale ed etica prima ancora che estetica: la fine di quella civiltà borghese cui Tonio non sapeva offrire una risposta, interrogato a Lubecca da un poliziotto e da un maître d’hôtel, su quale fosse la sua professione, su quale fosse in tale società il proprio ruolo. A quella civiltà Tonio non aveva infatti altri documenti da mostrare se non le pagine stampate di un ultimo racconto, con la sua firma in calce. Arte salvezza o arte dannazione? Artista o borghese? Il vecchio, agostiniano manicheismo “protestante” sembra informare tutto questo percorso verso la ricerca di un “senso” per l’arte, di un senso che forse è ancora, classicamente o goethianamente, un’utilità: l’utilità della Bellezza, l’utilità della Verità, intese non come dati, non come canoni immutabili, non come aristotelici ipse dixit, ma come “metodo”, come principio, come tensione che mantiene vivo quel “carrozzone verde” che è la morta materia, l’inutile letteratura, l’inutile arte. Proprio come i due cavalli, uno che tira verso il basso, l’altro che tira verso l’alto, del platonico mito di Er, così l’artista sa di essere al tempo stesso il clown salvifico/vittima, e l’Arlecchino/demonio trasgressore: FRANCESCA MILANESCHI […] les grands auteurs dramatiques ont fréquemment fait du clown ou du bouffon l’agent d’un salut, le bon génie qui, malgré sa maladresse et ses sarcasmes, pousse à la roue du destin et contribue au retour de l’harmonie dans un monde que le maléfice avait perturbé. Cette fonction de sauveur ou de sauveteur n’est pas constamment liée au sacrifice du clown, si ce n’est certes pas constamment liée au sacrifice du clown, si ce n’est que le clown est toujours et partout un exclus, et que, devenant un intrus, il gagne un droit à l’omniprésence. Par la licence qu’il s’arroge ou qu’on lui concède, le clown apparaît comme un trouble-fête; mais l’élément de désordre qu’il introduit dans le monde est la médication correctrice dont le monde malade a besoin pour retrouver son ordre vrai (Starobinski, , p. ). L’artista ricopre allora il ruolo essenziale – anche socialmente, e persino nel mondo “al di là” – di “traghettatore”, di colui cui è affidato il misterioso e sacro compito di “far passare” al senso, alla verità, tutti gli altri, siano essi cenciosi zingari nel carrozzone verde o fieri e “idioti” e tutti identici tra loro “occhiazzurrini”: Si le clown est bien celui qui vient d’ailleurs, le maître d’un mystérieux passage, le contrebandier qui franchit les frontières interdites, nous comprenons pourquoi, au cirque, sur la scène, une importance si considérable fut attachée de tout temps à son entrée. […] tout vrai clown surgit d’un autre espace, d’un autre univers: son entrée doit figurer un franchissement des limites du réel, et, même dans la plus grande jovialité, il doit nous apparaître comme un revenant (ivi, pp. -). L’ultima forma di amore concessa, o rimasta, all’artista della consapevolezza che è Tonio, – che non può godere fino in fondo della propria condizione perché è cosciente di sé, perché “sa” quello che sta facendo (non è più dunque, l’io poetico platonico invasato e posseduto dal daimon, ma sacerdote di un rito di cui conosce insieme la verità e la menzogna) – sarà allora l’ironia, quel riso che pone una distanza, ma che presuppone una “simpatia”, una sofferenza che è stata, in un momento precedente, condivisa, e poi mostrata per quello è che, in tutta la sua umana miseria: Le non-sens dont le clown est porteur prend alors, en un second temps, valeur de mise en question; c’est un défi porté au sérieux de nos certitudes. Cette bouffée de gratuité oblige à reconsidérer tout ce qui passait pour nécessaire. Ainsi, parce qu’il est d’abord absence de signification, le clown accède à la très haute signification de contradicteur: […] peut rire de sa propre lourdeur. Il n’y a plus de limites, donc plus de franchissement. Subsiste la dérision (ivi, p. ). Come già rilevava Cesare Cases: L’antiumanismo dell’età moderna contiene in sé una rivendicazione della vera umanità nella negazione delle sue forme alienate. Tuttavia non è un caso che questo concetto venga messo in bocca a Zeitblom [personaggio già ironico dal punto di vista onomastico]. Il diretto interessato, Leverkühn, e il suo creatore, sono di altro parere (Cases, , p. ). L’ironia sembra dunque l’ultima forma di amore possibile per l’artista borghese “organico”, dunque non autoescluso o autoespulso, ma immerso e responsabilmente coinvolto nella realtà in cui vive: come distacco che testimonia in verità una comunione, o almeno l’inveterato anelito, l’inveterata tensione a una comunione. BLAUE AUGEN , BLONDE BESTIE ( UND KEINE ZIGEUNER IM GRÜNEN WAGEN ) Note . Ci si riferisce qui naturalmente alla Morte a Venezia. . I riferimenti a Bolaffi, Matassi, e ad Eichendorff sono relativi ai seguenti seminari svoltisi presso il Dipartimento di Letterature Comparate nell’a.a. -: Marino Freschi: Mann e la cultura del suo tempo; Elio Matassi: Mann e la musica; Ute Weidenhiller: Mann e il romanticismo; Angelo Bolaffi: Mann e la politica. . Cfr. in Starobinski () il capitolo intitolato L’éblouissement devant la légèreté, ou le triomphe du clown. Bibliografia Opere di Thomas Mann – (-), Tutte le opere, Mondadori, Milano. – (), L’Eletto, traduzione di B. Arzeni, Mondadori, Milano. – (a), Tonio Kröger. La morte a Venezia. Cane e padrone, introduzione di G. Cusatelli, traduzione di S. T. Villari, Garzanti, Milano. – (b), I Buddenbrook, traduzione di A. Rho, Torino, Einaudi. – (), Tonio Kröger, introduzione di A. M. Giachino, traduzione di A. Rho (testo a fronte), Einaudi, Torino. – (a), Considerazioni di un impolitico, Adelphi, Milano. – (b), Nobiltà dello spirito, Mondadori, Milano. – (), Tristano, traduzione e cura di A. M. Giachino (testo a fronte), Einaudi, Torino. – (a), Doktor Faustus, traduzione e introduzione di E. Pocar, Mondadori, Milano. – (b), La montagna incantata, traduzione di E. Pocar, Corbaccio, Milano. Opere critiche (), Thomas Mann o dell’ambiguità borghese, De Donato, Bari. (), Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi, Torino. BARTHES R. (), Le degré zéro de l’écriture, Seuil, Paris. BERGSON H. (), Laughter, in W. Sypher (ed.), Comedy, Doubleday & Company, Garden City (NY). BOLOGNA C . (), Ritratto del critico come domatore di fantasmi , introduzione a J. Starobinski, Ritratto dell’artista da saltimbanco, Boringhieri, Torino . CASES C. (), Saggi e note di letteratura tedesca, Einaudi, Torino. ID. (), Thomas Mann, Mondadori, Milano. ID. (), Thomas Mann. Una biografia per immagini, Edizioni Studio Tesi, Pordedone. COLLINI P. (), Wanderung. Il viaggio dei romantici, Feltrinelli, Milano. GIRARD R. (), Menzogna romantica e verità romanzesca, Bompiani, Milano. KURZKE H. (), Thomas Mann. La vita come opera d’arte, Mondadori, Milano. LUKÁCS G. (), Thomas Mann e la tragedia dell’arte moderna, Feltrinelli, Milano. MAGRIS C. (), I saggi di Thomas Mann, una custodia per i “Buddenbrook”, in T. Mann, Nobiltà dello spirito, Mondadori, Milano. MITTNER L. (), Storia della letteratura tedesca, Einaudi, Torino, vol. III, tt. -. NIETZSCHE F. (), La nascita della tragedia, Adelphi, Milano. PEARCE R. (), Stages of the Clown Perspectives on Modern Fiction from Dostoevskji to Beckett, Southern Illinois University Press, Carbonsdale and Edwardsville. STAROBINSKI J. (), Portrait de l’artiste en saltimbanque, Gallimard, Paris. ZOLLA E. (), Discesa all’Ade e resurrezione, Adelphi, Milano. ASOR ROSA A. AUERBACH E. FRANCESCA MILANESCHI Altri testi BATAILLE G. (), La littérature et le mal, Gallimard, Paris. (), Critique d’art, Gallimard, Paris. R., GIOBBIO CREA E. (a cura di) (), Antologia della poesia tedesca, Mondadori, BAUDELAIRE C. FERTONANI Milano. (), Totem et tabù, introduzione di K. Kerény, Bollati Boringhieri, Torino. GOETHE J. W. (), Faust e Urfaust, Feltrinelli, Milano. HESSE H. (), Siddharta, traduzione di M. Mila, Adelphi, Milano. LÉVI-STRAUSS C. (), La voie des masques, Seuil, Paris. FREUD S. L’ESOTISMO AL SERVIZIO DELL’ART POUR L’ART: HÉRODIAS DI FLAUBERT di Federica Sforazzini Oriente, Medio Oriente, Nord Africa Sede dell’Ideale, orizzonte liberatorio per l’anima romantica da Novalis a Nerval (Pietromarchi, , p. ), questo Oriente che nell’Ottocento fornisce fantasmi all’Occidente da più di un secolo «reste une contrée aux frontières vagues, définie surtout par la présence de ses icônes (le chameau et la mosquée) ou de ses fantasmes (le harem et les femmes qu’il enferme)» (Yee, , p. ). Il termine “Oriente” appare, del resto, ulteriormente inadeguato se applicato al Nord Africa, nonostante gli specialisti dell’epoca avessero denunciato la maldicenza di questa estensione geografica. Nel dizionario Larousse del XIX secolo troviamo: «[…] l’usage s’est introduit d’appliquer le nom d’Orient aux pays situés à l’est des contrées où nous habitons. […] les orientalistes […] ayant étendu leurs études à l’Afrique toute entière et à l’Océanie, ont également étendu de ces deux côtés les limites de l’Orient». Il dizionario Littré del previene il lettore contro questa fallace abitudine: «Orient et oriental s’étendent souvent, par abus, fort au-delà de leurs limites; on entend plus d’une fois appeler de ce nom les pays de l’Afrique, leurs habitants et les choses qui s’y rapportent. Il est bon de prévenir contre cette faute». Eppure, alla pagina seguente, Fromentin è ritenuto un grande pittore orientalista allorché la sua fama è dovuta soprattutto a tele dipinte in Algeria! È dunque chiaro che l’uso del termine “Oriente” per fare riferimento ai paesi del Nord Africa era mal visto dagli specialisti, ma non è meno chiaro che questo uso era frequente. Il Nord Africa, denominato nei due secoli precedenti “Barbarie”, diventa “Oriente” nell’immaginario comune della Francia ottocentesca. Come ha precisato Pierre Jourda, «il est entendu que le terme d’Orient s’entend de tous les pays chauds qui vont de l’Inde au Maroc» (Jourda, , p. ) e in effetti il calore del clima sembra avere un ruolo simbolico non meno importante della situazione geografica. Ma l’aspetto di gran lunga più decisivo in questa definizione dell’Oriente è la presenza dell’Islam: come ha osservato Paul Siblot, la distinzione spaziale tra Oriente e Occidente nasce «en raison d’un clivage historique qui a fait de l’espace islamique le lieu de perception privilégié de l’alterité» (Siblot, , p. ). Questa con/fusione tra Oriente e Nord Africa è particolarmente evidente in ambito letterario. A eccezione di autori-viaggiatori come Pierre Loti, per il quale la distinzione tra Estremo Oriente e Oriente islamico non teme imprecisioni, nomi più o meno illustri della letteratura francese dell’Ottocento si comportano da «proxénètes de l’exotisme» (Yee, , p. ) traducendo (tradendo) l’esotismo in forme pre- FEDERICA SFORAZZINI fabbricate, pur conservando, nella maggior parte dei casi, un’ironica consapevolezza del cliché. Come ha dimostrato Jennifer Yee, nella produzione letteraria dell’epoca, «le cliché coexiste même, étrangement, avec cette conscience ironique de la part de l’auteur» (ibid.). La spiegazione s’iscrive, secondo Edward W. Said, nel contesto storico di un’Europa protesa a dominare politicamente quanto culturalmente l’Oriente riducendolo a immagini convenzionali che a forza di essere ripetute finiscono per appartenere al regime del senso comune. Metonimica, a questo proposito, è per Said la cortigiana egiziana descritta (posseduta) da Flaubert: The relationship between Occident and Orient is a relationship of power, of domination, of varying degree of a complex hegemony […]. The Orient was orientalized not only because it was discovered to be “Oriental” in all those ways considered commonplace by an average nineteenth-century European, but also because it could be – that is, submitted to being – made Oriental. There is very little consent to be found, for example, in the fact that Flaubert’s encounter with an Egyptian courtesan produced a widely influential model of the Oriental woman; she never spoke of herself, she never represented her emotions, presence or history. He spoke for and represented her. He was foreign, comparatively wealthy, male and these were historical facts of domination that allowed him not only to possess Kuchuk-Anem physically but to speak for her and tell his readers in what ways she was typically “Oriental”. My argument is that Flaubert’s situation of strength in relation to Kuchuk – Anem was not an isolated instance. It fairly stands for the pattern of relative strength between East and West, and the discourse about the Orient that it enabled (Said, , pp. -). L’eurocentrismo che Said attribuisce a Flaubert precede tuttavia il riconoscimento del merito di aver consapevolmente giocato con le limitazioni imposte dall’esotismo romantico al fine non di dominare graficamente l’Oriente quanto di porlo al servizio del suo progetto estetico: creare una forma funzionale all’esplorazione di determinati temi esistenziali. Il possesso non solo fisico della donna orientale che Said attribuisce a Flaubert, e a tutta la sua generazione, non impedisce all’autore della Tentation de saint Antoine, di Salammbô e di Hérodias di varcare le frontiere dell’orientalismo ufficiale. Al contrario: la crescente consapevolezza dei luoghi comuni dell’esotismo romantico si stempera, romanzo dopo romanzo, viaggio dopo viaggio, nella constatazione della resistenza ontologica di una realtà destinata a restare inaccessibile alla conoscenza occidentale. Ed ecco che l’Oriente totalmente assorbito dall’ego del giovane Flaubert ancora alla ricerca di uno stile, ancora acritico nei confronti dell’imagerie esotica, si coniuga, a partire da Salammbô, con il desiderio di fare «de l’Art, de l’Art pur et pas autre chose» . Inizia infatti in Salammbô la progressiva emancipazione di Flaubert dalla tirannia del narrativo imposta al romanzo dall’opera di Balzac, ma è con i Trois contes che lo stile flaubertiano «disloquant la phrase et brouillant le sens, s’expose à nu comme une articulation sans objet» (AA.VV., , p. ). Per la prise en charge dell’indicibile, caratteristica di tutta la poetica flaubertiana, dell’innominabile, legato all’impresa impossibile del romanzo antico, l’Oriente di Hérodias fa di Flaubert l’inventore di un nuovo esotismo che, a differenza di quello romantico, si configura come «perception aigüe et immédiate d’une incompréhensibilité éternelle» (Segalen, , p. ). L’ ESOTISMO AL SERVIZIO DELL’ A RT POUR L’ A RT : HÉRODIAS DI FLAUBERT L’esotismo di Flaubert Il Flaubert di Hérodias è ormai consapevole dell’impossibile rappresentazione romanzesca dell’Oriente e della Storia. Ambientati in un’epoca e in uno spazio remoti, i suoi romanzi “esotici” rispondono sempre al medesimo intento estetico: «fixer un mirage, en appliquant à l’antiquité les procédés du roman moderne» (Corr., III, p. ). La distinzione imperfetta, onnipresente nelle opere “antiche”, tra Estremo Oriente e Oriente islamico è quindi conseguente: lo scopo di Flaubert non è ricostruire il passato adottando il punto di vista di uno storico, ma resuscitarlo alla luce delle necessità estetiche di un romanziere. Come la Cartagine di Hamilcar e l’Egitto di saint Antoine, la Palestina di Hérode urla il falso e noi intendiamo dimostrare come all’origine, consapevolmente o no, ci sia il sistema della scrittura di Flaubert e la sua visione della Storia e dell’Oriente. Lungi dal costituire una fuga di fronte alla realtà, Flaubert propone ed elabora un esotismo che non è solo scrittura, ma anche problema di scrittura. Come ha dimostrato Luca Pietromarchi, Flaubert si rende conto dell’impossibilità di dare all’Oriente una chiara resa descrittiva sin dal suo primo e unico viaggio in Egitto raccontato nell’epistolario: Il “vrai” Orient si oppone implicitamente al carattere oleografico di un Oriente di convenzione e il presentimento di un’estensione spaziale smisurata fa dileguare quella che poteva essere la tranquillizzante sicurezza di muoversi all’interno di un paesaggio familiare. Il viaggiatore perde il controllo dello spazio. Dinanzi a sé vede l’immensità di una dimensione libera da ogni referente, totalmente estranea e vertiginosamente dilatata che lo attira e alla quale è pronto ad abbandonarsi. È questo il vero Oriente a cui accede Flaubert, allontanandosi dall’immagine descritta e codificata dai tanti Voyages e avvicinandosi alla complessità di una realtà che sarà continuamente denunciata come “indescrivibile” (Pietromarchi, , p. ). Ma l’appropriazione impossibile dello spazio si riscatta apparentemente nel possesso dell’almea Kuchuk Anem, nella quale Flaubert vede «less a woman than a display of impressive but verbally inexpressive femininity» (Said, , p. ). Ma si tratta di un possesso individuale e non estetico, un possesso che non varcherà mai, proprio come lo spazio battuto, le frontiere della scrittura privata. Lo stesso senso di smarrimento provato di fronte alla dilatazione di uno spazio che rivela confini e silenzi insondabili coglie il giovane Flaubert disteso accanto alla cortigiana: «J’ai pensé à Judith et à Holopherne couchés ensemble» (Du Camp, , p. ). Non una parola, nell’epistolario, sull’esclusione e sulla solitudine che aspettano Kuchuk dopo la partenza dell’amante passeggero, solo questo pietoso desiderio in difesa di un sentimentalismo volutamente ferito: «Quelle douceur ce serait pour l’orgueil si, en partant, on était sûr de laisser un souvenir et qu’elle pensera à vous plus qu’aux autres, que vous resterez en son cœur» (ibid.). Messa a tacere dal mito della donna fatale e dal tema della cupidigia della cortigiana esotica, Kuchuk è destinata a restare inaccessibile alla conoscenza occidentale e pertanto metonimica di un Oriente che perde il suo carattere retorico unicamente per sottrarsi a ogni tentativo di riduzione da parte di un orientalismo presbite. Nonostante la leggenda biografica ed estetica di Kuchuk Anem, ritenuta per molto tempo una cortigiana d’alto bordo e risultata poi una meretrice come tante, la sua influenza sulle eroine esotiche di Flaubert si esaurisce nel ricordo della danza come FEDERICA SFORAZZINI preliminare erotico, ponendo l’autore della Tentation de saint Antoine e di Hérodias in netta conformità all’associazione, universalmente sposata dai letterati dell’epoca, tra esotismo ed erotismo. E da questa convergenza tra uomo e autore nasce la donna orientale di Flaubert. Falsamente orientale, poiché incarnata contemporaneamente dalla moresca Salammbô, dalla leggendaria Regina di Saba, dalle ebree Hérodias e Salomé. Tutte eroine identificate nei più usurati clichés della donna esotica condensati nell’ellittica autodefinizione della Regina di Saba: «Je ne suis pas une femme, je suis un monde» (Flaubert, , p. ). Convergenza di eco letterarie e di esperienze biografiche, restituita da una scrittura sempre più incerta nello sbriciolamento metonimico e sineddotico delle descrizioni, la donna orientale di Flaubert traduce l’evoluzione estetica del romanziere, la sua crescente ironia gettata non tanto sul reale (in questo caso l’Oriente), ma sulle capacità della letteratura nella rappresentazione di questo reale. L’esplorazione dell’Oriente e della donna esotica è infatti contemporaneamente l’esplorazione di un processo verbale, narratologico. Esplorazione che attualizza l’incompatibilità tra cose e parole su cui Flaubert s’interroga sin dai tempi di Madame Bovary: […] comme si la plénitude de l’âme ne débordait pas quelquefois par les métaphores les plus vides, puisque personne, jamais, ne peut donner l’exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs, et que la parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles (ivi, p. ). Se ho a lungo insistito su Salammbô e sulla Tentation è perché la scrittura di Hérodias, lungi dall’essere un discorso unico e autonomo sull’Oriente, s’inserisce nella continuità dell’esotismo flaubertiano, dove «tout texte remet en cause, redéfinit, le genre dont il ne peut manquer de s’inspirer» (Wetherill, , p. ). Come ha dimostrato Peter Michael Wetherill, è possibile leggere Salammbô alla luce di Hérodias in nome di continui richiami intertestuali che non sono solo diegetici, ma anche e soprattutto stilistici (Wetherill, , p. ). La portata ironica dell’intertestualità è evidente: la somiglianza tra tutti i romanzi flaubertiani, a cui si aggiunge quella dei manoscritti che li precedono, traduce l’intento dell’autore di fondare l’incomprensibilità dell’Oriente e contemporaneamente di ripensare la letteratura. E il carattere verbalmente inaccessibile della Palestina di Hérodias ben si presta a questo intento. Vediamo perché. Sulla fonte biblica di Hérodias la critica è unanime: Flaubert si sarebbe ispirato più alla Vie de Jésus di Renan, pubblicata nel , che al breve racconto edificante dei Vangeli di Matteo e di Marco. Nella riscrittura storica e critica di Renan infatti Hérodiade è descritta come «violente, ambitieuse, passionnée» (Renan, , p. ), avversa al giudaismo e alle sue leggi, tutte caratteristiche possedute dall’eroina flaubertiana, mentre Hérode è dipinto come «plus timide que cruel» (ivi, p. ) e, in generale, piuttosto passivo. L’esitazione iniziale riguardo alla scelta del titolo confermerebbe questa tesi: dopo La décollation de saint Jean-Baptiste, Flaubert sceglie Hérodias senza mai pensare al nome di Hérode né di Salomé. Ma è soprattutto l’epistolario a rivelare l’intento non edificante dell’opera: Après saint Antoine, saint Julien; et ensuite saint Jean-Baptiste; je ne sors pas des saints. Mais pour celui-là je m’arrangerai à ne pas «édifier». L’histoire d’Hérodias, telle que je la comprends, n’a aucun rapport avec la religion. Ce qui me séduit là- L’ ESOTISMO AL SERVIZIO DELL’ A RT POUR L’ A RT : HÉRODIAS DI FLAUBERT dedans, c’est la mine officielle d’Hérode (qui est un vrai préfet) et la figure farouche d’Hérodias, une sorte de Cléopatre et de Maintenon (Corr. Co., VII, p. ). A Flaubert non interessa quindi la storia di Giovanni Battista, ma il ruolo decisivo giocato da Hérodias nella decapitazione del santo, ruolo ulteriormente rilevato dalla cronologia del racconto, dove l’azione si svolge in sole ventiquattro ore esigendo dall’autore la tecnica dell’ellissi. Come ha osservato Debray-Genette (, p. ): «L’ellipticité du conte, appuyée sur sa théâtralité, est la condition même de sa résonance imaginaire, idéologique et symbolique». In altre parole, è la tecnica dell’ellissi, richiesta dalla struttura del racconto, a minarne la storicità che Flaubert è pronto a sacrificare alla costruzione mitica del testo e del reale. La riduzione della Storia a elemento marginale è elaborata già a partire dai testi preparatori, dove Flaubert afferma che occorre «se passer, autant que possible, d’explications indispensables» (ivi, p. ). Inverso è invece il procedimento nella resa degli spazi: dalla topografia obiettiva dei brouillons si passa alle descrizioni fortemente focalizzate del testo definitivo, come dimostra in particolare l’incipit del racconto. Qui la focalizzazione è addirittura doppia: dopo aver descritto la cittadina di Macheronte con l’impersonalità di uno storico, Flaubert procede a una rotazione del punto di vista affidando a Hérode la prospettiva: «Un matin, avant le jour, le Tétrarque Hérode-Antipas vint s’y accouder, et regarda» (Hérodias, p. ). A partire da questo momento, la descrizione perde il suo carattere didattico per farsi simbolo della preoccupazione di Antipas per la minaccia araba. Dopo aver percorso lo spazio con un movimento prima discendente e poi orizzontale, lo sguardo del tetrarca si appunta sull’oggetto del suo timore: «[…] Antipas reconnut ce qu’il craignait d’apercevoir. Des tentes brunes étaient dispersées; des hommes avec des lances circulaient entre les chevaux, et des feux s’éteignant brillaient comme des étincelles à ras du sol. C’étaient les troupes du roi des Arabes» (ibid.). Sin dall’inizio del racconto, siamo di fronte al superamento della descrizione di tipo balzachiano, dove lo spazio è un’apparizione neutra, del tutto indipendente dallo stato d’animo dell’osservatore. Come per i precedenti romanzi di Flaubert, vale il giudizio di Jean Rousset: «Il n’y a pas de réalité objective, toute vision, toute perception est l’illusion propre à chacun, autant des “verres colorés” que des regards» (Rousset, , p. ). La lacuna topografica che chiude l’orizzonte osservato da Antipas è pertanto giustificata dal timore del prefetto (l’invasione delle truppe arabe) e dalla sua speranza (l’arrivo dei Romani in suo soccorso). Questa scrittura frammentaria anticipa il metodo descrittivo che Philippe Hamon attribuisce ai Nuovi Romanzieri, nei quali il ritratto del personaggio si affida a dettagli detentori di diverse funzioni narrative: Pour ce type de texte, et pour sa théorie, la description n’est que le lieu d’un déplacement, sous forme de noms de choses, de lieux ou d’objets, de qualifications psychologiques, professionnelles ou caractérielles assignables et attribuables en dernières instances aux personnages. De plus, cette différence d’écriture du sociologique et du psychologique, ces digressions synecdotiques et métonymiques que signale Roman Jacobson (au lieu de parler «directement» de la psychologie de x, ou du caractère de x, ou de la profession de x, on parle de son habit, de son habitat, de ses habitudes) est aussi une information différée: tel «détail» est toujours un indice, indice valant pour les événements ultérieurs du récit, ou indice rappelant un événe- FEDERICA SFORAZZINI ment antécédent. Le «détail», lui-même inséré dans une description, est alors un pur procédé anaphorique rétablissant la cohérence du personnage (son passé, son avenir, son inclusion dans classes caractérielles et psychologiques), donc son statut sémantique «unitaire» (Hamon, , pp. -). Nella descrizione della sala del festino è una similitudine in eccesso a complicare la resa dello spazio: «Elle avait trois nefs, comme une basilique» (Hérodias, p. ). Per Brunetrère si tratta di un paragone superfluo che non aggiunge nulla alla precisione referenziale. Al contrario, per Raymonde Debray-Genette «basilique» è un termine polivalente su cui si appoggia l’intero edificio del capitolo: letteralmente, precisa la forma della sala; da un punto di vista culturale, rinvia a un edificio greco-latino, ben noto ai latinisti dell’epoca, al fine di destabilizzare le nostre certezze storiografiche; ma in particolare Flaubert ha voluto alludere al passaggio dal paganesimo al cristianesimo giocando sul senso che prenderà la parola in era cristiana, quando i fedeli celebreranno il loro culto nelle basiliche e le trasformeranno in chiese (DebrayGenette, , pp. -). Si tratta di procedimenti che Flaubert ha già sperimentato nelle sue precedenti opere ambientate in Oriente e con le quali intende condividere l’esotismo degli effetti, come testimonia questo passaggio dell’epistolario: «J’ai peur de retomber dans les effets produits par Salammbô, car mes personnages sont de la même race et c’est un peu le même milieu» (Hérodias, p. ). Accostando i personaggi e l’ambiente del “romanzo cartaginese” alla materia diegetica di un racconto ambientato in Medio Oriente, Flaubert conferma la presenza in entrambi i testi del presupposto estetico volto a fare dell’Oriente mitico il principio stesso dell’opera. Senza spingerci fino a postulare la stagnazione della scrittura flaubertiana, prendiamo con grano di sale la confessione di Flaubert: durante la gestazione di Hérodias, l’autore cerca (e non teme) l’esotismo di Salammbô avvalendosi di un approccio romanzesco e non storico. Personaggi e ambiente rimandano infatti a quella paccottiglia orientale che se da un lato destabilizza le nostre certezze spazio-temporali, dall’altro rafforza l’unità romanzesca. Come ha osservato DebrayGenette, «Hérodias emprunte au mythe sa clarté narrative en même temps que son obscurité interprétative» (Debray-Genette, , p. ). Come i personaggi di Salammbô, quelli di Hérodias nascono dalla confluenza di clichés esotici e di infiltrazioni moderniste che li privano di qualsiasi statuto storico. Il primo dialogo, ad esempio, tra Hérodias e Antipas presenta tutta la volgarità borghese del dibattito familiare e nel contempo rivela due personaggi ossessionati dal passato, eredi dell’ignavia di Frédéric e di Deslauriers: «“J’ai pris un bon soutien, en entrant dans ta famille! – Elle vaut la tienne!”, dit simplement le Tétrarque. Hérodias sentit bouillonner dans ses veines le sang des prêtres et des rois ses aïeux» (Hérodias, p. ). Questi rimproveri sordidi, degni degli screzi domestici più banali, allontanano i personaggi dal loro contesto avvicinandoli all’ambiente medio borghese del romanzo intimo del primo Ottocento e tradiscono così lo sguardo ironico gettato da Flaubert su comportamenti che egli ritiene universali ed eterni. La Giudea del I secolo diventa così una variante della Parigi del Secondo impero. Ma è soprattutto negli alterchi inseriti nella scena del banchetto che torna il tema del silenzio in cui Wetherill ha visto un esempio di continuità diegetica dei Trois contes. Lo scontro verbale tra farisei e sadducei degenera infatti in una serie di dispute inarticolate che L’ ESOTISMO AL SERVIZIO DELL’ A RT POUR L’ A RT : HÉRODIAS DI FLAUBERT se da un lato rimandano ai problemi razziali di Gerusalemme attestati da Renan, dall’altro alludono alla crisi moderna del linguaggio avvertita da Flaubert sin dai tempi di Madame Bovary (Flaubert, , pp. -). Inoltre, la presenza d’eco di altri testi di Flaubert indebolisce ulteriormente la coerenza storica della scena, dove la scrittura trova effetti allucinatori già sperimentati nei banchetti di Salammbô e della Tentation: «Plusieurs causaient debout, au milieu de la salle; et la vapeur des haleines avec les fumées des candélabres faisait un brouillard dans l’air» (Hérodias, p. ). Come nei romanzi esotici precedenti, Flaubert avvolge il festino in una nuvola che di per sé suggerisce l’eccesso della scena togliendole ogni verosimiglianza. Lo spazio appare così alienato dall’azione narrativa al punto da proporsi come uno spettacolo o una visione avvolti nel mistero (Neiland, , pp. -). Topos ricorrente nella scrittura flaubertiana, costantemente associato alla bestialità del comportamento umano in cui Flaubert constata un’avvilente continuità tra passato e presente, la scena del banchetto trova in Hérodias effetti di ferocia senza precedenti. La disumanizzazione dei personaggi riposa inizialmente su un linguaggio metaforico: i farisei hanno «l’air de bouledogues» (Hérodias, p. ); Hérodias «ressemblait à Cybèle à côté de ses lions» (Hérodias, p. ). In seguito Flaubert paragona la violenza animale alla rabbia umana: Hérodias «se cassa les ongles au grillage de la tribune, et les deux lions sculptés semblaient mordre ses épaules et rugir comme elle» (Hérodias, p. ). Come si evince dai brouillons, lo scopo di questa crescente disumanizzazione dei personaggi è infestare di violenza la scena affinché diventi teatro di azioni cruente: «[…] la dispute s’échauffe la fête devient (sombre) farouche». Per motivare la paura di Vitellius, Flaubert aggiunge negli abbozzi: «assassinats pendant les festins». Il trattamento di questo topos, erede di una ricca tradizione classica e religiosa, rivisitato nel Cinquecento da Rabelais e nell’Ottocento da Balzac, è quindi singolare: lungi dall’incoraggiare il dialogo e la convivenza pacifica, il banchetto in Flaubert rinvia alle costanti di una natura umana bloccata nel mondo dell’inarticolato e spesso impaziente di infliggere la mutilazione. La donna fatale come strumento di esplorazione testuale Ancora una volta la continuità diegetica e stilistica dell’esotismo flaubertiano forgia una verità tutta testuale che, volente o nolente, ironizza sulla realtà extraletteraria identificata dalla letteratura romantica in un Oriente mitico ridotto, il più delle volte, ad harem dell’Occidente (Yee, , pp. -). A questo proposito, è bene ricordare che nella rielaborazione tematica e stilistica della donna orientale Flaubert non è un esponente isolato nel panorama letterario del suo tempo. Prima e dopo di lui autori illustri come Baudelaire, Mallarmé, Huysmans, Wilde e Apollinaire, sensibili alla crisi della letteratura avvertita in quegli anni, si cimentano nel tentativo di adattare il tema della donna orientale all’esplorazione del testo. E l’abbondanza di queste risonanze è tale che, in epoca decadente e simbolista, il tema di Salomé diventerà un mito (Marchal, , pp. -). Non che questa esotica icona abbia aspettato l’Ottocento per fare la sua apparizione in ambito estetico: corteggiata, in ordine cronologico, dalla letteratura latina decadente, ospitata nella biblioteca di Des Esseintes, dall’arte figurativa medioevale e da quella rinascimentale, dove spesso la si confonde con Hérodiade, Salomé subisce un’attenzione e un trattamento senza precedenti a partire FEDERICA SFORAZZINI dagli anni Quaranta del XIX secolo, quando, con la Atta Troll di Heinrich Heine, perde ogni semantica storica e politica per farsi paradigma della donna fatale e spietata (Decaudin, , p. ). Bram Dijkstra ha spiegato la fortuna pittorica e letteraria di questo mito con il diffondersi nella Francia fin de siècle di una misoginia pseudoscientifica, di nascente antisemitismo e di disprezzo per le razze inferiori (ma pericolose) di cui le donne fanno naturalmente parte (Dijkstra, ). Per Helena Shillony bisogna aggiungere a tutto questo il diffondersi della prostituzione nella Parigi dell’epoca e un conseguente cambiamento nella visione maschile della femme entretenue che da vittima diventa una nemica (Shillony, , p. ). In Hérodias, Storia e mito, documentazione e finzione confluiscono nel valore testuale e tematico della donna fatale che Flaubert non identifica in Salomé, ma in sua madre Hérodias. La presa di distanza dall’approccio tradizionale si evince infatti già dal titolo, ma è soprattutto la mise en texte, il dispositivo enunciativo ambiguo a rendere incerta la lettura dei clichés esotici. Nei vari e frammentari ritratti di madre e figlia, Flaubert si serve di una scrittura lacunosa volta a rafforzare il carattere soggettivo della focalizzazione e nel contempo a conferire unità all’azione narrativa: è infatti Hérode a detenere il punto di vista nel momento in cui Hérodias tenta vanamente di sedurlo. Al Tetrarca Hérodias appare dotata di una bellezza esotica ormai stagionata: senza ornamenti, in cui l’immaginario maschile identifica la femminilità orientale, ha «des plis» (Hérodias, p. ) sulla fronte; Salomé, al contrario, si scompone ai suoi occhi nella freschezza di ogni singolo dettaglio, come la vita sottile o il braccio nudo, «un bras jeune, charmant et comme tourné dans l’ivoire par Polyclète» (Hérodias, p. ). L’unità narrativa riposa appunto su questa opposizione percepita da Hérode: Hérodias, non essendo più capace di sedurre essa stessa il Tetrarca, deve ricorrere alla figlia di cui fa un oggetto puramente erotico. Questo spiega il valore tematico della frammentazione del ritratto di Salomé ridotta a un corpo seducente visto attraverso lo sguardo concupiscente di Antipas. Flaubert affronta qui il tema della giovinezza come conditio sine qua non della seduzione femminile il cui effetto si fa devastante laddove la donna, oltre a essere giovane è esotica, vale a dire estranea all’universo muliebre occidentale, dove una sempre più rigida morale borghese impone abiti castigati alle donne oneste lasciando alle «grandes horizontales» la libertà di scoprirsi. Il riferimento alla realtà parigina della prostituzione si stempera nel commento d’autore che precede la danza di Salomé per rivelarne la funzione drammatica voluta da Hérodias, la quale non ha esitato a servirsi del corpo della figlia pur di perseguire il suo obiettivo di seduzione (Hérodias, p. ). La degradazione di questa figura materna che intima alla figlia di prostituirsi è completa nel momento in cui Hérodias richiama Salomé con un semplice schioccare di dita per ordinarle cosa chiedere al Tetrarca. Ridotta così a un corpo addestrato a provocare il desiderio maschile, incapace di accedere al più elementare pensiero, Salomé accoglie i più usurati clichés della femminilità orientale senza tempo e contemporaneamente uno dei concetti esistenziali più frequentati da Flaubert: la fusione/confusione tra donna ideale e meretrice in un’epoca in cui l’esaltazione della donna-angelo ha fatto della prostituzione un’esigenza sociale. Ed è la scrittura a conferire una funzione di rappresentatività totalizzante al personaggio di Salomé attraverso il capolavoro descrittivo della sua danza. La critica ha a lungo insistito sulla matrice autobiografica di questa descrizione, chiamando in causa le ripetute esperienze mercenarie avute dal giovane Flaubert con la danzatrice di Esneh, Kuchuk Anem e con quella di Assouan, Azizeh. Senza L’ ESOTISMO AL SERVIZIO DELL’ A RT POUR L’ A RT : HÉRODIAS DI FLAUBERT mai contestare questa teoria, Luca Pietromarchi ha però dimostrato come l’incontro con Kuchuk costituisca la conferma di un’ossessione che Flaubert condivideva già con i suoi contemporanei prima del viaggio in Egitto: la piatta associazione tra esotismo ed erotismo, tra Oriente e sessualità, tra amore e semplice contatto di due tessuti. Nella danza di Kuchuk, il viaggiatore riconosce il continuarsi di una lezione di grazia addirittura ellenistica: «J’ai vu cette danse sur des vases grecs» (Du Camp, , p. ). In altre parole, prima di osservare la danza di Kuchuk, Flaubert è già convinto dell’immutabilità dello spazio e della storia orientali, dell’impotenza della parola di fronte a una realtà che, come il destinatario dei richiami gestuali di Salomé, «s’enfuyait toujours» (Hérodias, p. ). A riprova di questa tesi è sufficiente citare il magistrale lavoro genetico di Mary Neiland, la quale ha individuato nella danza di Salomé dettagli testuali della Tentation del e di altri romanzi flaubertiani (Neiland, , pp. -). Alla consultazione degli appunti di viaggio relativi all’evocazione della danza di Kuchuk contrapposta a quella di Azizeh vanno quindi aggiunti svariati richiami intertestuali al fine di cogliere la natura composita e polisemica di una danza autenticamente letteraria, vale a dire indissociabile dal discorso che la veicola. Nella Tentation del , testo scritto di getto alla vigilia del viaggio in Egitto, si condensa tutta la cieca adesione del giovane Flaubert all’imagerie esotica nell’allineamento di temi e figure metonimici di un Oriente che Pierre-Marc de Biasi ha definito mitico per la presenza di paesaggi emblematici dell’infinito, ma anche e soprattutto femminile per la fusione tra esotismo ed erotismo (Flaubert, , p. ). Largo spazio è dato dall’autore della prima Tentation al ruolo della Luxure, ma soprattutto a quello delle «trois filles»: Adultère, Fornication e Immondicité, le tre figlie della personificazione del peccato di lussuria, circondano il santo per tentarlo verbalmente attraverso tre distinti monologhi. Ebbene, la danza di Salomé recupera le immagini e le associazioni esplicitamente elaborate durante i monologhi delle «trois filles» all’interno di un’unica sequenza narrativa scandita da tre passaggi distinti che corrispondono alle tre diverse psychologies citate negli abbozzi. Qui Flaubert stabilisce che deve esserci una «psych différente & progress à chaque danse». Inizialmente Salomé, con un movimento di piedi che ricorda la danza di Azizeh, è definita «plus légère qu’un papillon» (Hérodias, p. ), con un implicito riferimento al monologo di Adultère (La tentation I, p. ) e all’armonica sensualità di Kuchuk. Il languore voluttuoso del secondo movimento, annunciato dai «sons funèbres de la gingras» (Hérodias, p. ) accoglie invece la confluenza di misticismo e sensualità che richiama in particolare le parole di Fornication (La tentation I, p. ) e, più in generale, la religiosità kitsch di Emma e Salammbô. Nel terzo movimento, immagini di disordine riflettono la lascivia selvaggia di Immondicité e della danza di Azizeh, entrambe a suo tempo associate a una sensualità depravata. Nel momento in cui Salomé si piega «en écartant les jambes» (Hérodias, p. ) ricordando «les cuisses écartées» (La tentation I, p. ) di Immondicité, lo scopo della sua danza è raggiunto: il desiderio di Antipas, ulteriormente accresciuto da quello degli altri spettatori, è stato suscitato fino a rendersi irresistibile. Flaubert interrompe a questo punto la descrizione della danza di Salomé per passare a evocarne gli effetti ispirandosi stavolta non più ai fantasmi condivisi con i suoi contemporanei, ma ai ricordi di viaggio e, in particolare, alle contorsioni di Azizeh con il loro «effet de décapitement effrayant» (Flaubert, , p. ). L’esito dell’esibizione di Salomé rientra così nella struttura circolare del racconto, sia essa tematica che stilistica. Come ha dimostrato Debray-Genette (, pp. -) assistiamo, nell’excipit, a una FEDERICA SFORAZZINI brusca inversione dello spazio testuale che inizialmente abbiamo visto affidato al punto di vista di Hérode. È infatti Hérodias, durante la sequenza della danza di Salomé, a dirigere lo spettacolo dall’alto della sua tribuna d’oro per poi reclamarne il prezzo, evidenziando così il suo ruolo di protagonista e quello di semplice esecutrice della figlia. Il suo complotto, basato sulla consapevolezza dell’ascendente esercitato sull’immaginario maschile da una studiata seduzione femminile, ha come risultato la decapitazione del Battista posta, sin dall’inizio, in relazione all’annichilimento del Tetrarca. La degradazione di questo personaggio, di cui Flaubert aveva sposato inizialmente il punto di vista unicamente per annunciare la sua totale estraneità al piano ordito dalla moglie, è completa nel momento in cui «les mains contre ses tempes» (Hérodias, p. ) osserva la testa mozzata di Giovanni Battista richiamando la nostra attenzione sulla prima allusione dell’autore all’opera: «La vacherie d’Hérode pour Hérodias m’excite» (Corr. Co., VII, p. ). Impossibile, come ha osservato Rosa Maria Palermo Di Stefano, non vedere in questo gesto del Tetrarca, la «vacherie» tout court del personaggio (Bonaccorso, , p. XCI). Questi si pone così come il prototipo dell’uomo ottocentesco terrorizzato dalla donna sessualmente attraente, prototipo peraltro molto battuto dagli autori dell’epoca, i quali, da Huysmans a Proust, sostituiscono la figura della cortigiana virtuosa vittima del destino con quella della calcolatrice femme entretenue, portatrice di sofferenze, se non di morte, per i suoi amanti. L’epilogo del racconto rivela quindi la circolarità tematica e stilistica tessuta da Flaubert attorno al «pour qu’il croisse, il faut que je diminue» (Hérodias, p. ) di Iaokanan: l’ineluttabilità («il faut que je diminue») si rivela la chiave di lettura dell’opera, dove ogni personaggio, e non solo Salomé, risulta né più né meno che un semplice strumento posto al servizio dell’esplorazione del romanzo e del romanzesco. E chi più di tutti riflette il parallelismo tematico dello scritto e dell’umano è proprio Hérodias, senza il cui irrefrenabile appetito di potere, da cui nasce il bisogno di sopprimere il Battista, non avremmo avuto l’esecuzione di Iaokanan e la successiva diffusione della parola del Messia a cui corrisponde, al di là della diegesi, l’imperativo estetico di Flaubert: la scomparsa dell’autore dalla propria opera. Affinché la Giudea di Hérode non varchi mai le frontiere del testo e i personaggi rinviino tutti all’attività di cui sono la manifestazione essenziale e ironica: l’Arte. Note . Grand dictionnaire universel du XIX siècle, Larousse, Paris , p. . . Dictionnaire de la langue française, Littré, Paris , p. . . Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris . . Per la corrispondenza di Flaubert si fa riferimento alle edizioni Gallimard (Flaubert, ) e Conard (Flaubert, -), abbreviate d’ora in avanti rispettivamente in Corr. e in Corr. Co., seguite dal numero del volume e da quello della pagina. . Le citazioni di Hérodias sono tutte tratte dall’edizione Œuvres curata da A. Thibaudet e R. Dumesnil (Flaubert, ). Tutti i rimandi a tale edizione saranno abbreviatai d’ora in avanti in Hérodias. . Bibliothèque nationale de Frace, nouvelles acquisitions françaises, Nafr. , f. v. Ogni riferimento a questo dossier genetico è abbreviato in Nafr. . Nafr. , f. . . Tre donne figurano nell’omonimo quadro di Bruegel. Per un’analisi delle fonti di questi personaggi, cfr. Kim (, pp. -). L’ ESOTISMO AL SERVIZIO DELL’ A RT POUR L’ A RT : HÉRODIAS DI FLAUBERT . Nafr. , f. v. «Psych» è un’abbreviazione di psychologie e «progress» un’abbreviazione di progression. . I riferimenti alla Tentation del , abbreviati d’ora in avanti in La tentation I, sono tratti dall’edizione Œuvres complètes curata da B. Masson (Flaubert, ). Bibliografia (), Travail de Flaubert, Seuil, Paris. (), Flaubert e il pensiero del suo secolo. Atti del convegno internazionale, Messina. AFFERGAN F. (), Exotisme et altérité. Essai sur les fondements d’une critique de l’anthropologie, PUF, Paris. AMOSSY R., ROSEN H. (), Les discours du cliché, Sedes, Paris. BERTY V. (), Littérature et voyage, L’Harmattan, Paris. BHABHA K. H. (), I luoghi della cultura, trad. it., Meltemi, Roma. BONACCORSO G. (), Corpus flaubertianum, vol. I, Hérodias, Nizet, Paris. CHESSEX J. (), Flaubert ou le désert en abîme, Grasset, Paris. COUPRIE A. (), Voyage et exotisme au XIX siècle. Thèmes et questions d’ensemble, Paris, Hatier. CULLER J. (), Flaubert, the Uses of Uncertainty, Paul Elek, London. CZYBA L . (), Mythes et idéologie de la femme dans les romans de Flaubert , Presses Universitaires de Lyon, Lyon. DEBRAY-GENETTE R. (), Métamorphoses du récit. Autour de Flaubert, Seuil, Paris. DECAUDIN M. (), Un mythe fin de siècle: Salomé, in “Comparative literature studies”, , pp. -. DIJKSTRA B. (), Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in “fin de siècle” Culture, Oxford University Press, Oxford. DOUCHIN J. L. (), La vie érotique de Flaubert, Carrère, Paris. DU CAMP M. (), Voyage en Orient, a cura di G. Bonaccorso, Peloritana Editrice, Messina. DU MARSAIS C. C. (), Traité des tropes, Nouveau Commerce, Paris. FLAUBERT G. (-), Correspondance, Conard, Paris ( voll.). ID. (), Hérodias, in Id., Œuvres, texte établi et annoté par A. Thibaudet et R. Dumesnil, Gallimard, Paris, vol. II. ID. (), La tentation de saint Antoine, version de , in Id., Œuvres complètes, textes présentés par B. Masson, Seuil, Paris. ID. (-), Correspondance, édition établie et annotée par J. Bruneau, Gallimard, Paris ( voll.). ID. (), Voyage en Egypte, édité par Pierre Marc de Biasi, Bernard Grasset, Paris. HAMON P. (), Du descriptif, Hachette, Paris. ID. (), L’ironie littéraire. Essai sur les formes de l’écriture oblique, Hachette, Paris. JOURDA P . (), L’exotisme dans la littérature française depuis Chateaubriand , Slatkine Reprints, Genève. KIM Y.- E . (), «La tentation de saint Antoine», version de : genèse et structure , Kangweon University Press, Chuncheon. MARCHAL B. (), Salomé entre vers et prose. Baudelaire, Mallarmé, Flaubert, Huysmans, Corti, Paris. MELTZER F. (), Salomé and the Dance of Writing. Portraits of Mimesis in Literature, The University of Chicago Press, Chicago and London. NEILAND M . (), “Les tentations de saint Antoine” and Flaubert’s Fiction: A Creative Dynamic, Rodopi, Amsterdam-Atlanta. PIETROMARCHI L. (), L’illusione orientale. Gustave Flaubert e l’esotismo romantico (-), Guerini, Milano. AA.VV. AA.VV. FEDERICA SFORAZZINI PRAZ M. (), La carne, la morte il diavolo nella letteratura romantica, Sansoni, Firenze. RENAN J. E. (), Vie de Jésus, in Id., Œuvres complètes, Calmann-Lévy, Paris, vol. IV. ROUSSET J. (), Forme et signification, Corti, Paris. SAID E. W. (), Orientalism, Penguin Books, Harmondsworth. SEGALEN V. (), Essai sur l’exotisme. Une esthétique du divers, Fata Morgana, Paris. SHILLONY H. (), Helena, Hérodias, Salomé, Judith: figures emblématiques de la peur de la femme dans la seconde moitié du XIX siècle, in “Travaux de littérature”, XVII, pp. -. SIBLOT P. (), Orient de l’Occident, in AA.VV., Exotisme et création, Actes du colloque de Lyon, L’Hermes, Lyon. (), Flaubert, la dimension du texte , Manchester University Press, Manchester. ID. (éd.) (), Trois Contes, Garnier, Paris. ID . (), Le discours de l’histoire , in AA . VV ., Salammbô de Flaubert: histoire, fiction , Champion, Paris. YEE J. (), Clichés de la femme exotique. Un regard sur la littérature coloniale française entre et , L’Harmattan, Paris. ZAGONA H. G. (), The Legend of Salomé and the Principle of Art for Art’s Sake, Minard, Paris. WETHERILL P. M . GERMANISTICA Giuli Liebman Parrinello Agnese Nobiloni Toschi Marta Bignami RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER di Giuli Liebman Parrinello Questo brillante saggio di Enzensberger, scrittore scomodo, viene spesso doverosamente citato, e sono anche abbastanza numerosi gli autori che lo considerano con attenzione sotto il profilo del suo vero e proprio assunto, il turismo (Kramer, ; Asmodi, ; Spode, ; Pagenstecher, ); ma non è forse esagerato affermare che esso non è stato scandagliato fino in fondo. Trascorsi ormai quasi cinquant’anni, il lavoro ben merita una rivisitazione in chiave di una rilettura che da un lato lo contestualizzi riprendendone il discorso originale in tutta la sua suggestiva complessità ma anche nelle sue possibili incongruenze, e ne faccia emergere dall’altro i diversi risvolti anticipatori in chiave di teoria del turismo sulla base delle principali angolazioni che da allora si sono sviluppate, non da ultimo alla luce della globalizzazione del fenomeno. Nato come trasmissione radiofonica, pubblicato in “Merkur” nel e ripubblicato nel in Einzelheiten (Enzensberger, ) il breve testo, assieme a vari altri saggi, va collocato negli interessi di quegli anni dell’autore, e ricollegato in ispecie alla Bewußtseins-Industrie, quell’industria della coscienza che rappresenta un superamento e uno sviluppo della Kulturindustrie adorniana. Già allora Enzensberger sagacemente individua nel turismo, assieme alla moda, alle attività formative e all’istruzione religiosa dei settori non ancora riconosciuti e indagati dell’industria della coscienza «l’industria-chiave del secolo Ventesimo» (Enzensberger, b, pp. -). Sembra quasi che Enzensberger sia nel contempo attratto e respinto da questa industria, come risulta appunto da suoi testi quali questo sul turismo, sui libri tascabili e su un diffuso catalogo (Lau, , p. ). L’industria della coscienza è – sia pure diversamente da Adorno – una necessaria resa dei conti con l’Illuminismo, le cui realizzazioni (o per lo meno proclamazioni) ne rappresentano le premesse indispensabili, mentre le condizioni materiali e politiche sono legate al processo di industrializzazione, quello stesso processo che sta poi alla base del moderno turismo: Premessa politica dell’industria della coscienza è la proclamazione dei diritti dell’uomo, dell’uguaglianza e della libertà in particolare, non la loro realizzazione effettiva […]. Soltanto la finzione che ogni uomo abbia diritto a disporre del suo destino e di quello dei suoi simili politicizza la coscienza che il singolo e la società hanno di sé; l’induzione industriale di una coscienza così politicizzata diventa condizione prima di qualsiasi dominio futuro (Enzensberger, b, p. ). Questi i dati da cui partire: va chiarito che non esiste una continuazione vera e propria della tematica del turismo nell’opera successiva di Enzensberger, ma se ne pos- GIULI LIEBMAN PARRINELLO sono casomai cogliere dei cenni che fanno presagire, quasi in guisa di frammenti, l’evoluzione e il quadro posteriore: per un verso nel cuore della matrice occidentale del fenomeno il gusto del lusso, del consumo vistoso vebleniano attraverso nuovi percorsi che passano anche tramite la tranquillità, gli spazi, la sicurezza ecc. in Zig Zag (Enzensberger, ); per l’altro il nuovo necessario referente de La grande migrazione (Enzensberger, ) che prospetta negli anni Novanta non solo una visione meno eurocentrica, ma sembra anche sommergere la mobilità del turismo nelle altre dirompenti mobilità sociali. Rimanendo a Una teoria del turismo (Enzensberger, a), la lungimiranza dell’autore potrebbe sembrare per molti versi sorprendente, considerando che si era appena agli inizi di un turismo di massa mondiale, ma l’osservatorio dato dalla Germania del miracolo economico rappresentava probabilmente una sorta di situazione in vitro in cui cogliere prodromi e futuri sviluppi a livello mondiale. Il Sud si era già allontanato di molto, come aveva scritto addirittura nel Gottfried Benn, consapevole della perdita di funzione del mito letterario dell’Italia: «Il sud di Mignon, il sud di Goethe e di Byron si trova oggi a Tahiti e a Fakavara» (Benn, , p. ). Per Enzensberger era implicitamente superato anche quel rapporto Germania-Italia reso nell’immagine così retorica e tenace delle due figure femminili di Overbeck; non meraviglia allora che il quadro tedesco, europeo e mondiale evocato nel suo scritto del superi i limiti culturali della tradizionale visita-pellegrinaggio alle chiese di Roma (Pagenstecher, ) e, anticipando il turismo intercontinentale, proietti i nuovi turisti su uno sfondo ben più ampio. Anche perché vi si aggiunge appunto la consapevolezza dei meccanismi di quella che è ormai diventata non solo un’industria di fatto, ma anche in modo più sottile un’“industria della coscienza”. Non è dunque esagerato affermare che si percepiscono i sintomi della globalizzazione: il turismo è già un’industria globale prima che questo processo sia avvertibile in altri settori e prima che gli anni Sessanta sanzionino con l’avallo delle organizzazioni internazionali lo scambio fra Nord e Sud del mondo attraverso questa sorta di cinghia di tramissione dell’economia mondiale (Lanfant, ). Turismo e turisti L’alternarsi di due voci di scrittori, distanti anni – Jean Paul nei primi anni dell’Ottocento e Max Frisch nel con i loro protagonisti letterari che peraltro non possono assolutamente dialogare –, apre in modo inconvenzionale il saggio. Le descrizioni e i commenti al loro rispettivo viaggio – a piedi dell’avvocato dei poveri Siebenkäs da Kuhschnappel a Bayreuth e in volo dell’ingegnere dell’UNESCO Walter Faber da New York a Caracas con atterraggio forzato nel deserto di Tamaulipas in Messico – non potrebbero essere maggiormente divaricanti, anche per il linguaggio che li caratterizza: l’accento estatico e descrittivo fin quasi a raggiungere l’estasi del primo e il tono razionale e distaccato del secondo. Scrive Enzensberger: La straordinaria differenza di stile dei due testi citati, tenuto conto del tratto di tempo che li divide, è un segno estremamente caratteristico del cammino percorso da un fenomeno che ci appartiene nella stessa misura in cui noi gli apparteniamo: il turismo (Enzensberger, a, p. ). RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER Da queste affermazioni traluce una fondamentale ambiguità di formulazione che dà adito a una rilevante questione di carattere sociologico: in che misura la nostra società ha foggiato il turismo e in che misura oggi siamo sue creature, dipendiamo da esso, diventato un’istituzione sociale? Ma un’altra ambiguità consiste nella sovrapposizione dell’oggetto d’indagine, turisti e turismo. I viaggiatori sono giustamente in primo piano come attori sociali (sono sempre essi i protagonisti, in un’ottica anche antropologica che sia necessariamente diversa da quella economica dell’industry legata all’offerta e alla domanda) ma viene poi evidenziata la rilevanza del maxifenomeno turismo, con un intreccio di piani che è quasi inevitabile nell’avvicinarvisi. Ai fini della nostra analisi dovremo cercare di scinderli e di dare un ordine, sia pure arbitrario, alla sequenza del discorso di Enzensberger. Va sottolineato che l’interesse degli studi turistici ha oscillato continuamente fra la faticosa focalizzazione di un fenomeno così magmatico e quella dell’attore sociale, del turista, cui concorrono le varie discipline del turismo, e che comunque prevede un’ottica multi- o pluridisciplinare. Il turista oggi è stato “ricollocato” (Graburn, ); non è più l’ingenuo e sprovveduto gregario dei viaggi di massa, ma è giustamente visto come un individuo avvertito, ricco di esperienza e profondamente coinvolto da quello sviluppo tecnologico contemporaneo, che riguarda non solo la velocità e la tipologia dei suoi spostamenti spaziali, ma la sua stessa corporeità (Liebman Parrinello, ). Aspetti semantici Non è affatto secondario o banale che Enzensberger adotti il termine internazionale Tourismus già nel titolo. Come egli giustamente dichiara: «Dobbiamo questo neologismo all’inglese, cosa che, come vedremo, è tutt’altro che accidentale» (Enzensberger, a, p. ). La prima attestazione del termine inglese tourist risale in effetti al , quella del termine francese touriste al , e il lessema si estenderà ben presto ad altre lingue europee; sicché del è il famoso manuale di viaggio di Stendhal, Mémoires d’un touriste, che si rifà a una consapevolezza lessicale ormai diffusa. Relativamente più recente è il termine tourism, documentato per la prima volta in inglese nel , in tedesco (Tourismus) nel e in francese (tourisme) nel . Sin dalla prima metà dell’Ottocento dunque l’espressione entra a far parte delle lingue europee, riprendendo il contenuto semantico originale (viaggiare per piacere) del termine inglese. Alcune osservazioni vanno fatte tuttavia per l’ambiente tedesco, dove quando Enzensberger scriveva era ancora frequente il termine Fremdenverkehr come tipico degli studi e della prassi turistica; la duplice implicazione del concetto di mobilità e di possibili relazioni (Verkehr), e quella di straniero (Fremder), presenta quindi una connotazione preminentemente autoctona. Se da un lato è vero che Fremdenverkehr e Tourismus sono oggi diventati quasi sinonimi, e comunque la parentesi può essere considerata chiusa con la definitiva affermazione di Tourismus, l’ottica divergente derivante dalla rispettiva semantica che caratterizza i due termini ha dato luogo in passato anche a formulazioni concettuali e ideologiche divaricanti. L’accento posto sul Fremder, sul forestiero, e sui diversi tipi di relazioni con gli abitanti si ritrova ad esempio nell’ispirazione sociolo- GIULI LIEBMAN PARRINELLO gica di Simmel () e viene ripreso da von Wiese () applicandolo al turismo. Hunziker e Krapf (), i padri fondatori della teoria turistica, usano il termine Fremdenverkehr ma intendono riferirsi a un fenomeno turistico inteso in tutta l’ampiezza della sua portata. In effetti è stato rilevato che alcune differenziazioni si presentano ancora a una lettura odierna: nel caso di Fremdenverkehr si evidenzia maggiormente la prospettiva nei confronti di un estraneo cui potrebbe eventualmente venir rifiutata l’ospitalità, con la conseguenza di una fondamentale connotazione di diffidenza (Opaschowski, ); tale termine caratterizzerebbe in primo luogo l’accoglienza degli ospiti in città e comunità, e dunque il risvolto incoming. Tourismus varrebbe a cogliere invece con maggior precisione gli aspetti del turismo outgoing (Mundt, ). La scelta semantica di Enzensberger alla fine degli anni Cinquanta è comunque una scelta decisa e consapevole, che opta per la dimensione e i risvolti internazionali del fenomeno, uscendo dallo specifico ambito tedesco. Teoria del turismo Affrontare nel breve ambito di un articolo una teoria del turismo può presentarsi come un’impresa quasi insormontabile. In effetti, sembra prevalere oggi un atteggiamento di rinuncia a una spiegazione unica e generale del fenomeno, accettandone invece la pluralità disciplinare e metodologica e collegandosi casomai a qualche categoria in fondo relativamente vincolante, come “postmoderno”, “globalizzazione”, “mobilità”. Accanto alla fuga, con le sue molte caratterizzazioni negative prospettate da Enzensberger, si possono comunque individuare vari altri aspetti quali la rigenerazione, la spinta a viaggiare, il conformismo, il rituale (Hennig, ). Non da ultimo, come osserva del resto Spode (b), una teoria monocausale del turismo porterebbe al riduzionismo. Metodologicamente, la prospettiva di Enzensberger, malgrado il forte accento posto sulla dimensione della vanità della fuga, è in fondo vasta e fiduciosa, quasi a testimonianza che al processo di sviluppo impetuoso del fenomeno di quegli anni dovesse poter corrispondere un imbrigliamento, peculiare di un atteggiamento che non vuol rinunciare alla spiegazione teorica sia pure ampia e indefinita. Va ricordato in proposito che, pur non essendo uno specialista, il saggista tedesco scrive contemporaneamente al sociologo del turismo Knebel, autore di Soziologische Strukturwandlungen im modernen Tourismus (Knebel, ), con un’affinità che sorprende, sottolineata dal riconoscimento di Knebel tanto dell’impostazione storico-sociologica di Enzensberger che della sua analisi del presente (ivi, p. ). Se si pone poi il problema di una teoria del turismo nel senso di un paradigma metodologico unitario per l’intero fenomeno turistico, qui la discussione è ancora aperta, in quanto non è stato fino a ora accertato un paradigma genericamente percorribile. Lo svizzero Krippendorf, ad esempio, pur erede della tradizione dei padri fondatori (Hunziker, Krapf, ) e di un retroterra come quello germanico mirante in linea di massima a una formulazione teorica definitiva, è contrario a una vera e propria disciplina turistica o “turismologia”, in quanto il turismo si reggerebbe benissimo con i metodi delle sue varie discipline, quali sociologia, etnologia, storia, economia, ecologia, geografia ecc. (Krippendorf, ). RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER Il dibattito sul “dilemma disciplinare” presenta in fondo pochi sostenitori di una “turismologia” quale scienza distinta del turismo, ma c’è chi ugualmente insiste sull’esigenza di una “teoria del turismo”, anche rifacendosi alla richiesta presente da decenni in ambito tedesco e all’irrinunciabilità della stessa (Spode, ). Spostato sul terreno più pedagogico nel senso se di ambito disciplinare oppure di disciplina unitaria si tratti, la controversia si è accesa a chiare lettere in un recente dibattito in ambito anglosassone (Leiper, ; Tribe, ), dove Leiper insiste a considerare gli studi turistici una vera e propria disciplina emergente in quanto giustificata soprattutto dal punto di vista didattico, mentre Tribe – come la maggior parte degli studiosi – sostiene che essi si basano su una varietà di studi disciplinari. Nell’ultimo decennio, gli studi turistici hanno dovuto confrontarsi con il mobility turn delle scienze sociali, venendo a perdere secondo alcuni la loro emergenza e la loro specificità di impostazione (Lash, Urry, ; Hannam, Sheller, Urry, ). Va rilevato in merito che, all’interno di un interesse focalizzato preminentemente sul turismo, il Trend Mobilität era stato già evidenziato da Knebel () con l’analisi dei mutamenti strutturali del turismo contemporaneo, mentre Enzensberger evoca suggestivamente quello che abitualmente è chiamato “l’esercito delle vacanze”: «Si fanno sentire certe analogie militari. Il turismo è la parodia della mobilitazione generale. I suoi quartieri generali sono simili a stati maggiori dove si calcolano in precedenza i movimenti di truppa» (Enzensberger, a, pp. -). Non si può prescindere a nostro avviso né dall’aspetto strutturale del turismo né dalla specificità dello stesso, anche se il problema si presenta ancora oggi aperto. L’atteggiamento di Enzensberger, ovviamente a monte delle formulazioni contemporanee, non va giudicato superato per il fatto che non vuole rinunciare all’esigenza teorica tedesca di un assetto globale e generalizzato del fenomeno. Vi si può invece individuare una posizione quasi euristica nel senso di una duplice ottica dell’aspirazione a una formulazione teorica non disgiunta dalla componente magmatica degli aspetti strutturali e dall’intreccio interdisciplinare, per cui l’ipotesi teorica dello scrittore tedesco potrebbe essere interpretata alla luce di recenti discussioni come una sorta di irrinunciabile “noumeno” (Liebman Parrinello, ). Turismo vs viaggio Elemento comune è senz’altro il processo circolare. Magris scrive a proposito del viaggio: «Quest’ultimo è circolare; si parte da casa, si attraversa il mondo e si ritorna a casa, anche se a una casa molto diversa da quella lasciata, perché ha acquistato significato grazie alla partenza, alla scissione originaria» (Magris, , p. XI). L’esperienza turistica vera e propria, circolare pur essa, ma considerata banale o addirittura volgare, non ha avuto certamente i suoi cantori ed esegeti letterari. La presa di posizione di Enzensberger, dopo aver riportato il turismo agli ultimi anni, è la seguente: «Il “viaggio” è una delle più antiche e comprensive figure della vita umana, possiamo seguirne le tracce sino nei primordi mitici (Enzensberger, a, p. ). Prosegue tuttavia chiedendosi: «Gli uomini hanno sempre viaggiato. Con quale diritto si può allora isolare nella storia, come se fosse qualcosa di particolare, ciò che noi indichiamo con il nome di turismo?» (ibid.). GIULI LIEBMAN PARRINELLO Constatazioni dirimenti sono quelle che seguono: «Il viaggio come avventura, come fine in sé, rimase ignoto fino al secolo XVIII inoltrato» (ivi, p. ), seguite dall’affermazione che già nel corso del XVIII secolo «il nodo che legava il viaggio a uno scopo determinato cominciò ad allentarsi» (ivi, p. ). Anche se la causa ultima viene lasciata aperta, lasciando intuire un divario epocale, una diversità anche antropologica, la «marcia trionfale» del turismo è resa possibile da una «situazione storica ben determinata» (ivi, p. ), che apre la prospettiva del viaggio quale conquista di libertà per tutti, in chiave di turismo. La vittoria della rivoluzione borghese aveva inculcato nel singolo una coscienza di libertà, destinata a intaccare la stessa società uscita dalla rivoluzione. Le brecce aperte nell’ordinamento sociale da una rivoluzione sono presto richiuse, ma il ricordo che le segue non scenderà mai più a compromesso con il potere restaurato: è una cicatrice permanente incisa nella coscienza (ivi, p. ). Proprio su queste basi lo studioso tedesco Spode riesce a inquadrare il turismo rispetto al viaggio, sostenendo che il turismo sarebbe caratterizzato da sicurezza, libera volontà e assenza di finalità specifiche quali acquisto di ricchezza, salvezza dell’anima, sapere, salute, escludendo quindi commercianti, pellegrini, navigatori, imprenditori, avventurieri e altre categorie sociali con le loro motivazioni primarie (Spode, ). In effetti, sembra che in questo campo proprio non si voglia ancora fare chiarezza: un contributo generico ispirato alla frequenza degli spostamenti lo dà ad esempio uno scrittore pur avvertito come Leed, che scrive: «Il viaggio è diventato comune, il turista è la norma, il mondo è un manifesto affisso al muro che si può consumare al prezzo di un biglietto» (Leed, , p. ) Ci si chiede quindi se non si debba ritornare anche a una dialettica interna e connaturata al fenomeno turistico stesso. Enzensberger cita subito all’inizio del saggio la componente elitaria, legata a un tipo specifico di viaggio e contraria alla pretesa volgarità del turismo. Sappiamo che già Byron tendeva a distanziarsi dalla massa dei turisti inglesi suoi contemporanei. Oggi è emerso il fenomeno dei cosiddetti “antituristi” che sembra focalizzare questa continua polarizzazione: come osserva Löfgren sono sempre esistiti i turisti d’élite, con la possibilità di pagare per privacy ed esclusività, ma gli antituristi si trovano in una posizione più difficile, perché – pur generalmente con mezzi più ridotti – desiderano sperimentare aspetti e luoghi incontaminati, non ancora sfruttati, fuori dai sentieri battuti, onde la loro irritazione nei confronti degli altri turisti (Löfgren, , p. ). Authenticity è stata la parola d’ordine negli studi turistici degli ultimi decenni, per la sua suggestione una delle teorie più diffuse, spesso acriticamente recepita. La ricerca dell’authenticity (MacCannell, , ) quale peculiarità del turista contemporaneo sembrerebbe in certo qual modo nobilitarlo, ma è difficile sostenere fino in fondo una generalizzazione del genere. Va accettata invece, eventualmente in chiave fenomenologica come propone Cohen, la sua ricerca di una pluralità di esperienze, da quella più banale a quella più simile al viaggio esistenziale (Cohen, , ). Comunque, al di là della formulazione più specificamente turistica, e al di là del testo analizzato di Enzensberger, la dialettica viaggio-turismo e turismo-antiturismo va probabilmente ricondotta anche a una generalizzazione più ampia, nel senso di RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER un’industria della coscienza che, nell’affermazione di Enzensberger (b, p. ), «genera sempre di nuovo la propria contraddizione». La prospettiva storica: il terminus a quo e la metodologia Questo è uno dei punti più controversi del saggio di Enzensberger. C’è a rigore una sfasatura di piani e di momenti, anche per quanto riguarda il terminus a quo. Quello che emerge di primo acchito è l’esigenza di una ricostruzione storica intesa come un processo riguardante la gente comune In un secolo e mezzo di esistenza, il turismo non ha saputo ancora attrarre su di sé l’attenzione degli storici. Una storia del turismo resta da scrivere. Ci si è ormai liberati dall’idea che la storia si svolga soltanto alle corti dei re, sul campo di battaglia […]. Abbiamo in effetti una storia dei “popoli” e non una storia della “gente”. E poiché il turismo è un fatto della “gente,” non sono stati finora elaborati gli strumenti per una sua adeguata comprensione storica (Enzensberger, a, pp. -). Anche se manca ogni e qualsiasi riferimento alla Scuola delle “Annales”, a Enzensberger sta evidentemente a cuore soprattutto una prospettiva storica diversa da quella évenementielle e in effetti – come ricorda Spode – il concetto di storia del turismo andrebbe inteso in senso ampio, differenziandolo dalla storia del viaggio, sino ad allargarlo alla storia delle mentalità o alla storia sociale, mirando soprattutto alla specificità del turismo contemporaneo nelle società del tempo libero (Spode, a). L’altro aspetto è quello della collocazione storica del turismo, che è storicogenetica. Secondo Keitz () quello di Enzensberger può essere considerato l’unico tentativo di costruire una teoria del turismo sulla base di una storia del turismo, anche se vanno tenuti ovviamente in conto storici del turismo come Boyer, che ne sottolineano il carattere storico di “invenzione” (Boyer, ). Scrive Enzensberger (a, p. ): «Descriveremo la situazione storica da cui è sorto il turismo come complesso sintomatico di elementi spirituali, tecnici, economici, sociali e politici, accomunati dallo stesso carattere rivoluzionario». Il testo tedesco originale parla più sinteticamente ed efficacemente di «Syndrom» (Enzensberger, , p. ). Non si sa se Bauman abbia in mente Enzensberger quando usa lo stesso termine (Franklin, ). Quella che Bauman chiama tourist syndrome si lega al turismo (e al turista) come metafora della vita contemporanea, a una condizione di temporaneità e di non appartenenza. La mancanza o l’allentamento di legami, che si riconduce a una modernità liquida, il cosiddetto grazing behaviour ossia il mondo come collezione di grazing grounds, e non da ultimo la fragilità delle relazioni che i turisti stabiliscono ovunque essi si rechino (ivi, pp. -) riportano ai parametri di una condizione postmoderna, che diluiscono i tratti sociologici “forti” del postindustriale. Va ancora detto che dalla lettura del passo suddetto di Enzensberger sembra emergere chiaramente anche l’interdisciplinarietà del fenomeno e l’esigenza di un approccio adeguato. Questo approccio ci sembra dunque di ritrovarlo, e di ritrovare la “sindrome” nella definizione di della sociologa francese Lanfant, nella sua interpretazione del turismo (che prende lo spunto dall’Essai sur le don di Mauss) come di un “fenomeno GIULI LIEBMAN PARRINELLO sociale totale” (Lanfant, , p. ), ossia con una compresenza delle diverse dimensioni della realtà umana, di cui una emerge di volta in volta con maggiore incisività. Tecnologie e rivoluzione industriale Come si conciliano, come si allineano la rivoluzione anche tecnologica borghese e la Sehnsucht romantica? I mezzi di comunicazione, «con il cui aiuto la realtà da cui si fuggiva era stata realizzata» (Enzensberger, a, p. ), rendono più facile la fuga. Risvolti nuovi emergono dal progresso tecnologico anche sotto il profilo dell’omogeneizzazione dello spazio: La situazione nuova che si era venuta a creare non imponeva tanto l’immediata omogeneizzazione della società, quanto quella dello spazio. Il progresso della tecnica, in particolare l’inroduzione della ferrovia e della nave a vapore, permise al capitalismo la costituzione di una rete di comunicazioni rispondente a questo scopo (ivi, p. ). Enzensberger quasi ipostatizza la rivoluzione tecnologica, addirittura interpretando lo sviluppo della ferrovia in una società all’avanguardia come l’Inghilterra in chiave di mania, come «[…] un sintomo del desiderio violento di andarsene dai luoghi di lavoro e dalle abitazioni della rivoluzione industriale. Questa rete ferroviaria sembrava rendere possibile l’“apertura” della società stessa» (ibid.). Non è casuale questa concentrazione sulla ferrovia, che effettivamente rende possibile e agevola un turismo di massa e organizzato, a partire dal primo esperimento di Thomas Cook, con effetti allora dirompenti – che sembrano superare quelli dell’attuale viaggio aereo – come ha rilevato Schivelbusch, che alla sua storia del viaggio in ferrovia dà il sottotitolo illuminante di Industrializzazione di spazio e tempo nel ° secolo, mettendone in evidenza anche gli aspetti psicosociologici (Schivelbusch, ). Ma interviene di pari passo un livellamento sociale, che corrisponde all’emancipazione che va dagli scrittori romantici, alla borghesia, al turismo di massa, in una visione strutturale che considera lo sviluppo delle forze produttive, a cominciare dall’Inghilterra (Enzensberger, a, p. ). Il processo di democratizzazione favorito dai nuovi mezzi di comunicazione viene dunque intuito sin dal ed esplicitamente dichiarato: La sua azione favorisce e stimola il processo di fusione e di omogeneizzazione della società. Vi è sempre stata, e vi è ancora, interazione fra la tendenza egalitaria, che ha permesso alla borghesia la sua vittoria e che poi è stata causa del suo tramonto, e la possibilità offerta dai nuovi mezzi di comunicazione di uno scambio continuo e omnilaterale (ibid.). Mercificazione e sacri testi La mercificazione è una delle principali obiezioni che si muovono in chiave critica al turismo contemporaneo, specie se si parte da un’ottica antropologica, che vede un’utopica configurazione iniziale in un armonioso scambio di ospitalità fra host e guest, turista e abitante. Enzensberger, proprio per la sua impostazione storico-genetica, va invece al cuore del fenomeno e ne sottolinea la matrice, che non può portare RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER che a un processo di mercificazione sin dall’inizio. L’aspetto strutturale dell’industry viene debitamente enucleato: Si può sintetizzare il progresso del turismo, che è contemporaneamente progressivo aumento del suo potere, in tre conquiste fondamentali, ognuna delle quali è indispensabile per lo sviluppo di una grande industria: la standardizzazione, il montaggio, la produzione in serie (ivi, p. ). Certamente, sia detto a margine, l’assunto di una corrispondenza esatta e a tutto campo di sviluppo industriale e di sviluppo turistico si può criticare, anche sulla base di certi segmenti come l’alpinismo – cui in effetti Enzensberger dedica un notevole spazio – originariamente un caso di turismo di club non orientato al profitto e non commercializzato (Kramer, ; Asmodi, , p. ). Dopo aver abbinato le conquiste parziali del turismo alle faticose conquiste delle ferie retribuite, ancorandole quindi strutturalmente ed evitando anche le secche del semplice concetto di “tempo libero”, e aver concretamente ricordato il progressivo affollamento delle località di vacanza, trasformate in una sorta di slums, Enzensberger arriva alla nota formulazione dialettica del movimento turistico: La vittoria del turismo si era ormai rivelata per quello che era: una vittoria di Pirro. Il desiderio nostalgico di liberarsi della società andandosene lontano era stato ridisciplinato secondo le regole di quella società da cui si fuggiva. La liberazione dal mondo dell’industria si è stabilita essa stessa come industria; il viaggio dal mondo delle merci è diventato una merce (Enzensberger, a, pp. -). Ma non è un caso che accanto a questi aspetti più materiali si affaccino i fondamenti dell’industria della coscienza. La standardizzazione, si afferma, ha inizio con la trovata della guida, attraverso un condizionamento psicologico. Condizionamento che diventerà poi addirittura fisiologico e stabilirà l’imperativo per cui la bellezza turistica deve essere vista «È degno di essere visto ciò che deve essere visto» (ibid.). Già prima della collezione Beadeker è il Red book di Murray del , con il suo sightseeing, con la sua classificazione in asterischi. Ma è poi ben presto il montaggio ad opera di Thomas Cook che combinava i sightseeings in un unico itinerario, vendendo la confezione di un prodotto che trasformava l’avventura in un «preparato» sicuro da ogni rischio (ivi, pp. -). A completare il processo si aggiungeva dunque la formula del viaggio organizzato di gruppo (in Inghilterra nel ) seguito nel già dal primo viaggio collettivo attorno al mondo. La prospettiva di Enzensberger è mondiale, è quella di un turismo intercontinentale completamente dispiegato, in cui è implicita già la consapevolezza dell’esigenza di creare nuove attrazioni per soddisfare la domanda, intuendo anticipatamente la funzione del marketing turistico: «[…] il nostro secolo produce bellezze sintetiche a seconda del fabbisogno. Dal festival sino alla tenda lappone, si offre al turista tutto ciò che lo attrae» (ivi, p. ). Anche il discorso sulla marca e sul feticcio è anticipatorio: Il nome della meta del viaggio è appunto come la marca di un profumo: accresce il valore del prodotto, se non è essa sola a generarlo. La marca, ultima cristallizzazione dell’aura romantica del viaggiatore, garantisce il carattere di feticcio del giro turistico, carattere che si manifesta e realizza appunto in un feticcio: il souvenir (ivi, p. ). GIULI LIEBMAN PARRINELLO Il prestigio sociale e il consumo vistoso si traducono inoltre in esperienza ostentatoria all’interno di una concezione globale e circolare del viaggio: «Ultimo punto del programma di viaggio è il ritorno a casa» (ivi, p. ); tale discorso presenta una notevole affinità con Knebel () ma si distanzia dal realismo sociologico di quest’ultimo, arrivando a posizioni più attuali e disincantate: «L’industria turistica ha questo di particolare: la sua produzione si identifica con la sua reclam, i suoi consumatori sono anche i suoi impiegati […]. Il turista autentica il manifesto pubblicitario che lo ha convinto a partire» (Enzensberger, a, p. ). La dialettica dell’autenticità e la perdita del reale sono al cuore del postmoderno ed Enzensberger sembra dunque anche anticipare quello che Baudrillard ed Eco, nelle rispettive formulazioni sul viaggio, hanno chiamato “iperrealtà” (Gemünden, , p. ). Un immaginario superato Già cercando sin dalle prime pagine di stabilire un confine fra viaggio e turismo Enzensberger (a, p. ) riprende la nostalgia della lontananza come categoria romantica. Dalla rivoluzione borghese e dalla coscienza di libertà del singolo si passa alle radici spirituali del turismo moderno, che: […] affondano nel romanticismo inglese, francese e tedesco. Autori come Gray a Wordsworth, Coleridge e Byron, Rousseau e Chateaubriand, Seume ed Eichendorff, Tieck e Wackenroder, Chamisso e Pückler hanno colto e fissato l’immagine di una libertà che minacciava di soffocare tra la realtà nascente del lavoro capitalisticamente organizzato e la restaurazione politica. La loro forza immaginativa ha tradito la rivoluzione e, a un tempo, l’ha serbata per il futuro. Ha trasfigurato la libertà, proiettandola nelle lontananze incantate dell’immaginazione, sino a farla coagulare in una figurazione spaziale o temporale: la natura vergine, la storia passata, il monumento, il folklore. L’incontaminatezza del paesaggio e della storia sono rimasti sino a oggi gli ideali del turismo. Esso stesso non è altro che un tentativo di realizzare il sogno che il romanticismo aveva proiettato lontano. Quanto più la società borghese si chiudeva in se stessa, tanto più il borghese rinnovava i suoi sforzi per sfuggirle in qualità di turista (ivi, p. ). Sono dunque i poeti che hanno colto e fissato quell’immagine di libertà che minaccia di soffocare, e che si trasforma in figurazione spaziale e temporale: natura vergine, storia passata, monumento, folklore. L’alpinismo assume nello sviluppo del turismo una funzione particolare, che si unisce al suo ruolo emblematico, in quanto tende all’“elementare”, all’“inviolato”: In qualunque modo vogliamo chiamare il fine del turismo, la dialettica del processo rimane identica: raggiungere questo fine significa annientarlo. […] L’avventura, l’elementare, l’inviolato sono i valori bollati di cui i turisti possono menare un vanto imponente. La meta deve essere, a un tempo, accessibile e inaccessibile, lontana dalla civiltà e munita di tutti i comfort (ivi, pp. -). L’authenticity potrebbe allora essere interpretata in chiave di retaggio romantico. Un collegamento con MacCannell è effettuato da Gemünden () sotto il profilo semiologico. Mentre i turisti di Enzensberger fuggono da una dura realtà socia- RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER le, quelli studiati da MacCannell sperimentano il quotidiano come banale e spurio, e si mettono in movimento sperando di trovare altrove l’autentico, ma le due teorie convergono nella dialettica del turismo. Se Enzensberger sostiene che la ricerca dell’inviolato conduce alla sua distruzione, secondo MacCannell la ricerca da parte del turista del vero mondo conduce alla fabbricazione dell’autenticità (ivi, p. ). Per Enzensberger il turista certamente si illude, ma egli va alla ricerca «oltre che della storia ridotta a museo e della natura a orto botanico, anche di quell’incanto sociale che la high life rappresenta per lui» (Enzensberger, a, p. ), ossia del prestigio sociale. A nostro avviso, peraltro, malgrado la consapevolezza dell’assenza di vera authenticity, neppure da ritrovare su un eventuale backstage, il problema si inserisce in una più ampia tematica e non assume carattere preminente. La metafora della “Brandung” Il filo rosso del saggio è rappresentato dalle diverse variazioni della dialettica della fuga, oltre alla già citata “vittoria di Pirro”. Enzensberger, a testimonianza della sua formazione poliedrica e non insensibile anche al mondo dell’infanzia, non esita a far ricorso alla favola della lepre e del porcospino: «Come la lepre della favola è attesa beffardamente al traguardo dal porcospino, il turismo è atteso al varco dalla propria contraddizione» (ivi, p. ). Dopo ogni sconfitta, il turismo raddoppia le sue energie. Nelle pagine conclusive, l’autore riprende questa tematica attraverso la vergebliche Brandung der Ferne, ossia quella metafora che aveva fornito il titolo originario nel : […] il turismo è una forza violenta che, in tutto il mondo, getta ogni anno le masse sulla riva della loro breve felicità delle vacanze: è la forza di una ribellione cieca e inarticolata che ogni volta naufraga nel risucchio della propria dialettica. […] La fiumana turistica è una sola grande corrente di fuga dalla realtà che la società sfrutta per riorganizzarci. Ma il fuggire, per quanto folle, per quanto impotente, è già una critica della situazione in cui, con la fuga, ci si sottrae (ivi, p. ). Ciò si riconduce platealmente anche alle istanze dell’industria della coscienza, ove Enzensberger critica le illusioni della sovranità soggettiva, come se il singolo potesse rimanere padrone a casa propria. Vi è, come sottolinea Lau (, p. ), il continuo dramma della sovranità minacciata e riconquistata. Veniamo riportati ai paradossi della cultura occidentale, e specialmente il diritto alla libertà di movimento ci conduce agli universalismi contraddittori delle società globalizzate e ai paradossi della globalizzazione (Marramao, ). La libertà come paradosso viene esemplificata in chiave di biglietto per la libertà – «da una stazione non si partirà mai per la libertà» (Enzensberger, a, p. ) – secondo un preteso aforisma di Otto Weininger probabilmente introdotto a titolo di «curiosità esornativa» (Sampaolo, , p. ), forse anche in quanto il nome evocava un autore problematico e sintomo di crisi della modernità. Il turismo mostra che ci siamo abituati a considerare la libertà come un inganno collettivo cui ci affidiamo, pur intuendolo in segreto. Facendoci forti del biglietto di viaggio che portiamo in tasca, confessiamo implicitamente che non la libertà è la nostra meta: che abbiamo ormai dimenticato che cosa sia la libertà (Enzensberger, a, p. ). GIULI LIEBMAN PARRINELLO Enzensberger individua tuttavia anche molto bene una sorta di ufficializzazione di questa nuova libertà del turista, che viene rivendicata come nuovo diritto dell’uomo: «Il nuovo diritto riconosciuto all’uomo di liberarsi della propria civiltà assume i tratti innocenti del viaggio in periodo di ferie» (ivi, p. ). All’inizio del nuovo millennio viene ormai data per scontata l’accettazione dell’estensione dei diritti e delle libertà anche alla libertà di movimento: si impone allora una riflessione su quella progressiva estensione dei diritti, che nel caso del turismo trapassano drammaticamente dal diritto astratto al diritto concreto alla natura e alla cultura degli altri. Evoluzione antropologica e condizione umana Momenti antinomici sembrano coesistere nella rappresentazione di Enzensberger: da un lato un approccio multidisciplinare e storicamente fondato, dall’altro l’evocazione di una situazione generale diffusa, universale, che prescinde apparentemente da qualsiasi condizionamento storico, e che in ultima analisi si potrebbe ricondurre addirittura alla stessa condizione umana. Sotto un profilo metodologico ci soccorre molto bene Spode, che in un suo contributo sull’antropologia del turismo sottolinea l’aspetto culturale del turista e il carattere fuorviante di un’essenza ipostatizzata dell’uomo caratterizzato da istinto migratorio (Wandertrieb), da un generico impulso di libertà ecc., mentre suggerisce che una sorta di psicologia storica unita a una storia delle mentalità può aiutare nell’indagine (Spode, b). Una prospettiva antropologica certamente, ma su un’imprescindibile base storica, che sottragga il turista dalla sua immobilità di ruolo e lo immerga in una dimensione evoluzionistica. Ritornando al quadro iniziale e al confronto fra i due viaggiatori, il salto epocale fra il primo e secondo viaggiatore nel quale si collocava il fenomeno turismo faceva a rigore presagire, derivanti dalle tecnologie, anche epocali cambiamenti della percezione, che evocano appunto una concezione dinamica del turista quale soggetto in continua evoluzione. Se poi facciamo ipoteticamente intervenire un terzo viaggiatore che logicamente dovrebbe susseguirsi ai due, esso è legittimato anche dalle intuizioni dello stesso Enzensberger (a, p. ): «L’uomo non è ancora penetrato nello spazio che già si annunciano i primi turisti interessati all’astronautica». Tale viaggiatore dovrebbe a rigore essere donna con le fondamentali caratteristiche di gender, un diverso tipo di percezione, un’esperienza forse più emotiva ma supportata dalle tecnologie più avanzate, differente rispetto a quella del primo ma anche del secondo viaggiatore, confermandoci che la prospettiva razionale del Faber di Max Frisch non è quella definitiva. Eppure, questi aspetti così concretamente fondati e che forniscono anche la prosecuzione del suo discorso, sembrano venir contraddetti proprio da diverse affermazioni, man mano che l’autore sia avvia verso le conclusioni del saggio, che indicano un’aspirazione genericamente umana: La richiesta di cui vive il turismo è quella di una libertà felice. Questa richiesta si esprime in tutta la sua forza anche nella distratta confusione di Capri e di Ibiza. Finché non sapremo contrapporre immagini nostre di libertà a quelle che il romanticismo ha creato, queste vivranno oltre tutte le falsificazioni (Enzensberger, a, p. , corsivo mio). RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER Si può ricordare in termini più generali la critica di Kramer () e Asmodi () nel senso della relativizzazione della teoria di fuga dalla realtà e del carattere vano della fuga: talora il turismo si risolve in una vera e propria realizzazione. Inoltre, se è presente un retaggio dell’ideale di libertà romantico, viene trascurato il collegamento fra la fuga in sé e le sue motivazioni, creando una fondamentale incongruenza. Ma vi è soprattutto nella libertà felice un intrecciarsi di discorsi che occorrerebbe cercare se non di analizzare, per lo meno di dipanare: più a monte, dove nasce il mancato adeguamento dell’immaginario, il che significa una resa dei conti con l’intero pensiero occidentale. La collocazione storica si rivela allora fondamentale anche qui, perché pure il momento apparentemente eternizzante della ricerca della felicità come condizione umana trova la sua matrice nel Settecento, realizzandosi in uno dei diritti fondamentali settecenteschi (è ancora oggi presente nella costituzione degli USA), e si traduce attualmente nella pretesa di trasferire quel diritto alla felicità attraverso il turismo anche nella dimensione corporea e sensibile degli attori sociali. Conclusioni Se «il viaggio è antico quanto l’uomo» e se a esso si adatta l’abusata metafora della vita umana, a conclusione di questa rilettura il turismo sembrerebbe presentarsi come qualcosa di diverso. Si prospetta casomai una metafora più concreta, più storicamente fondata e intrisa di materialità di una specifica condizione umana, che non si comprende se non in un’evoluzione di lunga durata, ma non certamente eterna, e che non può genericamente essere ascritta alla “modernità” o alla “postmodernità”. Sembra trattarsi di un episodio della recente storia dell’umanità, ma da indagare sulla base di strutture di lungo periodo. Come proposto metodologicamente da Spode i parametri del viaggio turistico, della sua configurazione, vanno rapportati ad altri parametri strutturali, quali la percezione dell’Altro, di spazio e tempo, natura, libertà, lavoro ecc. (Spode, b). Da uno studioso di grande esperienza come Cohen viene oggi l’invito a considerare una sorta di erosione l’affievolirsi del fenomeno, nel senso da un lato della dedifferenziazione fra tempo libero e turismo, ma dall’altro dell’accentuarsi del turismo come un fatto esploratorio, anche in senso estremo (Cohen, ). Ma uno spunto molto rilevante ci viene soprattutto da una comunicazione personale di Enzensberger. Questa sembra indicare una direzione che va nel senso dell’esaurimento del fenomeno, del suo caratttere episodico per lo meno per quanto riguarda gli aspetti più eclatanti, quelli del diffuso turismo intercontinentale: Credo tuttavia che non ci vorrà molto perché per lo meno il turismo intercontinentale sia solo una reminiscenza; il fatto che milioni di persone volino in vacanza a Mombasa o a Bali dovrà aver presto fine per ragioni ecologiche ed economiche. Si tratta di un episodio dell’era petrolifera. Qui sembrano giocare un ruolo sostanziale l’aspetto economico e quello ecologico, ove anche la possibile crisi delle materie prime lascia intravvedere una nuova congiuntura negativa. GIULI LIEBMAN PARRINELLO Ci troviamo in un momento in cui le statistiche dell’Organizzazione Mondiale del Turismo si gonfiano oltre gli milioni nel per i soli turisti internazionali e si prevede presto il superamento del miliardo. L’esplorazione delle destinazioni tradizionali si sta probabilmente esaurendo, mentre vengono create continuamente nuove mete, in una commistione fra reale e immaginario sempre più complessa. L’immaginario umano sta diventando a sua volta sempre più ricco, con sempre nuove prospettive, sempre più articolate, anche alla luce delle più recenti tecnologie che il turista, rispetto a cinquant’anni fa, non solo usa ma addirittura incorpora. Non è forse arrischiato affermare che se il turista si è affacciato in questa veste di dominatore sul nascere del millennio, è difficile prevederne l’evoluzione in un arco temporale non solo del prossimo millennio, ma addirittura del prossimo secolo o forse addirittura dei prossimi decenni. Note . E-mail di Enzensberger del .. a me indirizzata (traduzione mia). . Ringrazio Hasso Spode e Giovanni Sampaolo per i loro commenti e suggerimenti. La responsabilità di eventuali errori e omissioni è ovviamente soltanto mia. Bibliografia (), Eine Theorie des Tourismus: die Enzensberger Studie, in H. Hahn, H. J. Kagelmann (hrsg.), Tourismuspsychologie und Tourismussoziologie. Ein Handbuch zur Tourismuswissenschaft, Quintessenz, München. BENN G. (), Drei alte Männer. Szenen, in Gesammelte Werke, herhausgegeben von D. Wellershof, Wiesbaden (a ed. ). BOYER. M. (), L’invention du tourisme, Gallimard, Paris. COHEN E. (), A Phenomenology of Tourist Experiences, in “Sociology”, , pp. -. ID. (), Contemporary Tourism. Diversity and Change, Elsevier, Amsterdam. ENZENSBERGER H. M. (), Eine Theorie des Tourismus, in Id., Einzelheiten, Suhrkamp, Frankfurt am Main. ID. (a), Una teoria del turismo, in Id., Questioni di dettaglio, traduzione di G. Piana, Feltrinelli, Milano. ID. (b), L’industria della coscienza, in Id., Questioni di dettaglio, traduzione di G. Piana, Feltrinelli, Milano. ID. (), La grande migrazione, traduzione di P. Sorge, Einaudi, Torino. ID. (), A Theory of Tourism, in “New German Critique”, , pp. -. ID. (), Zig Zag. Saggi sul tempo, il potere e lo stile, traduzione di D. Zuffellato, Einaudi, Torino. FRANKLIN A. (), The Tourist Syndrome. An Interview with Zygmunt Bauman, in “Tourist Studies” , , pp. -. GEMÜNDEN G. (), Introduction to Enzensberger’s “A Theory of Tourism”, in “New German Critique”, , pp. -. GRABURN N. (), Relocating the Tourist, in “International Sociology”, , , pp. -. HANNAM K., SHELLER M., URRY J. (), Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings, in “Mobilities”, , pp. -. HENNIG C. (), Jenseits des Alltags, in “Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismusforschung”, , pp. -. HUNZIKER W., KRAPF K . (), Grundrisse der allgemeinen Fremdenverkehrslehre , Polygraphischer Verlag, Zürich. ASMODI K. RILEGGENDO UNA TEORIA DEL TURISMO DI HANS MAGNUS ENZENSBERGER (), Reisen als Leitbild. Die Entstehung des modernen Massentourismus in Deutschland, Deutscher Taschenbuch Verlag, München. KNEBEL H. J. (), Soziologische Strukturwandlungen im modernen Tourismus, Enke Verlag, Stuttgart. KRAMER D. (), Aspekte der Kulturgeschichte des Tourismus, in “Zeitschrift für Völkerkunde”, pp. -. KRIPPENDORF J. (), «…erst wenn der Leidensdruck noch weiter steigt» (intervista con H. Spode), in “Voyage. Jahrbuch für Reise- & Tourismusforschung”, , pp. -. LANFANT M.-F. (), International Tourism, Internationalization and the Challenge to Identity, in Id. et al. (eds.), International Tourism. Identity and Change, Sage, London. LASH S., URRY J. (), Economies of Signs and Space, Sage, London. LAU J. (), Hans Magnus Enzensberger. Ein öffentliches Leben, Suhrkamp, Frankfurt am Main. LEED E. (), La mente del viaggiatore, dall’Odissea al turismo globale, trad. it., il Mulino, Bologna. LEIPER N. (), An Emerging Discipline, in “Annals of Tourism Research”, , pp. -. LIEBMAN PARRINELLO G. (), The Technological Body in Tourism Research and Praxis, in “International Sociology”, , , pp. -. EAD. (), Enzensberger’s Tourism Theory Revisited. A Paradigmatic Approach sui generis , paper presentato all’ISA World Congress, RC, Durban. LÖFGREN O. (), On Holiday. A History of Vacationing, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London. MACCANNELL D. (), Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings, in “American Journal of Sociology”, , pp. -. ID. (), The Tourist. A New Theory of the Leisure Class, Schocken Books, New York. MAGRIS C. (), L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano. MARRAMAO G. (), Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione, Bollati Boringhieri, Torino. MUNDT J. W. (), Einführung in den Tourismus, Oldenbourg, München. OPASCHOWSKI H. W. (), Tourismus. Eine systematische Einführung , Lesker + Budrich, Opladen. PAGENSTECHER C. (), Immer noch brandet die Ferne. Tourismustheorie nach Enzensberger, in “izw. Blätter des Informationszentrums . Welt, Sonderheft: Fernweh – wenn einer eine Reise tun…”, , November, pp. -. SAMPAOLO G. (a cura di) (), Otto Weininger e la differenza, Guerini, Milano. SCHIVELBUSCH W. (), Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im . Jahrhundert, Hanser, München-Wien-Frankfurt am Main. SIMMEL G. (), Exkurs über den Fremden, in Id., Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Gesamtausgabe vol. XI, herausgegeben von O. Rammstedt, Suhrkamp, Frankfurt am Main (a ed. ). SPODE H. (a), Historische Tourismusforschung, in H. Hahn, H. J. Kagelmann (hrsg.), Tourismuspsychologie und Tourismussoziologie. Ein Handbuch zur Tourismuswissenschaft, Quintessenz, München. ID . (b), Tourismusanthropologie , in H. Hahn, H. J. Kagelmann (hrsg.), Tourismuspsychologie und Tourismussoziologie. Ein Handbuch zur Tourismuswissenschaft, Quintessenz, München. ID. (), “Reif für die Insel”. Prolegomena zu einer historischen Anthropologie des Tourismus , in C. Cantaw (hrsg.), Arbeit, Freizeit, Reisen. Die feinen Unterschiede im Alltag, MünchenNew York. ID. (), “Grau, teurer Freund…”. Was ist und wozu dient Theorie, in H.-P. Burmeister (hrsg.), Auf dem Weg zu einer Theorie des Tourismus, Loccumer Protokolle, Loccum. TRIBE J. (), Indisciplined and Unsubstantiated, in “Annals of Tourism Research”, , pp. -. WIESE L. VON (), Fremdenverkehr als zwischenmenschliche Beziehungen, in “Archiv für den Fremdenverkehr”, , pp. -. KEITZ C . BAD: «UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA» di Agnese Nobiloni Toschi «Ein für die germanische Kultur wichtiges Wort» scrive Friedrich Kluge a proposito di Bad, nel suo noto dizionario etimologico (Kluge, , p. ). E a questa affermazione fa seguire interessanti informazioni. Bad è una parola del germanico comune: antico alto tedesco bad; medio alto tedesco, medio nederlandese e nederlandese moderno bat; antico sassone bath; antico frisone beth; anglosassone bœд́; tutti termini che indicano l’odierno Bad; l’antico nordico baд́ denota invece il Dampfbad cioè il “bagno di vapore”. Anche il verbo derivato dal nome appartiene al germanico comune: l’antico alto tedesco bado-n, il nederlandese medio e moderno baden hanno la stessa radice del verbo bähen che significa “riscaldare”. Pertanto anche la parola baden trae origine dall’azione del “riscaldare”. Il latino classico era balneum (dal greco balanêion), il latino volgare *bannium è poi passato allo slavo banja (Murko, ). Grazie alla particolarità del tedesco in fatto di parole composte, la voce Bad nei vocabolari è notevolmente estesa: a seconda dell’aspetto che si vuole sottolineare esiste un termine ad hoc: Vollbad (completo), Sitzbad (a sedere), Wannenbad (in vasca, nella “bagnarola”), Douchebad (doccia), Kräuterbad (alle erbe aromatiche), Freibad (all’aperto), Heilbad (termale, curativo), Schwitzbad (per sudare) e molti altri ancora. Tra le combinazioni più singolari registrate nel tempo rileviamo l’ Ameisenbad (bagno alle formiche) ottenuto aggiungendo all’acqua della vasca uno o due chili di formiche schiacciate in un sacchetto di lino, e il Tierbad detto anche animalisches Bad, trattamento terapeutico che consisteva nell’avvolgere la parte malata nella pelle di animali appena uccisi (Meyers Konversationslexikon, , Bd , pp. -) cui sembra sia stato sottoposto da bambino anche il Kaiser Guglielmo II per curare il suo braccio deforme. Origini antiche hanno anche – come vedremo – il Maibad o Maienbad (bagno di maggio) e l’Hochzeitsbad (bagno nunziale), che la moderna industria del benessere ripropone oggi come regalo di nozze secondo formule tipo «Wohltuendes Hochzeitsbad zu zweit bei Kerzenlicht, Prosecco und sinnlichen Düften» (pubblicità della società monacense Auszeit-Wellness mit Ambiente, http://www.auszeit-muenchen.de) («Bagno-benessere in due, al lume di candela, con prosecco ed essenze sensuali»). Moltissimi proverbi e modi di dire richiamano il Bad e le usanze a esso legate e si rifanno quasi sempre a trattamenti poco gradevoli o a pratiche punitive (Röhrich, ): jemandem ein Bad anrichten (preparare un bagno a qualcuno) allude alla tortura di mettere il delinquente in un locale riscaldato dall’esterno fino a temperature elevatissime per indurlo a confessare; einem das Bad segnen (benedire il bagno a qualcuno), è un’espressione attestata già nel XIV secolo che risale alla storia del balivo ucciso con un colpo d’ascia nella tinozza per aver fatto proposte oscene alla AGNESE NOBILONI TOSCHI padrona di casa, dopo avere preteso che questa gli preparasse un bagno, e divenuta assai popolare perché utilizzata da Schiller nel Guglielmo Tell: «Und mit der Axt hab’ich ihm’s Bad gesegnet» (Schiller, , p. ) (FIG. ). La ricerca storica dedicata al bagno e alla sua importanza nella vita quotidiana nei territori di lingua tedesca inizia nel XIX secolo. I fondamentali studi Über das Badewesen in mittelalterlicher und späterer Zeit (Zappert, ) e il successivo Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen (Martin, ) hanno per oggetto il Badewesen nel Medioevo e nelle epoche successive. La parola composta Badewesen non ha un esatto corrispettivo in italiano: insieme al Bad (bagno) essa designa infatti il …wesen cioè le cose e le pratiche che attengono al bagno («Alle Dinge und Vorgänge, die zu einer Sache gehören») (Wahrig, , p. ). Spesso l’italiano rende questo …wesen con “sistema”, per esempio Bankwesen è il sistema bancario, Schulwesen il sistema scolastico. La mancanza di un corrispettivo italiano per Badewesen rimanda evidentemente a un divario culturale. Alla conoscenza del particolare Badewesen medioevale, oggetto del presente studio, concorrono discipline diverse – storia della cultura, sociologia, diritto, medicina, architettura, archeologia – come si legge alla voce Bad del Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte (Zoepfl, ): Figura . Baumgarten erschägt Wolfenschießen, incisione di Christoph Murer, . BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » Mittelalterliche öffentliche Badeanlagen haben sich – unverändert – nicht erhalten. Für ihre Kenntnis sind wir in der Hauptsache auf Angaben in Weistümern, Badeordnungen, ärztlichen Anweisungen, Dichtungen […], allegorisch-moralische Auswertungen des Badebetriebes […], Reisebeschreibungen […] und auf bildliche Darstellung angewiesen. (Stabilimenti di bagni pubblici medioevali in forma originale non ci sono pervenuti. Pertanto la nostra conoscenza si basa essenzialmente su indicazioni contenute in sentenze, regolamenti, prescrizioni mediche, componimenti poetici […] interpretazioni allegorico-morali delle pratiche legate al bagno […] descrizioni di viaggio […] e fonti iconografiche.) Si tratta cioè di quella vasta produzione letteraria e documentaria originata dall’invenzione della carta e della stampa che lo storico della lingua tedesca Peter von Polenz definisce «frühbürgerliche Schriftlichkeit» (Polenz, ). Nella terminologia legata al termine Bad si riflette anche il lento processo evolutivo della lingua tedesca verso la standardizzazione. Troviamo nell’antico alto tedesco: bad, pad (Bad ); bado-n, pado-n (baden) (Schützeichel, ); nel medio alto tedesco: bade, bade-gewant, bat-, pat-gewant (Bademantel ); bade-kleit (Badegewand); bade-kneh (Badergehilfe); bade-lachen (Badetuch, Badeumhang); baden, beiten, paden (baden); baderinne (Badefrau, Bademagd); bade-, bat-stube (Badestube, Badehaus); bade-vaz ( Badezuber ) (Hennig, ); e nell’alto tedesco protomoderno: badekappe (Bademantel ); bader (Bader), padgelt (Badegeld); padknhet (Badediener); padmaid (Badedienerin); padpeck (Badebecken, Waschbecken); padpfait (Badehemd); badstube, batstube ( Bad , Badstube , Badehaus ); padswamp ( Badeschwamm ); padwann (Badewanne) (Baufeld, ). Nei testi qui di seguito presi in esame compaiono tutte le suddette varianti ortografiche. L’impiego dell’acqua calda per i lavacri mattutini da parte dei Germani è già testimoniata da Tacito nel ventiduesimo capitolo della Germania: Statim e somno, quem plerumque in diem extrahunt, lavantur, saepius calida, ut apud quos plurimum hiems occupat (Tacito, , p. ). (Appena svegliati dal sonno, che assai spesso è protratto avanti nel giorno, il più delle volte si lavano con acqua calda, perché in quelle regioni l’inverno occupa gran parte dell’anno.) Le fonti scritte più antiche sono in realtà piuttosto ambigue su cosa debba intendersi per Bad: Schwitzbad (bagno di sudore), Dampfbad (bagno di vapore) oppure Wannenbad (bagno in vasca). Ritrovamenti archeologici risalenti al I secolo avanti Cristo confermano l’ipotesi che i Germani già conoscessero la sauna. Una continuità con le terme romane (come nel caso dell’hamam orientale) non sembra verosimile: a nord delle Alpi gli impianti termali romani andarono distrutti all’epoca delle grandi migrazioni e sui resti di solo alcuni di essi sorsero nel Medioevo luoghi di cura. Nei nomi geografici Baden equivale al latino Aquae nella forma del dativo plurale zu den Bädern (Kluge, ). Le località termali e di cura, con sorgenti di acque minerali, sono denominate Wildbäder (bagni “selvatici”, all’aperto, nella natura). Nella Lex Baiuvariorum che risale ai secoli VII e VIII troviamo il passo: AGNESE NOBILONI TOSCHI De minoribus aedificiis. Si quis desertaverit aut culmen eicerit, unicuique, quod firstfalli dicunt, quae per se constructa sunt, id est balnearius, pistoria, coquina vel cetera huiusmodi, cum III solidi conponat (Dölling, , p. ). (Sugli edifici minori. Se qualcuno avrà raso al suolo o fatto crollare il colmo di ciascuno di quegli edifici costruiti separatamente che vengono chiamati firstfalli, e cioè il bagno, il forno e la cucina, pagherà un risarcimento di solidi.) Il termine firstfalli fa pensare a costruzioni di legno (Trier, ) mentre il fatto che il balnearius sia un edificio a sé fa supporre che fosse destinato allo Schwitzbad (bagno di sudore) e non al Wannenbad (bagno in vasca) (Tuchen, , p. ). Nei documenti più antichi si parla sempre di balneum o balnearium o anche balneatorium situato di solito in conventi (per esempio a San Gallo) o residenze nobiliari. Con l’ascesa della borghesia e la crescita delle città, dalla metà del XII secolo sorgono sempre più numerosi i bagni pubblici (Badehäuser): nella città di Colonia appare la definizione stupa (balnei) (Hähnel, , p. ) e a poco a poco Badstube diventerà il termine corrente sia per l’ambiente del bagno strettamente inteso, sia per l’edificio (Badehaus). «Badstube, balneum, Bain étuve, so wird das Gemach in einem zum Baden und Schröpffen angelegten Haus genennet» (Zedler, , Sp. ) (Badstube, balneus, bain étuve, si chiama così l’ambiente predisposto in un locale pubblico per il Baden e lo Schröpfen). Dello Schröpfen (pratica del salasso) si dirà più avanti. Vale la pena di soffermarsi ancora sul termine Stube ricorrendo nuovamente al dizionario etimologico del Kluge. Il mediolatino stuba fa già la sua comparsa nella Lex Alemannorum (VIII secolo); il corrispondente stuba dell’antico alto tedesco e stube del medio alto tedesco hanno il significato di «heizbares Gemach (besonders für Frauen), Badezimmer» (ambiente riscaldabile – particolarmente per le donne –, stanza da bagno). Anche stove (basso tedesco medio e medionederlandese) significa stanza riscaldabile, bagno caldo; l’anglosassone stofa, sta per stanza da bagno, l’inglese stove per ofen. Proviene dal germanico anche l’antico russo istǔba da cui deriva izba. Tutti questi termini germanici traggono origine dal latino volgare *extu-fa-re dal greco tŷphos da cui l’italiano: stufa, stufare e il francese étuve, étouffer (Kluge, ). È interessante un confronto di stube con l’italiano stufa che nel corso dei secoli ha assunto i seguenti significati: utensile per il riscaldamento della stanza; stanza ben riscaldata (XVII secolo), serra (XVIII secolo); suffumigio (XIV secolo); bagno caldo (XIV-XVII secolo). «La voce può essere stata rafforzata nella Galloromania dal germanico stufa bagno (Lex Alemannorum). Sull’italiano alpino stua (stanza riscaldabile) può avere agito anche il tedesco Stube» (Battisti-Alessio, , p. ). Come sottolinea Alfred Martin (, p. ) «in der Einteilung der Bäder herrscht ein großer Wirrwarr» cioè nella classificazione dei tipi di bagni, c’è una grande confusione e ciò è dovuto alla sovrapposizione di usanze e di termini diversi. Heinrich Wittenwiler nella sua opera comico-didattica intitolata Der Ring, databile intorno al -, scrive: Hie so scholt du mercken pei Daz man da vindet zwaierlai Peder nach der gmainen sag: Swaisspad und auch wasserpad! Swaisspad daz sei dir berait, Hast du überflüssichait BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » Zwüschen flaisch und auch der haut! Wasserpad mit edelm chraut, Daz lawisch sei und nicht ze heiss, Macht dich schön und dar zuo faiss. (Wittenwiler, , p. ) (Devi tener presente che esistono due tipi di bagni come si dice comunemente: bagno di sudore e bagno nell’acqua! Il bagno di sudore è consigliabile Se hai qualcosa di troppo Fra la carne e la pelle! Il bagno nell’acqua con essenze pregiate Che sia tiepido e non troppo bollente Ti rende bello e anche forte.) Altri autori, in generale medici, come Walter Hermann Ryff (Newe und heilsame Badenfahrt, ) o Georgius Pictorius di Villingen (Badenfahrtbüchlein, ) fanno un’ulteriore distinzione fra: . heiße, trockene (Heißluftbäder) (bagni asciutti, di aria calda secca); . Dampfbäder in den Badestuben (bagni di vapore nelle Stuben); . Wasserbäder in Zubern (bagni a immersione in tinozze). Il primo tipo corrisponde all’odierna sauna mentre il secondo somiglia molto all’ hamam o bagno turco. Indispensabile in ogni caso era un adeguato sistema di riscaldamento e pertanto il Badofen (insieme stufa, forno e camino), detto anche haitzofen o stainofen costituisce l’elemento distintivo di un bagno pubblico. Al suo interno venivano poste delle pietre che si riscaldavano fino a temperature molto alte, poi, versando acqua sulle pietre incandescenti, si produceva il vapore necessario. Accanto alla stufa c’era un serbatoio di metallo (Kessel ) con acqua bollente e una tinozza di legno (Kübel ) con acqua fredda (Martin, , p. ). Raffigurazioni di Badestuben ci sono state tramandate da importanti artisti, fra cui Albrecht Dürer in vari disegni a penna e incisioni su rame (Badestube, Das Frauenbad, Vorraum des Männerbades) come pure da miniature contenute nel Sachsenspiegel o nel Codice di Manesse. Da queste fonti iconografiche si ricavano importanti informazioni sull’arredo e il funzionamento delle Badestuben (FIG. ). Il gestore del bagno pubblico è il Bader corrispondente al latino balneus che troviamo in antiche iscrizioni. Il mestiere del Bader è stato a lungo considerato unehrenhaft, cioè non onorevole, e veniva già da Lutero contrapposto a quello di Bischof, per indicare i due poli opposti della scala sociale: «Wir können nicht alle Bischof werden, man muß auch Bader haben» («Non possiamo tutti diventare vescovi, bisogna avere anche i Bader»). Nel linguaggio comune, l’espressione «Bischof oder Bader», caratterizzata dall’allitterazione tipicamente tedesca, significa «tutto o nulla» (Lorey, ). Una xilografia di Jost Amman, illustratore del celebre libro dei ceti e mestieri di Hans Sachs apparso nel , mostra il Bader nell’esercizio delle sue funzioni (FIG. ). L’immagine è accompagnata dal testo seguente: Wolher ins bad reich unde arme, Das ist jetzund geheizet warm. Mit wolschmacker lauge ma euch wescht, Denn auff die Oberbank euch setzt, AGNESE NOBILONI TOSCHI Figura . Frauenbadstube , xilografia di Hans Sebald Beham (-). Figura . Der Bader, xilografia di Jost Amman. BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » Erschwitz, den werdt ir zwagn und gribn, Mit lassn das ubrig Blut außtriebn, Denn mit dem Wannenbad erfreewt, darnach geschorn und abgefleht. (Tuchen, , p. ) (Tutti al bagno, ricchi e poveri che ora è caldo al punto giusto. Sarete lavati con detergenti profumati, Poi vi siederete sul banco in alto suderete, verrete sciacquati e strofinati, il sangue in eccesso verrà fatto uscire, poi avrete il piacere di un bagno in vasca dopo di che sarete rasati e spulciati.) Che i Badehäuser fossero istituzioni democratiche, dove ricchi e poveri, nobili e servi potevano ritrovarsi gli uni accanto agli altri, è ampiamente testimoniato. Qualcosa di simile nella moderna cultura tedesca è rappresentato dal Biergarten. Adombrata nel suddetto testo è anche la distinzione fra il bagno di sudore (essenzialmente destinato alla cura del corpo) e il bagno nella Wanne (destinato piuttosto al piacere). La pratica medica del salasso e le cure igienico-sanitarie del radere e spulciare erano imprescindibili trattamenti nel pacchetto offerto dalle “Spa” medioevali. Per aprire un Badehaus era necessario ottenere una concessione da parte delle autorità cittadine o dal signore territoriale, come per il forno, il mulino e l’osteria. Con una antica parola tedesca queste attività venivano definite ehehaft, cioè riconosciute dalla legge. L’uomo o la donna che aveva ottenuto questo privilegio doveva rispettare degli obblighi: riscaldare nei giorni convenuti, disporre di un certo numero di inservienti, possedere il minimo di materiale per il buon andamento dello stabilimento, mantenere l’ordine fra i clienti e rispettare i prezzi e gli orari di apertura fissati. In campagna le Badestuben funzionavano uno o due giorni a settimana (sabato e mercoledì). In città mediamente tre giorni a settimana, mai di domenica e solo in via eccezionale nei giorni festivi. Il bagno di venerdì era malvisto e spesso addirittura proibito: «Es ensol nieman dehain badstuben heizein am vritag» (Lucerna ). Uno dei più antichi regolamenti dei Bader pervenutici è quello della città di Amburgo, Disz ist die Satzung der Badstöver: , che in diciannove articoli fissa le procedure per ottenere la concessione e le norme da rispettare nell’esercizio dell’attività. Il punto cinque sancisce la proibizione dei bagni in comune fra uomini e donne: Ferner soll man das Baden also halten, dasz die Faruen sollen baden alle Werkeltage von des Morgens bis zu zwey Uhren des Tages sonder Mann und nicht länger. Von zwey Uhr Zeit Tages sollen die Männer badenm, bis man zu dem Thumb Vesper läutet (Koepke, ). (I bagni pubblici devono essere gestiti in modo che le donne possano entrare tutti i giorni lavorativi dalla mattina alle due del pomeriggio senza uomini; dalle due in poi possono entrare gli uomini finché nel duomo non suonerà il Vespro.) In altre città la separazione dei sessi fu ordinata molto più tardi, per esempio a Basilea nel , mentre per Strasburgo il primo decreto ufficiale in proposito conservato negli archivi risale all’inizio del XVI secolo (Wittmer, ). È un fatto però che la promiscuità dovette restare a lungo una delle maggiori attrattive dei Badehäuser e AGNESE NOBILONI TOSCHI contribuire non poco a farne luoghi di piacere oltre che di igiene e di cura: uomini e donne, fino a quindici persone, facevano il bagno insieme, si mangiava, si beveva, si faceva conversazione, al motto di «Aussig Wasser, innen Wein, Lasst uns alle fröhlich sein!» (ibid.) («Fuori acqua, dentro vino, allegria!»). È recentemente arrivato alla trentesima edizione in Germania un libro di Joachim Fernau (-) intitolato Und sie schämeten sich nicht. Eine Geschichte der Liebe (E non si vergognavano. Una storia dell’amore), pubblicato per la prima volta nel che ricostruisce i passatempi dei bagni medioevali: Große Hofe und Burgen wohlhabender Ritter besaßen eigene Badestuben. Aber lediglich, weil es zum guten Ton gehörte; amüsant war es nicht. Amüsant waren die öffentliche Bäder. In den Vorräumen zog man sich aus. Dann betraten Männer und Frauen nackend (zu einigen Zeiten mit einer dünnen Schamverhüllung) die Badestuben. Am liebsten badete man paarweise in einer Wanne sitzend. Der Bader legte ein Brett über den Rand und fragte nach den Wünschen. Er servierte das Frühstück auf dem Brett... schlug auf Wunsch den Baderof* auf… Man aß und trank, planschte herum, ließ Hand und Finger spielen, recht ungeniert, plauderte mit dem Nebenpaar oder begrüßte Bekannte, die sich zu einer kurzen Morgenvisite als Zuschauer auf der Galerie eingefunden hatten (Fernau, ). * Baderof oder Baderofen: kleines Zelt, das über die Wanne gestülpt wurde, wenn die Badegäste ein Schwitzbad nehmen wollten. Unter dem Baderof wurde aber nicht nur geschwitzt. (Grandi corti e castelli di cavalieri benestanti avevano bagni privati. Ma era soltanto un fatto di bon ton: lì non ci si divertiva. Divertenti erano i bagni pubblici. Ci si spogliava nell’atrio. Poi uomini e donne nudi (coperti a volte da sottili perizomi) entravano nelle Stuben. Di preferenza si sedeva in due nella vasca. Il Bader fissava un vassoio sul bordo e prendeva le ordinazioni. Serviva la colazione e su richiesta montava il Baderhof*… Si mangiava, si beveva, si sguazzava, si giocava con le mani e con le dita, senza problemi, si chiacchierava con la coppia accanto o si salutavano conoscenti che erano venuti a dare una sbirciata mattutina. *Baderof o Baderofen era una piccola tenda che veniva montata sulla vasca quando l’ospite voleva fare un bagno di sudore. Sotto la tenda però non si sudava soltanto.) (FIG. ) Non mancano naturalmente numerose critiche a queste usanze da parte di contemporanei, soprattutto uomini di chiesa. Fra questi il predicatore Geiler von Kaysersberg (-) e l’umanista Jakob Wimpheling (-) (Wittmer, ). Una testimonianza, piuttosto indignata, dell’usanza di recarsi al bagno in atteggiamento discinto, la troviamo anche in Die Greuel der Verwüstung menschlichen Geschlechts () del medico trentino Hippolitus Guarinonius (-), un’opera che è considerata una miniera di informazioni sulla storia della cultura agli inizi dell’età moderna. L’autore narra che «wol erzogene Burger und Burgerinnen sich in ihren Häusern entblössen und also nackend über die offentliche Gassen bis zum Bad – oder Schandhaus vor aller fürgehenden Augen gehen» (Tuchen, , p. ), cioè di cittadini e cittadine ben educati che si spogliano a casa loro per poi recarsi al bagno (significativamente definito anche Schandhaus, luogo di vergogna e poi anche Wüsthaus, luogo di inciviltà) mostrandosi praticamente nudi agli occhi dei passanti. La circostanza che nei Badehäuser ci fossero dei letti fa sì che, come annota lo scandalizzato Guarinonius: […] etlicher Badmeister will sich so weit in die lasterliche und straffwürdige Unerbarkeit einlassen, dass sie die freyen Bübischen und Hürischen Ligerstätten BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » umb das Gelt zulassen und darbieten, under dem Schein, als wolt man nach dem Bad ruhen oder ein Schlaff thun» (ivi, p. ). (alcuni gestori si prestavano con peccaminosa e colpevole disonestà a concedere i giacigli in cambio di denaro a uomini e donne che facevano finta di voler riposare o dormire dopo il bagno). A lungo è stata interpretata come critica alla nordica libertà dei costumi una lettera scritta nel dall’umanista Poggio Bracciolini (-) all’amico Niccolò Niccoli dalla località termale di Baden im Aargau dove si era recato durante il Figura . Wanne mit Baderof, xilografia (Lübeck ). Concilio di Costanza. Secondo interpretazioni più attuali, la critica dell’autore sarebbe invece rivolta piuttosto alle condizioni sociali in patria (Matheus, ): i divertimenti sarebbero stati in verità da Poggio equiparati alle medicine e pertanto giudicati molto positivamente. E pensare che tre secoli e mezzo dopo il povero Goethe-Werther a venticinque anni non ha ancora visto una donna nuda, come sottolinea uno studioso che ci racconta di quando «Goethe badet»: Ich veranlaßte Ferdinanden zu baden im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! […] Noch aber fehlt mir leider Venus. […] Ich nahm mir fest vor, es koste was es wolle, ein Mädchen in dem Naturstande zu sehen wie ich meinen Freund gesehen hatte (Böhme, ). (Spinsi Ferdinand a fare il bagno nel lago: che fisico meraviglioso ha il mio amico! […] Purtroppo ancora mi manca Venere. […] Mi ripromisi fermamente, a qualunque costo, di vedere una ragazza allo stato di natura, così come avevo visto il mio amico.) Già a partire dal XIII secolo incontriamo riferimenti al bagno in componimenti poetici. Uno dei più antichi è Der Wälsche Gast () del moralista Thomasîn von Zerklaere (/-), opera didattica in dieci libri che documenta la cultura e i costumi del tempo. A proposito di daz bat, nella parte V (v. ) si legge fra l’altro: wir sitzen sus ûf warmen steine: Man begiuzt den herren vomme gebel Mit wallendem pade, peche und swebel, und rîbt im abe mit grôzem vlîze hût und vleisch, sô wirt er wîze und giuzet aver ûf daz gebeine daz heize pat, daz er sich reine. […] (Thomasîn von Zerklaere, ) AGNESE NOBILONI TOSCHI (ci si siede su pietre calde: il signore viene innaffiato dall’alto con acqua che scroscia mista a pece e zolfo, e si strofina con molto impegno pelle e carne, per sbiancarla e di nuovo si versa sul corpo l’acqua bollente per pulirlo. […]) Anche un componimento poetico di Seifried Helbling, – cavaliere austriaco nato nel – scritto alla fine del XIII secolo descrive in dettaglio una visita al Badehaus: «Ich hôrte daz der bader blies» (Tuchen, , p. ) («ho sentito che il Bader ha suonato»), dice il servo al cavaliere. Infatti il Bader invitava al bagno suonando il corno o con Baderufe, ritornelli che sono arrivati fino a noi, come il seguente del : Hört reich und arm Das bad ist warm Wer sich wöll waschen vund salben Am hobt vund allenthalben Er sey herr, Knecht, frow, oder man Dem wirt gewarttet schon. (Martin, , p. ) (Ascoltate ricchi e poveri il bagno è caldo chi si vuole lavare e dare unguenti la testa e le altre parti signore, servo, uomo o donna sarà subito servito.) Ma torniamo al racconto di Helbling (Tuchen, , p. ): Als ich zuo dem badehûse kam Der kneht von mir nam Daz gewant und leit ez hin. Er sprach: nu her ân allen tadel Einen frischen niuwen wadel Hinden wol gebunden; den han ich schiere funden: […] (Arrivato al Badehaus l’inserviente mi prese gli abiti e li depose. Disse: ora senza nessuna esitazione prendete un wadel fresco e nuovo ben legato da un parte; l’ho trovato subito: […]) L’abbigliamento da bagno consisteva in un badehr, cioè una camicia senza maniche per le donne, mentre gli uomini indossavano una mutanda detta niederwad. C’era poi un copricapo di paglia intrecciata, badhut o schaubhut, probabilmente per proteggere il capo dal calore eccessivo. BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » Una volta entrati, il Badeknecht esortava dunque i clienti a munirsi di un wadel: Badewedel o Badequast è una sorta di scopetta frondosa di rametti di betulla o di quercia legati insieme, che viene usata ancora oggi nella sauna finlandese. Questa scopetta è uno strumento caratteristico e insieme al tipico copricapo di paglia, compariva spesso sulle insegne affisse all’entrata dei bagni medioevali. Essa veniva utilizzata per percuotere e strofinare la pelle, procedura denominata lecke ovvero das Lecken. All’occorrenza il Badewedel veniva inoltre utilizzato per coprire le pudende e infatti in alcune opere tedesche Adamo ed Eva sono rappresentati con un Wedel al posto della foglia di fico (FIG. ). Prima dell’ingresso dei clienti il pavimento di legno doveva già essere stato lavato («di diln wol begozzen») come pure i sedili («gewaschen schon die benke»). Il cliente veniva cosparso di acqua tiepida («weder ze kalt noch ze warm») e poi introdotto nel vero e proprio Baderaum dove gradualmente si abituava al calore; durante il bagno di sudore veniva poi percosso con la scopetta su tutto il corpo al fine di rimuovere lo sporco e far aprire i pori. Indispensabili nel Badehaus erano i vari recipienti per l’acqua; dalle fonti scritte e iconografiche se ne rilevano tre tipologie per usi diversi: i più piccoli erano recipienti per mescere e versare l’acqua ([bad]kibel, schaff, eimer, brendlin); quelli di media grandezza servivano per trasportare l’acqua o per mettere a bagno i piedi durante i salassi (schrepfkibel, gelten); i più grandi infine servivano per le scorte d’acqua e di liscivia o per i bagni in vasca (sehster, badwannen, badzuber, cufen) (ivi, p. ). Come detergente per il corpo, i capelli e la barba si utilizzava la Lauge, una liscivia ottenuta versando acqua bollente su cenere Figura . Adam und Eva, xilografia (Straßburg ). AGNESE NOBILONI TOSCHI (solitamente di legno di vite o di salice) contenuta in un sacco filtrante triangolare appeso su una tinozza di raccolta (FIG. ). Wer baden wel, muoß sich besachen Das er auch künd ein laugen machen, Die vunser haubt vund alle sinn Wesch, vund alles das ist din… Zuo laugen muoß man eschen han, Durch einen sack abrinnen lan Das wasser, so wirt laugen dan. (Martin, , p. ) (Chi vuole prendere un bagno deve prepararsi A saper anche fare una liscivia Per lavare il capo e tutti i sensi E tutto ciò che è tuo… Per la liscivia bisogna avere la cenere Far colare attraverso un sacco L’acqua così si ottiene la liscivia.) Oltre al Bader è presente nel Badehaus anche altro personale maschile e femminile: il Badhüter e la gewandthüterin sono i custodi che prendono in consegna gli abiti; i Reiber sono i massaggiatori. Non stupisce che Rîberîn (massaggiatrice) abbia assunto già allora una connotazione negativa. Altrettanto dicasi per Zwagerin (termine che deriva da dwahen, lavare, riferito ai capelli): oggi si direbbe “sciampista”. Altri Badeknechte avevano il compito di fornire i cappelli, le scopette e i mastelli per l’acqua: a costoro non veniva richiesto un particolare addestramento. Un’istruzione ad hoc era invece indispensabile per chi doveva radere e salassare e sostituire il Bader in queste funzioni in caso di una sua assenza: «Es sol sich auch der bader yederzeit mit guten geschickten scherern, schrepfern und badknechten versehen, darmit, wo er nit zugegne, das dannocht nichts desterweniger die badstub versehen werdt» (Tuchen, , p. ). Figura . Laugen machen , xilografia (da: Thomas Murner, Ein andechtig geistlich Badenfahrt, ). È importante sottolineare che nel Badehaus oltre alle pratiche igieniche e cosmetiche venivano eseguite le più diffuse cure mediche per denti, occhi, ossa; vi si effettuavamo clisteri, a volte amputazioni, e soprattutto BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » salassi e flebotomie. Si trattava di pratiche terapeutiche allora assai comuni, basate sul concetto ippocratico dei quattro umori, nel cui ambito il salasso era considerato atto ad allontanare dal corpo gli umori cattivi («die schlechten Säfte»). Come spiega il vocabolario tedesco Wahrig il Bader era al tempo stesso anche Scherer e Schröpfer: «<urspr.> Wärter im öffentlichen Badehaus oder Besitzer eines solchen, der zugleich Barbier war und einfache medizinische Behandlungen vornahm; <später> Barbier; Heilgehilfe» («<Originariamente> gestore o proprietario di un bagno pubblico che era al tempo stesso barbiere ed eseguiva semplici trattamenti medici; <più tardi> Barbiere; aiuto medico»). Il Dizionario delle lingue italiana e tedesca (Macchi, a cura di, ), riporta per il tedesco Bader due significati: . barbiere (Barbier); . cerusico (Wundtarzt). Perduto il riferimento al Bad predominano le attività di barbiere e medico. Scherer è colui che taglia: oggi piuttosto tosatore, anticamente barbiere; i suoi strumenti erano lo scharsach (rasoio) e la schaer (forbici). Si distingueva fra il putzen auf nassen bänken, naß scheren (rasare sui banchi bagnati, rasatura bagnata) e trucken scheren (rasatura asciutta), eseguita anche dal cosiddetto Truckenscherer per il quale si afferma in seguito la definizione di Barbier. Tra Bader e Scherer si è sviluppata col tempo una certa conflittualità: la contesa riguardava il diritto di radere i clienti anche indipendentemente dal bagno e l’esercizio della chirurgia. Le due espressioni zur Ader lassen (dal latino laxare venam) e schröpfen (scarificare, incidere) indicano due diversi metodi per far uscire il sangue, entrambi favoriti dal calore del bagno. L’Aderlass (flebotomia) consiste nell’incidere la vena, generalmente nella parte interna del braccio corrispondente al gomito, per mezzo di un apposito strumento metallico detto Fliete cioè un «Eisen zum Aderlaß» (Kluge, , p. ): in questo caso il sangue zampillante viene poi raccolto in una bacinella. Lo Schröpfen invece si esegue applicando un recipiente in cui si è creato il vuoto bruciando l’aria, in un punto del corpo precedentemente inciso, da cui il sangue può essere risucchiato (FIG. ). Questi recipienti sono detti Schröpfköpfe (ma anche Laßkopf , Baderkopft , Ventose, Ventuse, Vintuse, Fintusze) (Martin, , p. ). Per questa pratica ci si orientava sulle stagioni e i giorni favorevoli venivano indicati in appositi calendari, cosiddetti Aderlasskalender: quello dell’anno è considerato il primo testo di medicina a stampa ed è conservato nella biblioteca nazionale di Parigi. Spesso i Bader abusavano di questa pratica e Hans Sachs, nel suo Schwank, Die neun lehr in einem bad, mette in guardia «Die sechste lehr, dass man halt maß / im bade, wer im schrepffen laß, / Dass er nit laß zu vil geblüts / deß menschen krafft ist es nit nütz» (Tuchen, , p. ) («La sesta regola è di non esagerare nel bagno con i salassi. Non si deve eccedere nel far uscire il sangue perché ciò debilita la persona»). Alla fine del trattamento, dopo lo Schwitzen, Waschen e Schröpfen purificato nel corpo e nello spirito il cliente veniva risciacquato «begozzen wart ich vor der tür» e quindi gli veniva offerto un letto per riposare «Dâ was mir gerichtet für / ein bett, als is wolde, dâ ich ruowen solde» (ivi, p. ). Alle pratiche di purificazione e rigenerazione eseguite nei Badehäuser, si ispirano vari componimenti di carattere allegorico-morale; uno dei più noti è Ein andechtig geistlich Badenfahrt (all’incirca Un pellegrinaggio spirituale al bagno) del francescano Thomas Murner (-). Si tratta di un componimento in rima apparso a Strasburgo nel in cui Cristo nelle vesti di un Bader accoglie il peccatore e per mezzo dei lavacri e dei trattamenti offerti nel Badehaus, misticamente intesi ma realisticamente descritti, riporta la sua anima in stato di grazia (Murner, ). AGNESE NOBILONI TOSCHI Un altro autore qualche anno dopo si servì della metafora del Bad con ben altri obiettivi. Philips von Allendorf, nella sua opera in versi intitolata Der Juden badstub del , sfrutta l’allegoria del bagno per dar voce al già circolante antisemitismo e fomentarlo pesantemente. Il frontespizio non lascia dubbi sulle intenzioni dell’autore: Der Juden badstub. Ein anzeygung jrer manigfeltigen Schedlichen hendel / zuo warnung allen Christen / jren trieglichen listigkeyten zuo entweychen vnd zuo uermeyden. Wer wissen wil was schand vund schad Entspringet auß dem Juden bad / Der selb durchleß mich biß zum endt Von jn wir sehend sind verblend. (Il bagno degli ebrei Una denuncia dei loro svariati traffici dannosi / ad ammonimento di tutti i cristiani perché possano sottrarsi ad essi ed evitare le loro ingannevoli astuzie Chi vuole sapere quali cose vergognose e danni Derivano dal bagno degli ebrei Mi legga fino in fondo Essi accecano la nostra vista.) Nel seguito vengono illustrate le varie procedure igienico-sanitarie e tutte, dai lavaggi ai salassi, diventano una metafora dei misfatti degli ebrei: «Ein wunder seltzam neuwen orden / Die Juden sind nun bader worden» (Frey, ) («Stranezze del nuovo ordine / gli ebrei sono diventati Bader»). Per gli ebrei, come è noto, la pratica del bagno, oltre a essere una misura igienica, ha anche una imprescindibile funzione religiosa. Ogni sinagoga comprende una Mikwe, cioè una vasca alimentata da acqua corrente, dove potersi immergere per il rito della purificazione. Oggi si contano in Germania circa quattrocento siti archeologici di Mikwaot (plurale di Mikwe) medioevali. Quanto ai bagni igienico-sanitari, poiché a seguito di varie misure antiebraiche, in particolare dopo il Sinodo di Vienna del , non fu più permesso agli ebrei di utilizzare le stesse Badestuben dei cristiani, nacquero bagni pubblici di e per ebrei variamente attestati (Martin, , p. ). Figura . Schröpfmann mit Badehut und Badewedel, xilografia (Basel ). Il bagno era una necessità fondamentale ed era strettamente collegato alla vita quotidiana. Il denaro per il bagno faceva parte del salario di artigiani e operai, come si legge ad esempio nel libro mastro di Endres Tuchers della città di Norimberga relati- BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » vo agli anni -: «So soll in der stat paumeister geben alle wochen, es sei veiertag oder werckentag, für sein lone und padgelt fünf pfunt alt» (Tuchers, , p. ) («In città il capomastro deve corrispondere ogni settimana, che sia giorno di festa o giorno lavorativo, come salario e denaro per il bagno, cinque libbre»). Se si offriva del denaro come mancia non era per bere (Trinkgeld ) ma per prendere un bagno (Badegeld). Ci sono pervenute varie indicazioni relative ai costi dei servizi. Il bagno in vasca (Wannenbad) era particolarmente caro e in generale era poco diffuso fino al sedicesimo secolo. Nel Medioevo se ne faceva uso in occasioni particolari come i cosiddetti Maienbäder (bagni di maggio). Das Maibad ist stets ein Wasserbad. In keinem der vielen Kalender, die ich durchgesehen habe, ist in diesem Monat das Schweißbad empfohlen, wohl aber in anderen (Martin, , p. ). (Il bagno di maggio è sempre nell’acqua. In nessuno dei molti calendari che ho visionato viene raccomandato in questo mese un bagno di sudore, come invece accade in altri mesi.) Era convinzione comune che nel mese di maggio, cioè all’inizio della primavera, la natura avesse speciali poteri curativi e rigeneratori, da ricercarsi particolarmente nelle erbe aromatiche e nelle acque: «Arbeyten in dem Meyen, ist dir nit schad. Loss dyn odern und mach ein lustig Bad» («Lavorare a maggio non fa male. Fai un salasso e un bagno divertente»). Il divertimento era garantito se al Bad si univa la Minne: al bagno di maggio non doveva mancare il gioco dell’amore come testimoniano numerose illustrazioni pervenuteci. La tradizione dei bagni di maggio, che a volte si svolgevano nell’arco di un’unica nottata, sarebbe da mettere in stretto collegamento con gli antichi usi pagani della notte di Valpurga (la notte che precede il o maggio). La visita al Badehaus costituiva, durante il Medioevo, un’occasione di divertimento e di vita sociale (FIG. ). Molti festeggiamenti iniziavano o terminavano con un bagno, in particolare i matrimoni. Wenn man hochzeit haben sol, Wen man hat darzu geladen, Der muez sich gar sauber paden Vnd legt schonew chlaider an. (Martin, , p. ) (Quando ci si deve sposare Chi è stato invitato Deve lavarsi bene con un bagno E indossare abiti nuovi.) Così canta il poeta popolare Heinrich der Teichner nel XIV secolo. Ma lo Hochzeitsbad non era soltanto una normale pratica igienica; esso costituiva parte dei festeggiamenti che potevano protrarsi per più giorni. Nel Badehaus, in compagnia degli amici, gli sposi festeggiavano mangiando e ballando la prima notte di nozze, detta anche Walgernacht. Ci sono pervenute varie ordinanze e normative che cercavano di regolamentare questa usanza limitando il numero degli accompa- AGNESE NOBILONI TOSCHI gnatori: la polizia di Norimberga consente alla sposa, nel XIII e XIV secolo, di portare con sé solo quattro giovani donne; a Regensburg il numero massimo per gli accompagnatori dello sposo nel XIV secolo è fissato a ventiquattro; a Monaco il regolamento cittadino (prima del ) recita «Ze der vest und ze pette und ze pade sol man haben ietweders tails niur sehs frawen, daz sint zwelf frawen» (Martin, , p. ) («Alla festa, a letto e al bagno ognuna delle parti può avere solo sei donne, il che fa dodici donne»). È una normativa che non può non stupire! L’antica usanza dello Hochzeitsbad venne gradualmente abolita: «Die walgernacht, wie sie vor alters gehalten, als mit bade vund dantzen, soll gantz vund gar absein vund nit mehr gehalten werden» (ivi, p. ) («la Walgernacht come si svolgeva secondo l’antica usanza con bagno e danza deve essere abolita e non avere più luogo») è scritto nello Figura . Geselliges Bad (circa ). Statuto della città di Stolberg nel . Una pratica caritatevole della società medioevale erano i cosidetti Seelenbäder (balnea animarum) cioè bagni in favore dell’anima dei defunti. Spesso vescovi, principi, nobili e patrizi ma anche borghesi benestanti lasciavano per testamento dei fondi destinati al bagno dei poveri affinché questi, in cambio, pregassero per le loro anime. A volte oltre alla possibilità di prendere un bagno, veniva offerto anche un pasto gratuito. I “bagni per le anime” si diffusero in tutta la Germania e furono anche esportati in Norvegia dalla gente di Lubecca. Il massimo sviluppo dei Badehäuser si ebbe nel XII e XIII secolo. Già nel XV secolo, quando il legno comincia a scarseggiare, la temperatura nelle Badestuben si abbassa e i prezzi salgono. Il pubblico comincia a lamentarsi. Ma anche altre cause concorsero a mettere in crisi il Badewesen , in primo luogo il rischio di malattie contagiose quali la peste, la lebbra e il “mal francese”. Secondo una cronaca di Norimberga la sifilide compare per la prima volta nel «ist bös krankheit, malo franco, welches man die Franzosen nennt, erstlich ins Teutschland kommen» (ivi, p. ). Alla metà del XVIII secolo le abitudini igieniche dell’uomo comune sono molto mutate e le Badestuben chiudono i battenti. Maggiore continuità nella consuetudine a prendere bagni si riscontra nelle presenze presso i Wildbäder, località di acque termali che i tedeschi amano molto e non hanno mai smesso di frequentare: un altro aspetto di una lunga tradizione. BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » Appendice Das baderthier (di Hans Sachs, -) Einsmals ein bader fraget mich, / Wie er mit seinem werckzeug sich Verbutzen möcht in solchen furm, / Dass er seh gleich eim wilden wurm, Auff dass in fürchtet weib und kind, / Dergleichen sein gantz badgesind. Dem bader ich die antwort gab: / So zeuh dich mutternacket ab, Dein halben leib mit ruß bescheiß, / Den andern theyl mit blut beschmeiß Und stelle dich auf alle vier / Nider, recht wie ein wildes thier, Stürtz darnach auff dein haubet bloß / Dein laugenhaften weit und groß! Und steck in das ein ohr dein scher / Und in das andr ein schermesser! Auff jedes aug setz ein laßkopff, / Dein nasen vol strohhälmer stopff! Nimb den badschwamen in dein maul! / Bleck die zen wie ein ackergaul Und steck den kamb in deinen bart! / Wilst du haben noch wilder art, So henck den reibstein auch darein, / Die scherladen und den streichstein Und henck darnach dein bruch an hals / Für einen maulkorb und nachmals Nimb auß der flayhlaugen die würtz! / Flicht dir ein satteldeck und schürtz Sie ubert lend, steck flitten drein/ Das sollen deine porsten sein. Angezünt den laßdegel setz / Auff deinen rücken und zuletz Bind umb die weychn ein ströhen gflecht, / Als seyst du meerkatzen-geschlecht! In die rechte hand nimb ein scherbeck, / Die linck in einen kübel steck, Bind an dein fuß ein laugenfaß, / Das schlepp nach dir ohn unterlaß! An den andren ein zuber hach, / Den zösch auch also hindennach! Dein gschirrlich in ein badhut heck, / Der am bauch wie ein euter schwecnk! Hinden auff-burtze dich gar hoch, / Henck den kösten durch das rauchloch, Als ob es sey ein biberschwanz, / So bist du denn gebutzet gantz. Wo denn der leut nit warten recht/ Scherer, lasser und bodenknecht, Das gsind nit fleissig flayh und zwag, / Laß, scher, reib oder wasser trag, Dass sie etwann der lentze stech, Oder wasser im bad gebrech, Dass der schöpffer auch sey stüdful / Und die badmayd hencken das maul, Dass du das badgsind wilt erschrecken, / Auffmundern und von faulheit wecken, So zeuch denn die stigen herab / Gerüst, wie ich erzelet hab, Und kreuch in die badstuben nein / Zu dem faulen badgsinde dein! Wie ein meerwunder murr und brumb! / Mach ein gerümpel umb und umb! So fürcht sich denn dein badgsind, / Wirt hurting, munder, resch und gschwind, Gehorchsam, willig überauß, / Wie mayd und knecht in meinem haus, Die auch mit vil geben umb mich: / Ob ich mich gleich stell grausamlich, Machens ein tagwerck in zwey tagen / und lassen mich schelten und klagen. Dergleichen auch dein badgsind thut. / So nimb von mir die lehr für gut Von deinem weckzeug, dass kein ungmachs / Auß dem schwanck komb, so spricht Hans Sachs. (Tuchen, , p. ) (Il Bader bestiale Una volta un Bader mi ha chiesto, / come poteva con i suoi arnesi, camuffarsi in modo tale, / da sembrare un rettile, per spaventare donne e bambini, / e tutto il personale del suo bagno. Al Bader ho risposto: / spogliati nudo come appena nato, per metà imbràttati con fuliggine, / l’altra parte cospargila di sangue e mettiti giù a quattro zampe / proprio come una bestia selvaggia e poi rovesciati sul capo nudo / una bella secchiata della tua liscivia! In un orecchio conficcati le forbici / e nell’altro un rasoio! Piazza su ogni occhio una ventosa per i salassi, / E imbottisciti il naso con la paglia! Mettiti la spugna da bagno in bocca! / Mostra i denti come un cavallo che ara AGNESE NOBILONI TOSCHI Infila il pettine nella barba! / Se vuoi sembrare ancora più selvaggio, Appèndivi anche la pietra abrasiva, / gli astucci dei rasoi e la pietra per affilare le lame e poi appènditi i pantaloni al collo / come una museruola e togli le erbe aromatiche dalla liscivia!/ Intrécciati una gualdrappa e legatela sui fianchi, infilzaci le lancette per i salassi / saranno i tuoi aculei. Metti il recipiente per i salassi sulla schiena / dopo averlo acceso e infine Legati intorno ai fianchi un cesto di paglia, / come se fossi un cercopiteco! Nella mano destra prendi un catino da barbiere, / la sinistra mettila in un mastello, legati al piede un secchio da liscivia, / e trascinatelo dietro senza sosta! All’altro aggancia una tinozza, / strascicati dietro anche questa! Metti il tuo giocattolino in un cappello da bagno penzolante, / che dondola sulla pancia come una mammella! Sul di dietro addobbati di tutto punto / appendi lo scopetto conficcandolo nel posteriore, come se fosse la coda di un castoro, / Così sei ben camuffato. Se la gente non fa bene il suo lavoro / chi deve radere, salassare e pulire il pavimento, Se il personale non lava accuratamente corpo e capelli, / non salassa, rade massaggia e porta l’acqua come si deve, se talvolta li prende la pigrizia, o nel bagno manca l’acqua se lo Schröpfer è lentissimo / e le inservienti fanno il muso, E allora tu vuoi spaventare il personale, / incitarlo e svegliarlo dalla pigrizia Allora cala la scala / attrezzato come ti ho detto, E striscia dentro nella Badstube / dai tuoi pigri dipendenti! Come un mostro marino muggisci e brontola! / Fai fracasso tutt’intorno! Così la gente del tuo bagno si spaventa, / Diventa lesta, vivace, vispa e veloce Ubbidiente, assai volenterosa, / come le cameriere e i servi nella mia casa, che anch’essi non fanno molto intorno a me: / Anche se io mi atteggio a cattivo, per fare il lavoro di un giorno ne impiegano due e io devo sgridali e lamentarmi. Così fanno anche quelli che lavorano nel tuo bagno. E allora impara dal mio insegnamento a servirti dei tuoi arnesi, / e niente di male deriverà dallo Schwank. Lo dice Hans Sachs.) (T.d.A.) Bibliografia BATTISTI C., ALESSIO G. (), Dizionario etimologico italiano, G. Barbera Editore, Firenze. BAUFELD C . (), Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch , Max Niemeyer Verlag, Tübingen. (), Eros und Tod im Wassers-»Bändigen und Entlassen der Elemente«. Das Wasser bei Goethe, in Id., Kulturgeschichte des Wassers, Suhrkamp, Frankfurt am Main (consultabile su: http://www.culture.hu-berlin.de/hb/node/). BRUE A. (), Cattedrali del corpo, Feltrinelli, Milano. DÖLLING H. (), Haus und Hof in germanischen Volksrechten , Veröffentlichungen der Alterturmskommission für westfalische Landes-und Volkskunde , Münster. FERNAU J. (), Und sie schämeten sich nicht. Eine Geschichte der Liebe, Verlag Herbig, München. FREY W. (), Es ist kein glück wo Juden sein: zu Philips’ von Allendorf Der Juden Badstub (consultabile su: http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/volltexte///). GRIMM J., GRIMM W. (), Das Deutsche Wörterbuch (-), S. Hirzel, Leipzig (consultabile su: http://germazope.uni-trier.de/Projects/WBB/woerterbuecher/dwb/ wbgui?lemid=). BÖHME H. BAD : « UNA PAROLA IMPORTANTE PER LA CULTURA GERMANICA » (), Die Grewel der Verwüstung menschlichen Geschlechts, Ingolstadt. (), Stube. Wort- und sachgeschichtliche Beiträge zur historischen Hausforschung, Schriften der volkskundlichen Kommission des Landschaftsverbandes Westfalen, Bd , Aschendorf, Münster. HENNIG B. (), Kleines Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Max Niemeyer Verlag, Tübingen. KLUGE F. (), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Walter de Gruyter, BerlinNew York. KOEPKE K. (), Badekultur im Mittelalter (consultabile su: www.fogelvrei.de/besucher/ badekultur.shtml). KRAMER K. (), Das private Hausbad -, Klaus Kramer, Schramberg KŘÍŽEK V. (), Kulturgeschichte des Heilbades, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln. LOREY E. M. (), Der Beruf des Baders (consultabile su: www.elmar-lorey.de/Genealogie/ Bader.htm). MACCHI V. (a cura di) (), Dizionario delle lingue italiana e tedesca, Sansoni, Firenze. MARTIN A. (), Deutsches Badewesen in vergangenen Tagen, Eugen Diederichs, Jena. MATHEUS M . (hrsg.) (), Badeorte und Bäderreisen in Antike, Mittelalter und Neuzeit (Mainzer Vorträge ) Steiner, Stuttgart. Meyers Konversationslexikon (), (consultabile su: www.meyers-konversationslexikon.de). MÜNCH P. (), Lebensformen in der Frühen Neuzeit bis , Propyläen, Frankfurt am Main-Berlin. MURKO M. (), Die Schröpfköpfe bei den Slaven. Slav. “bańa”, “bańka”, lat. “balnea”, in “Wörter und Sachen”, V, , pp. -. MURNER T. (), Ein andechtig geistlich Badenfahrt, in Thomas Murners Deutsche Schriften, herausgegeben von V. Michels, Franz Schultz, Straßburg, Bd , . Teil (ed. or. ). POLENZ P. VON (), Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart, Bd I, Walter de Gruyter-Berlin-New York. RÖHRICH L. (), Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten, Herder, Freiburg-Basel-Wien. SCHILLER F. (), Wilhelm Tell, Landibuchverlag, Zürich. SCHÜTZEICHEL R. (), Althochdeutsches Wörterbuch, Max Niemeyer Verlag, Tübingen. STEINHAUSEN G. (), Geschichte der deutschen Kultur, Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien. TACITO (), La vita di Agricola. La Germania, Rizzoli, Milano. THOMASÎN VON ZERKLAERE (), Der wälsche Gast (ed. or. ) (versione digitale consultabile su: http://dobc.unipv.it/scrineum/wight/dwg.htm#). TRIER J. (), First. Über die Stellung des Zauns im Denken der Vorzeit, in “Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschften in Göttingen”, Philosophisch-historische Klasse IV, neue Folge III, pp. - TUCHEN B. (), Öffentliche Badhäuser in Deutschland und der Schweiz im Mittelalter und der Frühen Neuzeit, Michael Imhof Verlag, Petersberg. TUCHERS E. (), Baumeisterbuch der Stadt Nürnberg (- ), herausgegeben von M. Lexer, Editions Rodopi, Amsterdam. WAHRIG G. (), Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh. WITTENWILER H. (), Der Ring, nach dem Text von E. Wießner ins Neuhochdeutsche übersetzt und herausgegeben von H. Brunner, Reclam, Stuttgart. WITTMER C. (), Bains et baigneurs à Strasbourg au Moyen Age, in “Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire”, . ZAPPERT G. (), Über das Badewesen in mittelalterlicher und späterer Zeit, in “Archiv für Kunde österreicher Geschichtsquellen”, . ZEDLER A. (), Großes Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, Halle/Leipzig. ZOEPFL F. (), Bad , in O. Schmitt (hrsg.), Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte , Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München-Stuttgart, Bd I, Sp. -. GUARINONIUS H. HÄHNEL J. IL GRUPPO : SCRITTORI TEDESCHI DAL AL di Marta Bignami Il Gruppo nasce subito dopo la catastrofe tedesca della seconda guerra mondiale, in un momento di straordinario fiorire dell’ambito culturale, di riviste e case editrici che pubblicavano testi proibiti dal nazismo e spettacoli teatrali anch’essi all’indice durante il regime. Reduci dal dodicennio nazista che li aveva imbavagliati, gli intellettuali tedeschi volevano leggere, discutere, scrivere. Ed è proprio da una rivista il cui pensiero è in linea con questo desiderio di riscatto che nasce il Gruppo . È difficile sintetizzare le caratteristiche di un gruppo che nel giro di un ventennio accolse nel suo ambito scrittori di tutti i generi e di tutte le età. Ne fecero parte poeti, prosatori, drammaturghi, commediografi, scrittori di radiodrammi e di copioni per il cinema e per la televisione. Le loro tendenze artistiche erano disparate: spaziavano dal realismo tout court al realismo poetico, dalla satira sconfinante nel grottesco all’estrema aggressività critica, dal misticismo poetico al surrealismo, da una scrittura fatta di sogni e di incubi a una prosa rozza e volgare punteggiata di bestemmie e di interiezioni scurrili. Scrive Joachim Kaiser che nella “fisionomia” del Gruppo alcuni stonavano, ma che bisognava tollerarli, poiché al ritorno da una guerra sanguinosa e logorante esprimevano l’orrore del vissuto. Del resto, continuava Kaiser, lo stesso Thomas Mann aveva scritto: «In realtà il sentimento è indotto a perdonarsi, altrimenti se ne va sbadigliando. Per onorare la perfezione assoluta occorre una dedizione al pensiero e alla bellezza esemplare e magistrale» (Heinz, hrsg., , p. ). I primi scrittori del Gruppo si rendevano conto che, nell’immediato dopoguerra, l’intellettuale non poteva prescindere dalla politica. Così Alfred Andersch, guardando indietro in un’intervista del : «Si partiva comunque dal dato di fatto che la letteratura influisce sulla politica. In fondo per noi era tutt’uno, non potevamo immaginare la politica separata dalla letteratura intesa come torre d’avorio avulsa dal mondo» (ivi, p. ). E lo stesso Hans Werner Richter (-), padre spirituale e mentore del Gruppo , in testa all’Almanach (AA.VV., ) che tira le somme delle attività svolte in un quindicennio: «L’origine del Gruppo è di natura politico-pubblicistica. Non furono letterati a crearlo, ma pubblicisti politicamente engagés con tendenze letterarie» (König, , p. ). L’origine del Gruppo risale alla rivista “Der Ruf” (letteralmente “il grido” o “il richiamo”) voluta dagli americani nei campi di prigionia statunitensi. Scopo del foglio era combattere le teorie naziste tra i prigionieri e insistere sulla tesi della “colpa collettiva” (Kollektivschuld) e della denazificazione (Entnazifizierung). Tornati in patria dalla prigionia, i redattori, tra i quali spiccavano Alfred Andersch e MARTA BIGNAMI Hans Werner Richter, si adoperarono per continuare la pubblicazione in Germania con il sottotitolo “Blätter für die junge Generation”, questa volta senza le costrizioni imposte dalle autorità statunitensi. Le loro idee erano improntate a un socialismo individuale e idealistico: auspicavano che tutti i cittadini europei si unissero a formare un’Europa socialista fondata sul mutuo soccorso. Nonostante il gruppo dei redattori si nutrisse di letture proibite durante il nazismo, quali quelle comuniste ed esistenzialiste francesi (Sartre, Léon Blum, Camus) e quelle libertarie e improntate alla rivolta della lost generation americana (Faulkner, Hemingway ecc.), la Weltanschauung politica non era affatto comunista, come quella del loro grande contemporaneo Brecht: anzi si evitavano accuratamente parole come Lager e Marxismus-Leninismus. Sennonché, l’edizione monachese del “Ruf” durò solo nove mesi: dal settembre all’aprile . Il fatto è che contravveniva alle meticolose regole dell’amministrazione americana che voleva confermare le sue tesi sulla Kollektivschuld e sulla Entnazifizierung. Quindi il “Ruf”, accusato di “nichilismo”, dovette chiudere. Nel luglio del si svolse una riunione nella villa della contessa Degenfeld ad Altbeuern, vicino Rosenheim, alla quale furono invitati i curatori del “Ruf” insieme a scrittori della giovane generazione. Presiedeva Rudolf Alexander Schröder e Stephan Hermlin, scrittore anteguerra, tenne un discorso alquanto prudente e teorico sulle prospettive della nuova letteratura. Gli scrittori del “Ruf”, appartatisi in giardino, decisero di riunirsi di nuovo nell’intento di fondare una nuova rivista. L’occasione si presentò presto quando furono invitati da Ilse Schneider-Lengyel, poetessa e grafica, nella sua casetta sul lago Bannwald vicino a Füssen (settembre ). Heinz Friedrich dà una descrizione divertente di questa riunione destinata a elaborare il numero zero della rivista “Skorpion”, nome promettente quanto alla facoltà di pungere di questo animale, unita al veleno oltre che mortale, utile alla farmacopea. Anche questa rivista fu tuttavia accusata di nichilismo dall’amministrazione americana e quindi proibita. Nonostante gli ostacoli, questo gruppo di scrittori continuò a riunirsi due volte l’anno (fino alla metà degli anni Cinquanta): c’era molta carne al fuoco, molto da discutere, da approvare e anche da bocciare. All’inizio la cerchia dei quarantasettini era ristretta: Hans Werner Richter, loro capo spirituale, preparava le riunioni mandando cartoline di invito a chi stimava o gli era simpatico. Tutto si svolgeva in modo informale: le riunioni avevano luogo in posti appartati, come conventi abbandonati, locande perse in mezzo ai boschi, luoghi di villeggiatura troppo diroccati dalla guerra per attirare turisti, specie se intellettuali senza un soldo. Una volta sistemati, i quarantasettini cenavano con quello che passava il convento, abbandonandosi a rumorose discussioni politico-letterarie annaffiate da abbondati libagioni di birra di malto. Richter, sempre neutrale e sorridente, passava da un tavolo all’altro cercando di calmare gli animi e verso l’alba batteva le mani, intimando a tutti di andare a letto. L’indomani le letture cominciavano alle nove: infatti la regola del Gruppo prevedeva che gli scrittori leggessero brani delle loro opere inedite ai loro colleghi, i quali, dopo ampia discussione, dovevano accettarli o bocciarli. Il rituale era sempre lo stesso: il lettore si sedeva con il suo manoscritto a un tavolino su una sedia, scherzosamente chiamata “sedia elettrica”, Hans Werner Richter munito di una campanella gli sedeva accanto su una poltroncina, i “giudici” sedevano in ordine sparso su sedie scomode o, se non avevano trovato posto, sui davanzali delle finestre oppure addirittura per terra (le stanze erano piccole, i partecipanti molti e parecchi gli IL GRUPPO : SCRITTORI TEDESCHI DAL AL “imbucati”). Qualcuno chiudeva le porte; Richter con la campanella dava il segnale del silenzio e iniziavano le letture che si alternavano protraendosi sino al tardo pomeriggio inframmezzate dalle discussioni che a volte erano lunghe e animate. Quando, dopo la discussione, l’autore veniva bocciato, doveva ritirarsi subito con il manoscritto sotto il braccio. L’intero procedimento veniva ripetuto il sabato e la domenica, e il lunedì i partecipanti tornavano a casa contenti o delusi, ma sempre ricchi di nuove esperienze. Il Gruppo , insomma, non era un’associazione limitata da regole precise o obbligata a versare quote di iscrizione, i suoi membri potevano dire, scrivere o fare quello che volevano purché non oltrepassassero i limiti della decenza. Il Gruppo , secondo Hans Mayer (AA.VV., , pp. -), a parte l’entusiasmo da neofita che lo muoveva, non assomigliava a nessun movimento letterario formatosi durante la lunga e complicata storia della letteratura tedesca: era semplicemente un gruppo di amici che si criticavano a vicenda cercando di migliorare le proprie prestazioni. Coloro che avevano talento si affermavano in campo letterario e le loro opere diventavano best seller. Pian, piano, dopo il fallimento del “Ruf”, seguito da quello dello “Skorpion”, si passò dalla pubblicistica alla letteratura, alle riunioni affluirono lettori di case editrici e giornalisti, i primi a caccia di nuovi talenti, i secondi impegnati a descrivere le riunioni e a intervistare gli autori emergenti. D’altra parte, il Gruppo sollevò, tra i ben pensanti, reazioni negative: colpisce l’ingiusto commento del critico Günter Blöcker che già nei primi anni Sessanta accusava il Gruppo di essere un’associazione mafiosa intenta a tessere nell’ombra oscure trame pur di ottenere successo. Un consigliere culturale democristiano giunse a chiamare i membri del Gruppo Pinscher ovvero cagnolini che abbaiano per un nonnulla e alzano spesso la zampa per fare pipì. Questa lievitazione del Gruppo dispiacque un po’ ad Hans Werner Richter, che lo avrebbe voluto conservare quale era agli inizi; ma il boom delle case editrici, parallelo al “miracolo economico”, la diffusione dei media come la radio e la televisione, cui si dedicarono non pochi scrittori famosi del Gruppo , lo indussero a rassegnarsi. Gli autori del Gruppo , così chiamato da una definizione da Wolfgang Weyrauch nella sua introduzione all’antologia Tausend Gramm (titolo che rende bene la leggerezza stilistica di quegli anni), volevano liberarsi della retorica che aveva afflitto il dodicennio nazista: miravano a una lingua semplice, priva di fronzoli, e possibilmente non “inscatolata” (eingeschachtelt) quale era stata quella della burocrazia precedente. Si parlò di Kahlschlag, di taglio dei rami secchi nel bosco da potare, di Nullpunkt, di punto zero a partire dal quale ricominciare tutto daccapo. Non era così facile, dato che in campo culturale non vi può essere soluzione di continuità. Comunque, l’essenziale prosa di Wolfdietrich Schnurre, che nella short story raggiunse la massima concisione, i brani letti alle prime riunioni, quali quelli di Nicolaus Sombart o di Jürgen von Holländer, testimoniano la ricerca di uno stile nuovo, colloquiale, a volte vernacolare, sincopato, con frequenti parolacce e bestemmie, dove l’Ich è sostituito dal man a indicare la massa, con neologismi grammaticali e lessicali. In altri casi gli orrori della guerra e dell’immediato dopoguerra venivano evocati con frequenti flash-back e incubi – nella sostanza, ma non nello stile – degni di Kafka (ma era proibito farne il nome). In questi primi scritti è difficile individuare la frontiera tra realismo, realismo poetico e realismo noir, realismo triviale, satira, polemica, naturalismo post litteram, impressionismo ingenuo ed espressionismo. Si andava dall’ enfant terribile Hans MARTA BIGNAMI Magnus Enzensberger, che nel suo beffardo poema Schaum relegava tutto il reale nelle spumose pattumiere dell’immaginazione, al raffinato Alfred Andersch, formato sui classici, che nel lesse il suo capitolo di Geister und Leute intitolato Weltreise auf deutsche Art, una sensibile disamina del militarismo prussiano sotto Guglielmo II. Un outsider fu il grande scrittore Uwe Johnson (-), cittadino della DDR e oppositore del governo di Ulbricht. I suoi primi romanzi Mutmaßungen über Jakob (Congetture su Jakob) e Das dritte Buch über Achim (Il terzo libro su Achim) divennero best-seller nella BRD prima di essere pubblicati nella DDR. Si trattava di veri e propri romanzi noir in cui veniva esaltato il coraggio di chi voleva emergere dal grigiore della quotidianità totalitaria del regime filocomunista. Tentativo peraltro fallito con la morte apparentemente accidentale dei due eroi. Johnson, ottenuto finalmente il visto per la BRD partecipò ad alcune riunioni del Gruppo . Scontento tuttavia anche dell’atmosfera occidentale, emigrò a New York. Il Gruppo , consapevole della sua compattezza, diffidava degli autori della Innere Emigration , di quelli cioè che si erano piegati alle regole della Reichsschrifttumskammer (l’organo preposto alla censura durante il nazismo) e avevano continuato a pubblicare in patria anche dopo il , anno in cui il nazionalsocialismo aveva iniziato a mostrare il suo vero volto. Basti citare il famoso romanziere Hermann Hesse e l’inimitabile poeta e anatomo-patologo Gottfried Benn. Anche per questi autori eccezionali il Gruppo non dimostrava grande simpatia. Un momento importante per i quarantasettini fu la partecipazione alle riunioni di critici letterari professionisti. Uno di questi critici, Walter Höllerer, che diresse per una decina di anni la rivista “Akzente”, negli anni Sessanta fondò a Berlino dei work-shop di scrittori cui erano ammessi anche giovani scrittori di altri paesi: ne fecero parte, tra gli altri, Edoardo Sanguineti, Alfredo Giuliani ecc., autori del Gruppo italiano. Essi avevano il pregio di domare una lingua specializzata, atta a sintetizzare con poche parole i contraddittori che avvenivano in seno al gruppo. Col passare degli anni esso si gonfiò a dismisura, con grande rabbia di coloro che rimpiangevano le sedute ristrette senza flash di fotografi né cineprese televisive. La sua notorietà si diffuse per tutt’Europa e perfino Oltreoceano. Dall’impegno politico alla letteratura: questa la parabola che conobbe alti e bassi della storia del Gruppo , che vide la partecipazione di nomi illustri, quali i premi Nobel Heinrich Böll e Günter Grass e una grande poetessa come Ingeborg Bachmann, e che nel Hans Werner Richter dichiarò conclusa: infatti, come diceva lui stesso, si era tornati al punto di partenza, alla Kalligraphie, scomoda eredità di tendenze letterarie ormai sepolte. La riunione successiva si doveva tenere a Praga, ma la primavera praghese e i carri armati sovietici ne impedirono la realizzazione. Il “funerale” del Gruppo si tenne dieci anni dopo, nel , con una riunione nostalgica a Sulgau vicino a Ulm. Bibliografia AA.VV. (), Almanach der Gruppe , Rohwolt Verlag, Reinbek bei Hamburg. HEINZ L. A. (hrsg.) (), Die Gruppe . Ein kritischer Grundriß, Text + Kritik (Sonderband), München (a ed.). (), Hans Werner Richter, Notizen einer Freundschaft, Carl Hanser Verlag, München. KÖNIG B . ISPANISTICA Fausta Antonucci Maria Cristina Assumma Filomena Liberatori Otello Lottini Pina Rosa Piras Giuliano Soria Simone Trecca Laura Mariottini MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’OTTOCENTO: PEPITA JIMÉNEZ VS TRISTANA di Fausta Antonucci Poco meno di vent’anni separano la prima pubblicazione di Pepita Jiménez () di Juan Valera, da quella di Tristana () di Benito Pérez Galdós. Entrambi romanzi della tarda maturità dei loro autori, condividono un tratto paratestuale caratteristico di altre opere, tanto di Valera come di Pérez Galdós: il titolo che coincide con il nome della protagonista femminile. La lettura dei due testi ci pone poi di fronte ad altre analogie: la vita di entrambe le protagoniste è segnata dalla convivenza con un uomo molto più anziano di loro, e poi dall’amore per un uomo più giovane; per entrambe è determinante il rapporto fra amore e fede religiosa che si viene a stabilire nella loro traiettoria esistenziale; entrambe vengono presentate come donne autonome, dal carattere indipendente e volitivo, capaci di esercitare un influsso sostanziale sulla vita dell’uomo cui si accompagnano. Tuttavia, come sa chiunque abbia letto anche solo superficialmente i due romanzi, il punto di approdo delle due protagoniste è radicalmente diverso, per non dire opposto: sposa e madre felice Pepita Jiménez, che realizza nel matrimonio con don Luis le sue aspirazioni individuali e sociali; moglie sterile Tristana, mutilata e invecchiata precocemente, spenta in tutte le sue aspirazioni. A un primo approccio, è facile ascrivere questa differenza alla ben nota diversità caratteriale e ideologica dei due autori: ottimista e idealista Juan Valera, tanto quanto Pérez Galdós è invece tendenzialmente pessimista e influenzato dalla visione naturalista degli individui e della società. Il confronto potrebbe poi sembrare un’operazione poco redditizia anche per la sproporzione fra le due protagoniste. Tristana ci colpisce per la sua modernità: quella figurina di donna che vuole a tutti i costi fuggire dal destino scontato che la società le impone, la sua tristissima sconfitta, il finale aperto e ambiguo parlano al nostro cuore di donne e uomini del XXI secolo assai più di Pepita Jiménez, troppo bella, troppo buona, troppo fortunata per non risultare almeno in parte stucchevole, come lo sono le protagoniste dei romanzi rosa un po’ démodés. Tuttavia, proprio questa differenza fra Tristana e Pepita Jiménez può essere l’indizio forte di un rapporto fra i due testi che non si stabilisce soltanto nella nostra mente di lettori, ma che può aver presieduto alla stessa ideazione del romanzo di Pérez Galdós, se è vero, come ha segnalato Stephen Gilman (), che Galdós spesso componeva le sue opere avendo in mente un romanzo preesistente, con il quale entrava in dialogo polemico rovesciandone e capovolgendone alcuni elementi. In riferimento a Pepita Jiménez, e alla polemica su realismo e idealismo che la sua pubblicazione scatenò nel mondo intellettuale madrileno, già Vernon Chamberlin () ha fatto notare come Doña Perfecta () possa leggersi come la risposta galdosiana al romanzo di Valera. Forse però il dialogo di Galdós con Pepita Jiménez FAUSTA ANTONUCCI non si è esaurito con quel romanzo dei suoi esordi, ma ha continuato a percorrere la sua opera, fino a manifestarsi di nuovo in Tristana. E se il dialogo tra Pepita Jiménez e Doña Perfecta interessa, come si evince dall’analisi di Chamberlin, soprattutto la figura del protagonista maschile e, non secondariamente, tutti i personaggi che caratterizzano l’ambiente della cittadina di provincia, il dialogo tra Pepita Jiménez e Tristana interessa fondamentalmente, come cercherò di mostrare in queste pagine, la figura della protagonista e le sue motivazioni. Cosciente o no che sia stato per Galdós il riferimento a Pepita Jiménez nel comporre la sua Tristana, rimane il fatto che noi lettori di oggi possiamo rintracciare somiglianze e scostamenti ugualmente significativi fra le due opere; e se forse non possiamo parlare di ipertestualità nel senso in cui raccomanda Genette di utilizzare il termine, solo quando cioè sia dimostrata l’intenzionalità del riferimento a un testo A da parte dell’autore del testo B (Genette, , pp. -), possiamo però senz’altro parlare di una relazione transtestuale che ci offre insospettate chiavi di lettura e ci permette di illuminare meglio l’atteggiamento che Valera e Galdós assumono nei confronti dei mutamenti che il ruolo femminile nella società sta iniziando a subire proprio in quell’arco di tempo. Il vecchio e la giovane Una madre vedova e in povertà, una figlia giovane e bella, un uomo già in là con gli anni ed economicamente più agiato: questo triangolo costituisce la situazione di partenza narrativa tanto del personaggio di Pepita Jiménez come di quello di Tristana. Nella lettera che apre la prima parte del romanzo di Valera, il protagonista don Luis racconta a suo zio il Deán la storia di Pepita così come gli viene riferita dai suoi compaesani: quando lo zio della giovane, l’ottantenne don Gumersindo, le aveva proposto di sposarlo, la madre di lei l’aveva praticamente obbligata ad accettare. È, come non hanno mancato di notare molti critici, una situazione che riecheggia quella da cui prende avvio una famosa commedia moratiniana, El sí de las niñas: una madre «vulgar, de cortas luces y de instintos groseros» (Valera, , p. ) che sacrifica la figlia al suo desiderio di miglioramento economico. Pepita ha sposato quindi don Gumersindo e la sua vita matrimoniale è durata in pace e armonia per tre anni, finché la morte del marito l’ha lasciata nuovamente libera e ricca. Anche Tristana, come Pepita, è orfana di padre, e la morte di questi ha lasciato lei e la madre in assoluta povertà; Galdós sceglie tuttavia un modo più sottile e ironico di presentare i rapporti fra la madre, la figlia e l’uomo più anziano con cui questa inizia la sua vita di donna. Tutt’altro che volgare e «de cortas luces», la madre di Tristana è anzi stata, da giovane, un’intellettuale che scriveva versi e amava il teatro; la disgrazia familiare la sprofonda però nella follia, ed è questa follia a spingere indirettamente la figlia nelle braccia di don Lope, l’amico d’infanzia del marito che con il suo aiuto economico ha permesso alle due donne di sopravvivere. Consumata dalle sue stranezze, in punto di morte doña Josefina raccomanda Tristana a Don Lope; questi porta la ragazza a vivere con sé e «a los dos meses de llevársela aumentó con ella la lista ya larguísima de sus batallas ganadas a la inocencia» (Pérez Galdós, , p. ). Presiede a questa unione una mescolanza di pulsioni erotiche e motivazioni economiche: infatti, don Lope ritiene Tristana una specie di compensa- MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’ OTTOCENTO zione per i sacrifici fatti per assecondare le manie della madre; Tristana, dal canto suo, accetta passivamente la situazione, proprio come la protagonista della commedia moratiniana e come Pepita Jiménez. La grande novità introdotta da Galdós nel trattamento del tema del «viejo y la niña» (così chiama i suoi protagonisti nel sesto capitolo, con il titolo di un’altra famosa commedia moratiniana sullo stesso tema) sta tuttavia proprio nell’irregolarità del loro legame; non avendo sposato Tristana, in quanto profondissimamente refrattario all’istituzione matrimoniale, don Lope non può vantare su di lei i diritti del marito, e i suoi tentativi di rivendicarli vengono percepiti da Tristana come grottesche e ingiuste pretese. Ciò fa anche sì che, quando nella sua vita si affaccia l’amore per un uomo più giovane, questo venga vissuto da lei come una liberazione e senza alcun senso di colpa. L’assenza del vincolo matrimoniale, per quanto abbia relegato Tristana in una sorta di limbo sociale, le permette di vivere il suo amore per Horacio con una libertà affatto insolita per le protagoniste romanzesche dell’epoca. In questo senso, la situazione di Tristana è in parte analoga a quella di Pepita Jiménez dopo la sua vedovanza; e, di fatto, anche Pepita Jiménez, quando incontra don Luis e per la prima volta sperimenta la passione amorosa, mette in atto tutto quanto è in suo potere per realizzare questo amore. Per entrambe le protagoniste, l’innamoramento per un uomo giovane, bello, che immaginano ardente di ideali, si contrappone al rapporto con un uomo più anziano, caratterizzato in entrambi i casi, seppure con sfumature diverse, come un dongiovanni dalla grande esperienza mondana condita da una buona dose di cinismo. Il triangolo amoroso che viene a crearsi si carica così delle contrastanti connotazioni, non solo dell’età (giovane vs vecchio) ma anche, in modo più complesso e senz’altro più moderno rispetto all’impostazione moratiniana, di un confronto-scontro fra idealismo e materialismo. Quasi ad apertura di libro, il lettore di Pepita Jiménez viene a sapere, dalla prima lettera di don Luis, che il padre di questi, don Pedro, maturo possidente di cinquantacinque anni, vorrebbe sposare la ventenne Pepita Jiménez. Pepita viene quindi a trovarsi in una situazione che, potenzialmente, le farebbe riprendere il ruolo della moglie giovane di un marito anziano, ruolo da lei già impersonato nei tre anni durante i quali è stata sposata a don Gumersindo. Stavolta, però, non ha più una madre accanto a obbligarla e, potendo decidere in prima persona, si mostra affabile con il suo pretendente ma senza dargli speranze concrete. In questa fase, Pepita giustifica il suo rifiuto con l’inclinazione che prova per la vita spirituale e religiosa; tuttavia, dimostrando una grande capacità di introspezione, sospetta che questa inclinazione non nasca da vera pietà religiosa quanto piuttosto dal disdegno per il mondo che la circonda e che lei sente inferiore a sé. Anche don Pedro, il suo maturo pretendente, lo ha capito benissimo, seppure in termini forse più spicci, e lo esprime a suo figlio già prima che questi riporti gli scrupoli di Pepita così come gli vengono riferiti, in forma anonima, dal Vicario: La culpa de los desvíos de Pepita, decía mi padre, es sin duda su orgullo, orgullo en gran parte fundado; ella es naturalmente elegante, distinguida; es un ser superior por la voluntad y por la inteligencia, por más que con modestia lo disimule; ¿cómo, pues, ha de entregar su corazón a los palurdos que la han pretendido hasta ahora? Ella imagina que su alma está llena de un místico amor a Dios, y que sólo con Dios se satisface, porque no ha salido a su paso todavía un mortal bastante discreto y agradable que le haga olvidar a su niño Jesús. Aunque sea inmodestia, añadía mi padre, yo me lisonjeo aún de ser ese mortal dichoso (Valera, , p. ). FAUSTA ANTONUCCI Questo mortale non sarà tuttavia, com’egli spera, don Pedro, bensì suo figlio don Luis, che susciterà l’amore di Pepita per le sue doti, così diverse da quelle di suo padre: giovane, colto, ingenuo, fervidamente religioso, puro di cuore. Nonostante ciò, don Pedro, proprio come il don Diego di El sí de las niñas, non è geloso del rivale più giovane e fortunato: forse anche in ragione della consanguineità, riesce a superare i sentimenti negativi per far posto alla rinuncia generosa. Senza troppe difficoltà, passa dal desiderare per sé il ruolo di marito, all’immaginare e prefigurare quello di nonno: il che equivale a dire che decide di assumere, anche nei confronti di Pepita, il ruolo di padre; e questo suo farsi da parte contribuisce in maniera determinante allo scioglimento felice della vicenda dei due giovani. In Tristana, invece, il comportamento di don Lope è assai diverso e piú complesso: ibrido di padre e amante, don Lope è, tra i due, quello che gli conviene di più essere, a seconda delle circostanze. Quando Tristana lo rifiuta come amante, lui, per trattenerla, si trasforma in padre. Per questo, la paternità di don Lope, pur desiderata e auspicata più volte da Tristana come liberazione da un rapporto per il quale prova ripugnanza, ha i caratteri castranti dell’incesto, in quanto porta di fatto la protagonista, prima a rifiutare la proposta di matrimonio di Horacio e, infine, al termine di un percorso di progressiva infelicità e annullamento di sé, a sposare il suo seduttore, ormai anziano e fisicamente decaduto. Né d’altronde si tratta di un matrimonio tanto dissimmetrico dal punto di vista della vitalità fisica, perché Tristana, mutilata di una gamba, si è trasformata anche nell’aspetto, dimagrito e trascurato, tale da farla sembrare una donna di quarant’anni. È evidente la pesante ironia che Galdós mette in opera, facendo sì che i suoi due personaggi, entrambi, per ragioni diverse, refrattari al matrimonio e proiettati verso tutt’altre ambizioni, finiscano sposati l’uno con l’altra quando ormai la loro vitalità è decaduta e le loro pulsioni erotiche sono spente, sostituite entrambe da occupazioni tanto prosaiche e quotidiane come l’allevamento di galline e l’arte culinaria. Dall’orgoglio alla conciliazione fra realtà e ideale: il percorso parallelo di Pepita Jiménez e di don Luis de Vargas Abbiamo già avuto modo di citare quei passi di Pepita Jiménez nei quali si diagnostica il motivo profondo del rifiuto della protagonista a risposarsi: amor proprio e orgoglio, che la fanno sentire superiore ai suoi pretendenti. L’identificazione iniziale di Pepita nel polo euforico dell’antinomia alto-basso si capovolge tuttavia radicalmente con il suo innamoramento per don Luis, che la spinge ad assumere una visione di sé che incorpora valori tradizionalmente connessi con la femminilità come l’umiltà e la sottomissione. Ecco come, di fronte al padre Vicario, la protagonista espone il suo concetto, spazialmente e assiologicamente orientato, della relazione tra sé e don Luis: ¿Cómo, por más esfuerzos que hiciera, habría yo de elevarme hasta él, y comprenderle, y poner en perfecta comunicación mi espíritu con el suyo? Yo soy zafia aldeana, inculta, necia; él no hay ciencia que no comprenda, ni arcano que ignore, ni esfera encumbrada del mundo intelectual a donde no suba. Allá se remonta en alas de su genio, y a mí, pobre y vulgar mujer, me deja por acá, en este bajo suelo… (ivi, p. ). MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’ OTTOCENTO Un concetto che trova esatta corrispondenza nel sentire di don Luis, per il quale cedere all’amore per Pepita significherebbe non soltanto tradire la sua vocazione religiosa, ma anche abbassarsi, scendere in gerarchia davanti a se stesso e davanti agli uomini: Pensaba luego don Luis en la alteza soberana de la dignidad del sacerdocio a que estaba llamado, y la veía por cima de todas las instituciones y de las míseras coronas de la tierra […]. ¿Cómo por el liviano incentivo de una mozuela, por una lagrimilla quizás mentida, despreciar esa dignidad augusta, esa potestad que Dios no concedió ni a los arcángeles que están más cerca de su trono? ¿Cómo bajar a confundirse entre la obscura plebe, y ser uno del rebaño, cuando ya soñaba ser pastor […]? Cuando don Luis reflexionaba sobre todo esto, se elevaba su espíritu, se encumbraba por cima de las nubes en la región empírea y la pobre Pepita Jiménez quedaba allá muy lejos, y apenas si él la veía (ivi, pp. -). Il cammino verso la realizzazione dell’amore è dunque, per entrambi i protagonisti, anche un apprendistato di umiltà, e, soprattutto per don Luis, una ridefinizione sostanziale delle sue ambizioni, dei suoi ideali. Infatti, mentre le aspirazioni di Pepita coincidono integralmente con la realizzazione del suo amore, don Luis si trova scisso fra la pulsione amorosa e l’ideale religioso che si è costruito. La conciliazione fra le istanze della realtà e quelle dell’ideale è molto più difficile per lui che per Pepita. Per quest’ultima, infatti, don Luis incarna la perfetta unità di reale e ideale, di anima e corpo; anzi, è solo attraverso la forma sensibile e tangibile che Pepita riesce a percepire lo spirito, e lo dichiara in maniera efficacissima replicando alle vane esortazioni di don Luis a vivere il loro amore in forma esclusivamente spirituale: ¡Ay, señor don Luis! […] Lo declararé todo, desechando hasta la vergüenza. Soy una pecadora infernal. Mi espíritu grosero e inculto no alcanza esas sutilezas, esas distinciones, esos refinamientos de amor. Mi voluntad rebelde se niega a lo que usted propone. Yo ni siquiera concibo a usted sin usted. Para mí es usted su boca, sus ojos, sus negros cabellos, que deseo acariciar con mis manos; su dulce voz y el regalado acento de sus palabras que hieren y encantan materialmente mis oídos; toda su forma corporal, en suma, que me enamora y seduce, y al través de la cual, y sólo al través de la cual se me muestra el espíritu invisible, vago y lleno de misterios. […] Yo amo en usted, ya no sólo el alma, sino el cuerpo, y la sombra del cuerpo, y el reflejo del cuerpo en los espejos y en el agua, y el nombre y el apellido, y la sangre… (ivi, pp. -). Al contrario, don Luis tenta continuamente, fino al momento climatico dell’incontro notturno con Pepita la vigilia di San Giovanni, di eludere la fisicità del suo amore travestendolo da mero incontro di anime. Nel tentativo di spiritualizzare una sostanza molto più materiale e terrena, ricorre continuamente alle immagini e ai testi del misticismo; ma alla fine sarà costretto ad ammettere l’inconsistenza e l’assurdità di questo tentativo, accettando una sconfitta dovuta alla scarsa autenticità della sua vocazione. Il tramite indispensabile per questa conciliazione fra ideale e reale, seppure problematica e dolorosa, è indubbiamente Pepita; tuttavia, non va trascurato il ruolo che svolge a questo riguardo il padre del protagonista, che, come si apprenderà alla fine di Paralipómenos, è stato il regista occulto dell’avvicinamento sempre crescente fra Pepita e don Luis. È don Pedro il responsabile di quella che possiamo definire educazione mondana di don Luis, un’educazione che completa quella libre- FAUSTA ANTONUCCI sca e astratta ricevuta dallo zio sacerdote, e il cui percorso ci viene tracciato nelle lettere del protagonista che compongono la prima parte del romanzo. L’apprendistato dell’equitazione, e la conoscenza dei giochi da tavolo che fanno parte degli intrattenimenti sociali, sono le due tappe fondamentali di questo processo che serve a far sì che don Luis non si senta più così diverso ed estraneo rispetto alla società che lo circonda. Di fatto, sono abilità che lo preparano al ruolo, molto diverso da quello che aveva immaginato inizialmente per sé, di ricco proprietario terriero, sposo felice e padre di famiglia. Il mutamento di ruolo, benché accompagnato dalla felicità dell’amore realizzato, non è indolore: nel romanzo si insiste più volte sulla malinconia che sommerge don Luis quando considera «el rebajamiento del ideal con que había soñado»; la sua vita attuale gli appare allora «vulgar, egoísta y prosaica, comparada con la vida de sacrificio, con la existencia espiritual a que se creyó llamado en los primeros años de su juventud» (ivi, p. ). Ma, d’altra parte, don Luis comprende anche «que el hombre puede servir a Dios en todos los estados y condiciones»; e realizza con Pepita l’ideale «más humilde y fácil» con cui si era proposto di sostituire «el antiguo y encumbrado ideal»: […] renovar con Pepita Jiménez, en nuestra edad prosaica y descreída, la edad venturosa y el piadosísimo ejemplo de Filemón y de Baucis, tejiendo un dechado de vida patriarcal en aquellos campos amenos, fundando en el lugar que le vio nacer un hogar doméstico, lleno de religión, que fuese a la vez asilo de menesterosos, centro de cultura y de amistosa convivencia, y limpio espejo donde pudieran mirarse las familias (ivi, p. ). E proprio questo è ciò che i due sposi realizzano, stando a quanto raccontano le lettere di don Pedro che chiudono il romanzo: Así como el afecto que se tienen y la ternura y cordialidad con que se tratan y tratan a todo el mundo ejercen aquí benéfica influencia en las costumbres, así la elegancia y el buen gusto con que acabarán ahora de ordenar su casa servirán de mucho para que la cultura exterior cunda y se extienda (ivi, p. ). Se la Chiesa ha perso un sacerdote, la società ha acquistato un cittadino esemplare, modello di virtù laiche, perfetto rappresentante di un’élite che sa assumersi, nei confronti della società rurale e periferica cui appartiene, un ruolo civilizzatore. E se quella di sacerdote sarebbe stata per definizione una vita solitaria, di rinuncia sentimentale e sessuale, la nuova vita di don Luis è, al contrario, una vita di socialità, nella quale l’amore coniugale ha un posto centrale. A questa centralità rimanda la conclusione del romanzo, giustamente sottolineata da molti critici, nella quale si descrivono alcuni significativi particolari della casa dei due sposi: i quadri di soggetto profano e amoroso che adornano il cenador del giardino (Psiche che contempla Cupido addormentato, Dafni che cerca di togliere dal seno di Cloe la cicala che vi si è rifugiata) e la copia marmorea della Venere dei Medici, che «ocupa el preferente lugar, y como que preside la sala. En el pedestal tiene grabados, en letras de oro, estos versos de Lucrecio: Nec sine te quidquam dias in luminis oras / Exoritur, neque fit laetum, neque amabile quidquam» (ivi, p. ). L’invocazione lucreziana alla Venere genitrice suggella l’idillio dei due protagonisti che, non lo si dimenticherà, è già stato allietato dalla nascita di un figlio; quel MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’ OTTOCENTO figlio il cui desiderio Pepita sublimava nell’adorazione del Gesù bambino cui aveva dedicato un altarino in casa sua: «El padre Vicario dice que Pepita adora al niño Jesús como a su Dios, pero que le ama con las entrañas maternales con que amaría a un hijo, si le tuviese…» (ivi, p. ). Troviamo dunque, in questo passaggio di Pepita da una maternità sublimata a una maternità effettiva e carnale, un’ulteriore conferma delle analogie fra il tragitto della protagonista e quello di don Luis. Anche lei, seppure in modo meno sofferto, più immediato e impulsivo, è passata da una devozione religiosa ardente – che tuttavia era basata più che altro, non solo sull’amor proprio e l’orgoglio, ma anche sull’assenza di un degno oggetto di amore terreno – a un amore umano che unisce anima e corpo, spirito e carne, secondo un ideale tipico di Valera e da lui espresso anche in altri romanzi. Un ideale in cui la procreazione ha un posto centrale, e non è dunque un caso che la coppia protagonista generi subito un figlio e che il romanzo si concluda, come dicevamo, con i versi dedicati da Lucrezio alla dea dell’amore terreno, senza la quale «nulla emerge alle divine sponde della luce». Tristana: l’ambizione come trappola e il conflitto irrisolto tra realtà e ideale Come abbiamo già ricordato, il percorso di Tristana può sembrare, fino a un certo punto, analogo a quello di Pepita Jiménez: l’incontro con un uomo giovane con il quale vivere un amore condiviso e appassionato, che si contrappone al rapporto con un uomo molto più anziano. Nel momento in cui si rende conto della situazione socialmente falsa e sentimentalmente insoddisfacente in cui l’ha messa la sua forzata convivenza con don Lope, Tristana sente risvegliarsi in sé un tumulto di sentimenti, tra i quali spiccano la coscienza del proprio valore e un orgoglio che in parte l’accomuna a Pepita Jiménez . Tuttavia, e a differenza di quello che notiamo nel personaggio di Valera, questo orgoglio, questa coscienza di sé e delle proprie capacità che nasce in Tristana già prima di conoscere Horacio, non si modifica con l’amore, ma al contrario si esalta e si acuisce. Mentre, come abbiamo notato, parlando di sé in rapporto a don Luis l’innamorata Pepita si collocava nel polo disforico dell’antinomia spaziale alto-basso, Tristana al contrario finisce col superare il suo amante in slanci e aspirazioni, in un processo di crescita interiore che capovolge l’usuale gerarchia fra i sessi: Estos alientos de artista, estos arranques de mujer superior, encantaban al buen Díaz, el cual, a poco de aquellos íntimos tratos, empezó a notar que la enamorada joven se iba creciendo a los ojos de él y le empequeñecía. En verdad que esto le causaba sorpresa, y casi casi empezaba a contrariarle, porque había soñado en Tristana la mujer subordinada al hombre en inteligencia y en voluntad, la esposa que vive de la savia moral e intelectual del esposo y que con los ojos y con el corazón de él vive y siente. Pero resultaba que la niña discurría por cuenta propia, lanzándose a los espacios libres del pensamiento, y demostraba las aspiraciones más audaces (Pérez Galdós, , p. ). È Tristana a trascinare con sé Horacio nelle eteree regioni dell’ideale, non viceversa; e l’amore goduto e realizzato non le impedisce di continuare a sognare un improbabile destino di donna libera, indipendente, affrancata dalle piccolezze di una quotidianità, che, per sua stessa ammissione, è assolutamente incapace di FAUSTA ANTONUCCI gestire. Quella capacità di conciliazione tra reale e ideale che è, come abbiamo visto, una caratteristica di Pepita Jiménez, e alla quale dolorosamente si converte anche don Luis con l’aiuto di lei, non è fra le doti di Tristana. È invece, per una curiosa inversione rispetto al romanzo di Valera, un’aspirazione di Horacio, che, nel suo desiderio di dare concretezza e futuro al loro legame, cerca continuamente di riportare Tristana in regioni a lui più accessibili, e anche più consone alla tradizionale divisione di ruoli fra uomo e donna. Horacio ammira Tristana e i suoi ideali, ma pensa anche alla realtà pratica: come conciliare il vivere quotidiano con «tal flujo de pensar temerario» (ivi, p. )? E con chi dei due vivrà il figlio che egli già desidera da lei, visto che Tristana rifiuta il matrimonio? Tristana afferma che il figlio vivrà con lei, perché sarà più suo che di Horacio: affermazione che provoca la prima seria discussione fra i due innamorati (ivi, pp. -). E quando Tristana torna a esprimere la sua «idea de conquistar mi independencia y de arreglármelas con mi ingenio como pueda», Horacio tenta di convertirla a una più tranquillizzante e praticabile sottomissione femminile: Tu deseo no puede ser más noble. […] Pero no te afanes, no te aferres tanto a esa aspiración, que podría resultar impracticable. Entrégate a mí sin reserva. ¡Ser mi compañera de toda la vida; ayudarme y sostenerme con tu cariño!… ¿Te parece que hay un oficio mejor ni arte más hermoso? Hacer feliz a un hombre que te hará feliz, ¿qué más? (ivi, p. ). Domande cui Tristana risponde riaffermando la sua assoluta incapacità di gestire le questioni pratiche della vita quotidiana, e formulando in chiusura di capitolo la seguente autodiagnosi: «Lo que he pensado de mí, estudiándome mucho, […] es que sirvo, que podré servir para las cosas grandes; pero que decididamente no sirvo para las pequeñas» (ivi, p. ). Non sarà certo un caso, dunque, che, in apertura del capitolo seguente, il narratore ci mostri un Horacio estenuato dal conflitto fra amore e incapacità di immaginarsi un futuro con la donna amata; un conflitto cui cerca sollievo temporaneo allontanandosi da Madrid per accompagnare un’anziana zia alla sua proprietà levantina di Villajoyosa. Tuttavia, il conflitto riesplode ben presto nello scambio epistolare che Horacio intrattiene con Tristana, rimasta a Madrid. Il giovane vuole l’amata vicino a sé, non si rassegna a «tener[la] aquí en espíritu», e le propone formalmente il matrimonio con parole da cui traspare il desiderio di convincere Tristana a unire poesia e quotidianità, spirito e realtà pratica: Dime que te gustará esta vida oscura y deliciosa; que amarás esta paz campestre; que aquí te curarás de las locas efervescencias que turban tu espíritu, y que anhelas ser una feliz y robusta villana, ricachona en medio de la sencillez y la abundancia, teniendo por maridillo al más chiflado de los artistas, al más espiritual habitante de esta tierra de luz, fecundidad y poesía (ivi, p. ). Tristana però non si fa convincere: la sua risposta alla lettera citata di Horacio è emblematica, e vale la pena di citarne alcuni passi. L’apertura è una presa in giro del topico della «vida retirada» (non a caso cita un verso dell’ode omonima di Fray Luis de León), della quale si censura la limitatezza degli orizzonti; una limitazione che Tristana esagera di proposito, accentuando gli aspetti degradanti che questa vita prosaica potrebbe avere su di lei e su Horacio: MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’ OTTOCENTO ¡Qué entusiasmadito y qué tonto está el señó Juan! […] Bien quisiera entusiasmarme con tu rustiquidad (ya sabes que yo invento palabras) que del oro y del cetro pone olvido. Hago lo que me mandas y te obedezco… hasta donde pueda. […] ¡Yo de villana, criando gallinitas, poniéndome cada día más gorda, hecha un animal, y con un dije que llaman maridillo colgado de la punta de la nariz! ¡Qué guapota estaré, y tú qué salado, con tus tomates tempranos y tus naranjas tardías, saliendo a coger langostinos, y pintando burros con zaragüelles, o personas racionales con albarda…, digo al revés! (ivi, p. ). Tristana non è fatta per questa vita, l’ambizione la divora e le fa sognare altri orizzonti: Oigo desde aquí las palomitas, y entiendo sus arrullos. Pregúntales por qué tengo yo esta ambición loca que no me deja vivir; por qué aspiro a lo imposible, y aspiraré siempre. […] Pregúntales por qué sueño despierta con mi propio ser transportado a otro mundo, en el cual me veo libre y honrada… (ivi, pp. -). E, subito di seguito, passa a raccontare a Horacio che don Lope, ormai fisicamente malandato, […] ha dado en la flor de entenderme, de estimar en algo este afán mío de aprender una profesión. ¡Pobre don Lepe! Antes se reía de mí; ahora me aplaude, y se arranca los pelos que le quedan, rabioso por no haber comprendido antes lo razonable de mi anhelo. Pues verás: haciendo un gran esfuerzo, me ha puesto profesor de inglés, digo, profesora, aunque más bien la creerías del género masculino o neutro; una señora alta, huesuda, andariega, con feísima cara… (ivi, p. ). Gli scambi epistolari successivi non fanno che riproporre, amplificandole, le diversità fra Horacio e Tristana nella visione del mondo e nella percezione dell’altro/a. Horacio insiste sugli aspetti piacevolmente prosaici della sua nuova vita, compiacendosi nell’abbassarsi («me están pesando mucho las carnazas») e cercando di richiamare a sé Tristana («no te encarames a las estrellas») (ivi, p. ). Tristana, che non vuole cambiare, lo prega di non legarla, di lasciarla libera («Déjame suelta, no me amarres…», ivi, p. ); e continua a parlargli di ciò che la entusiasma, in particolare dei suoi studi di inglese, ribadendo come adesso don Lope si sia trasformato per lei in un padre comprensivo: Se arrepiente de no haberme comprendido, de no haber cultivado mi inteligencia. Maldice su abandono… Pero aún es tiempo; aún podremos ganar el terreno perdido. Porque yo tenga una profesión que me permita ser honradamente libre, venderá él la camisa, si necesario fuese (ivi, p. ). Incapace di accettare la realtà cui la chiama il suo innamorato, Tristana si afferra disperatamente al suo ideale e cerca a sua volta di trascinare Horacio dalla sua parte: «No vaciles y déjate de gallinas y de vulgaridades estúpidas. ¡El arte! ¡La gloria, señó Juanico! Es la única rival de la que no tengo celos» (ivi, p. ). Nella lettera successiva, gli racconterà di soffrire per un forte dolore alla gamba: è iniziata la malattia che porterà Tristana all’amputazione, alla mortificazione fisica, alla prigionia definitiva in casa di don Lope. L’organizzazione del racconto non lascia adito a FAUSTA ANTONUCCI dubbi: Galdós ha dotato il rifiuto di Tristana alle proposte di Horacio e l’inizio della sua malattia di una contiguità testuale che adombra, nella costruzione del significato, un rapporto di causalità. E difatti: il comportamento di don Lope, che all’improvviso si manifesta così comprensivo e disponibile verso le aspirazioni di Tristana, serve a rafforzarla in questo rifiuto. E dunque, tutte le conoscenze che Tristana assorbe con tanta avidità nella sua lontananza da Horacio, non servono, contrariamente a quello che lei ingenuamente pensa, a renderla libera, bensì a legarla ulteriormente al suo tiranno, proprio come il dolore alla gamba, «porque la cojera es como un grillete que la sujeta más a su malditísima persona…» (ivi, p. ). La conferma di questa intuizione ci arriva poco più avanti, in un monologo di don Lope di cui vale la pena citare la parte finale: La querré como hija, la defenderé contra todos, contra las formas y especies varias de amor, ya sea con matrimonio, ya sin él… Y ahora, ¡por vida de…!, ahora me da la gana de ser su padre, y de guardarla para mí solo, para mí solo, pues aún pienso vivir muchos años, y si no me cuadra retenerla como mujer, la retendré como hija querida; pero que nadie la toque, ¡vive Dios!, nadie la mire siquiera (ivi, p. ). Detto, fatto: sospettando che l’innamorato di Tristana le abbia proposto il matrimonio, don Lope si dedica a distruggere nella mente della ragazza questa prospettiva, con parole non molto diverse da quelle che già Tristana aveva usato con Horacio (e d’altronde, fin dalle prime pagine del romanzo il narratore ci fa sapere che la contrarietà al matrimonio è un’idea di don Lope che Tristana, nella sua ingenuità e malleabilità, ha assorbito passivamente da lui). Come alternativa, la adula e le prospetta un destino glorioso: Has nacido para algo muy grande, que no podemos precisar aún. El matrimonio te zambulliría en la vulgaridad. Tú no puedes ni debes ser de nadie, sino de ti misma. Esa idea tuya de la honradez libre, consagrada a una profesión noble; esa idea que yo no supe apreciar antes y que al fin me ha conquistado, demuestra la profunda lógica de tu vocación, de tu ambición diré, si quieres. Ambicionas porque vales (ivi, p. ). Ed è questa ambizione che di fatto perde Tristana, come donna e come creatura di questa terra; il volo della sua mente verso regioni sempre più eteree (dall’inglese, alla pittura, alla musica, alla devozione religiosa) ha come contraltare la mutilazione e l’invecchiamento del suo corpo, del quale d’altronde non le importa più nulla. Tristana percorre, insomma, un cammino del tutto inverso a quello seguito da don Luis in Pepita Jiménez : invece di riconciliare anima e corpo, spirito e realtà, in lei il divorzio fra realtà e ideale si fa sempre più accentuato, comporta l’annullamento della fisicità, e in ultima analisi perfino l’annullamento della sua individualità di persona, se è vero che alla fine tutto le è indifferente, persino sposarsi e ritrovarsi a compiere quei gesti prosaici e quotidiani che tanto le ripugnavano ai tempi del suo amore felice con Horacio. Di fatto, ha assecondato in pieno, pur senza saperlo, i propositi di don Lope, si è desessualizzata, è regredita da donna a figlia; ed è dunque naturale e ovvio che, contrariamente a Pepita Jiménez, Tristana non sia una madre né, anzi, desideri mai davvero esserlo. È illuminante a questo proposito la risposta che dà a Horacio quando questi le manifesta il suo desiderio di paternità: MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’ OTTOCENTO ¡Ay! No, no; le querría yo tanto [a un hijo], que me moriría de pena si me le quitaba Dios. Porque se mueren todos […]. ¿No ves pasar continuamente los carros fúnebres con las cajitas blancas? ¡Me da una tristeza!… Ni sé para qué permite Dios que vengan al mundo, si tan pronto se los ha de llevar… No, no; niño nacido es niño muerto…, y el nuestro se moriría también. Más vale que no lo tengamos (ivi, p. ). Vale la pena tornare, a questo punto, all’ultima lettera di Horacio a Tristana, nella quale lui la prega di non farsi contagiare dalla «fealdad seca y hombruna» della sua insegnante di inglese (ivi, p. ). A partire da questo momento, il dialogo fra i due innamorati si interrompe, e il lettore conoscerà solo le lettere di Tristana, espressioni di quello che appare ormai come un lungo e a volte delirante monologo. Ebbene, nella lettera di risposta a quella di Horacio appena ricordata, Tristana racconta di aver iniziato a leggere Shakespeare con la guida della sua insegnante: Me dio a escoger, y elegí el Macbeth, porque aquella señora de Macbeth me ha sido siempre muy simpática. Es mi amiga… En fin, que le metimos el diente a la tragedia. Las brujitas me han dicido que seré reina…, y yo me lo creo. Pero, en fin, ello es que estamos traduciendo. ¡Ay, hijo, aquella exclamación de la señá Macbeth, cuando grita al cielo con toda su alma: Unsex me here, me hace estremecer y despierta no sé qué terribles emociones en lo más profundo de mi naturaleza! (Ivi, p. ). Queste frasi costituiscono un nodo particolarmente significativo per la comprensione del significato del romanzo. Tristana si è avvicinata alla tragedia; e di fatto di qui a poco la sua vita sprofonderà nella tragedia della malattia. Tristana prova simpatia per Lady Macbeth, simpatia in senso etimologico, perché soffre delle sue stesse passioni: ambizione sfrenata, desiderio di desessualizzarsi per poter fare ciò che il suo uomo esita a fare… Tuttavia, mentre la colpa di Lady Macbeth sta nell’aver istigato a uccidere il re, vertice dell’ordine sociale e, ai suoi occhi, immagine del padre, la colpa di Tristana è, al contrario, quella di non essere riuscita a uccidere, nemmeno simbolicamente, l’ambigua figura paterna che è per lei don Lope. Tristana dice inoltre che le streghe le hanno detto che sarebbe diventata regina… Ma le streghe della tragedia shakespeariana profetizzano un destino regale a Macbeth, non a sua moglie. Questa confusione, non sappiamo se deliberata o inconscia, di Tristana, ci mette sulla pista di un’equivalenza assai significativa, costruita anch’essa sullo scambio di ruoli: così come Macbeth è stato istigato da sua moglie al regicidio che inaugura una serie di atroci delitti motivati dall’ambizione, anche Tristana viene istigata, al delitto simbolico di cui dicevo più sopra, dall’amante-padre che è per lei don Lope. E così come la coppia protagonista della tragedia di Shakespeare condivide il destino avvelenato frutto della complicità nel delitto, anche la coppia formata da Tristana e da don Lope condivide una pena che, nel loro caso, e nel quadro di un abbassamento della tragedia a dramma borghese, consiste nella perdita di tutti gli ideali e le aspirazioni di cui si erano nutriti. Dal rifiuto del matrimonio si passa a un matrimonio di convenienza, dalla rivendicazione della libertà sessuale si passa all’annullamento del corpo e delle sue pulsioni, dal disprezzo per le prosaiche attività del buon borghese proprietario e per i saperi domestici si passa a coltivare un orticello, allevare galline e cucinare buoni dolci… Se dunque nell’epilogo di Pepita Jiménez il narratore può concludere, ricalcando il finale delle fiabe, che don Luis e Pepita «vivieron largos años, gozando de cuanta felicidad y paz caben en la tierra» (Valera, , p. ), il narratore di Tristana non FAUSTA ANTONUCCI può che chiudere il suo romanzo in modo molto più problematico e aperto: «¿Eran felices uno y otro? Tal vez». Dall’ottimismo positivista al pessimismo finisecolare Come si conviene al modello realista al quale, anche se in modi diversi, i due romanzi fanno riferimento, entrambi i narratori offrono una descrizione fisica assai dettagliata delle loro protagoniste. Poco si somigliano peraltro Pepita Jiménez, bionda con gli occhi verdi, e Tristana, dagli occhi neri e i capelli castani; un tratto almeno però lo hanno in comune, la bellezza e candore delle mani: […] las manos de esta Pepita, que parecen casi diáfanas como el alabastro, si bien con leves tintas rosadas […]; estas manos, digo, de dedos afilados y de sin par corrección de dibujo, parecen el símbolo del imperio mágico, del dominio misterioso que tiene y ejerce el espíritu humano […]. Imposible parece que quien tiene manos como Pepita tenga pensamiento impuro, ni idea grosera, ni proyecto ruin que esté en discordancia con las limpias manos que deben ejecutarle (ivi, p. ). Sus manos, de una forma perfecta – ¡qué manos! –, tenían misteriosa virtud, como su cuerpo y ropa, para poder decir a las capas inferiores del mundo físico: la vostra miseria non mi tange. Llevaba en toda su persona la impresión de un aseo intrínseco, elemental, superior y anterior a cualquier contacto de cosa desaseada o impura. […] De papel nítido era su rostro blanco mate, de papel su vestido, de papel sus finísimas, torneadas, incomparables manos (Pérez Galdós, , p. ). In entrambe le descrizioni emerge con forza la contrapposizione fra il bianco di queste mani perfette e la sporcizia, l’impurità che sono in agguato nel mondo esterno ma che non potrebbero mai macchiare quelle mani; mani che diventano, nella percezione del narratore (e del lettore), riprova fisica della purezza spirituale della protagonista, della sua superiorità rispetto alle bassezze della vita. Se il punto di partenza è analogo, la traiettoria evolutiva delle due donne è tuttavia, come abbiamo avuto modo di vedere, opposta. Pepita, pur senza tradire il suo idealismo e la sua spiritualità, non perde mai di vista l’importanza degli aspetti più fisici e concreti della vita, per sé e per don Luis; mentre Tristana si allontana sempre di più da questi ultimi per inseguire un ideale vago e imprecisato, che si identificherà, alla fine del suo percorso, con Dio. La mutilazione di Tristana allude dunque simbolicamente, non solo alla definitiva prigionia cui verrà costretta in casa di don Lope per l’impossibilità di muoversi, ma, anche e forse soprattutto, all’escissione di una parte di sé, quella che coincide con il suo essere sessuato. Ecco allora che la vita matrimoniale, che in Pepita Jiménez viene presentata come un idillio luminoso, appena velato da una malinconia riscattata da un forte senso di costruttivo laicismo, in Tristana diventa l’unione sterile e forzata di due esseri che non sono riusciti a trovare un termine medio fra l’aspirazione a un ideale ultraterreno e il basso prosaismo quotidiano del piccolo borghese. Insomma, il matrimonio fra Tristana e don Lope sembra a tutti gli effetti una parodia del modello tratteggiato da Juan Valera nel descrivere la vita matrimoniale di Pepita e don Luis. È evidente che i vent’anni intercorsi fra la stesura di Pepita Jiménez e quella di Tristana, al di là delle differenze di carattere fra i due autori, favoriscono una mag- MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’ OTTOCENTO gior sensibilità di Galdós al pessimismo finisecolare, all’acuta percezione di una caduta delle illusioni positive, di una perdita di fiducia nella possibilità umana di dirigere il proprio destino. In particolare, credo che si possa cogliere, nella vicenda di Tristana, un’anticipazione di problematiche che verranno poi più ampiamente e diversamente sviluppate da Baroja, attraverso un protagonista maschile, in El árbol de la ciencia (). Di fatto, l’educazione che Tristana riceve grazie ai buoni uffici di don Lope, e che inizia dopo la partenza di Horacio da Madrid, è per lei un frutto avvelenato, come quello biblico dell’albero del bene e del male che dà il titolo al romanzo di Baroja, perché, invece di aiutarla a ottenere quell’indipendenza cui lei aspira con tanta forza, la lega per sempre al suo tiranno. Non è facile tuttavia capire quali intenzioni ideologiche abbiano guidato Galdós nel costruire la traiettoria discendente della sua protagonista. Da un lato, la sete di conoscenza di Tristana viene ripetutamente messa in rapporto con l’orgoglio e l’ambizione, e dunque si potrebbe dire che è un frutto avvelenato perché le impedisce di assecondare il suo destino “naturale” di sposa e madre; quello cui invece accede Pepita, che al contrario di Tristana accetta la sua inferiorità culturale rispetto all’uomo amato, e ne viene remunerata con la felicità. D’altro canto, si può dire anche, con altrettante prove testuali, che la conoscenza è per Tristana un frutto avvelenato per colpa dell’egoismo del suo amante-padrone, e che la protagonista subisce la triste sorte dei precursori, condannati a soccombere di fronte a una società che non è ancora matura per le loro utopie, come succede all’Andrés de El árbol de la ciencia barojiano. Entrambe le interpretazioni trovano riscontro nel testo, e gli conferiscono uno spessore e un’ambiguità che non hanno nulla a che vedere con la limpida e univoca intenzione ideologica di Pepita Jiménez; probabilmente, la loro compresenza riflette la contraddizione che doveva agitarsi nella mente di chi, con l’apertura dell’intellettuale ma anche con gli inevitabili pregiudizi del proprio sesso, si misurava con le prime rivendicazioni femminili per una maggiore parità fra uomo e donna. Note . Intitolare il romanzo al nome del protagonista è, si sa, un tratto caratteristico del genere fin dai tempi dei libri di cavalleria: dall’Amadís de Gaula si dipartono, per imitazione o per parodia, tanto le infinite serie di Amadís de Grecia, Felixmarte de Hircania, Florisel de Niquea, quanto i ben più famosi e importanti Lazarillo de Tormes e Don Quijote de la Mancha; e si potrebbe continuare a ricordare altri titoli analoghi, da Robinson Crusoe a Tom Jones al Wilhelm Meister. Meno numerosi, i titoli che richiamano il nome di una protagonista: in questo caso, se si vuole prescindere da La Celestina, intitolazione che come si sa non è frutto della volontà di Fernando de Rojas ma di quella degli editori successivi, bisognerà arrivare fino alla Moll Flanders di Defoe, per poi, su tutt’altra tipologia di personaggio, passando per la Pamela di Richardson e la Jane Eyre di Charlotte Brontë, approdare alle grandi eroine tragiche del romanzo realista: Madame Bovary e Anna Karenina. Sia Valera sia Galdós sembrano particolarmente affezionati a questa tipologia di intitolazione: per il primo, oltre a Pepita Jiménez abbiamo anche Juanita la larga; per il secondo, ricordiamo almeno Doña Perfecta, Gloria, Fortunata y Jacinta, Marianela. . Quest’ultimo tratto distanzia radicalmente sia Pepita Jiménez sia Tristana da un’altra grande protagonista del romanzo spagnolo di questi anni, Ana Ozores (protagonista di La Regenta di Clarín). La traiettoria di questo personaggio, per quanto condivida con Pepita Jiménez e Tristana i primi due tratti caratteristici elencati, risulta non paragonabile anche in quanto nella vicenda di Ana entra in gioco la problematica dell’adulterio, estranea ai due romanzi di cui ci stiamo occupando. FAUSTA ANTONUCCI . Sul rapporto, personale e letterario, fra i due scrittori, cfr. almeno Ontañón de Lope () e Aguinaga Alfonso (). . «Dígase lo que se quiera – argüía para su capote, recordando sus sacrificios por sostener a la madre y salvar de la deshonra al papá –, bien me la he ganado» (Pérez Galdós, , p. ). . «[…] al llegar la noche, cuando el viejo y la niña se quedaban solos…» (ivi, p. ). . «En rigor de verdad [dice Tristana a Horacio in uno dei loro incontri] debo parecerte ya menos culpable, porque no soy adúltera; no engaño sino a quien no tiene derecho a tiranizarme. Mi infidelidad no es tal infidelidad, ¿qué te parece?, sino castigo de su infamia; y este agravio que de mí recibe se lo tiene merecido» (ivi, p. ). . «Mi padre no está más adelantado ni ha salido mejor librado, según dicen, que los demás pretendientes; pero Pepita, para cumplir el refrán de que no quita lo cortés a lo valiente, se esmera en mostrarle la amistad más franca, afectuosa y desinteresada» (Valera, , p. ). . «Amar a Dios sobre todas las cosas, buscarle en el centro del alma donde está, purificarse de todas las pasiones y afecciones terrenales para unirse a Él, son ciertamente anhelos piadosos y determinaciones buenas; pero el escrúpulo está en saber, en calcular si nacerán o no de un amor propio exagerado. ¿Nacerán acaso, parece que piensa la penitente, de que yo, aunque indigna y pecadora, presumo que vale más mi alma que las almas de mis semejantes; que la hermosura interior de mi mente y de mi voluntad se turbaría y se empañaría con el afecto de los seres humanos que conozco y que creo que no me merecen?» (ivi, pp. -). . «La misma puntita de vanidad, lastimada por sus desdenes [di Pepita], se embota ya al considerar que si no me ama, ama mi sangre, se prenda del hijo mío» (ivi, p. ). . Impossibile da citare per la sua estensione, ma centrale per la definizione del comportamento di don Pedro e delle ragioni della sua rinuncia, è la sua lettera al fratello Deán, riportata nella parte finale di Paralipómenos, la seconda delle tre sezioni di cui si compone il romanzo (ivi, pp. -). . «Oyó Díaz estas cosas con indignación primero, con asombro después, y lo único que se le ocurrió decir a su amada fue que debía romper cuanto antes aquellas nefandas relaciones, a lo que contestó la niña muy acongojada que esto era más fácil de decir que de practicar, pues el muy ladino, cuando advertía en ella síntomas de hastío y pruritos de separación, se las echaba de padre, mostrándose tiránicamente cariñoso» (Pérez Galdós, , p. ); «En último caso [dice don Lope a Tristana quando sospetta del suo idillio con Horacio], yo me revisto de autoridad para apartarte de un extravío, y si otra cosa no te gusta, me declaro padre, porque como padre tendré que tratarte si es preciso» (ivi, p. ); e ancora: «Pues no te suelto, no. Te estimo demasiado para entregarte a los azares de lo desconocido y a las aventuras peligrosas. Eres una inocentona sin juicio. Yo puedo haber sido para ti un mal padre. Pues mira, ahora se me antoja ser padre bueno» (ivi, p. ). . «Y lo raro es – decía la niña, a solas con su pasión y su conciencia – que si este hombre comprendiera que no puedo quererle, si borrase la palabra amor de nuestras relaciones, y estableciera entre los dos… otro parentesco, yo le querría, sí señor, le querría, no sé cómo, como se quiere a un buen amigo, porque él no es malo, fuera de la perversidad monomaníaca de la persecución de mujeres» (ivi, p. ); e confessa a Horacio: «A veces paréceme que le aborrezco, que siento hacia él un odio tan grande como el mal que me hizo; a veces…, todo te lo confieso, todo…, siento hacia él cierto cariño, como de hija, y me parece que si él me tratara como debe, como un padre, yo le querría…» (ivi, p. ). . «Cuando don Lope notó esta nueva fase de sus costumbres seniles, ya no se hallaba en condiciones de poder apreciar lo extraño de tal cambio. Anublóse su entendimiento; su cuerpo envejeció con terrible presteza; arrastraba los pies como un octogenario, y la cabeza y manos le temblaban» (ivi, p. ). . «Al año de la operación, su rostro había adelgazado tanto, que muchos que en sus buenos tiempos la trataron apenas la conocían ya, al verla pasar en el cochecillo. Representaba cuarenta años cuando apenas tenía veinticinco» (ivi, p. ). . Come risulterà evidente anche dalle pagine seguenti, la mia interpretazione del significato di questo matrimonio è radicalmente opposta a quella che ne offre Livingstone, , per il quale rappresenta il rientro dei protagonisti in un ordine naturale da cui entrambi si erano discostati con il loro rifiuto iniziale del matrimonio. . «Yo había soñado una vida venturosa al lado de este hombre que me enamora; yo me veía ya elevada hasta él por obra milagrosa del amor; mi pobre inteligencia en comunión perfectísima MODELLI FEMMINILI NEL ROMANZO SPAGNOLO DELL’ OTTOCENTO con su inteligencia sublime; mi voluntad siendo una con la suya; con el mismo pensamiento ambos; latiendo nuestros corazones acordes. ¡Dios me lo quita y se lo lleva, y yo me quedo sola, sin esperanza ni consuelo!» (Valera, , p. ). . «En cuanto a lo que él llamaba su caída, antes de caer, fuerza es confesar que le parecía poco honda y poco espantosa después de haber caído. Su misticismo, bien estudiado con la nueva luz que acababa de adquirir, se le antojó que no había tenido ser ni consistencia; que había sido un producto artificial y vano de sus lecturas, de su petulancia de muchacho y de sus ternuras sin objeto de colegial inocente. […] Todo había sido presunción suya» (ivi, p. ). . Come lo ha d’altronde nell’altro romanzo della vecchiaia di Valera, Juanita la larga, anch’esso intitolato col nome della protagonista, nel quale si può leggere un’opposizione di modelli coniugali: quello, privo di affetti e di moralità profonda, che lega doña Inés e don Álvaro, e quello, fondato sull’amore e il rispetto reciproci, che lega Juanita e don Paco. . «[…] notó en sí algo que se le había colado de rondón por las puertas del alma, orgullo, conciencia de no ser una persona vulgar» (Pérez Galdós, , p. ). . «Subyugado por tanta firmeza, Horacio se mostraba más amante cada día, reforzando el amor con la admiración. Al contacto de la fantasía exuberante de ella, despertáronse en él poderosas energías de la mente; el ciclo de sus ideas se agrandó, y comunicándose de uno a otro el poderoso estímulo de sentir fuerte y pensar hondo, llegaron a un altísimo grado de tempestuosa embriaguez de los sentidos, con relámpagos de atrevidas utopías eróticas y sociales» (ivi, pp. -). . «Es muy particular lo que me pasa: aprendo fácilmente las cosas difíciles; me apropio las ideas y las reglas de un arte…, hasta de una ciencia, si me apuras; pero no puedo enterarme de las menudencias prácticas de la vida. Siempre que compro algo, me engañan; no sé apreciar el valor de las cosas; no tengo ninguna idea de gobierno ni de orden, y si Saturna no se entendiera con todo en mi casa, aquello sería una leonera» (ivi, p. ). . Un’altra citazione dalla stessa Oda i di Fray Luis si trova alla fine del capitolo , proprio in chiusura, quando Tristana dichiara a Horacio che non si sente fatta per le piccole cose della vita quotidiana («Ni del dorado techo… se admira fabricado…, del sabio moro, en jaspes sustentado », ivi, p. ). Ignoro se altri critici abbiano già notato l’allusione intertestuale presente nel nome di Horacio, che si chiama come il poeta latino che ha legato il suo nome al topos del Beatus ille, e le cui Odi tradusse Fray Luis de León, ispirandosi a lui anche per la sua poesia originale. Fra i critici che si sono occupati degli echi intertestuali del romanzo, né Ayala () né Gullón () notano questa allusione. Sánchez (, p. ) pensa che per il nome dell’innamorato di Tristana Galdós possa essersi ispirato all’Horace dell’École des femmes di Molière. . Questo rapporto di contiguità, certo non casuale, è stato già notato da Bordons (, p. ). . Sull’intuizione dell’importanza di questo riferimento al Macbeth si è costruita la tesi di Alessia Ciccariello, Echi shakespeariani in “Tristana” di Galdós, da me diretta e discussa presso l’Università di Roma Tre nella sessione invernale dell’a.a. -. Già Schmidt (, pp. -) si soffermava sulla connessione fra le citazioni del Macbeth e la vicenda esistenziale di Tristana, in un articolo che offre una lettura per molti aspetti coincidente con quella che propongo in queste pagine. . Anche Sánchez (, pp. -) sostiene che il matrimonio di Tristana e don Lope si può interpretare come un’antitesi parodica e grottesca della concezione krausista del matrimonio (concezione che, come sappiamo, era invece fortemente presente in Valera). . Coincido in questo totalmente con l’interpretazione di Bordons (), che afferma: «Galdós hace que la historia de Tristana, modelo de la mujer nueva, sea narrada desde una perspectiva ambigua, elusiva, difícil de concretar, por un narrador quizás poco convencido de las ideas de independencia de la protagonista pero que tampoco puede rechazarlas abiertamente» (ivi, p. ). Nello stesso articolo si trovano riferimenti bibliografici alle diverse interpretazioni cui ha dato luogo il modo con il quale Galdós conduce la vicenda della protagonista. Bibliografia (), Valera y Galdós: dos concepciones del modo de novelar, in Actas del Congreso Internacional sobre Juan Valera ( ), Ayuntamiento de Cabra-Diputación provincial, Cabra-Córdoba. AGUINAGA ALFONSO M. FAUSTA ANTONUCCI AYALA F. (), Galdós entre el lector y los personajes, BORDONS T. (), Releyendo “Tristana”, in “Nueva in “Anales galdosianos”, , pp. -. Revista de Filología Hispánica”, XLI, , pp. -. (), Doña Perfecta: Galdós’ Reply to Pepita Jiménez, in “Anales galdosianos”, , pp. -. GENETTE G. (), Palimpsestes. La littérature au second degré, Seuil, Paris (trad. it. Palinsesti. La letteratura al secondo grado, Einaudi, Torino). GILMAN S. (), Galdós and the Art of the European Novel: -, Princeton University Press, Princeton (NJ). GULLÓN G. (), “Tristana”: literaturización y estructura novelesca , in “Hispanic Review”, , pp. -. LIVINGSTONE L. (), The Law of Nature and Women’s Liberation in “Tristana”, in “Anales galdosianos”, , pp. -. ONTAÑÓN DE LOPE P. (), Juan Valera y Galdós: historia de una enemistad, in “Bulletin Hispanique”, , , pp. -. PÉREZ GALDÓS B. (), Tristana, introduzione di V. Galeota, traduzione e note di A. Guarino, con testo a fronte, Marsilio, Venezia. SÁNCHEZ R. G. (), Galdós’ “Tristana”. Anatomy of a “disappointment”, in “Anales galdosianos”, , pp. -. SCHMIDT R. A. (), Tristana and the Importance of Opportunity, in “Anales galdosianos”, , pp. -. VALERA J. (), Pepita Jiménez, edición de L. Romero, Cátedra, Madrid. CHAMBERLIN V. A. “ROSA NATURALE” E “ROSA DI CARTA”: IL POPOLARISMO POETICO NEL DIBATTITO SPAGNOLO OTTO-NOVECENTESCO di Maria Cristina Assumma Al rapporto di alleanza tra livello colto e livello popolare che, infranto in Italia nel Rinascimento, caratterizza tenacemente la storia delle lettere spagnole Rafael Alberti dedica La poesía popular en la lírica española contemporánea, conferenza tenuta all’Università Friedrich Wilhelm di Berlino nel novembre del . Replicata a Madrid nel maggio del presso il Teatro Español, la conferenza si avvale della partecipazione, in veste di cantante, dell’“Argentinita” e, in veste di pianista, di Federico García Lorca. Il quale aveva già espresso, in La imagen poética de don Luis de Góngora (-), alcune considerazioni sul popolarismo letterario. A dimostrazione del suo atavismo, entrambi i poeti andalusi chiamano in causa l’Arcipreste de Hita, il Marqués de Santillana, Jorge Manrique, Gil Vicente e Cristóbal de Castillejo, antagonista di Garcilaso de la Vega nella sua funzione di importatore in Spagna del modello colto rinascimentale italiano. Modello che, pur consolidandosi grazie ai seguaci della scuola petrarchista, non sottrae energia al popolarismo, destinato a conoscere un momento apicale nel XVII secolo grazie a Lope de Vega. Convinto che «la Geografía y el Cielo triunfan de la Biblioteca» (García Lorca, b, p. ), Lorca difende anche nel caso del culterano Góngora la familiarità con l’espressione popolare, ravvisabile nell’accezione visionaria della metafora, nell’andalusissima inclinazione all’iperbole, nella vivificazione delle forze cosmiche e nella menzione poetica delle piccole cose. Alla produzione poetica del XVIII secolo, con la sua declinazione neoclassica e illuministica, Alberti addebita il depauperamento dell’ispirazione popolare, ora confinata in ambito teatrale ove sainetistas quali Ramón de la Cruz e Castillo ne garantiscono la sopravvivenza (eppure, anche in un poeta come Juan Meléndez Valdés non cessa di agire il contagio popolare se non altro sul piano della versificazione, come dimostra il fatto che una prova di stampo così decisamente neoclassico come Del sol llevaba la lumbre non disdegna di combinare le forme poetiche del romance e del villancico ). Nonostante la grandiloquenza dei romantici, l’accento cancioneril perdura nella lirica d’autore grazie a Gustavo Adolfo Bécquer e a Rosalía de Castro. La linea di continuità del popolarismo sfocia, quindi, nella produzione di Antonio Machado e di Juan Ramón Jiménez, al quale Alberti ascrive la creazione del romance moderno in virtù della lirificazione del genere. A partire da questi due poeti – prosegue il poeta gaditano – esplode una generazione poetica (Moreno Villa, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Federico García Lorca, Fernando Villalón, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Emilio Prados, Juan Larrea) erroneamente etichettata con il termine “avanguardista” dato il radicarsi dell’habitus mentale metaforico del surrealismo spagnolo nell’estetica popolare: MARIA CRISTINA ASSUMMA Los poetas acusados de este delito [surrealismo] sabíamos que en España – si entendemos por surrealismo la exaltación de lo ilógico, lo subconsciente, lo monstruoso sexual, el sueño, el absurdo – existía ya desde mucho antes que los franceses trataran de definirlo y expresarlo en sus manifiestos. El surrealismo español se encontraba precisamente en lo popular, en una serie maravillosa de retahílas, coplas, rimas extrañas, en las que, sobre todo yo, ensayé apoyarme para correr la aventura de lo para mí hasta entonces desconocido (Alberti, , pp. -). Fin qui la disamina di Alberti volta a evidenziare il rilievo di cui gode il popolarismo. Al quale Benedetto Croce imputa l’esaurimento della letteratura spagnola, dimostrato dalla scarsa influenza da essa esercitata sulla vita culturale dell’Europa moderna, fatto salvo il caso di Miguel de Cervantes, non insensibile – asserisce il filosofo italiano a conforto della sua istanza critica – ai richiami dell’umanesimo italiano (Croce, ). Ben diversa è la considerazione accordata al popolarismo nell’ambito del dibattito spagnolo, del quale esaminiamo l’articolazione otto-novecentesca, prevalentemente caratterizzata dalla persuasione dell’esemplarità della lirica del pueblo, promossa a modello espressivo pur nella convinzione della sua inimitabile specificità. Prima di addentrarci in questo dibattito non sarà superflua una riflessione sulla discussa questione dell’origine della poesia popolare: si tratta di una creazione dal basso, come sostenuto dal popolarismo romantico, teso all’esaltazione della sua spontaneità e autonomia, o di un ribassamento di prodotti originariamente colti, come sostenuto da posteriori orientamenti che negano l’originalità delle espressioni popolari documentandone i contatti e i prestiti dal versante colto? Di queste opposte istanze si fecero interpreti, in Spagna, due letterati prestati agli studi demologici, Antonio García Gutiérrez e Juan Valera, nei loro discorsi di ammissione alla Real Academia Española, pronunciati entrambi nel . Se Juan Valera (, pp. -) sostiene l’ipotesi, già formulata da Manuel Milá y Fontanals, delle radici colte della poesia popolare, Antonio García Gutiérrez considera popolare la poesia che il popolo «produce» e non quella che «apprende»; la poesia che «fabbrica» per il suo uso, propaga tra i suoi simili e a volte vede adottata da altri, ben lungi dal pretenderlo, e non quella che riceve dall’alto (García Gutiérrez, , p. ). Qualche anno prima Fernán Caballero, pur optando per la tesi autonomistica, aveva osservato il fenomeno della «discesa» di stimoli letterari dalla sfera colta al popolo, il quale in linea generale preferisce «inventare» anziché «imparare», «improvvisare» anziché «ripetere», ma ciò non impedisce, ammette la scrittrice, che talune coplas da lei stessa raccolte presso il popolo siano state da questo «casualmente» attinte in ambito colto (Caballero, , pp. XIII-XIV). Avanzamenti teorici sono dovuti, nel Novecento, a Ramón Menéndez Pidal, i cui contributi in merito alla nascita dei fatti folklorici e al loro eventuale spostamento nella dimensione sociale presentano spazi di convergenza rispetto alle posizioni di Pëtr Bogatyrëv e Roman Jakobson. I due studiosi collegati al Circolo linguistico di Praga riconoscono il fenomeno dell’adozione in ambito popolare di antecedenti extrafolklorici, ma pongono in risalto la rielaborazione a cui essi sono sottoposti nell’essere integrati alle esigenze espressive della cultura orale (Bogatyrëv, Jakobson, , pp. -). Il processo di folklorizzazione implica, dunque, non un’assunzione inerziale degli stimoli “alti”, ma un adattamento integrativo all’orizzonte popolare di adozione, ed è per questo da considerarsi un processo “creativo”. Per dirla con “ ROSA NATURALE ” E “ ROSA DI CARTA ”: IL POPOLARISMO POETICO Ramón Menéndez Pidal (, p. ), l’identità popolare di un canto non risiede nella sua origine, ma nella sua rifondazione in vista di specifici bisogni espressivi, a mo’ di un liquido che prende la forma del bicchiere in cui si versa. Si dà il caso, dunque, di coplas di derivazione colta, che tuttavia i cantori “correggono” dal punto di vista metrico-formale e concettuale, immettendole in una dinamica di varianti e nell’anonimato popolare. Alla luce di questa mediazione tra il “popolarismo” romantico e il “cultismo” che a esso reagì, si attribuisce, insomma, un valore di invenzione poetica alla rielaborazione popolare di fonti eterogenee. Ulteriore è il caso – oggetto del nostro interesse – di prodotti colti che mimetizzano i bisogni espressivi popolari e che, per questo, sono adottati dai cantori anonimi attivando un singolare meccanismo di ida y vuelta, di flusso e riflusso. Su questo fenomeno di pendolarismo culturale consideriamo le posizioni teoriche che dai romantici giungono agli esponenti della Generazione del ’ sulla scorta di una sorprendente linea di continuità. Nel prologare la silloge poetica La Soledad () di Augusto Ferrán, Gustavo Adolfo Bécquer sottolinea il sapore letterario delle coplas d’autore, che inevitabilmente «se distinguen de los originales del pueblo; la forma del poeta, como la de una mujer aristocrática, se revela, aun bajo el traje más humilde, por sus movimientos elegantes y cadenciosos» (Bécquer, , p. ). Il principale elemento differenziale è individuato da Bécquer nell’essenzialità espressiva della copla popolare che, naturale, breve, secca, «brota del alma como una chispa eléctrica». La capacità del popolo di racchiudere una sentenza profonda in una forma concisa fa sì che nessuno sappia sintetizzare meglio le credenze, le aspirazioni e il sentimento di un’epoca (ivi, pp. -). Similmente, Antonio García Gutiérrez (, p. ) ritiene che lo stile popolare: […] es tan especial, es tan marcado, que fácilmente se distinguen las poesías del vulgo de las que á su imitación han hecho ingenios más levantados. El vulgo […] se ha formado un estilo […] cuya imitación es muy difícil, si no imposible, para los que ejercitados en la poesía, se han formado ya una manera peculiar. Persuaso del fatto che tutto ciò che è affettazione e ricercatezza cessi di essere poesia, anche l’autore di El Trovador valorizza della poesia popolare l’indole essenzialista. Qualità che ritiene perfettamente incarnata in questa copla flamenca, che non esita a presentare come una delle più belle espressioni poetiche mai scritte: En el carro de los muertos ayer pasó por aquí. Llevaba la mano fuera: por ella la conocí . In soli quattro brevi versi si dipana, secondo il poeta, una dinamica di alto valore drammatico. I primi due versi proiettano negli occhi del lettore il passaggio di un cadavere anonimo. Non sappiamo di chi sia, quel cadavere, né che rapporto abbia con il soggetto poetico, la cui presenza è definita da una coordinata di tipo spaziale rappresentata dall’avverbio «aquí» (qui), che rende appena circostanziata l’azione. Si aggiunge, nel terzo verso, un’ulteriore dose d’informazione, volta a qualificare la condizione del morto come di orfandad e di tristísimo desamparo: «Llevaba la mano fuera» indica, infatti, che nessuno si è incaricato del cerimoniale nel trasporto del morto, che prevede, tra l’altro, che le mani siano incrociate sul petto. Nell’ultimo verso si completa il MARIA CRISTINA ASSUMMA senso grazie a un solo monosillabo: il pronome la sv
Scarica