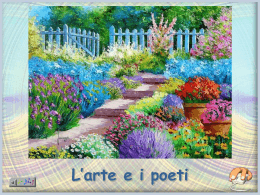Isola Nera 1/17 Casa di poesia e letteratura. La prima in Sardegna, in Italia, aperta alla creazione letteraria degli autori italiani e di autori in lingua italiana. Isola Nera è uno spazio di libertà e di bellezza per un mondo di libertà e bellezza che si costruisce in una cultura di pace. Direzione Giovanna Mulas. Coordinazione Gabriel Impaglione. [email protected] - Agosto 05 - Lanusei, Sardegna “ E’ odioso che un poeta dopo aver scritto, lavorato, vissuto e pensato sia costretto a doversi esporre al pubblico. Noi non siamo gente di spettacolo, non siamo attori, siamo pensatori, gente che sta a casa e che si crogiola nelle proprie depressioni, non abbiamo voglia di considerare pubblicamente quello che ci passa nel cuore. Ed è bene che sia così. Io credo di scrivere cose passate attraverso il mio corpo, la mia esperienza, nonostante la mia vecchia età. Oramai ho 70 anni anch’io. Però comincio a essere stanca di servire da tiro a segno di tanti cretini. Il poeta non ha bisogno di grande cultura per scrivere, ma di grande cuore. Forse la gente questo non lo capisce. Una volta, veramente, i poeti venivano tenuti molto in considerazione. Oggi, invece, mi sento spesso chiedere: “Lei che corsi ha fatto? Perché conosceva Montale? Perché conosceva Quasimodo? Che persone erano?” Ebbene, erano persone normali, con tutte le avarie, i disguidi, le figuracce che il poeta fa con se stesso, i pentimenti, le tentazioni di tutti noi. Quindi non capisco questo voler vedere la celebrità che non esiste se non nell’effimero plauso che un uditorio può fare. “ Alda Merini I PROMESSI SPOSI Manzoni e Scott I Promessi Sposi sono un romanzo storico, un nuovo genere di romanzo che ebbe grande successo nell’Ottocento e che ha il suo capostipite nell’ “Ivanhoe” (1819) dello scrittore inglese Walter Scott (1771-1832). Diciamo subito, però, che l’influenza dello Scott fu pressoché irrilevante sull’ispirazione del Manzoni, anzitutto perché il Nostro aveva già dimostrato con estrema evidenza il suo orientamento a trarre dalla storia non solo gli argomenti ma anche i motivi delle proprie opere (liriche civili e tragedie), ma anche e soprattutto perché gli esiti del suo romanzo sono risultati estremamente diversi da quelli conseguiti dallo Scott con i suoi vari romanzi storici. Lo Scott fa, tutto sommato, storia romanzata, nel senso che rappresenta epoche ambienti e personaggi 1 storici mettendone in risalto gli aspetti più pittoreschi e più capaci di colpire la fantasia del lettore e quello che di fantastico aggiunge ai dati reali finisce col falsare la realtà stessa. Il Manzoni, invece, anche nel romanzo, come già nelle tragedie, è rispettoso della verità storica e quello che vi aggiunge di fantastico non nasce da una pura e gratuita invenzione, a fine di diletto, ma da una cordiale e profonda penetrazione dei fatti reali allo scopo di intuire e meglio rappresentare la verità della vita quale si agita nel profondo della coscienza umana. Senza voler essere irriguardosi dell’arte dello Scott, che fu pure un notevole scrittore, ci sembra di poter affermare che fra i romanzi dell’inglese e quello del Manzoni corre la stessa differenza che separa i romanzi d’appendice da un grande poema esistenziale. Le edizioni La prima redazione del romanzo risale agli anni 1821 - 1823: il primo titolo fu “Fermo e Lucia”, mutato poi in “Sposi Promessi”. L’opera non lasciò soddisfatto l’Autore, che non volle mai pubblicarla (fu infatti pubblicata postuma ma solo per metterla a confronto con l’edizione definitiva) e la rinnovò sostanzialmente, pubblicandola col titolo di “Promessi Sposi” nel 1827. Il Manzoni sottopose poi il romanzo ad una lenta e paziente revisione linguistica “per mettere quel povero testo nella lingua viva di Firenze”, e a tale scopo si trasferì per qualche tempo nel capoluogo toscano. L’edizione definitiva, quella che noi oggi leggiamo, fu da lui pubblicata a Milano in fascicoli tra il 1840 ed il 1842. I motivi fondamentali: la Provvidenza e la Storia La trama del romanzo è fin troppo nota ai nostri giovani lettori che vorranno perciò scusarci se non ci addentriamo in una descrizione analitica. Riteniamo tuttavia opportuno richiamare alla loro memoria alcuni dati essenziali. Come si sa, il filo conduttore del romanzo è dato dalla vicenda di due umili promessi sposi, Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, che vengono contrastati nel loro disegno di nozze dalla tracotanza di un signorotto locale, don Rodrigo, che ha messo gli occhi sulla formosa Lucia e si avvale di ogni mezzo per farla sua, ricorrendo alla complicità del timoroso Don Abbondio, ma anche all’influenza di cui son capaci i suoi potenti parenti di Milano, quando è necessario ridurre all’impotenza quel certo Padre Cristoforo, che ha osato prendere le difese di una insignificante contadina mettendosi contro un nobile casato. Don Rodrigo, forte della protezione che la società del tempo gli offre, non rinunzia alla sua impresa neppure quando non ha altra scelta che il rapimento della ragazza, che egli tenta una prima volta con i suoi bravi, senza successo, e poi con l’aiuto di un ribaldo più potente di lui (l’Innominato). La vicenda si svolge tra il 7 novembre 1628 e la fine del 1630 nella Lombardia dominata dagli Spagnoli. Ha inizio in un piccolo paese tra Como e Lecco, ma si estende poi in uno scenario ben più vasto coinvolgendo soprattutto Monza, il Bergamasco, Milano. La vicenda dei protagonisti è essenziale all’Autore per poter esprimere la sua profonda ispirazione, il suo Vero, che consiste nella eterna lotta tra il Bene ed il Male, ma essa si inserisce costantemente in situazioni ben più rilevanti della storia di quegli anni (la carestia, la peste, la guerra per la successione al ducato di Mantova, la discesa dei Lanzichenecchi; il malgoverno spagnolo, la crisi della giustizia, le violente contestazioni popolari, ecc.) senza per questo annullarsi e neppure ridimensionarsi agli occhi del lettore, che partecipa al dramma dei due giovani promessi (come a quello di tanti altri personaggi minori: ad esempio, la madre di Cecilia) con non minore commozione di quella che lo coglie alla visione dei campi desolati e inariditi dalla siccità, delle strade di Milano ora invase dalla folla tumultuante ora squallidamente deserte per timore della peste, dell’agghiacciante scenario del Lazzaretto. Forse è proprio qui il segreto della “coscienza storica” del Manzoni, che non riesce a cogliere alcun significato nei grossi avvenimenti della storia se non verificandone cause ed effetti nelle singole coscienze degli uomini, potenti od umili che siano, dato che la vera tragedia della storia è lì che si compie. 2 E che di tragedia si tratti è dimostrato dalla considerazione, tutt’altro che gratuita, che la vita è essenzialmente “dolore”, l’egoismo non paga, la fede in una superiore Giustizia resta l’unica risorsa dell’uomo per fargli accettare la vita come dolore ed il Bene come un valore. Si spiega così nel romanzo la costante presenza della Provvidenza , che non è un personaggio a sé stante come i miti delle divinità pagane nelle opere classiche, ma è indistintamente, impalpabilmente dappertutto: è l’anima stessa della storia. D’altra parte la storia, al di là delle apparenze che ce la mostrano assai spesso in contrasto con la Legge di Dio, non può che tendere verso il fine supremo prescritto da Dio. Scrive a proposito il Sapegno: «In questo mondo basso, più triste che lieto, l'opera di Dio la senti soprattutto nelle tribolazioni, negli affanni, e in quegli spiragli di luce che s'aprono improvvisi in mezzo alle tenebre dell'angoscia e chiudono le porte alla disperazione... E' una presenza paterna, amorosa e severa, che palpita in ogni cosa; e il poeta l'avverte con la fede semplice e intatta di un fanciullo, la fede dei suoi contadini e di tutta la povera gente... Non a caso i Promessi Sposi sono stati chiamati il romanzo della Provvidenza». Ma se questo è vero, è pure vero che «se davvero di un protagonista sensibile si vuol parlare - come osserva il Russo -, bisognerebbe pensare e sostenere che protagonista è tutto un secolo, è tutta una civiltà, protagonista vero e immanente in ogni pagina è il Seicento». Leggiamo questa pagina interessantissima del Russo: «Di quel secolo egli viene tracciando l'intera vita, la quale, perché svuotata del sentimento intimo di Dio, deve essere necessariamente vana, pomposa, barocca. Il puntiglio e l'orgoglio, ecco le più vere divinità di quel secolo esteriore e farisaico. Don Rodrigo muove tutta l'azione per spuntare un impegno, per tenere fede a una vile scommessa; il conte Attilio e il conte zio debbono sostenere l'onore del casato; il podestà, l'onore della formale dottrina giuridica; don Ferrante, il più innocente di tutti, l'onore della scienza umbratile ed inutile e quello delle buone regole ortografiche. Il cancelliere Ferrer, per tutelare l'onore del governo, prima abbassa il prezzo del pane, e poi sguinzaglia i suoi bargelli; e don Gonzalo Fernandez de Cordova, per salvare l'onore di un trono, conduce una guerra funesta per la conquista del Casal Monferrato. Più cupo di tutti, come eroe di questo pregiudizio dell'onore e del decoro, il principe -padre, che sacrifica e conduce alla perdizione una figliuola. Del farisaismo del secolo il principe -padre è forse l'espressione più complessa. Nessuno vìola lo spirito formale delle leggi; nessuno impone, apertamente, la sua volontà. Il principe non adopera mai parole grosse. Egli ha un rispetto pieno di cortesia della volontà, delle inclinazioni, degli affetti della figlia; ma sulla sua volontà egli agisce, per vie indirette, quasi magicamente, demiurgicamente, creando tutta una atmosfera, che deve ispirare a poco a poco certi determinati sentimenti». Quindi i veri protagonisti del romanzo sono la Provvidenza e la Storia . Questo secondo protagonista ha un nome: il Seicento. E come tutti i personaggi storici del romanzo ha una sua fisionomia inconfondibile che non può e non deve essere alterata. Non per niente il Manzoni, prima di accingersi a scrivere l’opera, si è abbondantemente documentato sulla realtà storica di quel periodo, leggendo le storie di Giuseppe Ripamonti e di Pietro Verri, l’ “Economia statistica” di Melchiorre Gioia, la vita di Federico Borromeo scritta da Francesco Rivola, ma soprattutto un’infinità di cronache e documenti sparsi. Ciò non toglie, però, che quel secolo fu scelto a protagonista dell’opera più per rispetto di un principio teorico del Manzoni (“l'interessante per mezzo”) che per autentiche esigenze di ispirazione. Esso infatti, rappresentando la vita sociale, politica, economica, religiosa e, quindi, morale della Lombardia soggetta agli Spagnoli, richiamava la condizione attuale dei Lombardi soggetti agli Austriaci. Ma l’esigenza di scavare nel fondo degli avvenimenti reali per mettere a nudo il vero dramma degli uomini, soprattutto degli umili, coinvolti nell’eterna lotta tra il Bene ed il Male, certamente il poeta l’avre bbe potuta soddisfare con qualsiasi altra epoca storica. E' perciò più giusto affermare che non il Seicento, ma la Storia intesa come tragedia umana è il secondo protagonista del romanzo, che per questo è stato definito il romanzo degli umili. 3 Il romanzo degli umili: l'umorismo Scrive ancora il Sapegno: «Questo fondo popolano tiene una parte grande, predominante, nella struttura del romanzo. Anche il quadro storico, in cui tutta la vicenda si inserisce, non tocca se non di passata gli eventi politici, diplomatici, bellici, quelli insomma che formano essenzialmente e quasi esclusivamente la trama di una storia nel senso corrente del termine, e si specifica piuttosto in una serie di quadri d'ambiente e di costume, per cui si delinea, non il corso solenne dei fatti, sì il colore, la fisionomia minuta e variegata di un'epoca. E quando un avvenimento di vasta portata -il malgoverno spagnolo, la carestia, la guerra, la peste- penetra nel racconto, è visto non in una considerazione astratta e disinteressata da storico professionale, bensì in quanto aderisce alla vita degli umili, li agita, li fa soffrire, reca un improvviso sconquasso nelle loro abitudini e nelle loro coscienze. Naturalmente, in quella rappresentazione vasta e complessa di un periodo storico visto nei suoi riflessi umani e quotidiani, debbono entrare anche i grandi, i personaggi illustri, i rappresentanti dei ceti e degli ordini privilegiati; ma vi entrano, come è giusto, in funzione subordinata: o per antitesi, come le ombre che hanno il compito di delimitare e porre in rilievo le zone di luce; ovvero come elementi di sostegno e di conforto del concetto che regola la rappresentazione nel suo complesso, in quanto si tratti di potenti che s'adeguano al mondo degli umili e si mettono al loro servizio.» A questo mondo di umili il Manzoni aderisce con intima cordialità e profonda solidarietà. E se pure è vero che egli tratti quella povera gente con affetto e con simpatia, ma pur sempre con un certo compiaciuto divertimento nel sottolineare l’ingenuità od anche l’astuzia proverbialmente contadinesca (“scarpe grosse e cervello fino”), è senz’altro da scartare l’ipotesi di un atteggiamento volutamente malizioso ed è piuttosto da riscontrare in ciò la registrazione fedele di un rapporto genuino, non farisaico, fra l’Autore, aristocratico intellettuale, e le sue umili creature. E forse proprio grazie a questa genuinità di rapporti è nato il tono umoristico del romanzo, che poi ha assunto l’ufficio, ben più importante ed essenziale all'ispirazione etico-religiosa, di far da livellatore tra la severità del giudizio morale e l’umana comprensione o di limitare l’asprezza della polemica sociale (Così va il mondo, o almeno così andava nel secolo decimosettimo!”). I personaggi Ricchissima la galleria dei personaggi tratti dalla storia, come il cardinale Federico Borromeo, la monaca di Monza (figlia del conte Martino de Leyva), l’Innominato (Francesco Bernardino Visconti), il suo amico Egidio (Gian Paolo Osio), il gran cancelliere Antonio Ferrer, lo stesso fra Cristoforo (secondo un convincimento diffuso tra gli studiosi anche se le numerose ricerche effettuate non hanno portato ad alcuna precisa identificazione) o creati dalla fantasia dello scrittore - ma non per questo meno “storici” dei primi in quanto sapientemente costruiti sulle notizie attinte dalle cronache del tempo e ritratti con estrema perizia psicologica -, come Renzo, Lucia, Agnese, Perpetua, don Abbondio, don Rodrigo e tutta una serie di minori anch’essi magistralmente ben definiti e compiuti (Azze ccagarbugli, fra Galdino, il conte Attilio, il Conte Zio, il Padre provinciale, Tonio, Gervaso, Bortolo, don Ferrante, donna Prassede, il sarto), e ancora osti, barcaioli, barrocciai, comari, serve, “bravi” e bambini (Menico, Bettina, i figli di Tonio, quelli del sarto). Il paesaggio Più avara la fantasia del Poeta nei confronti della natura: le descrizioni paesaggistiche certamente non mancano ma sono di una sobrietà eccezionale che trattiene e quasi impedisce ogni effusione lirica. In questo il Manzoni si distacca molto dagli altri romantici che si sono serviti del paesaggio come espressione di particolari stati d'animo. Il paesaggio manzoniano, invece, è concreto, il palcoscenico di tante vicende storiche 4 accadute sotto il cielo di Lombardia, in cui prevale l’ “autunno”, la stagione che meglio si addice all’intuizione manzoniana della vita. Il motivo patriottico e l'ispirazione etico-religiosa Un problema - per la verità marginale dal punto di vista estetico - è quello relativo alla presenza o meno del motivo “patriottico” nel romanzo. Sotto la spinta degli ideali e perché no? - degli interessi risorgimentali, non pochi critici risposero nell’Ottocento positivamente a questo interrogativo. Lo stesso De Sanctis non lo negava e negli ambienti intellettuali correva voce che il Metternich avesse affermato che i “Promessi Sposi” erano una grande lettera «la cui soprascritta era indirizzata alla Spagna, ma il contenuto era per l'Austria». Ma già il Carducci era decisamente di parere opposto in quanto l’umiltà evangelica che dominava su tutto il romanzo non era, a suo parere, conciliabile con gli interessi politici e civili della Nazione. Noi siamo del parere che l’analogia fra la situazione della Lombardia seicentesca dominata dalla Spagna e la Lombardia ottocentesca dominata dall’Austria fu certamente ricercata dal Manzoni perché l’opera risultasse “interessante” per il lettore moderno, ma siamo anche convinti che il Poeta sentisse il problema della secolare servitù italiana in chiave morale, inquadrato cioè nella visione del rapporto fra oppressori ed oppressi, più che in chiave patriottica secondo il senso comune di questa espressione. Insomma per noi il motivo patriottico è assorbito dall'ispirazione etico-religiosa: nel romanzo non c’é l’Apostolo della Libertà della Patria nel senso mazziniano e tanto meno nel senso garibaldino, e non c’è neppure l’accorto politico che con le sue arti sottili vuol preparare il terreno della rivoluzione nazionale: c’è invece l’Apostolo di una superiore Giustizia che impone il rispetto della libertà dei popoli e dei singoli individui come legge universale di vita, come inoppugnabile volontà divina. Lo stile I caratteri essenziali dello stile del romanzo sono da individuare nella “naturalezza” del discorso narrativo e nella disinvoltura con cui l’artista registra, soprattutto nei dialoghi, il tono della parlata popolare. Abbiamo detto: il “tono”, perché in effetti la lingua è rigorosamente selezionata nel lessico (certamente senza l’ottuso perfezionismo dei puristi) e controllata nella costruzione sintattica, come se il Manzoni prestasse la sua sapienza linguistica a quei poveri popolani senza punto condizionarne la schiettezza, l’istintiva aderenza al linguaggio delle cose, la semplicità ed infine quel non so che di pittoresco, di rustico che sempre affiora dalla bocca dei “paesani”. A noi sembra che il Manzoni avesse aderito alle tesi romantiche del “realismo” e della “popolarità” dell’arte con estremo equilibrio, senza cioè il velleitarismo delle crociate anticlassiciste che lo avrebbero costretto a mortificare un aspetto, un elemento non secondario del proprio “gusto”: un vero artista teoricamente può anche smentire se stesso, ma praticamente non si tradisce mai. Alessandro Manzoni nacque a Milano nel 1785 da Pietro e da Giulia Beccaria, figlia del famoso Cesare, autore dell'opuscolo “Dei delitti e delle pene”. Di nobile e benestante famiglia, fu educato nei collegi di Merate e di Lugano e poi nel convitto “Longone” di Milano. L’educazione impartitagli fu rigidamente cattolica e gli studi orientati principalmente in campo umanistico. Il giovane fu piuttosto insofferente verso il tipo di educazione religiosa ma abbastanza soddisfatto dell’istruzione classicheggiante, che lo indusse ad amare in modo particolare il Parini ed il Monti, che considerò i suoi primi maestri d’arte. Nel 1800 lasciò la scuola e tornò in casa del padre, che nel frattempo si era separato dalla moglie, la quale era andata a convivere a Parigi col ricco conte Carlo Imbonati (lo stesso al quale, giovinetto reduce da una malattia, il Parini aveva dedicato l’ode “Torna a fiorir la rosa”). Tornato nella casa paterna, Alessandro cominciò a condurre vita dispendiosa e mondana, frequentando teatri, case da gioco, donne di facili costumi. Si invaghì anche perdutamente di una certa Luisina, genovese, ed il padre ritenne opportuno allontanarlo da Milano ed inviarlo a studiare a Venezia, dove però incappò in un’altra passione amorosa che lo impegnò non poco. In questo periodo, tuttavia, non trascurò gli studi personali orientati ora 5 decisamente verso le letture illuministiche, che lo allontanarono dalla fede cattolica e gli favorirono l’inserimento nella vita intellettuale milanese, particolarmente sensibile, dopo Marengo (giugno 1800), alle idee rivoluzionarie e anticlericali (si ricordi che erano ritornati in città il Monti ed il Foscolo). Nel 1805, morto a Parigi Carlo Imbonati lasciando erede universale dei suoi cospicui beni Giulia Beccaria, questa venne in Italia pe r far seppellire il conte nella sua villa di Brusuglio, presso Milano, e ripartì poi per Parigi conducendo con sé Alessandro. A Parigi il Manzoni ebbe l’opportunità di frequentare i migliori salotti intellettuali e di approfondire la propria cultura di stampo illuministico. Strinse anche rapporti di profonda amicizia con lo storico Claudio Fauriel, che gli fu prodigo di consigli e di incitamenti. In questo periodo gli avvenimenti più salienti, destinati ad avere un’influenza notevole su tutta la vita del Manzoni, furono il suo matrimonio con la sedicenne Enrichetta Blondel, figlia di un ricco banchiere ginevrino, che sposò a Milano nel 1808 col rito protestante (Enrichetta era calvinista), e la sua conversione al cattolicesimo, che si può assegnare al 1810, anno in cui celebrò nuovamente le nozze col rito cattolico in quanto anche Enrichetta era passata al cattolicesimo. Dopo il matrimonio (da cui nacquero ben nove figli) e la conversione, si ebbe la stagione più fortunata per la creatività artistica, che durò sostanzialmente poco più di un decennio, ma che fu sufficiente a far guadagnare al Manzoni uno dei primissimi posti nel panorama letterario dell’Ottocento italiano ed europeo. Dopo il 1823 la vita del Nostro fu funestata da una lunga catena di disgrazie familiari che spensero in gran parte il calore del sentimento, ma non la lucidità della mente, che fu rivolta a studi prevalentemente dottrinali: il Manzoni vide morire, uno dopo l’altro, ben sei figli, la moglie Enrichetta, la madre e la seconda moglie, Teresa Borri (già vedova del conte Stefano Stampa). Dal 1823 in poi il Manzoni visse piuttosto appartato, evitando di partecipare in prima persona ad attività pubbliche sia intellettuali che politiche e civili, anche se non si astenne dal far conoscere con fermezza e chiarezza i propri punti di vista. Nel 1860 fu nominato dal re Vittorio Emanuele Il senatore del Regno d’Italia e quattro anni dopo partecipò a Torino a quella storica seduta parlamentare in cui fu votato il trasferimento della capitale da Torino a Firenze, primo passo verso Roma. Visse gli ultimi anni della sua lunga vita onorato da tutti gli italiani e visitato da Cavour, Garibaldi, Mazzini, Verdi. Quest’ultimo compose per la sua morte, avvenuta nel 1873, la famosa “Messa di requiem”. Luigi de Bellis Charles Baudelaire Francia De profundis Clamavi Imploro la tua pietà, Tu, mio amore unico, dal fondo dell’abisso dov’è caduto il mio cuore. E’ un universo tetro dall’orizzonte plumbeo, dove nel buio nuotano la bestemmia e l’orrore; un sole che non scalda per sei mesi vi plana e per altri sei mesi la notte copre la terra; è un paese più nudo della calotta polare; -né bestie, nè ruscelli, nè foreste, nè erba ! al mondo non esiste orrore che superi la fredda crudeltà di questo sole glaciale, di questa notte immensa simile al vecchio Caos; ed invidio la sorte degl’infimi animali che possono tuffarsi in fondo a un sonno ottuso, 6 la matassa del tempo così lenta si dipana! Gabriel Impaglione Argentina Alla spirale del rombo i sensi Come api laboriose E un ora di luce Che viene col suo immenso cucchiaio zuccherato. L’altura rilascia specchi sopra la montagna Intanto cresce nei cipressi Il mormorio del vento Scorrendo fino ai confini dell’ora. Oh, Sardegna, isola dura e antica, quattro volte nata di sole azzurro, di segreti colpi millenari, di malinconico orizzonte carico di navi. Nella vite e nell’ulivo la virtù latente, vigilare dalla cima del nuraghe, preghiere di sole in un sentiero di capre, legno ardente nel centro dell’inverno. Ho riconosciuto l’essenza dell’abbraccio, i capricci della sua architettura. Il suo rito di maschere nel freddo carnevale Delle fiammeggianti risate con campane. Attraverso i suoi dettagli come un bambino. Tutto davanti a me inaugura il suo mistero. Adesso e adesso incontro nei suoi istanti L’amore preso come un canto. Da “alala” (el Taller del poeta, Galicia, 2005) Riceviamo e pubblichiamo: LA MARATONA DELL'ARTE SANREMO 2005 - 2006 DAL 18/12/ 2005 AL 06/01/ 2006 - VILLA ORMOND - C.SO CAVALLOTTI,113 - 18038 SANREMO (Im) Riprendendo, dopo la pausa estiva,(l'attività sociale del Centro d'Arte e Cultura La Tavolozza di Sanremo), vi inviamo il bando e regolamento del 7° Premio Nazionale di Poesia di Sanremo (in lingua madre ed in Vernacolo) Tema Libero. In attesa di leggervi, ulteriori concorsi,programma e delucidazioni sulla nostra attività le troverete collegandovi al sito www.sanremoarte2000.it oppure www.la-tavolozza.ito -cav. Casimiro Dell'Arco Talarico-.PER LE ARTI LETTERARIE: 7° Premio Nazionale di Poesia di Sanremo (in lingua madre ed in Vernacolo)Tema Libero- Le nostre manifestazioni sono già on-line- PER LE ARTI VISIVE - 13° Festival Int.dell'Arte Contemporanea-2° Concorso Internazionale "Valori Sacri nell'Arte Contemporanea" 7 Quel Fermo Posta di M. Cristina Buoso Una lunga lettera entro la quale si snoda un'esistenza intessuta di distanze, silenzi e richieste accorate; Fermoposta è una missiva che diviene summa di ricordi, ricettacolo di aspettative, richiesta ultima di ascolto. Ma Fermoposta è anche un mirabile esempio di introspezione e scandaglio interiore: Diva, la protagonista, ripercorre la distanza tra sé e il suo passato per ristabilire la propria identità, per pacificare le contraddittorie istanze che minano il proprio percorso esistenziale. E il suo viaggio finisce nell'esatto punto in cui era iniziato: nel lungo colloquio epistolare stabilito col padre, figura muta e lontana, con il quale la donna si confronta in absentia, in un complesso gioco di specchi e di rimandi, grazie al quale comprende che nella vita non esiste una verità univoca e che "l'apparenza può farci credere una cosa che il più delle volte non è la realtà". Fermoposta, Ed. il Filo, Roma.- Maria Cristina Buoso, poetessa, scrittrice (Rovigo, 1961). Diversi riconoscimenti in ambito letterario; della stessa autrice ricordiamo la silloge di poesia "Parliamone", vincitrice del primo premio ex-equo del Concorso Internazionale "Navarro" indetto dal Lions Club Sambuca-Belice nel 1995. Caro mail artista C’era una volta, in via Mecenate a Milano, una fabbrica di aeroplani. La fondò Giovanni Caproni e con i suoi velivoli riempì i cieli del primo ‘900. Nel 1917, mentre gli aeroplani Caproni percorrevano i cieli, nacque la posta aerea in Italia. Prima e dopo fu la Guerra. Dopo la Guerra. Dopo la Guerra, niente. Dopo anni di abbandono, la proprietà di MECENATE 79 riqualifica l’area e lancia un concorso di idee per l’utilizzo degli spazi interni del complesso di archeologia industriale ex Caproni. La contemporaneità e qualità urbana del quartiere lo rendono uno spazio affascinante; una zona dove passato e futuro convergono, dove si fondono progresso e tradizione. Qui organizzeremo una mostra di mail art e e-mail art sul tema del volo, del progresso come legame tra tradizione e futuro: si chiamerà mailparavion/avionparmail. Puoi inviare la Tua opera, preferibilmente entro il 15 settembre 2005, a: AVIONPARMAIL, Via delle rose 7, 21057 Olgiate Olona (VA)–ITALIA. Oppure a: [email protected]. Arianna, Roberta, Sara, Alessandro e Giacomo. Nostri Poeti Nostri Poeti Nostri Poeti Derek Walcott Il maggiore poeta del Caribe di Antonio Leal Messico Santa Lucía è una piccola isola che conta appena 620 km quadrati di estensione terriera, localizzata al nord di Trinidad e Tobago, nel Caribe, con una popolazione che raggiunge i 157.862 (90.3% africana, 5.5 % meticcia, 3.2% indios occidentali, 0.8% bianchi che parlano inglese, idioma ufficiale dell’isola, patois -francese criollo- e hindi). Il 90% degli abitanti è di estrazione cattolica. Scoperta da Cristóbal Colón nel 1502; Santa Lucía fu colonia britannica dal 1803 fino al 1979, quando celebrò la sua indipendenza il 22 febbraio. La sua forma governativa è strutturata in una democrazia bicamerale parlamentaria, Il potere esecutivo è affidato alla regina Isabel II. la sua moneta è il dollaro CEE. Conta con 610 Km quadrati di superficie coltivabile, la minaccia degli uragani e l’ attività vulcanica rappresentano le sue maggiori problematiche naturali. 8 Principali centri urbani: Santa Lucía, Castries, Gros Island, Marigot Bay, Morgan Bay, Rodney Bay, Soufriere e Vieux Fort. A Derek Walcott, si riconosce la nomea di “el poeta de Castries”, “Il poeta di Castries” ché nativo del luogo; porto e capitale della costa nord est di Santa Lucía che produce limas, zucchero, olio di cocco e cacao, con una popolazione di 45 mila abitanti. Dal 1605 Castries fu abitato da inglesi, nel 1780 fu distrutto in gran parte da un uragano e devastato dagli incendi negli anni 1796, 1813, 1927, 1948 e quindi nel 1951. Derek Walcott La sua biografia è scarna. Derek Walcott ed il suo fratello gemello Roderick perdettero il padre, acquarellista bohémien, in giovane età. La madre dirigeva la scuola metodista del luogo, i nonni nacquero schiavi. Al termine degli studi nel St. Mary’s Collage, in Santa Lucía, Derek Walcott viaggia in Giamaica per studiare all’Università de las Indias Occidentales. Nel 1953 giunge a Trinidad e Tobago dove trova impiego come critico di teatro e d’ arte. A diciotto anni pubblica una serie di scritti titolati 25 Poemi. "A seachantey": Anguila, Adina Antigua, Canelas, Andreuille, tutte le elle Viaggiatrici, delle liquide Antille. Estratto da 25 Poemi. E’ nel 1962, col libro In a Green Night, che Derek Walcott si rivela autentico scrittore. Nel 1959 fonda a Trinidad L’ufficio di teatro, dove vengono portate in scena le sue prime opere influenzate da elementi africani, asiátici ed europei. Elige questa città caribeña come sua residenza, mentre all’Università di Boston, EEUU, insegna letteratura e composizione creativa. Derek Walcott, come egli stesso ha ammesso, appartiene alla costellazione di scrittori segnata da Saint John-Perse come pure Aimé Césaire di “Le armi miracolose”,(nato a La Martinica nel 1913, vero patriarca, gigante della poesía francofona contemporanea scritta del Caribe; Césaire è uno dei massimi poeti della “negritude” nel mondo moderno, come il poeta africano Léopold Sédar Senghor -Senegal, 1906-, presidente del suo paese tra il 1960 ed il 1980). Césaire e Senghor si conobbero a Parigi nel 1928, fondarono il movimento estetico conosciuto come “negritude”, un riscatto degli autentici valori della letteratura orale a partire dagli elementi “creoli” di ogni paese del Caribe; un ritorno alle fonti culturali della stessa Africa. “E’ il maggiore poeta e autore drammatico anglofono che le Indie occidentali hanno prodotto. Riceve il Premio Nobel della Letteratura nell’ anno 1992. In questa occasione confessò: “Sono soltanto l’ ottava parte degli scrittori che potrei essere, se avessi potuto contenere dentro di me tutti i frammentati linguaggi di Trinidad”. I pescatori di lumache Dato che la pelosa ortica, la biforcuta mandragora e la maligna seta, la bava del rospo o l’affilato e spinoso riccio sono, per loro natura, velenosi, non dobbiamo dubitare di 9 ciò che mormorano d’aver visto coi loro occhi di luna i pescatori di lumache. Chi è questo principe? Che elmo porta? Vediamo volare alto i deformi mangiatori di carogne, ogni volta più abbondanti, vediamo che il nostro alito traccia forme vacillanti, ma cosa turba le bagnate rocce accantonate mentre mirano le stelle insonni come il mare? Che rumori nascosti attraversano il regno, occultandosi dalle lanterne dei vigilanti notturni nelle strade bagnate? Schiaffeggiati dai nostri inquisitori, i pescatori di lumache solo farfugliano: «E’ come un’ostrica saldata alla roccia del mare, e non esiste coltello che possa separarla». I sottili torturatori fingono di crederlo. Il moderno sermone del prelato mostra che non c’è male, soltanto volontà male orientata, ma gli occhi dei pescatori di lumache sono grigi come ostriche e la nera vela si distende lentamente sotto la sua chiglia muschiosa. «E’ Abdón l’usurpatore, al cui cuore si lega il rospo.» «Non c’è nulla sotto il suo elmo salvo la vostra paura». «Ha bevuto le orbite dei suoi occhi, e squamosi artigli afferrano l’impugnatura della sua spada». «E riappare una volta che avete fatto il segno della croce?» «Sí. Lo scorpione del mare accorre al suo fischio come un cane». «Sotto la sua saliva acida gli avvoltoi dispiegano i loro ombrelli, e il mare riluce come una profondità di rete attraverso la nebbia. Si afferra al collo di questo mondo e non c’è modo di distoglierlo». Quando gli diamo zuppa, e questo si prolunga durante notti, il più giovane guarda il vapore fino a che raffredda. «Se Abdón è l’ usurpatore, che usurperà?» Vibra. «Magari si confrontano con lui legioni di serafini d’argento». Gli spieghiamo che è la luce della luna che è ammutinata sopra le onde, l’ illusione dei pescatori, che sono impazziti per il sale nei tagli dei palmi delle mani, ma tutti credono che è Abdón, quello che si erge nel bagnato rompi -onde, facendo tremolare le sue ali nervose come un cane bagnato, eretto come una pastinaca, è una manta, non il demonio; ma il più giovane ripete con voce inumana per l’ afonía, come il lento ritrarsi delle onde sopra la roccia ulcerata dalle lumache: «Se non è lui, perché allora 10 smembrano la luna le nubi di nero manto e affogano il suo rotondo grido come di pazza?» Occhi selvaggi come lumache sopra il cucchiaio alzato. (Trad: Gabriel Impaglione e Giovanna Mulas) Derek Walcott Derek Walcott le origini della poesía caribeña Sono soltanto un negro rosso che ama il mare. Ricevetti una solida educazione coloniale. Vive in me dell’olandese, del negro E dell’inglese, E, o sono nessuno o sono una nazione. (Señala Shabine, uno dei personaggi di Derek Walcott) Al ricevere il Premio Nobel nel 1992, durante il suo discorso titolato Le Antille, frammenti di una memoria epica, Walcott pronunzió queste parole: "La poesía è come il sudore della perfezione, ma deve luccicare così fresca come gocce di pioggia sopra la fronte di una statua. Combina il naturale con il marmoreo. Coniuga simultaneamente ambo i tempi: il pasato e il presente: il pasato è la statua; il presente la rugiada o la pioggia sopra la fronte. Esiste il linguaggio luttuoso e il vocabolario personale; il lavoro della poesía è scavo e scoperta di uno stesso. Per ciò che tocca la tonalità, la voce personale è un dialetto; compone il suo accento, il suo vocabolario e la sua melodía, a dispetto del concetto imperiale del linguaggio: il linguaggio di Ozymandias, delle biblioteche e i dizionari, dei tribunali di giustizia, i crítici, le chiese, le università, il dogma político e la dizione delle istituzioni. La poesía è un’ isola che si allontana dal continente. I dialetti del mio arcipelago mi paiono uguali a fresche gocce di pioggia sopra la fronte della statua; non sono un sudore sorto dal classico marmo severo, se non la condensazione di un elemento rinfrescante: pioggia e sale…” Assegnando allo scrittore antillano Derek Walcott il Premio Nobel della Letteratura per l’anno 1992, l’accademia svedese riconobbe il fecondo lavoro di un poeta profondamente radicato alla terra del Caribe. Walcott pubblicò nel 1964 la sua prima silloge poetica, Selected Poems, alla quale seguirono The Gulf (1970), Another Life (1973), The Star-Apple Kingdom (1979), The Fortunate Traveller (1981), Midsummer (1984), The Arkansas Testament (1987) e Omeros (1990). Nel 1993, la casa editrice newyorchese Farrar, Straus & Giroux pubblicó un ulteriore volume di poesie, Odyssey: A Stage Version, col suo discorso del ricevimento del Premio Nobel («The Antilles: Fragments of Epic Memory»). Omeros fu tradotto in spagnolo da José Luis Rivas e editato, assieme al testo originale dal Círcolo di Lettori nel 1995. L’anno precedente, Visor Libros incorporó alla collezione di poesía El Testamento de Arkansas, nella versione spagnola a cura di Antonio Resines ed Herminia Bevia. Attualmente si traduce l’ultima silloge poetica di Walcott, pubblicato a New York nel 1998, The Bounty. L’ edizione in spagnolo di La sovrabbondanza apparirá per i tipi della Visor Libros dopo l’estate. Álvaro Pombo ha selezionato e tradotto poemi della prima parte di questo libro per Nueva Revista, anticipando in questo modo ciò che sarà un grande evento editoriale dell’autunno prossimo. Osservazioni 11 di un traduttore non caribeño su Derek Walcott di Álvaro Pombo (1) E’ la prima volta che mi propongo di tradurre poetica e pubblicamente a un poeta. Al di là di tutto il processo di traduzione mi sono sentito come qualcuno che entra in un territorio agreste che, a semplice vista, pareva liscio e piano. Derek Walcott è poeta antillano, nato nel 1930 nell’ isola di Santa Lucía. Vinse il Premio Nobel di Letteratura nel 1992. Questo poema, La sovrabbondanza, dà títolo ad una silloge di poesia che evoca l’isola natale del poeta. Ho eletto questa opera perchè si tratta di una, a mio giudizio, ammirabile elegía alla madre di Walcott: Alix Walcott. Desidero sottolineare, una volta in più, i due sentimenti contrapposti che hanno accompagnato il mio lavoro come traduttore: un sentimento di facilità o familiarità e altro sentimento, opposto, di difficoltà ed estraneità. In tali condizioni sono stato obbligato a leggere ognuna delle sette parti che compongono la elegia ad Alix Walcott un buon numero di volte per, infine, fare una prima traduzione selvaggia, e terminare con una seconda versione; quella che adesso offro ai lettori di Nueva Revista come la definitiva. Tradurre questo poema ha significato per me due attività molto diverse: una pratica, consistente nel fissare mediante una decisione finale il testo spagnolo, e altra, teorica, consistente nel domandarmi se la mia traduzione spagnola traduce —in relazione al testo inglese, che ha carattere indicatorio — il significato dei diversi versi e frammenti che Derek Walcott va accumulando come chi ordina gli eterogenei oggetti di una tavola in un modo intelligibile e anche arbitrario. (2) Per la prima volta dopo molto tempo, la poesia di Derek Walcott ha aguzzato i miei sensi poetici. Leggendolo ho risentito quel caratteristico appetito per le parole della tribù, purificate dal poeta, che chiamiamo poesía. L’espressione poetica è stata per me un alito costante: nei miei quattro libri di poesia è contenuto tutto l’essenziale della mia scrittura. Mantengo piena la testa di questi anni di prosa narrativa, e per le narici e per le orecchie esce il ritmo della prosa, linguette scolorite dell’edera d’ orazione subodinata. Non ho perso il polso della contemplazione poetica –nè l’abitudine- però un poco la mania dell’espressione poetica, l’urgenza di scrivere poemi. Questo è ciò che mi ha fatto ricordare Derek Walcott immediatamente: il gusto rinnovato per l’espressione poetica. (3) E questo ha una certa grazia: casualmente non esistono due paesaggi basali più opposti di quello di Walcott ed il mio: il Caribe e Castilla la Vieja. Il più marittimo del mio paesaggio basale è il principale, l’ isola di Mouro, il fiume Cubas, la baia di Santander. In questo c’è grazia poetica in più, la stessa della pianura di Castilla. Walcott è stato capace di percepire nei poemi di Antonio Machado una gran quantità di bellezza nell’austerità alla quale io faccio referenza. Al comparare questi due mondi infantili, il caribeño e il castellano, ricordo un’interessante osservazione di Walcott ne La Voce del Crepuscolo, a proposito delle sere di forte caldo in Porto Spagna, “quando il risplendere del sole faceva le strade bianche”: “Mi costa percepire questo vuoto come desolazione, questa pazienza è la lunghezza della vita nelle Antille, e il segreto risiede nel non chiederle ciò che non può dare, non esigerle 12 un’ambizione che non le interessa. Questo legge il viaggiatore nel letargo, nel torpore. Non è questo stesso letargo ciò che interpreta il viaggiatore frettoloso nell’attraversare i campi di Castilla o le pagine di orti, ciliege, peri, mandorli, retamas e cardi borriqueros dei miei libri di poesia? E’ curioso che Walcott veda privazione dove altri vedono il pittoresco, e che ci avverta quando “il viaggiatore non può amare perché l’amore è estasi e il viaggio è movimento”. E così ci dice che “la privazione può imprigionare insolite virtù, una delle quali è, senza dubbio, quella di salvarsi dall’attuale onda di mediocrità giacchè oggi i libri non si creano tanto quanto si rifanno”. In qualche maniera la familiarità che ho sentito leggendo l’esuberante poesia di Walcott, procede di pari passo con la sua insistenza in cui il lettore abbandona la sua condizione di viaggiatore e s’installa nella concentrazione e nell’estasi. Tale concentrazione, ammirazione estatica, esaltazione poetica nei confronti delle dure terre spagnole, mi ha accompagnato sempre e mi ha implicato a fondo adesso nel lavoro di questo poeta. Vero è che Walcott ha un’idea vivida dello sforzo che il poeta compie nel captare il significato, il senso del mondo. Perché le cose del mondo “per essere ciò che erano, con lo stesso nome, necessitavano di passare per un processo di traduzione” ( Cfr: dall’articolo di Walcott “Brodsky e il suo benedetto esilio”, abc 1.11.1996). In questo stupore reverenziale per le cose comuni di cui parla Walcott, vedo una ripetizione creativa nell’idea di Rilke circa i poeti, che succhiano nelle cose visibili il miele dell’invisibile. Da qui il suo desiderio e la lezione che apprese dalla madre Alix Walcott: « che le formiche m’insegnino di nuovo, con lunghe file di parole/la mia professione e il mio dovere, la lezione che insegnasti ai tuoi figli/ scrivere sulla sovrabbondanza della luce sopra le cose familiari/che stanno al punto d’essere tradotte da se stesse in nuove ». Questa grande innovazione di tutta la sfera familiare, disfae le immagini topiche dei turisti fino a farci vedere che «il Caribe non è un luogo idilliaco, non per i nativi”. Il Caribe è un luogo reale, dove la poesia importante, l’importante cos cienza creativa, s’inginocchia ed emerge nella realtà. Una realtà che è sovrabbondanza, e, di conseguenza, naturalmente, ci trasporta in una regione che mi avventurerei a chiamare religiosa: una zona della coscienza del mondo esaltato ed espresso con devozione e con stupore, in un eterno adesso, accanto alla trascendenza. La Sovrabbondanza di Derek Walcott for Alix Walcott I Il deserto dove le esaltazioni d’Isaia fanno sorgere una rosa nella rena Giace tra la vista dell’ufficio del turismo e il vero paradiso. Il canto trentatrè circonda le nuvole dell’aurora con uno splendore concentrico, il frutto dell’albero del pane apre le sue palme in un elogio dell’abbondanza bosco-pane, albero del pane, alimento di schiavo, gioia di John Clare Tom vagabondo, rotto, che carezza l’ermellino nella sua provincia Di giunchi e grilli di canna, che giocano con l’aria umida, che si allaccia gli stivali coi fusti delle vigne, che inquieta gli scarafaggi glassati con soavi spinte, cavaliere del calabrone involto nelle nebbi e dei campi di palme come guglie di corni di lumaca che si aprono alle pozze come coppe dell'anima di Tom che sta più in salvo della nostra dunque cinte di ferro incatenano le sue caviglie. In piedi stà Tom, con il ghiaccio sbiancando la barba, nel guado di un ruscello, come il Battista che alza i suoi rami per benedire le cattedrali e le lumache, la nascita di questo nuovo giorno, e le ombre della strada della spiaggia vicina alla quale giace mia madre accompagnata da un transito di insetti che vanno a lavorare in ogni caso. 13 La lucertola fissata sopra la parete bianca nel geroglifico della sua ombra pietrificata, l’arcata scricchiolante delle palme, le anime e le vele dei gabbiani giratori rimano con: Nella sua volontà c’è la nostra pace. Nella sua volontà c’è la nostra pace. Pace nelle bianche baie, nelle marine degli alberi maestri concordi, nei meloni crescenti lasciati tutta la notte nel frigorifero, nei lavori Egiziani di formiche che muovono pezzi di zucchero, parole in questa frase, ombra e luce, che vivono nella porta accanto come vicini e nelle sardine in salsa pepata. Mia madre giace Vicina alle pietre bianche della spiaggia, John Clare giace vicino ai mandorli del mare e nonostante L’abbondanza ritorni ogni mattina, per mia sorpresa, per sorpresa mia, si, e tradizione, entrambe le cose assieme. Come te, anch’io, Tom pazzo, mi sento commosso per una fila di formiche; qui contemplo il suo lavoro e mi sembrano giganti. II Lì, nella spiaggia, nel deserto, giace il pozzo oscuro dove fu sepolta la rosa della mia vita, vicina alle piante agitate, accanto allo stagno delle lacrime fresce, solcato dal rintocco della campana dorata della danza Allemanda, spine della bouganvillae e questa è la sua abbondanza! Brillano sfidanti tra le erbe e i fiori, incluso quei fiori che fioriscono in altri luoghi, piante aromatiche, edere, clemátides sopra le quali il sole si alza ora con tutto il suo potere, e non in beneficio dell’ufficio del turismo o di Dante Alighieri se non perché non esiste nessun altro cammino per il suo corso eccetto fare delle piante rampicanti del cammino della spiaggia un’ allegoria del decorso di questo poema, del tuo stesso decorso, perché lei morì a beneficio di una ghirlanda coronatrice di falso lauro; cosicchè, John Clare, perdonami per amore di questa mattina, perdonami, caffè, e scusami, latte con due bustine di zucchero artificiale, mentre vedo crescere queste linee e l’ars poetica mi indurisce in un dolore tanto insolente come queste, alfine di disegnare la velata figura di Mamà entrando a far parte del convenzionalmente elegiaco. No. Il dolore è veritiero, sempre lo sarà, ma non deve provocare pazzia come fu con Clare, che pianse la perdita di uno scarafaggio per il peso del mondo in una goccia di rugiada sopra la clemátide o la pianta aromatica. e c’è il fuoco nelle linee della stoppia secca che odio tanto quanto l’amo, povera disgraziata, colpita dalla pioggia, 14 redentrice di topi, frustrata signora della cavalleria sotto la tua mantella. Venga già, già è sufficiente! III Sovrabbondanza! Nelle campane delle rane arboree col loro clamore stabile, nell’oscurità azzurro-violetta prima dell’aurora, il morse debilitato delle lucciole ed i grilli, quando sopravviene la luce sopra il guscio dello scarafaggio, e i ritardatari presagi del rospo, e ortiche del rimorso che cresceranno nella sua tomba a partire dell’angustia della pala. E il non averla amata sufficientemente è, si lo confesso, amarla più ancora. E lo confesso.Il gocciolare delle sorgenti sotterranee, il mormorare dei deformati strapiombi sotto i bagnati lecci che perdono l’appoggio delle loro radici, fino a che un ammasso peloso come pugni che si aprono, girano fino a dove voglia portarli lo strapiombo, e i suoi risultati tremolanti dribblano le aste della canna selvaggia. Sovrabbondanza nella furia delle formiche al destarsi, nel guscio delle lumache movendosi lentamente sotto le patate selvagge, elevazione nella decadenza e nel processo, stupore reverenziale per le cose correnti, nel vento che legge le linee delle palme dell’albero del pane, nel sole contenuto in un globo di cristallo ghiacciato, sovrabbondanza nel seguire delle formiche una linea di farina cruda, compassione per la mangosta che passa correndo in fretta di fronte alla mia porte, nel parallelogrammo di luce teso nel pavimento della cucina, perché Tuo è il Regno, Tuo è il Potere e la Gloria, le campane di San Clemente nei fiori-meraviglia sopra l’ altare, nelle spine delle bouganvillae, nei lillà imperiali e nelle palme piumose che muovono la testa all’entrata di Gerusalemme, il peso del mondo sopra la spalla di un asino; disarcionando. Al disarcionare, Lui lasciò lì la Sua croce per la guardia e il centurione che si prendeva gioco di lui. Allora ho creduto nella Sua Parola, nel marito immacolato di una vedova, negl’inginocchiatoii di legno marrone, quando il campanaro della chiesa congregava il nostro gregge tra pareti purificate, nelle quali inni scricchiolanti ho ascoltato le fresce fonti Giacobee, il mormorio della grazia, che ascoltò Clare e che permane con noi, il chiaro linguaggio che lei c’ insegnò «come il cervo anela », all’arrivare a questo i suoi attenti orecchi si drizzavano mentre i suoi tre cerbiatti sorbivano le acque che rinfrescano l’anima, «come il cervo anela all’acqua della fonte», che apparteneva al linguaggio nel quale la piango adesso, o quando 15 le mostrai la mia prima elegìa, la elegìa di suo marito, e ora la sua. [...] VII In primavera, dopo l’auto-sotterramento dell’orso, i balbuzienti zafferani si aprono e cantano in coro, i ghiacci scivolano e si sciolgono, stagni gelati si frammentano in mappe, lance verdi sorgono dai campi disciolti, stormi di grajos si alzano e raschiano la luce perforata, le lente valanghe che si rovesciano da un cielo inquieto; il topo di campo si svita e il castoro mostra la sua elegante testa tra i rami del cespuglio; solchi, canali e ruscelli ruggiscono con un’acqua che indurisce il polso. Salta il cervo invisibili barriere e odora l’aria viva, gli scoiattoli si alzano come domande, le nocciole arrossiscono facilmente, gli arbusti godono nelle loro forme (sia chiunque sia il loro creatore). Ma c’è una stazione, qui, nel nostro eden verdeggiante che è l’eden del giardino primogenio che originò decadenza, a partire dalla semente del rifiuto di uno scarafaggio o una lepre morta, così bianca e dimenticata come l’inverno al principio della primavera. Non c’è cambio adesso, nè cicli di primavera, autunno, inverno, né l’eterna estate di un’isola; mamà portò il tempo con lei, neppure clima c’è, né calendario, ad eccezione di questo giorno sovrabbondante. Così come il povero Tom diede la sua ultima scorza di pane ai passeri trepidanti così come unito alle canne e ai freddi stagni che John Clare benedì a questi magri musicisti, che le formiche m’insegnano di nuovo con lunghe file di parole, la mia professione e il mio dovere, la lezione che tu insegnasti ai tuoi figli: scrivere sulla sovrabbondanza della luce sulle cose familiari, che stanno al punto di essere tradotte a sé stesse in nuove: il gambero, il passero-fregata che plana sopra le sue ali cruciformi e quell’albero inchiodato e incoronato di spine che apre i suoi inginocchiatoii al merlo che non ha dimenticato mia madre perché canta. Fonte: http://www.nuevarevista.net/ mailto:[email protected] Su gentile segnalazione di Antonio Leal, Mexico Translation to the italian language by Gabriel Impaglione and Giovanna Mulas Fabio Grasselli Italia 16 I POETI CINESI CONTEMPORANEI E LA LORO CONCEZIONE DELLA POESIA CINESE ODIERNA (i discorsi circa la poesia contemporanea in Cina sono tratti dalle risposte al questionario proposto da C. Pozzana e A. Russo, postfazione di “nuovi poeti cinesi”) YANG LIAN Yang Lian, nato a Berna nel ’55 (la famiglia tornerà in Cina lo stesso anno), svolge negli anni settanta, come grandissima parte dei giovani cinesi, lavori nelle campagne e viaggia in diverse regioni periferiche della Cina; nel ’76 perde la madre, figura centrale nella sua vita. Queste esperienze gli forniscono i primi spunti ispirativi per la sua poesia. Comincia a pubblicare i suoi versi nel’79, sulla rivista Jintian, dopo esservi stato introdotto da Gu Cheng, conosciuto durante il movimento democratico Primavera di Pechino. Nell’83 è attaccato dal governo nell’ambito della campagna “contro l’inquinamento spirituale” a causa del contenuto del suo poema Norlang (nome di una divinità tibetana) e da quell’anno, quindi, incontra grosse difficoltà nella pubblicazione in Cina. Nel 1987 fonda insieme ad altri poeti il Club dei Poeti Superstiti con cui crea la rivista «Xincunzhe» (per l’appunto superstiti). Sul finire degli anni Ottanta comincia a viaggiare per il mondo, fissando un punto di ferma collaborazione con l’Università di Auckland in Nuova Zelanda, città in cui si trova quel drammatico 4 Giugno, quando l’esercito cinese massacra centinaia di studenti. A causa delle sue affermazioni sull’evento è esiliato. Yang Lian e l’amico Gu Cheng restano ad Auckland dove organizzano una storica lettura di protesta presso la cappella Maclauren dell’Università. Diviene uno dei poeti simboli dei menglong, prendendo elogi e venendo tradotto in più di venti lingue. Oggi vive a Londra. Due sono i temi- base dei versi di Yang Lian: il laceramento della materia e la scomposizione temporale. La storia, si introduce nella scrittura e la colma nei suoi lati visibili ed invisibili. Si passa da un’idea diacronica della storia ad una ideazione sincronica, dove passato e presente non si differenziano, o più semplicemente non sussistono. In Lian, come nei menglong e nei postmenglong, risulta basilare la forma, lo stile, il ritmo interno, visibile nell’ideogramma, tangibile, constatabile, evocativo, come Pound aveva sostenuto nella sua rinomata ed apprezzata (anche dai nuovi poeti cinesi) opera su Confucio e sui manoscritti di Fenollosa. Confessione rappresenta una delle prime prove dell’allora venticinquenne poeta, è una poesia della post-devastazione, un’ode alla solitudine, alla permanenza in vita dopo l’olocausto, una distesa desolata che richiama alla mente le rovine della waste land Eliotiana: Confessione. Alle rovine dello Yuanmingyuan1 (residenza imperiale a Pechino distrutta dagli eserciti europei nel 1860, di venuta simbolo della crisi nazionale cinese) nascita possa questa pietra taciturna testimoniare la mia nascita possa questo canto risuonare nella nebbia fluttuante in cerca dei miei occhi 17 dove si infrange la luce grigia archi e colonne proiettano ombre e ricordi più oscuri della terra bruciata immobili come nell’estrema agonia braccia tese convulsamente al cielo come ultime volontà consegnate al tempo ultime volontà divenute la maledizione della mia nascita sono venuto tra queste rovine in cerca di quella debole stella intempestiva sola speranza che mi ha illuminato destino – nuvole cieche segnano impietosamente la mia anima non per piangere la morte! Non è la morte che mi ha attratto verso questo mondo desolato io resisto a tutta la desolazione e la vergogna le fasce del neonato sono un sole incompatibile con la tomba nella mia precoce solitudine chi sa a quale spiaggia porta questa strada fosforescente che cantando va verso la notte un orizzonte segreto ondeggiando porta a galla sogni remoti quasi infinitamente remoti invece della meridiana spezzata sepolta nel fango c’è solo il vento che alzando una canzone indica la mia aurora (trad. di A. Russo) Ecco riportate le sue parole a proposito della singolarità della poesia cinese contemporanea: “per <<poesia cinese contemporanea>> s’intende la poesia della Cina continentale che ha il suo punto di partenza nella “poesia underground” del periodo della rivoluzione culturale e che si è manifestata apertamente dal 1979 attraverso riviste indipendenti come “Jintian”. Con questa stessa definizione si indicano anche le due caratteristiche principali di questa poesia. In primo luogo, si tratta della profondità dell’esistenza individuale. Parlo di esistenza e non di politica. Infatti fin dall’origine della poesia cinese contemporanea v’è l’abbandono di tutto il lessico, nonché della logica, delle menzogne politiche in Cina. La politica è soltanto un certo colore del contesto esistenziale nel quale si genera questa poesia. Perciò i problemi socio-politici non sono mai di ventati il tema della poesia cinese contemporanea (come invece avviene spesso nella <<poesia di critica sociale>>). La modalità fondamentale con cui la poesia cinese contemporanea esprime l’esistenza è individualizzata, non socializzata, è concreta, non astratta. Infatti la tonalità poetica fondamentale è permeata dalla sofferenza, dal dolore, dalla disperazione, dalla fluttuazione, dalla morte e dalla predestinazione. Vorrei ora parlare della “profondità”. Non intendo dire che la poesia cinese contemporanea è la più profonda che ci sia al mondo, ma indicare che in generale essa possiede un severo “senso dell’esistenza”. Forse la storia è stata tanto pesante, la vita tanto oppressiva, che l’umorismo è diventato un lusso. La lingua non può che combaciare con la durezza del mondo. Si può dire che noi, a partire dalla nostra personale sofferenza, abbiamo colto sempre più in profondità l’esistenza umana. Per esempio, a proposito di quel <<Quattro Giugno>> (il massacro di Tian’anmen del 1989 ) che ha scosso il mondo, nella mia poesia 18 non ho potuto che scrivere <<questo non è che un anno qualsiasi>>, non potendo esprimere in nessun altro modo l’intensità del dolore. Una poetessa ceca mi ha detto: <<ciò di cui hai scritto non è la politica, è la morte.>> Le ho risposto: <<la morte quotidiana.>> La seconda caratteristica è che la consapevolezza e la forma della poesia cinese contemporanea sorgono dalle caratteristiche della lingua cinese. L’atteggiamento del poeta cinese nei confronti della sua lingua è estremamente complesso. Da un lato sente profondamente l’oppressione di storia e cultura di cui è permeata la lingua stessa; ma d’altronde questa è la sua sola lingua. Noi non possiamo far altro che cercare individualmente di ricreare una tradizione. La caratteristica pittografia del cinese è stata alle origini della poesia imagista inglese e americana. Il poeta italiano Montale ha detto: <<la poesia cinese antica resiste ad ogni traduzione>>. D’altronde la poesia menglong ha creato un così grande scompiglio in Cina solo perché i poeti hanno cercato di ripristinare queste caratteristiche espressive della poesia tradizionale. Ma il fatto che la poesia contemporanea ritorni alle caratteristiche proprie della lingua cinese è il punto di partenza della ricerca della coscienza e della forma della poesia moderna. Ancor più dopo il 1985 alcuni poeti hanno strutturato <<immagini>> isolate e disperse nella composizione di <<immagini>> complesse, utilizzando intenzionalmente nella poesia contemporanea le peculiarità della lingua cinese: le sue caratteristiche visive, l’agilità grammaticale, la mancanza di flessioni, l’ellissi dei pronomi personali eccetera. In tal modo hanno composto alcune opere che io chiamo di <<coscienza poetica>>. La mia raccolta di versi Yu siwang duicheng [in simmetria con la morte] del 1986 mostra come i poeti cinesi sono impegnati nel duplice sforzo di esplorare la tradizione ed esprimere l’oggi. Io penso che a tutt’oggi la forza motrice della poesia cinese contemporanea, il principale fattore della sua singolarità, proviene dal fatto che noi proviamo un senso di <<difficoltà radicale>>: un altopiano di terra gialla non significa solo la povertà, ma anche lo scorrere inutile del tempo. Ogni carattere cinese è una trappola nella quale cadono una dopo l’altra intere generazioni. Questo non è il dolore per <<l’insaputo>>, ma il dolore per aver <<saputo>> tutto ciò che forse non è mai esistito. Quanto a questa <<singolarità>> dell’esistenza stessa, ciò che la poesia cinese contemporanea ha espresso finora è largamente insufficiente. Naturalmente ciascun poeta è fin dall’inizio del tutto diverso dagli altri. Io sto solo discutendo alcune impressioni generali.” Si ringrazia, per la preziosa collaborazione, lo staff di www.cinaoggi.it Lino Concas Australia Melanconia d’autunno Melanconia d’autunno, Secche foglie Che il vento ha disperso Come voci Che maledetta lingua Tra i denti ci uccide. Ritorno a quell’angolo Ove sempre scorre il fiume E più verde il cespuglio Nella felicità Defunta di un’ora. 19 Troppo ho amato E non è amaro lo sforzo Di questo ritorno, se il parco anche distrutto saprà accogliermi ancora. Se nella corteccia molle Di un platano nuovo Potrò scolpire il mio cuore. Susana Giraudo Argentina LA POLTRONA DEI SOGNI EL SILLÓN DE LOS SUEÑOS Un sillón de caña malaca y el infierno, filtrando su amenaza entre el junco y los espacios. Una poltrona di canna malese e l´inferno, filtrando la sua minaccia fra il giunco e gli spazi. Todo sobre esa nube en la que los sueños hablaban de algo lejano que hoy arde, quema, en los lugares donde la vida de tan precisa puede tocarse. Tutto su quella nuvola nella quale i sogni parlavano di qualcosa lontana che oggi brucia, scotta, nei luoghi dove la vita tanto precisa può toccarsi. RITUALE La danza nasce nel mistero. Qualcosa trabocca e cresce cresce cresce per tutto il corpo, cantando un suono che spinge che trema che lotta per spuntare in ritmo e movimento. E dopo è danza. Danza-riso dell´essere che si libera ridendo, disegnando con i piedi la sua voluttuosità. Ride il corpo la sua dichiarata passione. 20 Ride la pelle nella sua lubricità splendente. Ride danzando chi ascolta un battere d´ali che lo popolano. Danza amato, balla il tuo riso! Regna sui giri della tua danza Essi ti mostreranno i labirinti dell´Amore che sa di tutti gli amori. Danza! Danza! Balla fino all´estasi. Lì vedrai il Viso, vedrai la maschera vedrai lo spettro impazzito dei tuoi sogni, vedrai La Verità come la videro quelli che danzarono in rituali antichi. Balla amato, danza come se con il tuo corpo intenso e unico possa fondere il principio e il fine il primo e l´ultimo dei giorni! Danza amato! Danza! Susana Giraudo è autrice, tra l’altro, di: Trazo y Poema, Cuerpo de luz, La luna en fuegos de final de noviembre, La armonía de las desarmonías -edizione bilingue italiano/español, El sonar transparente. E’ presente in numerose antologie. Ha ricevuto vari riconoscimenti letterari, tra i quali ricordiamo: Primer Premio del Certamen de Poesía e Primer Premio del Certamen de Cuento de la Dirección Municipal de Cultura de Villa María, Premio Plaqueta de Oro del Certamen de Poesía "Hugo Mandón" di Santa Fe, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores 1999. Giovanni Urracci Svizzera la terra che non ride La mia terra è antica e martoriata: Dai tempi dei tempi è l`isola del dolore. La mia terra è antica è sconosciuta: Pochi hanno ascoltato i suoi palpiti profondi, i suoi lamenti, la sua voce. La mia terra è antica e taciturna: Per secoli fu l`isola del silenzio. La mia terra antica oggi riemerge come una terra nuova dal mare. Segnaliamo vivamente ai lettori il sito 21 Arte…non tutto ma quasi http://groups.msn.com/Artenontuttomaquasi di Vincenzo Conciatori [email protected] V. Conciatori, Pittore, muralista. Suoi lavori su tela e le opere murarie si trovano in diversi paesi della Sardegna, enti pubblici e privati. Art Director dell’Università degli Studi di Cagliari, promuove iniziative tendenti alla divulgazione dell’arte e coinvolge strutture già esistenti per manifestazioni regionali, nazionali, progetti per l’autogestione dell’Arte direttamente curati dagli artisti, organizza annualmente mostra nazionale nella Cittadella dei Musei dell'Università di Cagliari. Salvo Zappulla Italia L’Isola A sud dell’equatore c’è un’isola sconosciuta ai naviganti; non è segnata sulle carte nautiche e la rotta per arrivarci mai si troverà. Lembo di terra tiepida, folta di vegetazione e di bellezze incontaminate. Nessuno si illuda di potervi approdare perché è scritto che essa debba appartenere a pochi eletti soltanto: è l’isola dove vanno a dormire le anime dei marinai. Al calar delle tenebre un veliero silenzioso e furtivo salpa dall’isola, viaggia di notte per non farsi notare; prosegue piano, sospinto dal vento e non lascia scia al suo passaggio, come sfiorasse appena le onde, accarezzandole dolcemente. Naviga solitario, senza guida al timone, conosce già la sua meta e si dirige sicuro evitando gli ostacoli; non teme uragani e tempeste, esso stesso è parte integrante del mare e dei suoi momenti di furia. Nessuna vedetta sopra il ponte, né un mozzo e neanche un nostromo; di comandanti, poi, nemmeno a parlarne. Sono tutti sottocoperta, ognuno intento nelle proprie faccende: chi gioca a carte, chi ai dadi, altri stanno in silenzio assorti in chissà quali pensieri. I vecchi lupi di mare seduti in cerchio si raccontano le avventure di pesca e fanno a gara a chi la spara più grossa: “Vi ho detto di quella volta che arpionammo la balena parlante?” “Ed io, quando caduto in acqua, venni salvato da un’orca? Mi portò a riva in groppa alla sua schiena”. “E quel giorno che sba rcammo nella terra delle pietre danzanti? Il povero aiutante cuoco ci rimise un occhio”. “Suvvia, raccontala a un altro!”. Si scaccia la noia e la malinconia, e il tempo si affronta più serenamente. Ma ha senso il tempo di fronte alla vastità dell’oceano? Dinanzi alla calma della notte, al mare piatto senza fine? La fantasia vola alto ad acchiappar le nuvole, poi si tuffa a cercare nuova linfa tra i cavalloni marini e i meandri dei fondali; s’innalza ancora, sopra il pennone dell’albero maestro e da lì si specchia nell’acqua cristallina. I delfini, dispettosi, fanno mulinello in un girotondo gioioso. Quanti racconti ci vogliono per riempire lo spazio di un’eternità? C’è uno che se ne sta in disparte a guardare attraverso il vetro dell’oblò, e con lo sguardo insegue il volo dei gabbiani. Improvvisamente intona un motivo triste, quasi un lamento di dolore. Gli altri si fermano ad ascoltarlo, si alzano dai loro posti e tutti insieme si associano alla cantilena. Nelle menti si dipana il filo dei ricordi e gli occhi vagano disperati oltre l’orizzonte. Ognuno rimpiange un amico, la moglie, un figlio perduto per sempre. Lacrime silenziose si riversano nel mare. Chi l’ha mai detto che le anime non piangono? E tutte le gocce d’acqua salata, cos’altro sono se non lacrime? Quando cominciano a delinearsi i primi chiarori dell’alba, il veliero prende la via del ritorno, si accosta alla piccola insenatura dell’isola, docile come un bambino nel grembo della madre, e cala le ancore. L’isola lo attende paziente. Scendono le anime dei marinai a cercare riposo, ognuna nel suo giaciglio, sotto la brezza fresca di una palma e all’interno di un incavo naturale della roccia. Ora l’isola lentamente si inabissa per 22 nascondersi alla vista del giorno che arriva. Nessuno deve scoprirla, appartiene a loro, alle anime che donarono la propria vita al mare. Non c’è posto per altri. Solo chi ha amato veramente il mare può accedervi e avere in dotazione le chiavi che lo introdurranno nei segreti di un regno misterioso e inviolabile. Quando si ritira anche l’ultimo raggio di sole, l’isola riemerge in tutto il suo splendore, nemmeno la salsedine ne intacca la bellezza. Le anime dei marinai si ridestano, sciolgono gli ormeggi. Si riparte verso un altro viaggio, nuove storie, nuove avve nture. Poeti nascosti Poeti nascosti Poeti nascosti Poeti nascosti Poeti nascosti a cura di Lucio Mura La pagina “vuota”; “scarna” ma spontanea, fulmineamente crea l’insieme dei versi di Matteo Ventrella, poeta garganico. Essenziale nella sua sospensione letteraria a volte accompagnata ad un movimento di passione, ad un movimento di limpidezza, ad un amore della vita. Vi si trovano frammenti di esilio, di arcobaleni, senza eccentricità, senza strumenti dialettici freddi, con contrasti di esistenza, rappresentazioni di consuetudini, di vita naturale, discreta, rappresentazioni del vivere collettivo tipici del Sud. Leggiamo cosi Matteo Ventrella come poeta e come scrittore apprezzandone l’impronta e la semplicità legate alla saggezza di uomo e di insegnante. MADONNA Della mia terra, Madre delle madri Della mia terra, Giglio dei gigli Della mia terra Musa delle muse Della mia terra, dà forza a questo canto che morte non lo soffochi. E’ il canto d’amore D’amore e di rabbia D’un figlio delle tue figlie, indegno del Tuo ma tuo. IL LAMENTO Robusto Di una scavatrice Ti scava l’anima Fino a sera. Un’ora di sosta A mezzogiorno. TU LOTTI Con l’intelligenza Io con il sentimento, tu con la mente 23 io col cuore. Tu sei più forte, lo so, hai dietro cento generazioni, sei il loro risultato; io, invece, alle spalle non ho nessuno e sono niente, un povero, un povero di quel Sud, un tempo terra Magna terra di migrazioni. Per la tua Madunina Dammi tregua una generazione. SENZA INNESTO Non c’è frutto Non c’è progresso. L’innesto è mio Ed è tuo, è reciproco. Matteo Ventrella è nato a Vieste, nel Gargano. Per ragioni di studio e lavoro ha dovuto vivere lontano dalla sua terra, prima a Palermo, come maestro e studente di pedagogia, poi a Milano come professore di scuola media. Ha scritto numerosi libri, alcuni editi ed altri inediti, tutti ispirati all’innocenza dei ragazzi e alla verginità della sua terra; suo Eden. Una vasta opera di poesia e narrativa intitolata “Lo Sperone”. Premiato a carattere nazionale per la letteratura per l’infanzia, è autore di testi di narrativa per la scuola media. Sue poesie sono incluse nell’antologia “testi poetici del novecento” di Lucio Zaniboni (1985) ai cani sciolti della letteratura consigliamo vivamente www.villanovastrisaili.com www.villanovastrisaili.com www.villanovastrisaili.com di Rina Brundu. Salotto letterario, Narrativa, Poesia Roberto Mistretta Italia Piergiorgio Di Cara & Giacomo Cacciatore Il poliziesco made in Sicily tra Lucarelli e Scerbanenco 24 Appartiene alla scuola dei duri, quella che ha fatto del poliziesco e del noir un’icona e si riconosce nel nuovo caposcuola bolognese del gruppo dei 13, Carlo Lucarelli. Piergiorgio Di Cara, (1967), nativo di Palermo è Commissario Capo della Polizia di Stato e dirige il Reparto Prevenzione Crimine a Siderno. Ha pubblicato i racconti “Cammina stronzo”, e due romanzi “Isola nera” e il recente “L'anima in spalla” (E/O). In quest’ultimo leggiamo anche un realistico memoriale di un mafioso pentito, frutto dell’esperienza sul campo del commissario/scrittore Di Cara che del poliziotto ha tutto: l’andatura, il fisico, un certo modo di guardarti. Lo stesso come scrittore: l’attenzione per i dettagli, il gusto della ricerca, la passione per il confronto. Il suo personaggio è Salvo Riccobono, commissario a sua volta. - Di Cara, c'è un modello di scrittura o uno scrittore al quale si ispira? “Tra gli autori di noir italiani, mi sento molto vicino a Lucarelli, nello stile e nell'impostazione del racconto. Sono convinto che il prodotto finale di uno scrittore sia anche la summa delle sue esperienze culturali, delle sue letture, dei suoi miti e riti. Io sono grato a molti autori, non tanto perché mi hanno influenzato, quanto perché mi hanno entusiasmato, commosso, rapito, sedotto.” - Si sente sminuito se la definiscono giallista? - “Affatto, anzi mi piace molto la definizione di autore di genere.” - Chi è realmente il suo Riccobono? “Be’, in Riccobono è presente la mia equazione personale, voglio dire è un personaggio che mi somiglia molto, una sorta di alter ego. Ma Riccobono è anche, e forse soprattutto, un carattere, un personaggio da romanzo, con la libertà ed i limiti che da ciò discendono.” - Quanto della sua professione di commissario trasfonde in lui? “Direi che la mia professione entra nelle storie che racconto in quanto cerco sempre di rimanere vicino al mondo che conosco e che frequento nel mio lavoro. Faccio in modo di scrivere delle cose che se non sono vere, sono almeno verosimili. Parlo di poliziotti che somigliano ai poliziotti, e banditi che somigliano ai banditi. Non so se mi spiego: niente eroi da soap opera, né orchi.” - Ci sarà una terza avventura di Riccobono? “Sì, sto lavorando al nuovo romanzo che racconterà i fatti che gli succedono dopo la sua partenza da Lipanusa, dove è ambientato Isola Nera il primo romanzo. Il titolo è "Il Cuore Miope", la storia si svolge in Calabria, in un piccolo commissariato della locride dove viene trasferito per ragioni di sicurezza. Sarà una vicenda molto aspra e dolorosa, un po' il frutto della mia esperienza da Commissario a Siderno, nella locride appunto. Invece, più o meno in estate, uscirà un mio nuovo romanzo dal titolo "Hollywood, Palermo", per i tipi della Colorado Noir. In questo libro fa la sua apparizione un personaggio nuovo, un ispettore della Sezione Omi cidi della Squadra Mobile di Palermo, alle prese con un omicidio dalle fosche tinte.” - Quali storie le preme raccontare come scrittore ma che non vuole raccontare come poliziotto? “Quelle che racconto da scrittore sono le storie che racconterei da poliziotto. Ritengo di avere il senso della misura, di saper riconoscere quali vicende lo scrittore può rubare allo sbirro.” - Dove sta andando il giallo siciliano? “Non so dove stia andando, sicuramente procede di buona lena. Quello che mi auguro è che noi autori siciliani riusciamo a mantenere alto il livello della nostra scrittura, senza scadere nello stereotipo o nella maniera. Il punto di forza del giallo siciliano sta proprio nella ricchezza della lingua e nell’eleganza del tratto, vorrei che continuassimo così.” - Quanto il successo di Camilleri e la nostra cronaca giornaliera incide in questo boom di giallisti? “Camilleri ha fatto e fa da traino per la narrativa poliziesca italiana intera, e non solo isolana. Quindi ritengo che abbia un peso specifico considerevole. La cronaca è il pane quotidiano, o dovrebbe essere il pane quotidiano, di ogni buon giallista. I romanzi sono lì, per strada, nelle case, nei garage delle nostre città, basta solo raccontarli.” 25 Lo stile secco e diretto di Giacomo Cacciatore, (calabrese di nascita, vive da sempre in Sicilia), giornalista, ricorda il grande Giorgio Scerbanenco e la sua lucida quanto spietata durezza nelle short story metropolitane raccolte nei volumi Milano calibro 9 e Il Centodelitti. Cacciatore è autore di due romanzi noir a puntate, pubblicati nell’edizione siciliana de La Repubblica, e dei racconti “L’abbaglio”, (Giallo Mondadori, 14 colpi al cuore ) “Di che colore è uno sbirro” e “L’uovo” (Duri a morire-Dario Flaccovio). Ne “L’Abbaglio”, Cacciatore dà vita al brigadiere Vittorio Cacciameli, che deve risolvere uno strano omicidio a Ballarò. Si chiama invece Basilio il protagonista del racconto “Di che colore è uno sbirro”, un noir secco come un pugno a tradimento. Nel 2004 ha pubblicato un saggio sul cinema di Fulci ed ha partecipato al romanzo collettivo “Le tre bocche del drago” (Larcher). Di prossima pubblicazione il nuovo romanzo, “Sangue del mio sangue”, ma sta già lavorando ad un nuovo romanzo. - Cacciatore, la verità: le sta stretta l'etichetta di giallista? “Chiunque scriva può definirsi scrittore a tutto tondo: non importa che tipo di letteratura produca, ma lo spirito con cui la produce. Dipende dalle scelte del singolo. A volte ci si impongono dei percorsi forzati per non correre rischi, forse credendo di andare a colpo sicuro e incontrare il favore del pubblico. Di contro, esistono giallisti, o noiristi -o comunque li vogliamo chiamare - che ancor prima di definirsi e farsi definire scrittori “di genere” sono scrittori a tutto campo; raccontano storie che appartengono al proprio vissuto, cercano di farlo al meglio e la tendenza a usare gli strumenti del noir è del tutto incidentale, perché fa parte della loro formazione. Il problema, secondo me, è quando si parte dal genere come premessa imprescindibile .” - Vale a dire? “Che poi ci si sente obbligati a usare tutti i meccanismi e i luoghi comuni del genere stesso, soprattutto quando la premessa è che “fa tendenza”. Vogliamo parlare di etichette distintive? Ecco: ci sono i furbi e gli onesti. Quelli che scelgono le scorciatoie e quelli che rischiano di più, mantenendo saldo il loro patto di lealtà nei confronti del lettore e della realtà che li circonda, cercando di scavare, sviscerare, capire. E’ così nella scrittura come nella vita, credo.” - Nei suoi racconti aleggiano atmosfere che ricordano Giorgio Scerbanenco. Quanto si ispira a lui? “La scrittura di Scerbanenco è così tagliente e moderna che risulta davvero difficile non farsene contagiare. Mi piacciono la sua ferocia e la sua ironia. Il suo essere legato alla realtà del tempo senza per questo rinunciare ad impennate paradossali, allucinatorie. Credo che Scerbanenco sia un autore insuperato e ancora attuale. O magari è il nostro paese a non essere cambiato veramente.” - Che ne pensa degli altri giallisti siciliani? “Quando leggo, cerco persino di dimenticare se un autore sia siciliano. Voglio che non diventi una discriminante per me come lettore, e che non influenzi il mio giudizio. Direi che in generale c’è una varietà di toni e di registri della quale non ci possiamo lamentare. Se proprio devo citare qualcuno: a me è piaciuto molto il romanzo “Di nome faceva Michele” di Gery Palazzotto, perché ha uno stile nervoso, limpido, e non si sforza di raccontare una storia simpatica a tutti i costi. Rifugge l’auto-compiacimento del quale spesso noi siciliani pecchiamo, nella vita come nella scrittura.” Segnaliamo vivamente ai lettori Kamen’ rivista di poesia e filosofia diretta da Amedeo Anelli. Comitato redazionale: 26 Luigi Commissari, Daniela Cremona, Gianni D’Amo, Christine Koschel, Daniela Marcheschi, Stefania Sini, Birgitta Trotzig, Richard H. Weisberg. redazione Viale Veneto nr. 23 –26845 Codogno. E-mail per info: [email protected] In questo numero, il 27 : Poetiche/ Edgardo Abbozzo, Poesia/ Nanni Cagnone, Materiali/ Angelo Genovesi Giovanni Dino Italia Da E ritorno a te E ritorno da te Così come sono Senza fingere mentire nascondere/mescolare O frugare nelle tasche la parola Che meglio accompagni la mia figura/volto Non occorre con te Tu sai tutto di me Mi precedi ad ogni mio respiro Pensiero atteggiamento Mi conosci non so da quali cieli/acque Fulmine secolo o goccia di dolore Ancora prima di parlare Sai essere fra quei mari misteriosi Prima che esistessero il tuono I vulcani la pazienza il sorriso Riesci ad ascoltarmi quando non parlo A capirmi anche se non te lo chiedo Pronta ad allargare le braccia le gambe Sotto le coperte del tuo eccitante silenzio Negl’inconfessabili appuntamenti a luna alta Ad assorbirmi nella tua nuda ospitale verità Svuotandomi da ogni liquida umanità Riposa il mio respiro sulla tua seducente quiete Come Giovanni sul petto del Maestro Sei per me L’acqua che il pensiero rincorre fra deserti (…). Peter Irwin Russell Inghilterra Clair de lune 27 Beatitudine del raggio di ghiaccio E il raggio dell’abisso soleggiato Poiché il sole giace profondo nell’oceano Stanotte Il freddo calamaro si muove nella risacca Nel buio i mostri elettrici vanno La berta voga l’aria Ed il granchio erra per il cielo Tu che sei vestita di carne sulla soglia Tu che eri nuda sotto la luna La luna ti ha dato da vestire Stai in piedi nel chiostro ed accarezzi petali di rosa Dove la luce è di ghiaccio ed il buio è dei baratri E la tua voce è un filo d’argento. Berlino, 10 aprile 1964 Teresa Fantasia conduce, in Buenos Aires, il programma radiofonico “Sardegna nel Cuore”, dedicato a tutti i sardi in Argentina. [email protected] Grazia Deledda Sardegna- Italia Da Canne al Vento (…) Nei tempi di carestia, cioè nelle settimane che precedevano la raccolta dell'orzo, e la gente, terminata la provvista del grano, ricorre all'usura, la vecchia Pottoi andava a pescare sanguisughe. Il suo posto favorito era una insenatura del fiume sotto la Collina dei Colombi presso il poderetto delle dame Pintor. Stava là ore ed ore immobile, seduta all'ombra di un ontano, con le gambe nude nell'acqua trasparente verdognola venata d'oro; e mentre con una mano tene va ferma sulla sabbia una bottiglia, con l'altra si toccava la collana. Di tanto in tanto si curvava un poco, vedeva i suoi piedi ondulare grandi e giallastri entro l'acqua, ne traeva uno, staccava dalla gamba bagnata un acino nero lucente che vi si era attaccato, e lo introduceva nella bottiglia spingendovelo giù con un giunco. L'acino s'allungava, si restringeva, prendeva la forma di un anello nero: era la sanguisuga. 28 Un giorno, verso la metà di giugno, ella salì fino alla capanna di Efix. Faceva un gran caldo e la valle era tutta gialla sotto il cielo d'un azzurro velato. Il servo intrecciava una stuoia, all'ombra delle canne, con le dita che tremavano per la febbre di malaria; vedendo la vecchia che gli si sedeva ai piedi con la bottiglia in grembo, sollevò appena gli occhi velati e attese rassegnato, quasi sapesse già quello che ella voleva da lui. «Efix, sei un uomo di Dio e puoi parlarmi con la coscienza in mano. Che intenzioni ha il tuo padroncino? Egli viene a casa mia, si mette a sedere, dice al ragazzo: suona la fisarmonica (gliel'ha regalata lui), poi dice a me: manderò zia Ester, a chiedervi la mano di Grixenda; ma donna Ester non si vede, e un giorno che io sono andata là, donna Noemi mi ha preso viva, e morta m'ha lasciata, tanti improperi mi ha detto. Tornata poi a casa, Grixenda m'ha anche lei mancato di rispetto, perché non vuole che vada dalle tue padrone. Io non so da qual parte rivolgermi, Efix; non siamo noi che abbiamo chiamato il ragazzo dalla strada: è venuto lui. Kallina mi dice: cacciatelo fuori. Ma lei lo caccia fuori, quando ci va?» Efix sorrise. «Là non va certo per far all'amore!...» Allora la vecchia sollevò irritata il viso e il suo collo parve allungarsi più del solito, tutto corde. «E in casa mia viene forse a far all'amore? No; egli è un ragazzo onesto. Neppure tocca la mano a Grixenda. Essi si amano come buoni cristiani, in attesa di sposarsi. Dimmi in tua coscienza, Efix, che intenzioni ha? Fammi questa carità, per l'anima del tuo padrone.» Efix diventò pensieroso. «Sì, una sera, alla festa, egli mi disse: la sposerò... In mia coscienza credo però che egli non possa.» «Perché? Egli non è nobile.» «Non può, ripeto, donna!», disse Efix con più forza. «Per denari ne ha, questo si vede. Spende senza contare. E il tuo padrone morto diceva, mi ricordo, quando anche lui veniva a sedersi a casa mia ed era giovane e viveva mia nonna: l'amore è quello che lega l'uomo alla donna, e il denaro quello che lega la donna all'uomo.» «Lui? Diceva così? A chi?» «A me, sei sordo? Sì a me. Ma io avevo quindici anni ed ero senza malizia. Mia nonna cacciò via di casa don Zame e mi fece sposare Priamu Piras. E Priamu mio era un valent'uomo: aveva un pungolo con una lesina in cima e mi diceva, avvicinandomelo agli occhi: vedi? ti porto via la pupilla viva se guardi don Zame quando ti guarda. Così passò il tempo. Ma i morti ritornano: eccoli, quando don Giacintino sta seduto sullo sgabello e Grixenda sulla soglia della porta, mi par di essere io e il beato morto...» Quando ella incominciava a divagare così non la finiva mai, ed Efix che lo sapeva la mandò via infastidito. «Andate in pace! Cercate anche voi un uomo con un buon pungolo, per nipote vostra!» E la vecchia contenta di sapere che il ragazzo una sera alla festa aveva detto: «la sposerò» andò via senz'altro. Efix rimase solo in faccia alla luna rossa che saliva tra i vapori cinerei della sera, ma si sentiva inquieto: nel sopore in cui tutta la valle era immersa, il mormorio dell'acqua gli pareva il ronzio della febbre, e che i grilli stessi col loro canto si lamentassero senza tregua. No, la vita che Giacinto conduceva non era quella di un giovane onesto e timorato di Dio: giorno per giorno le grandi speranze fondate su lui cadevano lasciando posto a vere inquietudini. Egli spendeva e non guadagnava; ed anche il pozzo più profondo, pensava Efix, ad attingervi troppo si secca. Qualche sera Giacinto scendeva al poderetto per portare in paese le frutta e gli ortaggi che le zie poi vendevano a casa di nascosto come roba rubata, poiché non è da donne nobili far le erbivendole, e tutto questo era quanto di più utile egli faceva: il resto del tempo lo passava oziando di qua e di là per il paese. Ma eccolo che vien su per il sentiero 29 trascinandosi a fianco come un cane la bicicletta polverosa: arriva ansante quasi venga dall'altro capo del mondo e dopo aver gettato da lontano un involto al servo si butta per terra lungo disteso come morto. E di un morto aveva il viso pallido, le labbra grigie; ma un tremito gli agitava la spalla sinistra, tanto che Efix spaventato trasse di tasca un tubetto di vetro, fece cadere sulla palma della mano due pastiglie di chinino e gliele mise in bocca. «Mandale giù. Hai la febbre!» Giacinto ingoiò le pastiglie e senza sollevarsi si strinse la testa fra le mani. «Come sono stanco, Efix! Sì, ho la febbre: l'ho presa, sì! Come si fa a non prenderla, in questo maledetto paese? Che paese!», aggiunse come parlando fra sé, stanco. «Si muore: si muore...» «Alzati», disse Efix, curvo su lui. «Non star lì: l'aria della sera fa male.» «Lasciami crepare, Efix! Lasciami! Che caldo! Non ho mai conosciuto un caldo simile: almeno da noi si facevano i bagni...» Che dirgli, per confortarlo? «Perché non sei rimasto là?» Efix sentiva troppa pietà di tanta miseria prostrata davanti a lui, per parlare così. «Che hai fatto oggi?», domandò sottovoce. «E cosa vuoi che faccia? Non ce niente da fare! Scender qui a portarti il pane, tornar là a portare l'erba! E loro che vivono come tre mummie! Zia Noemi oggi però s'e inquietata un poco, perché zia Ester mi dice va che non riesce a metter su i denari per l'imposta. Si capisce! Spendono per me, e da me non vogliono niente! Io dissi a zia Ester: non preoccupatevi, andrò io dall'esattore. - Una furia, zia Noemi! Aveva gli occhi come un gatto arrabbiato. Non la credevo così collerica. Ebbene, mi disse persino: coi tuoi denari, se ne hai, compra un'altra fisarmonica a Grixenda. Che male c'è, Efix, s'io vado da quella ragazza? Dove si va, se no? Zio Pietro mi porta alla bettola, e a me non piace il vino, lo sai; il Milese vuole che io giochi (così s'è fatto la fortuna, lui!) ed a me non piace giocare. Vado là, dalla ragazza, perché è buona, e la vecchia dice cose divertenti. Che male c'è, dimmi. Dimmi?» Lo guardava di sotto in su, supplichevole, con gli occhi dolci lucidi alla luna. Efix aveva preso l'involto del pane, ma non poteva mangiare; sentiva la gola stretta da un'angoscia profonda. «Nessun male! Ma la ragazza, benché buona, è povera e non è degna di te.» «L'amore non conosce né povertà né nobiltà. Quanti signori non han sposato ragazze povere? Che ne sai tu? Più di un lord inglese, più di un milionario d'America han sposato serve, maestre, cantanti... perché? Perché amavano. E quelli son ricchi: sono i re del petrolio, del rame, delle conserve! Chi sono io, al loro confronto? E le donne? Le principesse russe, le americane, chi sposano? Non s'innamorano di poveri artisti e persino dei loro cocchieri e dei loro servi? Ma tu che cosa puoi sapere?» Efix stringeva fra le mani un pezzo di pane e gli sembrava di stringere il suo cuore tormentato dai ricordi. «Eppoi dicono di credere in Dio, loro! Perché non mi lasciano sposare la donna che amo?» «Taci, Giacinto! Non parlare così di loro! Esse vogliono il tuo bene.» «Allora mi lascino formare la mia famiglia. Io, magari, porterò Grixenda in casa loro ed essa le aiuterà. Ormai esse sono vecchie. Io lavorerò. Andrò a Nuoro, comprerò formaggio, bestiame, lana, vino, persino legna, sì: perché adesso, con la guerra, tutto ha valore. Andrò a Roma e offrirò la merce al Ministero della Guerra. Sai quanto c'è da guadagnare?» «Ma! E i capitali?» «Non ci pensare, li ho. Basta mi lascino in pace, loro. Io non sono venuto per sfruttarle né per vivere alle loro spalle. Ah, ma zia Noemi è terribile!», egli gemette a un tratto, nascondendosi il viso fra le mani. «Ah, Efix, sono così amareggiato! Eppoi mi fa tanta vergogna vederle così misere; vederle vender di nascosto le patate, le pere e i pomi ai bambini che entrano piano piano nel cortile, col soldo nel pugno, e domandando la roba sottovoce quasi si tratti di cosa rubata! Mi vergogno, sì! Questo deve cessare. Esse 30 torneranno quelle che erano, se mi lasceranno fare. Se zia Noemi sapesse il bene che le voglio non farebbe così...» «Giacinto! Dammi la mano: sei bravo!», disse Efix commosso. Tacquero, poi Giacinto riprese a parlare con una voce tenue, dolce, che vibrava nel silenzio lunare come una voce infantile. «Efix, tu sei buono. Ti voglio raccontare una cosa accaduta ad un mio amico. Era impiegato con me alla Dogana. Un giorno un ricco capi tano di porto in ritiro, un buon signore grosso ma ingenuo come un bambino, venne per fare un pagamento. Il mio amico disse: Lasci i denari e torni più tardi per la ricevuta che dev'essere firmata dal superiore. Il capitano lasciò i denari; il mio amico li prese, andò fuori, li giocò e li perdette. E quando il capitano tornò, il mio amico disse che non aveva ricevuto nulla! Quello protestò, andò dai superiori; ma non aveva la ricevuta e tutti gli risero in faccia. Eppure il mio amico fu cacciato via dal posto... sì, saranno quattro mesi... sì, ricordo, in carnevale. Egli andò a ballare. Si stordiva, beveva: non aveva più un soldo. Uscendo dal ballo prese una polmonite e cadde su una panchina di un viale. Lo portarono all'ospedale. Quando uscì, debole e sfinito, non aveva casa, non aveva pane. Dormiva sotto gli archi del porto, tossiva e faceva brutti sogni: sognava sempre il capitano che lo inseguiva, lo inseguiva... come nelle scene del cinematografo. Ed ecco una sera, ecco proprio il capitano che va a cercarlo sotto gli archi del porto. L'amico credeva di sognare ancora; ma l'altro gli disse: sa, è da un pezzetto che la cerco. So che è fuori di posto per via del versamento, ma a me preme che i suoi superiori e tutti sappiano la verità. È meglio anche per lei: dica in sua coscienza: li ho versati o no, i denari? - L'amico rispose: sì. - Allora il capitano disse: - Cerchiamo di aggiustare le cose. Io non voglio rovinarla: venga a casa mia, ecco il mio indirizzo: venga domani e assieme andremo dai suoi superiori. - Va bene! Ma l'indomani né poi l'amico andò. Aveva paura. Aveva paura. Eppoi il tempo era orribile ed egli non si muoveva di là. Tossiva e un facchino gli portava di tanto in tanto un po' di latte caldo. Che tempo era? Che tempo!», ripeté Giacinto, e sollevò il viso guardandosi attorno quasi per accertarsi che la notte era bella. Efix ascoltava, col gomito sul ginocchio e il viso sulla mano, come i bambini intenti alle fiabe. «Ma un giorno mi decisi e andai...» Silenzio. Il viso dei due uomini si coprì d'ombra ed entrambi abbassarono gli occhi. La spalla di Giacinto tremava convulsa; ma egli la sollevò e la scosse come per liberarsi dal tremito, e riprese con voce più dura: «Sì, ero io, tu avevi capito. Andai dal capitano. Non era in casa, ma la cameriera, una ragazza pallida che parlava sottovoce, mi fece aspettare in anticamera. La stanza era quasi buia, ma ricordo che quando un uscio s'apriva il pavimento rosso luccicava come lavato col sangue. Aspettai ore ed ore. Finalmente il capitano tornò; era con la moglie, grossa come lui, bonaria come lui. Sembravano due bambini enormi; ridevano rumorosamente. La signora aprì gli usci per vedermi bene: io tossivo e sbadigliavo. Si accorsero che avevo fame e m'invitarono ad entrare nella sala da pranzo. Io, ricordo, mi alzai, ma ricaddi seduto battendo la testa alla spalliera della cassapanca. Non ricordo altro. Quando rinvenni ero a letto, in casa loro. La cameriera mi portava una tazza di brodo su un vassoio d'argento e mi parlava con grande rispetto. Rimasi là più di un mese, Efix, capisci: quaranta giorni. Mi curarono, cercarono di rimettermi a posto; ma il posto era difficile trovarlo perché tutti ormai sapevano la mia storia. D'altronde anch'io volevo andarmene lontano, al di là del mare. Ciò che io ho sofferto durante quel tempo nessuno può saperlo: il capitano, sua moglie, la serva io li vedo sempre in sogno; li vedo anche nella realtà, anche adesso, lì, davanti a me. Essi erano buoni, ma io vorrei sprofondarmi per non vederli più. E il peggio è che non potevo andarmene da casa loro. Stavo lì, istupidito, seduto immobile ad ascoltare la signora che parlava parlava parlava, o in compagnia della serva che taceva: sedevo a tavola con loro, li sentivo scherzare, far progetti per me, come fossi un loro figliuolo, e tutto mi dava pena, mi umiliava, eppure non potevo andarmene. Finalmente un giorno la signora, vedendomi completamente guarito, mi domandò che intenzioni avevo. Io dissi che volevo venire qui dalle mie zie, di 31 cui avevo parlato come di persone benestanti. Allora mi comprarono il biglietto per il viaggio e mi regalarono anche la bicicletta. Io capii ch'era tempo d'andarmene e partii: venni qui. Che liberazione, in principio! Ma adesso, in casa delle zie, sono ancora come là... e non so...». Un grido che ave va qualche cosa di beffardo attraversò il silenzio del ciglione, sopra i due uomini, e Giacinto balzò sorpreso credendo che qualcuno avesse ascoltato il suo racconto e lo irridesse: ma vide una piccola forma grigia lunga, seguita da un'altra più scura e pi ù corta, balzare come volando da una macchia all'altra intorno alla capanna e sparire senza neppur lasciargli tempo di raccattare un sasso per colpirla. Anche Efix s'era alzato. «Son le volpi», disse sottovoce. «Lasciale correre: fanno all'amore. Sembrano folletti, alle volte» riprese mentre Giacinto si buttava di nuovo per terra silenzioso. «Hai veduto com'eran lunghe? Mangiano l'uva acerba come diavoli...» Ma Giacinto non parlava più. Ed Efix non sapeva cosa dire, se pregarlo di riprendere il racconto, se confortarlo, se commentare in bene o in male quanto aveva sentito. Ecco perché era stato triste, tutto il giorno, ecco come vanno le cose della vita! Ma che dire? In fondo era contento che il passaggio delle volpi avesse fatto tacere Giacinto; tuttavia qualche cosa bisognava pur dire. «Dunque... quel capitano? Si vede che era uomo savio: capiva che la gioventù... la gioventù... è soggetta all'errore... Eppoi quando si è orfani! Su, alzati; vuoi mangiare?» Entrò nella capanna e tornò sbucciando una cipolla: Giacinto stava immobile, abbattuto, forse pentito della sua confessione, ed egli non osò più parlare. L'odore della cipolla si mischiava al profumo delle erbe intorno, della vite e della salsapariglia; le volpi ripassarono. Efix cenò ma il pane gli parve amaro. E due o tre volte tentò di dire qualche cosa; ma non poteva, non poteva; gli sembrava un sogno. Finalmente scosse Giacinto, tentò di sollevarlo, gli disse con dolcezza: «Su, vieni dentro! La febbre è in giro...». Ma il corpo del giovine sembrava di bronzo, steso grave aderente alla terra dalla quale pareva non volesse più staccarsi. Efix rientrò nella capanna, ma tardò a chiudere gli occhi, e anche nel sonno aveva l'idea tormentosa di dover commentare il racconto di Giacinto, non sapeva però come, se in bene o in male. «Devo dirgli: ebbene, coraggio, ti emenderai! Dopo tutto eri un ragazzo, un orfano...» Ma sognò Noemi che lo guardava coi suoi occhi cattivi, e gli diceva sottovoce, a denti stretti: «Lo vedi? Lo vedi che razza di uomo è?». Si svegliò con un peso sul cuore; benché fosse notte ancora si alzò, ma Giacinto se n'era già andato. Per molti giorni non si lasciò più vedere, tanto che Efix cominciò a inquietarsi, anche perché gli ortaggi e i pomi si ammucchiavano all'ombra della capanna e nessuno veniva a prenderli. Ogni sera don Predu, che possedeva grandi poderi verso il mare, passava di ritorno al paese, e se vedeva il servo tendeva l'indice verso la terra delle sue cugine e poi si toccava il petto per significare che aspettava l'espropriazione e il possesso del poderetto; ma Efix, abituato a quella mimica, salutava, e a sua volta accennava di no, di no, con la mano e con la testa. Dopo la confessione di Giacinto s'inquietava però vedendo don Predu; gli sembrava più beffardo del solito. Una sera aspettò accanto alla siepe, e gli chiese: «Don Predu, mi dica, ha veduto il mio padroncino? L'altra sera venne qui che aveva la febbre e adesso sto in pensiero per lui». Don Predu rise, dall'alto del cavallo, col suo riso forzato a bocca chiusa, a guance gonfie. «Ieri sera l'ho veduto a giocare dal Milese. E perdeva, anche!» «Perdeva!», ripeté Efix smarrito. «Come lo dici! Vuoi che vinca sempre?» 32 «A me disse che non giocava mai...» «E tu lo credi? Non dice una verità neanche se gli dai una fucilata. Ma non è cattivo: dice le bugie, così perché gli sembran verità, come i bambini.» «Come un bambino davvero...» «Un bambino che ha tutti i denti però! E come mastica! Vi mangerà anche il poderetto. Efix, ricordati: son qua io! Se no, bastonate...» Efix lo guardava dal basso, spaurito; e il grosso uomo a cavallo gli sembrava, nel crepuscolo rosso, un uccello di malaugurio, uno dei tanti mostri notturni di cui aveva paura. «Gesù, salvaci. Nostra Signora del Rimedio, pensa a noi...» Don Predu s'era già allontanato, quando Efix lo raggiunse nello stradone porgendogli con tutte e due le mani un cestino colmo di pomi e di ortaggi. «Don Predu, mandi questo con la sua serva alle mie padrone. Io non posso abbandonare il poderetto... e don Giacinto non viene...» Da prima l'uomo lo guardò sorpreso; poi un sorriso benevolo gli increspò le labbra carnose. Sollevò una gamba e disse: «Guarda lì, c'è posto». Efix cacciò il cestino entro la bisaccia, e mentre don Predu andava via senza dir altro, se ne tornò su alla capanna: aveva paura che le padrone lo sgridassero; sapeva d'aver commesso un atto grave, forse un errore; ma non si pentiva. Una mano misteriosa lo aveva spinto, ed egli sapeva che tutte le azioni compiute così, per forza sovrannaturale, sono azioni buone. Aspettò Giacinto fino al tardi. La luna piena imbiancava la valle, e la notte era così chiara che si distingueva l'ombra d'ogni stelo. Persino i fantasmi, quella notte, non osavano uscire, tanta luce c'era: e il mormorio dell'acqua era solitario, non accompagnato dallo sbatter dei panni delle panas. Anche i fantasmi avevan pace, quella notte. Il servo solo non poteva dormire. Pensava alla storia di Giacinto e del capitano di porto, e provava un senso d'infinita dolcezza, d'infinita tristezza. Tutti, nel mondo, pecchiamo, più o meno, adesso, o prima o poi: e per questo? Il capitano non aveva perdonato? Perché non dovevano perdonare anche gli altri? Ah, se tutti si perdonassero a viceversa! Il mondo avrebbe pace: tutto sarebbe chiaro e tranquillo come in quella notte di luna. S'alzò e andò a fare un giro nel poderetto. Sì, sul sentieruolo bianco si disegnava anche l'ombra dei fiori: le foglie dei fichi d'India avevano le spine, nell'ombra, e dove l'acqua era ferma, giù al fiume, si vedevano le stelle. Ma ecco un'ombra che si muove dietro la siepe, fra gli ontani: è un animale deforme, nero, con le gambe d'argento: scricchiola sulla sabbia, si ferma. Efix corse giù; gli sembrava di volare. «Sei tu! Sei tu? M'hai spaventato.» Giacintino si tirò a fianco la bicicletta e lo seguì silenzioso; ma ancora una volta, arrivati davanti alla capanna si buttò a terra gemendo: «Efix. Efix, non ne posso più... Che hai fatto! Che hai fatto!». «Che ho fatto?» «Non so bene neppur io. È venuta la serva di zio Pietro, portando un cestino, dicendo che lo avevi consegnato tu al suo padrone. C'erano zia Ruth e zia Noemi in casa, poiché zia Ester era alla novena: presero il cestino e ringraziarono la serva, e le diedero anche la mancia; ma poi zia Noemi fu colta da uno svenimento. E zia Ruth la credeva morta, e gridò. Corsero a chiamare zia Ester; ella venne spaventata, e per la prima volta anche lei mi guardò torva e mi disse che son venuto per farle morire. Oh Dio, Dio, oh Dio, Dio! Io bagnavo il viso di zia Noemi con l'aceto e piangevo, te lo giuro sulla memoria di mia madre; piangevo senza sapere perché. Finalmente zia Noemi rinvenne e mi allontanò con la mano; diceva: era meglio fossi morta, prima di questo giorno. Io domandavo: perché? perché, zia Noemi mia, perché? E lei mi allontanava con una mano, nascondendosi gli occhi con l'altra. Che pena! Perché son venuto, Efix? Perché?» 33 Il servo non sapeva rispondere. Adesso vedeva, sì, tutto l'errore commesso, consegnando il cestino a don Predu e pensava al modo di rimediarvi, ma non vedeva come, non sapeva perché, e ancora una volta sentiva tutto il peso delle disgrazie dei suoi padroni gravare su lui. «Sta' quieto», disse infine. «Tornerò io domani al paese e rimedierò tutto.» Allora Giacinto riprese «Tu devi dire alle zie che non son stato io a consigliarti di incaricare zio Pietro della consegna del cestino. Esse credono così. Esse credono, e zia Noemi specialmente, che io cerchi l'amicizia di zio Pietro per far dispetto a loro. Io sono amico di tutti; perché non dovrei esserlo di zio Pietro? Ma le zie sanno che egli vuole comprare il poderetto. Che colpa ne ho io? Sono io che voglio venderlo, forse?» «Nessuno vuol venderlo. Perché parlare di queste cose? Ma tu, anima mia, tu... tu l'altra sera dicevi questo, dicevi quest'altro: promettevi mari e monti, per far felici le tue zie; e ieri sera, invece, sei andato a giocare...» «Giocando tante volte si guadagna. Io voglio guadagnare, appunto per loro: no, non voglio più essere a carico loro. Voglio morire... Vedi» aggiunse sottovoce «adesso, dopo la scena di oggi, mi pare di essere ancora nella casa del capitano... Dio mi aiuti, Efix!» Efix ascoltava con terrore: sentiva d'essere di nuovo davanti al destino tragico della famiglia alla quale era attaccato come il musco alla pietra, e non sapeva che dire, non sapeva che fare. «Oh», sospirò profondamente Giacinto. «Ma di qui me ne vado certo; non aspetto che mi caccino via! Sono senza carità, le mie zie, specialmente zia Noemi. Non m'importa, però: essa non ha perdonato mia madre; come può perdonare me? Ma io, ma io...» Abbassò la testa e trasse di saccoccia una lettera. «Vedi, Efix? So tutto. Se zia Noemi non ha perdonato mia madre dopo questa lettera, come può aver l'animo buono? Tu lo sai cosa c'è, in questa lettera, l'hai portata tu, a zia Noemi. Ed io gliel'ho presa: stava sul lettuccio, il giorno del mio arrivo: io ne lessi qualche riga, poi la presi dall'armadio, oggi... È mia; è di mia madre; è mia... Non è degna di stare là questa lettera...» «Giacinto! Dammela!», disse Efix stendendo le mani. «Non è tua! Dammela: la riporterò io, alle mie padrone.» Ma Giacinto stringeva la lettera fra le palme delle mani e scuoteva la testa. Efix cercò di prendergliela: supplicava, pareva domandasse un'elemosina suprema. «Giacinto, dammela. La riporterò io, la rimetterò nell'armadio. Parlerò io con loro, metterò pace. Tu aspettami qui. Ma dammi la lettera.» Giacinto lo guardò. La sua spalla tremava, ma gli occhi erano freddi, quasi crudeli. Allora Efix balzò, gli gravò le mani sulle spalle, gli sibilò all'orecchio una parola. «Ladro!» Giacinto ebbe l'impressione di essere assalito da un avvoltoio; aprì le mani e la lettera cadde per terra. Traduzioni Correzione di testi Información / info [email protected] / [email protected] 34 Arthur Rimbaud Francia Being beauteous Dinanzi a una neve un Essere di Bellezza di alta statura. Sibili di morte e cerchi di musica sorda fanno salire, allargarsi e tremare come uno spettro questo corpo adorato; ferite scarlatte e nere spiccano sulle carni superbe. I colori propri della vita si oscurano, danzano e si sprigionano intorno alla Visione, sul cantiere. E i brividi s’innalzano e rombano, e mentre il forsennato sapore di questi effetti si carica dei fischi mortali e delle musiche rauche che il mondo, lontano dietro di noi, lancia sulla nostra madre di bellezza, -essa indietreggia, si erge. Oh! Le nostre ossa sono rivestite di un nuovo corpo amoroso. . . . . Oh! Faccia cinerea, stemma di crine, braccia di cristallo! Il cannone su cui io devo abbattermi nella mischia degli alberi e dell’aria leggera! Isola Nera Casa di Poesia e Lettere. Per l’invio di materiale letterario: Via Caprera 6 – 08045- Lanusei. Italia Casa di poesia e letteratura. La prima in Sardegna; in Italia, aperta alla creazione letteraria degli autori italiani e di autori in lingua italiana…il progetto Isola Nera riguarda la prossima pubblicazione in formato cartaceo. Isola Nera merita degli sponsors in grado di valorizzare l’iniziativa e dalla quale vengano valorizzati. Si accettano e vagliano proposte. Aviso p ara ama ntes de poesía Ponemos a vuestra disposición Isla Negra revista en español de poesia y narrativa breve Más de 1600 suscriptores acompañan nuestra tarea de difusión literaria 35 AmiGos, eScritOres, dOceNtes, invitados Escribid a estais [email protected] Su distribucion es gratuita. 17 hasta la pròxima… al prossimo numero 36
Scarica