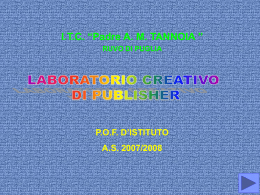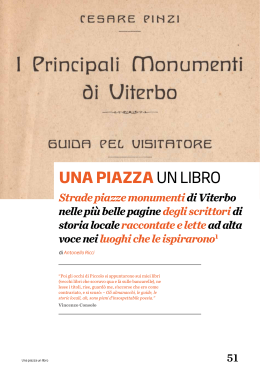l’ORIOLI Periodico di cultura, costume e società Anno 2 - Numero 2 - Euro 0,50 EDITORIALE D’amore e d’arte di Nicola Piermartini Non è trionfalismo, né autocelebrazione. Certo è però che l’esordio de L’Orioli, qualche mese addietro, ha registrato apprezzamenti lusinghieri da lettori di varia estrazione, anche personalità consacrate del mondo della cultura. Riflessi chiaramente confortanti, che confermano l’associazione “Francesco Orioli” e la redazione nel loro intento di proseguire il cammino intrapreso, con gli obiettivi - dichiarati con modestia in precedenza e qui ribaditi - di offrire stimoli all’approfondimento culturale. Tema centrale di questo numero è l’amore: argomento di vastità immensa, articolato in sfaccettature infinite, scintilla di vita, d’arte, di progettualità umana, di elevazione spirituale; l’amore, artefice di avvenimenti decisivi nella sfera individuale e sociale. Un sentimento (ma forse è riduttivo circoscriverlo in questa definizione) “che muove il sole e l’altre stelle”, per dirla con l’ultimo verso della Divina Commedia. Un tema, quindi, la cui trattazione può far precipitare nello scontato, nel “già detto”. L’Orioli, comunque, offre spunti di riflessione sicuramente non obsoleti: gli interventi del prof. Franco Lanza sulla vicenda di Paolo e Francesca come affrescata nel canto V dell’Inferno dantesco, del dott. Massimo Fornicoli, con una lettura originale della canzone Ho capito che ti amo di Luigi Tenco, di don Ampelio Santagiuliana, parroco di Vallerano, sul “Senso cristiano dell’amore”, per limitarci a qualche nome, contengono considerazioni di valenza indubbia per molteplici riguardi. Voltiamo pagina. La mostra di pittura, organizzata dall’associazione in settembre a Viterbo, nell’ex Chiesa degli Almadiani, è stata un successo: le opere di Nora Orioli, Giacomo Maria Giuffra, Mischa Faust, Elio Rizzo e Vittorio Verolini hanno suscitato interesse e ammirazione. Vittorio Arista propone un excursus molto particolare all’interno di alcuni quadri esposti. In questo numero è inaugurata una nuova rubrica: “Dentro l’opera d’arte”: un invito ad entrare in un quadro, in una poesia, in un brano letterario, in un capolavoro architettonico, ad entrarci quasi fisicamente. Federeico Zeri, critico d’arte famosissimo scomparso qualche anno fa, scrisse “Dietro l’immagine”; Vittorio Sgarbi, che non necessita di presentazione, scrisse invece “Davanti all’immagine”. L’Orioli, con “Dentro l’opera d’arte”, intende offrire un’esperienza diversa: è un tentativo. Non si intende proporre nuove pagine di critica: le innumerevoli antologie o i trattati sulla storia dell’arte sono molto eloquenti, informati, variegati. Il nostro è, lo ripetiamo, un tentativo di indicare un modo diverso d’approccio all’espressione artistica, sempre con l’obiettivo di suscitare o accentuare l’amore per l’arte e invitare alla riflessione e all’introspezione, non secondo modalità classiche che talvolta sono stereotipate e scostanti. Sono, questi, soltanto scarni flash sulle diverse proposte della rivista, che contempla altri centri di interesse nell’ottica consueta di offrire contributi sinceri alla causa della diffusione e della ricerca culturali. Diretto da Nicola Piermartini www.orioli.it IL Febbraio/Marzo 2004 PERCHÉ DI UNA SCELTA Domande Q per ogni forma di amore? Varrà per ogni nostro interesse questo limite apparentemente insuperabile del nostro orizzonte interiore ? Il soffrire che segue ad un amore non corrisposto soggiace forse a questa logica, ed è per questo, spesso, che fa aumentare “l’amore”? E la maggior quota di sensibilità che accompagna l’attesa del compimento di un desiderio è forse da computare a merito di ogni relazione amorosa o non è piuttosto il presagio della sua estrema provvisorietà? E la pietà che non un uomo di Chiesa, ma Eduardo invocava per i protagonisti della scombinata vicenda affettiva di “Gli esami non finiscono mai“, è prerogativa di chi ha la Fede nel Dio dei cristiani o è anche l’obbligo di chiunque voglia “amare“ l’uomo per quello che è, e non per quello che vorremmo che fosse? uesto secondo numero dell’ Orioli, interamente dedicato al tema dell’amore, esce molto in ritardo rispetto al concepimento della sua idea. I limiti di una attività editoriale come la nostra non ci permettono naturalmente di tenere il passo rispetto al modo di procedere dei giganti maggiori, ma anche minori, che abitano il mondo della carta stampata. Con il solito gusto per la provocazione presuntuosa pensiamo, però, non tanto di giungere tardi ma di sopraggiungere utilmente, con contenuti e angolazioni di visuale non frequenti. Libero Bigiaretti, scrittore che come Francesco Orioli ebbe cara la residenza, anche se saltuaria, a Vallerano, in un suo epigramma così stigmatizza la valenza egoistica di certi amori: “A tante donne ho detto/ amore, amore mio…/ ma parlavo al mio petto,/ lusingavo il mio io” ( L. Bigiaretti, Epigrammi e proverbi, 1975-1981, pag 9). Sarà così CENNI Ma anche in questa occasione il ruolo di chi ha promosso il dibattito è quello di farsi al più presto da parte per rispetto (posso dire: per amore?) della competenza di chi dovrà parlare, e della generosità dei nostri cinque lettori. [email protected] Paris Bordon, Gli amanti - Milano, Pinacoteca di Brera DI STORIA La viterbesità di Francesco Orioli di Bruno Barbini N el corso del convegno organizzato nell’ottobre del 1983 dal Comitato di Viterbo dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano per ricordare Francesco Orioli nel bicentenario della nascita, V. E. Giuntella sottolineò nel suo intervento la viterbesità del personaggio: una caratteristica che trova giustificazione non soltanto nella sua nascita a Vallerano e nelle scuole da lui frequentate a Viterbo e a Montefiascone, ma anche nel costante EVENTI amore sempre dimostrato nei confronti del natìo loco, un amore tutt’altro che affievolito dai lunghi anni di assenza, trascorsi prima a Bologna, nella cui università occupò la cattedra di Fisica, e, dopo la partecipazione ai moti del ’31, in esilio a Parigi e a Corfù. Significative, in proposito, risultano le accorate espressioni di nostalgia che compaiono in alcune lettere scritte in quel doloroso periodo della sua vita, in cui la lontananza dalla propria terra è interrotta soltanto dalle brevi pa- rentesi della partecipazione agli annuali congressi scientifici tenutisi in varie città d’Italia dal 1839 al 1847, ai quali poté recarsi godendo di speciali autorizzazioni. Le lettere - complessivamente quarantotto, conservate nell’archivio della Biblioteca viterbese degli Ardenti - sono indirizzate al “compare e amico” Filippo Saveri, un personaggio di tutto rilievo nell’ambito della città e del territorio, come dimostrano gli importanti incarichi da lui ricoperti in seno alla civica amministrazione e i suoi rapporti epistolari con due donne della famiglia di Luciano Bonaparte, fratello di Napoleone e principe di Canino, la moglie Alessandrina Bléchamps e la figlia Maria, sposata al conte Vincenzo Valentini, un aristocratico caninese eletto nel 1849 nella Costituente della Repubblica Romana e chiamato poi a reggere il dicastero delle Finanze. Il 24 agosto 1841 Orioli scrive all’amico da Firenze: “È parsa dura cosa fermarsi otto eterne ore nel porto di Cisegue a pag. 2 UN CONSIGLIO CULTURALI Successo di una mostra di Vitttorio Arista P iù di 1500 persone sono venute a visitarla. Una settimana intensa, ricca di emozioni, nelle quali i timori sono stati vinti dalla gioia di vedere premiato l’impegno di un gruppo di persone che ha in comune un unico ideale: l’amore per l’arte. La ex Chiesa degli Almadiani, con il suo suggestivo campanile in stile romanico, è stata la giusta cornice di una manifestazione culturale degna della città di Viterbo. Devo ammettere che i visitatori entravano all’interno con il rispetto di chi si trova in una segue a pag. 2 C’è una verità elementare, la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e splendidi piani: nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la provvidenza allora si muove. Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti mai sarebbero avvenute... Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio, potere e magia. Incomincia adesso. Johann Wolfgang Goethe CENNI segue da pag. 1 La viterbesità di Francesco Orioli vitavecchia; guardar sospirando le montagne che coronano l’orizzonte; pensar alle dolcezze passate dell’infanzia e della puerizia; fare in spirito la rivista di tanti che ci son cari; e trovarsi incatenato alla fortuna sul nobile palco della nave, senza che pur uno venga a portarti l’amplesso dell’amicizia... Pazienza!”. In questo passo, al rimpianto di non poter varcare la pur breve distanza che lo separa dai luoghi dove è nato e ha trascorso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, si unisce un sia pur velato rimprovero per gli amici che, timorosi di compromettersi di fronte alle autorità, non hanno approfittato della sua sosta nel porto tirrenico per venirlo a salutare. Più esplicito su questo punto era stato nella lettera precedente, datata 21 luglio e scritta non appena sbarcato a Livorno: “Vi sarebbe egli speranza di riabbracciarvi e d’avere il bene d’essere due o tre giorni con voi e colla Commare? O la mia rogna potrebbe avvaccarvisi a senso di codesti Magistrati? ... Io però sto bene, e la mia rogna non mi rode”. La mancata risposta a questa lettera fece pensare ad Orioli che l’amico temesse di compromettersi con le autorità governative mantenendo rapporti, anche se solo epistolari, con un compromesso politico. Pertanto gli inviò la lettera successiva a mano, tramite un amico comune, e aggiunse un significativo post-scriptum: “Se volete aver la bontà di rispondere almeno a questa, potete in tutta sicurezza affidare ad esso la risposta”. Già due anni prima, in una lettera scritta il 18 novembre 1839, troviamo espresso un analogo stato d’animo. Al suo rientro a Corfù dopo aver partecipato al primo dei congressi tenutosi a Pisa, aveva espresso la sua delusione ma, nel contempo, aveva cercato una plausibile giustificazione del mancato incontro: “Io speravo d’avere la felicità di rivedervi nel mio passaggio da Civitavecchia: ma la fortuna non m’ha accordato questo piacere. Forse io ve ne scrissi troppo tardi. Forse non potevate allontanarvi dal vostro impiego. Forse il cattivo tempo v’ha ritenuto? Forse ... non importa. Tanto e tanto io v’ho nel pensiero e nel cuore...”. La tristezza che caratterizza il tono delle lettere scritte negli anni dell’esilio lascia, però, il posto alla gioia non appena l’Editto del Perdono, promulgato da Pio IX il 17 luglio 1846, conferisce concretezza alla speranza, da così lungo tempo accarezzata, del ritorno in patria. Lo possiamo riscontrare in un passo della “Lettera al Marchese Massimo d’Azeglio”, un opuscolo che commenta favorevolmente l’editto con cui la Segreteria di Stato aveva concesso, il 15 marzo 1847, una certa libertà di stampa: “Dopo lungo navigare tra tempeste, bello è ricoverarsi nel porto, e prender terra sotto un cielo sereno, quando, al mancare del verno, primavera s’aspetta, incoronata di fiori, e larga promettitrice di frutti. E questo di me avviene...”. Dopo il ritorno, Orioli si stabilisce a Roma, ma pur nei numerosi impegni della militanza politica, che lo assorbono fino agli ultimi mesi del ’48, ha più volte occasione di rivendicare la propria viterbesità nella corrispondenza con Saveri, che in quei mesi diviene particolarmente intensa. Ragguagliando l’amico sulla propria candidatura alle elezioni politiche indette per il 19-20 maggio di quell’anno, il 15 aprile gli scrive tra l’altro: “... quantunque avrei qualche buona ragione per concepir la speranza d’esser fatto uno dei deputati della capitale, preferisco le mille volte l’offerta della mia Viterbo, posto che in mezzo a questa patria comune, l’Italia, e a quest’altra più ristretta ancora, lo stato, ve n’è una terza di più care ed intime simpatie, quella dove noi possiamo dire: “qui aspettano la resurrezione le ceneri di tutti i miei, quest’aria ho respirato fanciullo, qui ho folleggiato giovane, qui ho maturato la 2 I DI STORIA N. 2 Febbraio/Marzo 2004 mia virilità... qui desidero posare il capo nella tomba avita ancorché sarò inanimato cadavere”. Torna sull’argomento in una lettera di nove giorni dopo, nella quale le affermazioni della precedente trovano piena conferma: “Anche eletto altrove, ciocché non è né impossibile, né improbabile, io darò sempre le preferenze al voto ed alla rappresentanza del mio paese, del paese di mia moglie, di quello de’ miei antichi”. Ancora più esplicita la conclusione: “Gli Orioli han diritto di chiamarsi Viterbesi e si gloriano di questo diritto”. Il 12 maggio ribadisce questa preferenza per la propria terra: “... Ho dichiarato agli Iesini, a que’ di Sanginesio, a que’ di S. Elpidio a Mare, ai Ronciglionesi, agli Urbinati ecc. ch’io non accettavo altra candidatura che la viterbese”, e conclude: “Se sì, sì, se no, vorrà dire che i miei Compatriotti mi ricusano, e ci vorrà pazienza”. La partecipazione dei cittadini alle urne fu decisamente scarsa, ma i risultati non delusero le sue aspettative. Dei 964 elettori iscritti nelle liste viterbesi, il 19 maggio votarono soltanto 278, ma ben 244 suffragi si concentrarono sul suo nome. Nel ballottaggio del giorno successivo a lui andarono 222 dei 232 voti espressi. Il legame sentimentale che univa Orioli a Viterbo trovava, in tal modo, un’eloquente conferma nell’opinione pubblica o, quanto meno, nella parte di essa comprendente la ristretta cerchia di quelli che “contavano”. Nei mesi successivi, però, la posizione moderata assunta da Orioli nell’espletamento del suo mandato si contrappose spesso a quella dei molti parlamentari che - talvolta per intima convinzione, più spesso per la ricerca di una facile popolarità tra le masse - si attestavano su una linea politica sempre più decisamente rivoluzionaria. Ce lo dicono anche i risultati delle successive elezioni, tenutesi il 9 e il 10 novembre. Lo scienziato viterbese - che poco prima si era dimesso per contrasti con i colleghi - fu rieletto, ma con un più modesto margine di voti: 50 su 83 al primo scrutinio e 83 su 113 nel ballottaggio. Il primo atto della rivoluzione che porterà alla Repubblica Romana, l’uccisione del ministro Pellegrino Rossi, avvenne il 15 novembre, il giorno stesso in cui fu comunicata ufficialmente la rielezione di Orioli, il quale però, di fronte al progressivo affermarsi di una situazione politica che non condivideva, si dimise definitivamente ventiquattro ore dopo. Da allora in poi, si dedicò con passione e competenza alle ricerche, già iniziate nei decenni precedenti, che tendevano a riscoprire e valorizzare il patrimonio archeologico di Viterbo e della Tuscia. Questa rappresenta un’altra importante testimonianza dell’amore di Francesco Orioli per la propria terra: ma ne parleremo la prossima volta. Nota – Gli Atti del Convegno su “La figura e l’opera di Francesco Orioli”, tenutosi a Viterbo il 15 e 16 ottobre 1983, sono stati pubblicati in volume, a cura del Comitato organizzatore, nel 1986. NdR: Bruno Barbini, per molti anni docente di lettere e storia all’Istituto Magistrale “S. Rosa” di Viterbo, svolge, dal 1955, un’intensa attività giornalistica e di ricerca storiografica. Oltre alle numerosissime collaborazioni con quotidiani locali e nazionali, e con riviste di cui, in alcuni casi, è stato o è tuttora direttore responsabile, ha al suo attivo la pubblicazione di molti volumi dedicati alla storia e ai monumenti di Viterbo e della Tuscia, e una serie di importanti scritti sul Risorgimento. Nel 1993 ha pubblicato Viterbo - politica, economia, cultura e sport - 1945-1992, in cui ha ripercorso l’attività dell’amministrazione comunale viterbese a partire dal secondo dopoguerra; mentre, come presidente del locale Comitato dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, ha diretto l’organizzazione di un congresso nazionale e di quattro convegni interregionali. È a tutt’oggi il più importante studioso dell’opera di Francesco Orioli. NOSTRI SOCI NEL MONDO Cronaca di un impegno ueste foto ritraggono la nostra socia Sua Altezza Reale la Principessa India d’Afghanistan in visita a Piacenza alla Mostra “Sguardo afghano”, in cui la pittrice Ludovica Ba- Q EVENTI rattieri, moglie dell’Ambasciatore d’Italia a Kabul, ha presentato alcune sue tele dedicate alle difficili condizioni di vita nel paese asiatico. La Principessa India, che ha dovuto lasciare la sua terra nella prima metà del ‘900 in seguito al colpo di stato di cui rimase vittima suo padre, il Re progressista Abdullah, vive a Roma e sostiene il progetto di padre Giuseppe Moretti per la costruzione di una “Scuola di Pace” nella capitale afghana. abbandono nel quadro di Giuffra nel quale il paesaggio, ed in particolare il forte, sembrano composti di una materia di cui non riesci a comprendere la natura. Quando alla mostra venivano i bambini, si dirigevano subito verso le opere di Mischa Faust, attratti dai colori sgargianti, dall’acqua e dai pesci di origine sconosciuta che in essa erano immersi. Simbolismo? Allegoria? I grandi (padri e madri dei bambini) restavano incerti, senza poter dare risposta a queste silenziose domande interiori… Dalì, Mirò, Magritte i suoi ispiratori? Credo proprio di sì. I quadri di Elio Rizzo, tutti eseguiti con la tecnica della tempera all’uovo, lasciano al visitatore la possibilità di immaginare un mondo che vive sotto i suoi colori, sfumati ed accesi nello stesso tempo. Il giallo, l’azzurro e il blu prevalgono su tutti. In questo cromatismo si intravedono figure appena accennate, evanescenti, fantastiche. La sua “Alba Finlandese” ti avvicina a un tempo lontano nello spazio, come se potessi cogliere il freddo di un luogo che il sole non riesce a scaldare. Ho lasciato per ultimi i quadri di Nora Orioli e Mario Verolini. Della Orioli il “Goffredo di Buglione” è un vero capolavoro. L’antico condottiero delle crociate viene rappresentato come un uomo ormai stanco, quasi imbolsito. Potrebbe rappresentare (è questa la mia emozione) il passato che ha lasciato profondo sconforto nel cuore di chi ha vinto tante battaglie. Sulle sue mani si è posato un piccione viaggiatore bianco che ha legato sulla zampetta un messaggio. Ho voluto pensarlo come un messaggio di speranza: l’uomo non ne conosce ancora il contenuto, ma quello scritto potrebbe indicare la nuova via, il futuro, che, sebbene pieno di incognite, traccia un percorso diverso e meno sconsolante. Infine Verolini, e un’opera su tutte: il “Magnificat”. Un orizzonte dove bianche nuvole si specchiano in un mare lontano: un vecchio forte, una grande distesa di erba attraversata da una strada bianca, quasi una lama, fiancheggiata da alberi dalle tondeggianti chiome verde scuro, ancora più presenti per l’ombra che spargono intorno. Ho parlato con l’autore di questo quadro: un colloquio semplice, tra due amici che si incontrano per la prima volta dopo esperienze diverse. Quasi non ascoltavo le parole di Verolini, ero troppo preso da quel quadro. Ho immaginato che l’artista, vagando senza una meta in un paese a lui sconosciuto, si sia imbattuto per caso in quel paesaggio e, colpito da tanta bellezza, ne abbia voluto imprigionare i segreti e le luci, nascondendoli in una nebbia ovattata. Quante emozioni! La mostra è finita da tempo. Sono rimasti i ricordi ancora vivi. Un grazie a questi artisti che, per qualche giorno, hanno fatto volare la mia fantasia in tanti mondi diversi, arricchendo il mio spirito e la mia anima. CULTURALI segue da pag. 1 Successo di una mostra vera chiesa: le voci basse, i movimenti controllati; non mi sarei meravigliato se qualcuno, varcando la soglia, si fosse fatto il segno della croce. La sapiente disposizione dei quadri sui cinque espositori e le luci diffuse, mai accecanti ma dirette sulle tele, esaltando i colori e creando un “rapporto d’amorosi sensi” con chi le osservava, hanno contribuito a determinare un’atmosfera quasi astratta, un filo invisibile tra l’autore dell’opera e il suo critico. Ho una mia teoria, sul rapporto tra l’uomo e l’arte, che prescinde dalla conoscenza delle tecniche e delle correnti che ne hanno generato l’espres- sione. E’ una teoria basata sull’emozione che un quadro, una scultura possono causare in chi le ammira. Non importa se l’autore sia Michelangelo o Caravaggio, ma è importante il rapporto subliminale che può scaturire dall’incontro. Ho pensato al saggio sull’arte di Benedetto Croce nella sua opera dal titolo Estetica. Il grande filosofo ne esalta proprio l’universalità che prescinde dagli schemi e, al contrario, fa leva sui sentimenti, in una continua ricerca delle ragioni della propria esistenza e in un incessante confronto con chi, baciato dalla genialità, ne ha saputo rappresentare il fine. Osservando il “Deserto dei tartari” del pittore Giacomo Maria Giuffra ho cercato subito la corrispondenza tra quel quadro e l’omonimo romanzo di Dino Buzzati: solitudine e paura in quegli uomini chiusi in un fortino, nel mezzo del deserto, in attesa di un nemico che mai arriverà; solitudine e Allegato al n. 2 de L’Orioli Periodico di cultura, costume e società Speciale sull’Amore Febbraio/Marzo 2004 ...muore lentamente chi evita la passione, chi non rischia la propria sicurezza per l’insicurezza di un sogno... Pablo Neruda Venere che guida Cupido a scuola da Mercurio, Correggio 1523, Londra National Gallery Voce del verso amare di Umberto Broccoli e Patrizia Cavalieri UN AMORE IMPOSSIBILE (condizionale) Quante sfaccettature, quanti aspetti di uno stesso amore. E quante ne conosciamo, anche se non riusciremo mai a impadronirci di tutti i colori dell’amore. Un amore può essere proibito, può essere ostacolato dagli uomini o dalle situazioni create dagli uomini. Allora diventa impossibile resistere a quel tipo di amore. Ti sembra di esplodere, quando qualcosa o qualcuno attraversa la strada del tuo percorso di vita. Ti senti scoppiare dentro e - potenzialmente - sei nella condizione di fare ogni tipo di sciocchezza. Ti passa ogni voglia: dimentichi ogni altra circostanza che non sia quell’appuntamento nascosto, quel momento di incontro, quel tentativo di raggiungere lei o lui. Vivi quell’attimo, poi ti lasci andare. Ti lasci trasportare dalla vita quotidiana, quasi senza reagire. Aspettando un altro momento, un’altra possibilità d’incontro. E se non arriva? Se si allontana? Non pensi ad altro. Riempi fogli di carta di parole. Riempi i tuoi occhi di orizzonti sempre più lontani e sempre più malinconici, anche se splendenti. Sono orizzonti solitari: orizzonti senza orizzonti. Riduci la tua vita al solo pensiero di come sarà possibile, domani, ottenere quanto ti è impedito oggi. Sapendo come e quanto domani diventerà oggi, domani aspetterai un altro domani. E ancora domani, e ancora domani, e poi domani ancora... Un amore impossibile forse può diventare possibile; già Sesto Properzio lo credeva: rale e alle regole sociali, eternamente insoddisfatto delle sue conquiste e alla ricerca dell’amore assoluto, costituisce anzi un vero e proprio mito della modernità, da quando fece la sua comparsa nel 1630 nel dramma dello spagnolo Tirso de Molina per essere successivamente rielaborata nelle opere immortali di Molière (1665) e di Mozart (1787, con libretto di Da Ponte). Un esempio più recente? “Forse Tomas, il protagonista de L’insostenibile nunzio; ai secondi Giacomo Casanova, il conquistatore democratico, che passava dalla servetta alla nobildonna senza fare differenze. Ma c’è anche chi ha preso un po’ in giro questi conquistatori coatti: pensiamo a Il bell’Antonio o al Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati. C’è poi un seduttore, forse compulsivo, che al momento opportuno si tira indietro con classe, senza consumare: è il Philip Marlowe di Raymond Chandler”. bertà; mentre il suo frustrato desiderio di perfezione ne fa una figura profondamente umana. Con lui l’amore diviene inganno, guerra, seduzione intellettuale: il suo piacere non è nel possesso tout court ma nella conquista, nell’assoggettamento psicologico, nell’affermazione di sé. Come scrive Kierkegaard, egli vive “nell’attimo”, alla perpetua ricerca di un piacere che non sazia mai. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua FRASE per far sì che una serata come un’altra cominciasse per incanto ad ILLUMINARSI E allora Amore è pura fantasia, dove una frase basta a illuminare il più grigio inverno o a colorare intensamente il più sbiadito bosco autunnale. Il linguaggio degli amanti è ancora più povero, non può eguagliare la tavolozza dei colori di un Raffaello; solo il gesto talvolta tradisce questa pochezza e si fa eloquente in un abbraccio sovrabbondante di significato. Ma il corpo da solo nella sua pienezza non basta, deve poter lasciare ampio spazio alla creazione dell’Altro, che raramente corrisponde al nostro partner reale. E pensare che poco tempo prima parlando con qualcuno mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a CREDERE all’amore, a ILLUDERMI e SOGNARE Il salto nel mondo della fede apre dunque la strada all’amare, dove illudersi e sognare diventano elementi costituenti, se non la vera essenza di questo sentimento misterioso, vecchio e sempre nuovo. Ognuno di noi si crea un'immagine virtuale con quanto l’altro manifesta, e offre qualcosa o una parte di sé. In questo nostro tempo siamo così racchiusi nella nostra solitudine per paura che la nostra individualità venga dispersa, o in qualche modo diluita nell’altro, e rivendichiamo con forza solo la nostra creazione e in essa amiamo noi stessi; il frutto a cui siamo riusciti a dar corpo senza tuttavia possederlo completamente incorporandolo. Alla fantasia spetta dunque il ruolo decisivo nella scelta e nel permanere con un certo partner. “È un amore impossibile”, mi dici. “È un amore impossibile”, ti dico. Ma scopri che sorridi se mi guardi, e scopro che sorrido se ti vedo. “Di notte” - tu confessi - “io ti penso. “La società, le regole, i doveri...”, ma tremi quando stringo le tue mani. “Meglio felici o meglio allineati?”, ti chiedo. E il tuo sorriso accende il giorno, cambiando veste ad ogni mio pensiero. “Questo amore è possibile”, mi dici, “questo amore è possibile”, ti dico. Amore impossibile. A ben vedere, è l’amore dei poeti. I poeti soffrono le pene d’amore: forse per questo riescono a raccontarle bene e a farci da specchio per l’anima. DON GIOVANNI, FARABUTTO MA SIMPATICO In letteratura i seduttori impenitenti sono stati quasi sempre rappresentati come personaggi affascinanti, piuttosto che come soggetti con problemi comportamentali. La figura dell’inguaribile libertino, contrario alla mo- Nelle cose d’amore che definiamo “sentimento”, proprio il superare l’indifferenza ci fa accorgere che può esistere ed esiste una vita che si nutre di emozioni profonde. All’attrazione fisica carnale si sostituisce (anzi si riappropria del terreno lasciato libero) una parvenza d’amore quando l’assenza si fa più intensa: una presenza dove il sentire sovrasta il capire. L’immaginazione fa poi il resto: spesso colora un vuoto, trasformandolo nel più dolce dei rifugi d’amore, un’alcova vellutata di un rosso intenso. Ecco che ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare per un po’ ho cercato in me l’indifferenza poi mi son LASCIATO ANDARE nell’amore Nora Orioli, Roma primavera sul lungo Tevere, 1960 leggerezza dell’essere di Milan Kundera: nonostante ami davvero Teresa, Tomas non riesce a fare a meno di passare da una donna all’altra”, ricorda Simona Micali, docente di Letterature Comparate a Bologna. “Kundera divide i grandi seduttori in due categorie: i lirici, che in ogni donna cercano il loro ideale — e devono cambiare continuamente perché sempre delusi — e gli epici, che in ciascuna storia colgono e si appropriano di un frammento di femminilità. Ai primi appartengono senz’altro il mitico Don Giovanni e l’Andrea Sperelli de Il piacere di D’An- E al cinema? Possiamo ricordare L’uomo che amava le donne di Truffaut, o la seduzione seriale di James Bond, che a ogni film ha una nuova fiamma. Ma molti altri esempi si possono fare, e tutti, invariabilmente, risultano mossi dalla stessa incontenibile gioia di vivere, da un misto di sfacciataggine e coraggio che nonostante tutto ce li rende simpatici. Don Giovanni diviene mito perché si ribella sempre (etimologicamente “dissoluto” significa infatti “sciolto da ogni legame”), perché il suo burlarsi delle regole costituisce un inno alla li- DA UN POETA ALL’ALTRO… breve riflessione sull’amore attraverso una nota canzone di Luigi Tenco HO CAPITO CHE TI AMO Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo RITARDO per sentir svanire in me L’INDIFFERENZA per temere che tu non venissi più E infine, non potendo più ritornare sui propri passi, avviene come per miracolo il “lasciarsi andare”: si arriva a sconfinare dal terreno del conosciuto, del razionale protetto, esondando nell’irrazionale più puro dove il vero Amore ha l’ultima parola, riempiendo talvolta di significato e senso un’esistenza degna di essere vissuta, che, se siamo "sensibilmente dotati", può coincidere con la nostra vita. Massimo Fornicoli N. 2 Febbraio/Marzo 2004 3 ETRURIA BEL SUOL D’AMOR... L’Etruria è un grande ricordo che permea sottilmente le lande viterbesi e si traduce nella calma maestosa del loro paesaggio, nelle distese d’alberi e di rovi che coprono le ondulazioni delle superfici e condensano l’ombra del massiccio cimino al tramonto. Nel riparo dei burroni tufacei, degli antri scavati, dei sepolcri che si dipanano nel profondo, l’intenso ocra della terra etrusca assorbe lo sguardo e rimanda indietro nel tempo, in compagnia del sorriso stereotipato dei dipinti, della fissità delle figure umane e del fruscìo delle fronde con cui il vento squarcia il silenzio della natura. Dov’è la presenza di quella gente? Solo nei luoghi artificiali in cui i loro prodotti sono stati raccolti? O tutt’al più nel chiuso delle necropoli, o nello svettare delle poderose vestigia architettoniche? E’ sempre una presenza misteriosa, la loro, anche perché erano maestri nello svelare l’occulto. Una civiltà assorbita e celata, che a fatica stentiamo a ricostruire. Ma già ai tempi della Roma repubblicana, quando gli Etruschi erano ancora una realtà politica molteplice e declinante, l’immagine che essi offrivano di sé non era trasparente e si prestava a interpretazioni assai particolari. Leggiamo presso alcuni storici greci notizie singolari e intriganti su alcune abitudini degli Etruschi. Incominciando da Aristotele, meravigliato che essi banchettassero con le mogli sdraiati sotto la stessa coperta, per passare a dati più circostanziati e piccanti preservatici dal tardo erudito Ateneo, da lui appresi nelle opere storiche di Timeo e di Teopompo prima che si perdessero nel naufragio della letteratura antica. “Le cameriere – dice Timeo - servono gli uomini a banchetto svestite”. Teopompo aggiunge: “Vige l’abitudine presso i Tirreni di avere le donne in comune; queste hanno gran cura del proprio corpo e fanno ginnastica spesso assieme ai maschi, talvolta da sole: non si vergognano di mocon: strarsi nude. Si stenRegia: dono sui lettini per pranzare non accanto ai propri mariti, ma a chi capita dei convitati, e brindano a chi esse vogliano. Sono invero esperte bevitrici e il loro aspetto è assai gradevole. I Tirreni poi, tutti i figli che vengono fuori, li mantengono in vita senza sapere di chi è figlio ciascuno; e questi vivono alla stessa maniera di coloro che li allevano, sbevazzando e accostandosi a tutte le donne. Per nulla vergognoso è per i Tirreni mostrarsi non solo a fare loro qualcosa davanti a tutti, ma altresì a subirla: anche questa è un’abitudine locale. E tanto son lontani dal ritenerlo vergognoso che specificano pure, quando il padrone della casa sta facendo l’amore e qualcuno lo cer- ca, che sta subendo questo e quello, e indicano l’azione spudoratamente. Quando poi si riuniscono in gruppi associativi o di parenti, fanno così: innanzitutto quando smettono di bere e si mettono sdraiati i servitori fanno entrare nella stanza, all’ultimo chiarore delle lucerne, certe volte le cosiddette etère, altre volte maschi assai belli, altre ancora le mogli. Dopo essersi rinfrancati con queste, di nuovo fanno entrare giovanotti nel fior dell’età che si mettono accanto ad essi. Fanno l’amore nelle riunioni talora guardandosi tra loro, per lo più circondando i lettini con paraventi fatti di verghe intrecciate su cui vengon gettate sopra le vesti. Si coricano con impeto assieme alle mogli, ma molto più volentieri traggono piacere nello sdraiarsi con i giovanotti: ché infatti da loro ce ne sono di assai belli nel fisico, dato il lusso godereccio che conducono e la cura della cute che osservano. Tutti gli stranieri d’Occidente si depilano il corpo con ceretta e con ra- L’amore per il lusso, per la vita comoda e raffinata, per i piaceri corporali emerge dalle testimonianze figurative dell’epoca che segna la decadenza politica etrusca, ma contemporaneamente l’apogeo della civiltà. Pur tuttavia il tenore del resoconto di Teopompo, anche considerando il contesto in cui è conservato - una sezione dell’opera di Ateneo che tratta della tryphè in particolare dei Sibariti - ci fa sospettare sulla buona fede dell’informatore. Per quanto la struttura economico-sociale etrusca si possa interpretare con la chiave della tryphè (lusso) e dell’habròtes (raffinatezza) e far dipendere da una classe dirigente tipicamente oligarchica che poggiava il suo dominio sullo sfruttamento del lavoro dipendente, servile o semiservile, e quantunque alcuni osservatori critici come Posidonio abbiano spiegato il declino della potenza militare etrusca con il tenore di vita molle e la redditività della terra, sembra tuttavia poco probabile una diffusione così estesa di re e nella vita pubblica, aveva un ruolo molto più sacrificato e ristretto ad Atene e in parte a Roma che nelle società oligarchiche quali quella spartana o l’etrusca. Qui infatti era esaltato il suo ruolo di custode dei beni mobili e immobili e di comunicatrice dei possessi fondiari oltre che della discendenza familiare, anche nei casi di rischio di estinzione per colpa maschile. In Etruria l’importanza della donna si manifestò invece tanto nell’onomastica, come mostra l’indicazione dei cittadini di pieno diritto che – per lo meno dal IV secolo - era completata col nome materno, quanto nell’evidenza dell’intervento femminile in vari luoghi della casa, anche borghese, contrariamente alla scarsa presenza della donna nella dimora ateniese, limitata ai cosiddetti ginecei. Le donne etrusche risultavano anche proprietarie di oggetti importanti, su cui apponevano il proprio nome, e ricevevano un’istruzione quasi equivalente a quella degli uomini. Dunque una dote si prostituissero. Così Aristotele dà l’informazione sopra riportata sulle coppie a banchetto malinterpretando forse le scene rituali di un matrimonio. Che il quadro offerto da Teopompo non mostri una forte coerenza interna trapela ad una rilettura attenta del testo. Qui si insiste dapprima, per le donne, sulla facilità di costumi e addirittura sulla pluralità di partner che si oppone alla monogamia tradizionale; in seguito si distingue tra etère e donne sposate. Per quanto riguarda gli uomini, a proposito dei figli bastardi viene evidenziato il loro forte impulso sessuale verso le donne, ma dal testo (che riflette le parole di Teopompo, ma non ne sarà certo una trascrizione letterale) non si comprende se lo specificare “tutte quante” indichi la faciloneria e il trasporto animalesco di tali signori oppure l’assenza di discriminazione sociale, ossia se con uomini di incerta paternità e quindi di scarso peso sociale andassero non solo le sgualdrine ma pure le aristocratiche, nel qual caso sarebbe un’ennesima tirata contro la categoria femminile. Inoltre, mentre nella prima parte gli Etruschi risultano dei gran donnaioli, nella seconda si legge chiaramente che essi traggono piacere di gran lunga maggiore dai rapporti con lo stesso sesso. Insomma, sembra che la fonte abbia idee un po’ confuse, e attribuisca alle signore comportamenti tenuti per lo più dalle sgualdrine, forse anche per l’abitudine diffusa in qualche periodo e in qualche zona di prostituirsi per crearsi la dote (come attestato in Plauto). Certo da affreschi tombali come quelli del Triclinio la presenza delle signore ai banchetti è documentata, ma le illazioni sui comportamenti successivi sembrano frutto di eccessiva maliziosità. La quale peraltro trapela dietro l’insistenza sul voyeurismo e l’esibizionismo, con una prima osservazione che enfatizza la bisessualità – come indica l’opposizione fare/subire – dei personaggi, e una seconda che stranamente frena il proclamato esibizionismo e lo riduce ad una minore frequenza di casi. Voyeurismo implicito è nella scenetta del servo che indica con precisione in quali pratiche sessuali passive sia impegnato il padrone al visitatore capitato casualmente e che quindi non potrà essere ricevuto (dunque il voyeurismo è limitato al servo!). L’attendibilità delle notizie è infine indebolita dall’ultima parte del resoconto, quella che si riferisce alla tryphè e l’habròtes dei popoli occidentali e in particolare dei Sibariti. Qui i Greci d’Italia avrebbero appreso l’arte degli estetisti dai Sanniti e dai Messapi, gente semplice, guerriera e rude: e ciò sembra francamente strano. Come che sia, tra i misteri della terra d’Etruria c’è anche la reale natura della sua gente. Ma dalle testimonianze che conserviamo sottoforma di oggettistica, costruzioni, raffigurazioni fittili e dipinte, ci sembra comunque… che sapessero godersi la vita. TEATRO COMUNALE “FRANCESCO ORIOLI” DI VALLERANO 28 febbraio 2004 ore 17:30 Luna d’Amore Le più belle poesie d’amore d’ogni tempo e paese William Dyce, Paolo e Francesca, 1837 Le vicende della passione amorosa paragonate, nel loro succedersi , alle fasi della luna. Luna crescente: l’innamoramento, l’oggetto d’amore; luna piena: il desiderio, la passione; luna calante: il distacco, l’assenza; luna cinerea: il rimpianto, la memoria. Si affiancano così in questo spettacolo poeti lontanissimi per epoca e per cultura che tuttavia testimoniano con i loro versi l’immutabilità dell’amore esprimendo gli stessi stati d’animo persino con immagini e metafore analoghe. Queste poesie di tutte le letterature propongono emozioni, slanci, le luci della gioia e le ombre della sofferenza in cui ogni spettatore potrà riconoscersi. 4 N. 2 Febbraio/Marzo 2004 Miriam Nori, Oliviero Piacenti, Carla Chiuppi, Roberto Rosati, Antonio Cianchetti Oliviero Piacenti In occasione dello spettacolo verrà distribuito il secondo numero del foglio L’Orioli con lo speciale dedicato all’Amore soi, e presso i Tirreni ci sono molti centri estetici e operatori esperti di queste pratiche, come presso di noi i barbieri. E quando vengono in questi centri si mettono pronti senza reticenze, non vergognandosi dinanzi a chi li guarda o che passa davanti. Tali abitudini le hanno molti dei Greci che vivono in Italia, e le hanno apprese dai Sanniti e dai Messapi. Per via del loro amore per la raffinatezza i Tirreni, come attesta Alcimo, impastano il pane e fanno pugilato e danno i colpi di frusta al ritmo di uno strumento a fiato”. pose “petroniane”, quale emerge nel quadro di taluni storici ellenistici peraltro già anticamente tacciati di viziosità (“Theopompus… et Timaeus… duo maledicentissimi”, Nep.Alcib. 11). Dagli studi relativi è emerso che la società etrusca si fondava sulla famiglia monogamica. Come allora interpretare gli atteggiamenti osé delle scene sopra descritte, in cui compare ostentazione del nudo, negazione della struttura familiare tradizionale e piena libertà sessuale delle mogli? In realtà la donna, nell’ambito familia- agli occhi dei Romani o di certi Greci esse godevano di un’importanza particolare e fruivano di una possibilità di presenza in pubblico insperata altrove. Di qui ad attribuire una forte libertà sessuale il cammino è breve, specie tenendo conto della tendenza comune ad ogni età a mettere in cattiva luce popoli stranieri confinanti o con cui si sono avuti rapporti ostili o di rivalità. I vicini latini dell’età repubblicana – a quanto leggiamo in Plauto - pensavano che le ragazze etrusche non abbienti per costituirsi Filippo Sallusto FRANCESCA DA RIMINI Il più celebre ed ammirato episodio dell’Inferno dantesco ha sempre goduto di una reputazione eccezionale, se perfino nei detrattori del Seicento (Beni, Frugoni) e del Settecento (Cesarotti, Bettinelli) esercitò un certo fascino. Con l’inizio dell’età romantica poi si trasformò in un mito di formidabile portata, tanto da proporsi come prototipo dell’amore-passione, dell’amore-rivolta contro la società, le convenzioni, le leggi, la morale borghese. Dal punto di vista estetico, la critica romantica gareggiò con quella decadente nell’evidenziare la maestria compositiva dell’episodio, dello stesso canto V che è per metà diegetico ed enumerativo (“vedi Paris, Tristano... E più di mille / ombre mostrommi e nominommi a dito”) e per metà psicologico e tragico. Passare dal catalogo al ritratto — e che ritratto: è la scoperta della persona col suo destino di salvezza o di dannazione — costituisce una novità portentosa che supera di colpo tutta la letteratura cortese della Table Ronde. Francesca di Rimini si presenta come un gigante che occupa tutto lo spazio della scena. Ma quale ragione ha portato Dante ad un’invenzione poetica di tale portata? E quale è il rapporto fra lui stesso, personaggio ed autore del poema, con il personaggio rappresentato? Come ha conosciuto, assorbito, rappresentato una storia così forte e dolorosa? Qui bisogna dire subito quella che è l’unica certezza in questa storia d’un delitto passionale nell’alta società romagnola del Duecento: che cioè nulla, proprio nulla esiste nelle cronache del tempo prima che il poeta ne facesse oggetto di poesia. Abbiamo soltanto i nomi certi: Francesca figlia di Guido il Vecchio da Polenta, Paolo Malatesta fratello minore di Gianciotto Malatesta, signore di Rimini. Tutto il resto è leggenda: che Paolo fosse bello e gentile quanto Gianni detto Ciotto (lo zoppo) era brutto e deforme; che Francesca avesse sposato quest’ultimo credendo di sposare Paolo; che la tresca fra i due cognati si prolungasse per anni, finché Gianciotto non tese l’agguato mortale, facendoli uccidere l’uno sull’altra. Come talvolta accade, la poesia aveva preceduto la cronaca e non viceversa. Ora, chi è stato l’autore della finzione? Certamente Giovanni Boccaccio, che nelle sue Esposizioni o commenti della Commedia che lui avrebbe chiamata “Divina” raccolse — non si sa da dove — le notizie che tutte insieme hanno formato il celebre episodio così come lo conosciamo, e cui la critica moderna presta scarsissima fede. Secondo il Parodi, la storia di Paolo e Francesca sarebbe “la più bella e famosa novella del Decameron” ed equivale in fondo ad un’apologia di Francesca e del suo stesso peccato. Bisogna tener presente questa tesi perché, con diverse frange e tonalità, essa condiziona la lettura, più o meno, dei vari interpreti della creazione dantesca fino al Romanticismo, quando per opera del Foscolo e del De Sanctis il personaggio cresce fino al prototipo della donna moderna, cosciente della propria dignità ed autonomia soprattutto per quanto ri- guarda la sfera sentimentale: vada o no contro le leggi della società, della religione, del costume, Francesca è cosciente della propria passione, non è pentita, ama per l’eternità l’uomo che l’ha amata ed appunto per questo appare vittima di una fatalità ineluttabile. Pertanto risulta anticipatrice delle grandi creature romantiche, Manon Lescaut, Anna Karenina: eroine passive e quasi sempre disperate, ma ingigantite da quell’amore che è palpito dell’universo ed è legge tragica della vita. Per il De Sanctis Francesca è una creatura ideale in quanto, di fronte alle donne del “Dolce stil novo” delle quali ripete le movenze e il linguaggio, ha il vantaggio di essere vera, di una verità artistica ed umana che la rende unica ed inimitabile: “La donna che Dante va cercando nel sommo dei cieli l’ha trovata laggiù, nell’abisso infernale, nella bufera che mai non resta”. Una lettura di tal genere pone inevitabilmente il problema del rapporto fra Dante e la sua creazione, facendo quasi supporre un duplice contegno, di condanna come uomo e di assoluzione come poeta. Espressione di questa spaccatura sarebbe lo svenimento finale che lo fa cadere “come corpo morto cade”. Volumi sono stati scritti, in epoca positivistica, sul divario tra il sistema teologico, dottrinale, allegorico dell’oltretomba dantesco e la splendida eccezione di Francesca che lo contraddice in modo così vistoso. Eppure anche questa lettura, che ha avuto tanti illustratori, non soddisfa la riflessione critica moderna, perché ipotizza una debolezza speculativa che è tutta da dimostrare. Se c’è un principio chiaro e ben motivato nel pensiero dantesco è proprio la concezione dell’amore come epifania divina, Dio stesso nella persona dello Spirito, armonia delle sfere e delle creature, anima della creazione e principio della vita. Ed altrettanto chiara è l’indistruttibile presenza della legge morale, che distingue l’uomo dagli animali e dalle piante. La legge morale, che ha radici naturali (tant’è vero che in diverse forme interessa tutti i popoli della Terra) e conferme soprannaturali (cioè la rivelazione dei Profeti e di Cristo), è obbligante per tutti, anche se può essere ignorata o rifiutata dal libero arbitrio. Francesca l’ha infatti rifiutata per sostituirle un’altra legge, quella dell’amore. Una tipica ambivalenza verbale (amore è la parola più ambivalente del dizionario italiano ed universale, perché può riferirsi sia al mestiere della meretrice — “facciamo l’amore” — sia alla divina Bontà che “muove il Sole e l’altre stelle”) ha trascinato la donna nella bufera infernale che mai non resta. Per intendere questa ambivalenza, che del resto ha risvolti intensamente poetici e alimenta tanta parte dell’esperienza dantesca, dalla Vita nuova al Convivio, occorre rileggere l’episodio dei lussuriosi non solo nella prospettiva infernale ma anche in quella del Purgatorio che è assai più esplicita. Nei canti XXV e XXVI è esposta da Stazio la dottrina aristotelico-tomista sulla genesi dell’anima attraverso il concepimento fisico, con un immediato codicillo di Virgilio: “Per questo loco / si vuol tenere a li occhi stretto il freno / però ch’errar potrebbesi per poco”. Appunto per poco ha errato Francesca, tanto è vero che verbi e aggettivi e stilemi del “Dolce stil novo” sono passati nel suo linguaggio: “Amor che al cor gentil ratto s’apprende”, “Amor che a nullo amato amar perdona”, “aver pace”, “tempo felice”, “Come colui che piange e dice”, “il disiato riso”, coinvolgendo in perfetta corresponsione quello dell’ignoto pellegrino che ha pietà di lei: “Quanti dolci pensier, quanto desio...”, “i tuoi martìri”, “i dolci sospiri”, “i dubbiosi desiri” con tipica iterazione musicale; e la confessione d’essere “tristo e pio” al cospetto della tragedia amorosa, dove la tristizia e la pietà si fondono, mantenendo tuttavia alla prima il significato passivo di dolore ed alla seconda quello attivo di partecipazione. Ma c’è di più: l’iniziale similitudine “Quali colombe dal disio chiamate, ecc.” è di iconografia sacra (altro che motivarla “perché animali lussuriosissimi” di cui già rideva il Foscolo!) e il vento incessante si richiama allo “Spiro”, allo Spirito Santo che può scuotere le piante come le anime (“scendi bufera ai tumidi / pensier del violento” avrebbe invocato il Manzoni), né si trascuri lo scolorire del viso ed il tremare delle membra, tutte denotazioni del timor Domini. Se dunque il controcanto dell’illusoria felicità di Francesca è una collezione di emblemi sacri (c’è perfino la “preghiera condizionata” che piacque tanto al De Sanctis: “Se fosse amico il re dell’universo / noi pregheremmo lui per la tua pace...”), perché condannare una peccatrice che gode di tante attenuanti e che per giunta è circonfusa di vera ed alta poesia? La risposta non può essere che una: l’ancella d’Amore che ha affascinato tanti lettori e tanti emuli (Paolo ha per lei perduto la vita, ma forse d’uno struggimento ancor più profondo se n’è innamorato il De Sanctis) non è pentita e quindi non può ottenere misericordia. La sua auto-apologia, se tale può chiamarsi, è iperbolica ed esclusiva. Ipostatizza l’amore come un assoluto, una necessità inderogabile che ha distrutto lei e Paolo, loro soli al mondo. E il loro sangue ha tinto il mondo. Se proviamo a rileggere il celeberrimo episodio in chiave moralistica, i conti tornano perfettamente. L’amore come corresponsione necessaria è una favola, che l’esperienza smentisce ogni giorno: ma Francesca lo pone innanzi a tutto quasi tavola di una nuova legge. Quando poi Dante la interroga per sapere come quel sentimento che era celato e quasi silente (e quindi puro, come puro è ogni amore al primo germoglio) fosse divenuto d’un tratto rovinoso e colpevole, egli sa di cogliere il centro del problema. Finché la lettura della storia di Lancillotto e Ginevra rimaneva sul piano dell’immaginazione, l’idillio non debordava dall’amore-cortesia descritto nel famoso trattato di Andrea Cappellano e, benché non scevro di pericoli, rientrava nel gioco aristocratico di una società raffinata e galante; ma dal momento in cui il bacio dei due personaggi fittizi si invera in quello dei due protagonisti reali l’amore-passione prende il sopravvento e il talento sommerge la ragione. L’ultima pennellata al quadro è il tracollo del poeta che “come corpo morto cade”: che è parte anch’esso del rituale stilnovista, ma qui porta all’estremo il conflitto tra giustizia e pietà. Ed equivale, come osserva ogni commentatore, ad una personale confessione di Dante. Da ultimo, c’è un altro particolare che contrassegna l’originalità dell’episodio nel quadro dell’amore cortese: il libro. La mediazione amorosa era svolta, nei romanzi della Table Ronde, dai sortilegi, dai filtri, dagli anelli fatati, dalle pozioni afrodisiache (si ricordi quella che per equivoco, destinata a Re Marco, è bevuta da Tristano); e, nel peggiore dei casi, da un personaggio lascivo come Galeotto. Ma che tale funzione sia svolta da un libro comporta un salto di qualità che per la prima volta illumina con Dante un fattore di capitale importanza nella civiltà umanistica. C’è anche qui un possibile ammonimento cautelativo (la polemica contro i libri cattivi, senza dubbio; ma la carta è materiale infiammabile ed occorre discernimento; l’incendiario può finire acceso, come sperimentò tragicamente il Savonarola), tuttavia resta fondamentale la consacrazione della letteratura quale scelta operativa fra il bene e il male. Chi legge non è una spugna ma un filtro, non assorbe tutto ma solo quello che consuona con la propria sensibilità, col suo giudizio, con la sua tempra morale. In ogni caso, il libro vince il tempo. Fermando il pensiero nella scrittura, compie un atto che per sua natura si sottrae alla legge della consumazione dell’attimo, alla triste soggezione alle cose. Ed è per questa legge dell’intelletto e dello spirito che l’uomo si apre alle sfere superiori. È per il libro che noi stessi, leggendo la storia di Francesca, possiamo crescere nella conoscenza delle anime e delle passioni, e della catarsi che in noi si produce distaccandole da noi e contemplandole nella non peritura bellezza. Franco Lanza (All Rights Reserved) NdR: Franco Lanza, italianista di riconosciuta fama, è stato ordinario di letteratura italiana presso le Università di Palermo, Salerno e Viterbo. Ha al suo attivo una ricchissima bibliografia che va dagli studi danteschi all’analisi di momenti e protagonisti fondamentali nella storia letteraria italiana antica e moderna (tra gli altri G.B. Vico, Alfieri, Manzoni, Leopardi, la poesia barocca e del ‘900, la figura di Benedetto Croce, l’Umanesimo cattolico). Nel 1994 ha pubblicato Paolo VI e gli scrittori. Da lungo tempo, inoltre, si adopera per la diffusione della nostra cultura in campo internazionale, e in particolare presso le istituzioni dell’isola di Malta. La critica letteraria VINCENZO CARDARELLI Presentiamo in questo numero dedicato all’amore alcune poesie sul tema di Vincenzo Cardarelli, il poeta originario di Tarquinia che, intorno al 1920, propone attraverso la rivista La Ronda un ritorno all’ordine e all’equilibrio formale contro i recenti eccessi delle avanguardie letterarie. Per lui essere moderni, infatti, non significa estirpare le radici che fissano l'arte contemporanea alla tradizione, bensì riuscire a esprimere gli ideali del proprio tempo seguendo l’insegnamento di rigorosa armonia dei classici antichi. In Cardarelli, dunque, l’esigenza di novità si attua - seguendo la lezione di Leopardi - nella ricerca di un linguaggio estremamente controllato e elegante, e in uno stile attraverso il quale le vicende personali ed i dati paesaggistici sono elevati dal piano contingente a quello di una assorta e universale meditazione. Le emozioni che in lui suscitano, ad esempio, il mutare delle stagioni o il fascino ingannevole della bellezza, la fugacità dei sentimenti o la solitudine, diventano nei suoi versi il paradigma della condizione umana, l’espressione di una visione pessimistica dell’esistenza che è condotta però senza sentimentalismi e compiacimenti autobiografici, anzi sempre all’insegna di una sobria e dignitosa compostezza espressiva. Allo stesso modo, i ricordi penosi dell’infanzia e del paese natio, sempre avvertito come ostile, vengono trasfigurati attraverso la funzione idealizzante della memoria e resi mitici dagli echi culturali e letterari: così è per la riabilitazione in chiave leggendaria della figura paterna, o per la rievocazione della amata-odiata Maremma come terra dei misteriosi Etruschi, sorta di “paradiso perduto”. Se vogliamo rintracciare una presenza femminile nella vita solitaria di Cardarelli, l’unico suo vero amore è Sibilla Aleramo: egli se ne innamora a poco più di vent’anni, subendone tutto il fascino e restando quasi travolto quando capisce che questa passione tormentosa altro non è che un’effimera fiammata. Presto i due amanti si rivelano infatti l’uno l’antitesi dell’altra, lei tutta istinto e passione, lui trattenuto da una naturale introversione che finisce per trincerarlo dietro continue razionalizzazioni nevrotiche. Il poeta considererà sempre la donna come un mistero adorabile ma inafferrabile - “Io non crederò mai nella donna. Questa è la mia dannazione” - e si lascerà sopraffare dalla misantropia, risucchiato nel vuoto esistenziale. Nella nostra selezione, a un efficace ritratto della donna amata dal titolo omonimo, segue una composizione dalla quale emerge la malinconia per l’amore ormai finito e mai pienamente vissuto, e un’altra invece in cui la memoria ingannevole e pietosa interviene a mitigare nel cuore del poeta il ricordo doloroso della sua patria. Chiude questo brevissimo excursus nella poesia cardarelliana “Astrid”, l'ironico racconto carico di umori misogini della breve avventura tra il poeta trentenne e una giovanissima ragazza norvegese. Silvia Camicia Ritratto Esiste una bocca scolpita, un volto d'angiolo chiaro e ambiguo, una opulenta creatura pallida dai denti di perla, dal passo spedito, esiste il suo sorriso, aereo, dubbio, lampante, come un indicibile evento di luce. Amicizia Noi non ci conosciamo. Penso ai giorni che, perduti nel tempo, c'incontrammo, alla nostra incresciosa intimità. Ci siamo sempre lasciati senza salutarci, con pentimenti e scuse da lontano. Ci siam riaspettati al passo, bestie caute, cacciatori affinati, a sostenere faticosamente la nostra parte di estranei. Ritrosie disperanti, pause vertiginose e insormontabili, dicevan, nelle nostre confidenze, il contatto evitato e il vano incanto. Qualcosa ci è sempre rimasto, amaro vanto, di non ceduto ai nostri abbandoni, qualcosa ci è sempre mancato. Arabesco Se non fossero i ritorni che mi assicurano l’eternità! I belli orizzonti che ospito negli occhi con poco amore e mutano rapidamente, se non fosse il sagace inganno che si consuma nella mia memoria a riserbarmene il senso! Poi da un barlume, un ricordo, forse illusorio, ariose nostalgie, recuperate realtà distese. Dalle ignude concezioni le prospettive ridenti che si rifanno! E i suoni, difficile scherzo, senza dei quali il ritmo non sussiste. Attesa Oggi che t’aspettavo Non sei venuta... ... Amore, amore, come sempre, vorrei coprirti di fiori e d’insulti. Astrid (Temporale d’estate) Fin dalla prima sera, è inutile nasconderlo, io avevo messo gli occhi su Astrid. Ci voleva poco a capire l’enorme differenza che correva fra lei e le sue compagne. La sua persona aveva infinitamente più peso, più importanza. Ella spiccava come una regina fra le sue ancelle. Soltanto un osservatore superficiale o dispettoso avrebbe potuto non riconoscerla o trascurarla come si trascurano d’istinto e si eliminano dal commercio usuale i capolavori del genio, le grandi opere d’arte. Tutte le altre ragazze erano assai più alla mano, rappresentavano un tipo femminile abbastanza corrente. In lei sola il mistero del sesso pareva assumere un carattere, una figura, una faccia. Era dunque Astrid una fanciulla segreta, naturalissima, con qualcosa di tenero, di precocemente matronale e nobile. Più geniale che intelligente; e piena d’imprevisto. Perfidamente donna, aveva il gusto di esasperare l’amore e di far soffrire. Astrid era nata per piacermi. N. 2 Febbraio/Marzo 2004 5 IL SENSO CRISTIANO DELL’AMORE merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi”. (Luca 6, 27-35). Le due citazioni ci conducono immediatamente nel cuore del messaggio evangelico, al punto che l’amore viene indicato da Gesù come la divisa che distingue i suoi discepoli: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così Questa semplice incursione nelle pagine del Vangelo sarebbe già sufficiente per scuotere qualsiasi coscienza adagiata nell’apatia e nella roccaforte del proprio egocentrismo. Non capisco come mai scritti di questo livello, contenuto e proposta non abbiano trovato spazio tra gli lezioni letterarie impartite nelle nostre scuole, restando riservate all’ora di religione; la quale peraltro è facoltativa, quindi significa che tali insegnamenti possono benissimo essere ignorati. Ritengo questa una privazione fatta ai giovani, sotto il profilo formativo. Mi è stato rivolto l’invito a scrivere questo articolo per il giornale curato dalla Associazione che porta il nome di Francesco Orioli: spiegare il senso cristiano dell’amore. Una bella impresa! Mi sono messo a tavolino per cercare di riordinare le notevoli riflessioni provenienti dalla letteratura teologica, e mi sono reso conto immediatamente di camminare in spazi vastissimi, variegati, impossibili da esplorare anche solo in parte. Preferisco allora seguire il percorso più immediato suggerito dagli scritti evangelici e dal Nuovo Testamento, mettendomi in ascolto delle parole del Maestro dell’amore, Gesù Cristo, invitando il lettore a sedersi accanto a me, innanzitutto per apprendere, conservare nel proprio cuore, se possibile vivere una proposta davvero straordinaria. Anche a Lui, un giorno, un tale fece questa domanda: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita terna?” Gesù rispose: “Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?”. Costui disse: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso”. E Gesù: “Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: ‘Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno’. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?”. Il tale rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso”. (Luca 10, 25-37). La parabola del “Buon Samaritano” dipinge con efficacia l’immagine dell’amore cristiano. In un’altra pagina del Vangelo Gesù fa vedere cosa può compiere chi vive in modo radicale l’amore: “Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla Sette opere di Misericordia, Caravaggio olio su tela cm 390x260 - Napoli Pio Monte della Misericordia guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la amatevi anche voi gli uni gli altri. Da Gli apostoli, i primi discepoli, hanno tunica. Dà a chiunque ti chieda; e a chi questo tutti sapranno che siete miei diraccolto questa eredità preziosissima prende del tuo, non richiederlo. Ciò scepoli, se avrete amore gli uni per gli lasciata da Gesù, ed hanno percepito che volete gli uomini facciano a voi, altri”. (Giovanni 13, 34-35). Questo con chiarezza che Cristo aveva indicaanche voi fatelo a loro. Se amate quelamore vicendevole è tale da spingere il to la via giusta per ogni uomo. Guidati li che vi amano, che merito ne avrete? discepolo a donare persino la propria dallo Spirito hanno composto delle sinAnche i peccatori fanno lo stesso. E se vita per gli altri, e questo è il vertice tesi capaci di scandagliare i vari tratti e fate del bene a coloro che vi fanno del dell’amore secondo Gesù: “Nessuno virtù che si accompagnano all’amore e bene, che merito ne avrete? Anche i ha un amore più grande di questo: dala sua rilevanza esistenziale. Osserviapeccatori fanno lo stesso. E se prestate re la vita per i propri amici.” (Giovanni mo, a titolo di esempio, come S. Paolo a coloro da cui sperate ricevere, che 15, 13) elabora una teologia dell’amore incen6 N. 2 Febbraio/Marzo 2004 trata sulla figura di Cristo, e che per questo chiama caritas (in greco agaph, in italiano carità). Rivolgendosi ai cristiani di Corinto, che desideravano primeggiare nei vari doni ricevuti dallo Spirito Santo, l’apostolo si rende conto che l’attenzione era attratta maggiormente da manifestazioni straordinarie dello Spirito e i doni più apprezzati erano la capacità di operare guarigioni, di parlare lingue diverse, il fare profezie, l’esprimersi in modo eloquente, la fede eroica e indefettibile. L’apostolo riconosce la legittimità di aspirare ai doni più grandi, ma la via migliore di tutte sarà la carità, cioè l’amore. “Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi gioverebbe.” La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine… Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!”. (Prima Lettera ai Corinti 13, 113). Dobbiamo però essere avvertiti che, nella nostra sensibilità moderna, di solito, l’amore si accompagna e si identifica con le opere benefiche di vario genere. Esso viene allora inteso come prassi, azione, una specie di filantropia che gode di un consenso generale. Nella prospettiva cristiana l’amore non può essere ridotto a semplice prassi: esso è compreso a partire dall’amore di Cristo, il quale ci rivela e ci inserisce nell’Amore di Dio. Così si esprime Giovanni nella sua prima lettera: “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati”. (Prima Lettera di Giovanni 4, 7-10). Il segno più grande dunque dell’amore di Dio è Gesù Cristo morto in croce per noi, e per mezzo di Lui abbiamo accesso all’Amore di Dio. Da questo radicamento nell’amore di Dio, mediante Gesù Cristo, scaturisce e si fonda l’amore verso il prossimo: “Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. … Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo.” (Prima Lettera di Giovanni 4, 11 e 19). Gli scritti del Nuovo Testamento sembrano come condurci per mano per farci raggiungere la percezione dell’importanza decisiva dell’amore, il quale non può essere un tema tra i tanti, argomento di dibattito o di ricerca accademica. Nella prospettiva neotestamentaria e giovannea diventa questione di vita o di morte, e infatti, proprio Giovanni, in modo quasi lapidario afferma: “Chi non ama rimane nella morte.” (Prima lettera di Giovanni 3, 14b). Siamo partiti dal tema del senso cristiano dell’amore, il quale ha necessariamente la possibilità di dispiegamento solo nell’incontro con l’Amore di Cristo, che ci abilita ad amare il prossimo alla sua maniera. Amati da Cristo, amiamo come Cristo, cioè donando la vita. Sembra paradossale, ma è vero: amando, entriamo nella vera vita; non amando, rimaniamo nella morte. Se le cose stanno così, allora dobbiamo aggiungere che Gesù ci ha mostrato non tanto il senso cristiano dell’amore, ma il vero senso umano di ogni amore. Don Ampelio Santagiuliana NdR: Ampelio Santagiuliana, ordinato nella diocesi di Vicenza (1978), è sacerdote fidei donum nella diocesi di Civita Castellana (VT), dove è parroco. Allegato al n. 2 de L’Orioli Periodico di cultura, costume e società “Speciale sull’Amore” EROS CON FORCHETTA E COLTELLO Anziché parlare di sublimi sentimenti, vorrei soffermarmi su una passione molto terrena, vale a dire l’amore per la buona cucina, che, come novello eros, si sta impadronendo di molti. Mi si potrà obiettare che il buon cibo ed il buon vino sono sempre stati annoverati fra i piaceri umani e non posso che essere d’accordo. Però mi sembra decisamente esagerato passare le serate disquisendo sui ristoranti alla moda, citando le stelle attribuite dalle guide quasi si trattasse di decorazioni al merito, oppure filosofeggiando sul sapore di vini che, a giudizio del sommelier di turno, di tutto sanno meno che di uva. gliate non contribuivano a dare una sensazione di refrigerio. I signori avevano la fronte imperlata di sudore, mentre a noi signore, adeguatamente scollate, andava un po’ meglio. Il menù che ci venne presentato era un trionfo di pesce con le pere, carne con i fichi e pane al sesamo e finocchio. La mia scelta cadde su un piatto a base di pesce, di cui dimenticai subito il nome, complicatissimo. La cena iniziò con un antipasto offerto dallo chef: ci fu servito un cubetto annegato in una salsa chiara di origine ignota. Arrivò poi un secondo piatto con un cilindretto adagiato su una crema gialla screziata di verde ed arancione. Io pensai si trattasse di un altro antipasto: invece scoprii, con sommo stupore, che quello era il mio piatto a base di pesce. Provai quasi dispiacere nel rovinare una simile opera d’arte, ma ormai avevo un certo appetito. Il fatto più emozionante avvenne pri- AMORE E BELLEZZA Sul rapporto che lega il tema dell’amorepassione a quelli della bellezza e dell’arte, ancora una autorevole riflessione, tratta da La morte a Venezia di Thomas Man Tra l’amaro e l’amore c’è un esile confine: il mare è molto amaro, proprio come l’amore, nel mare si sprofonda come accade in amore, perché il mare e l’amore sono assai tempestosi. Chi ha paura dell’acqua, stia ben saldo alla riva: chi ha paura dei mali che soffrono gli amanti ANIME GRAFFIATE Qualche grande estimatore mi potrebbe far notare che, per apprezzare appieno l’alta cucina, bisogna educare il palato; io stessa, anzi, anche se mi sembrava fatica sprecata, l’estate scorsa mi sono lasciata convincere da alcuni amici a varcare la soglia di un tempio della gastronomia. Arrivammo verso le nove e mezzo e fummo accolti da un cortesissimo cameriere che ci fece accomodare. Il colpo d’occhio sulla sala da pranzo, affacciata sul mare, era notevole e i pochi tavoli rotondi spiccavano per la loro eleganza. A onor del vero i nostri vicini risultarono un po’ troppo rumorosi, ma dovevano essere clienti abituali ai quali era fatta questa concessione. Purtroppo faceva molto caldo e non potevamo godere della brezza marina, perché eravamo in un tavolo d’angolo piuttosto lontano dalla terrazza; inoltre i pesanti cuscini che coprivano le poltrone impa- (liberamente tratto dal soggetto - scritto da Maurizio Costanzo - del film Per sempre, con Giancarlo Giannini e Francesca Neri) ma del dessert, quando una signora francese, seduta di fronte a noi e per sua fortuna accanto alla finestra, all’improvviso perse i sensi. I suoi amici le si fecero intorno premurosi, tranne uno che non perse il suo aplomb e continuò imperturbato a cenare. Ci fecero capire che non era nulla di grave, che il malore doveva essere attribuito a “le chaud” e a “l’orage” – il cielo infatti nel frattempo si era fatto minaccioso -, mentre noi malignamente pensammo che forse la signora avesse visto “l’addition”. La cena si concluse con deliziosi pasticcini, anche questi di formato più che mignon. Io mi sentivo sazia, ma pensai che qualche commensale con un appetito più robusto del mio non lo fosse affatto. Alla fine il conto, presentato su un piattino d’argento, si rivelò salatissimo. Ma, si sa, anche i riti costano. Francesca Rossi Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice anonima questi bei versi: Amore Forte, potente ndo esce dal profo a dell’anim si ad occhi chiu sole il o rs volge ve terno in o is rr il suo so …e guarisce vecchie ferite felicità portando una insperata a che si trasform e… in dolor i lunghi sguard i rr zu occhi az mordono labbra che si sia la questa dicono vera vita Feeling Perché è così forte mi trascina altrove senza che io possa fermarlo è impossibile travolgente, cattura, si fa spasimo amo questa è la verità desidero sogno mi avvolgo di dolci ricordi sì vivo ora… fama e gli onori di cui godiamo; grottescamente ridicola la fiducia riposta in noi dal volgo, temeraria e indifendibile impresa l’educazione del popolo e della gioventù per mezzo dell’arte. Come potrebbe infatti fungere da educatore colui che irrimediabilmente e per sua propria natura è spinto verso l’abisso? Vorremmo sì distogliercene, vorremmo acquistare dignità; ma ovunque dirigiamo i nostri passi, esso ci attira. Così avviene che rinneghia- “...Giacché, sappilo, noialtri poeti non possiamo percorrere la via della bellezza senza trovarvi Eros, che ben presto ci impone la sua guida; e possiamo anche, a modo nostro, essere eroi e disciplinati guerrieri; ma in verità somigliamo alle donne, perché la passione è ciò che ci esalta, perché soltanto all’amore ci è dato aspirare: e questa è la nostra gioia e il nostro obbrobrio. Or dunque, vedi che noi poeti non possiamo essere né saggi né dignitosi, che fatalmente cadiamo nell’errore, fatalmente rimaniamo dissoluti venturieri del sentimento? Menzogna, millanteria è la nostra padronanza dello stile, Amore che slaccia la cintura a Venere buffonaggine la nostra Joshua Reynolds, Olio su tela, particolare - Firenze Amore amaro Canestra di frutta Caravaggio Olio su tela, cm 31 x 47 Milano, Pinacoteca Ambrosiana Febbraio/Marzo 2004 non permetta all’amore di coglierlo e infiammarlo: evitino l’uno e l’altro e il naufragio e l’incendio. La madre dell’Amore ebbe il mare per culla, dell’amor sorge il fuoco, e sua madre dall’acqua, ma l’acqua contro il fuoco non può prestar riparo. Se essa potesse estinguere il mio rogo quando delle sue avventure, non ha problemi a conquistare anche Giovanni, che pure di donne ne avute tante nonostante sia "felicemente" sposato. In questo caso, infatti, l'uomo si lascia completamente irretire nelle seduzioni della ragazza; schiavo di questa relazione, mette in discussione tutti i successi della sua vita, progetta un nuovo futuro con lei e lascia la famiglia: perdendo la testa in un rapporto che fin dall'inizio appare squilibrato, e in cui egli è totalmente passivo, succube di un'amante ambigua e dominatrice. Sara infatti non gli si dà mai del tutto, non prova nessun desiderio di vera intimità, rimane fredda, e - nel profondo - distante; dopo quattro anni, durante i quali alterna momenti di passione travolgente a distacchi improvvisi in cui si nega a Giovanni con Raramente l'amore è sinonimo di felicità. Spesso, anzi, quella sensazione di gioia e di leggerezza che si prova nei giorni dell'innamoramento lascia presto il posto al dolore, a volte così straziante da annientare. L'espressione "morire per amore" non rappresenta un'assurdità, un'iperbole dei poeti o delle canzonette. Può accadere davvero che qualcuno, disilluso dalla persona amata a cui ha donato tutto se stesso, riceva un tale graffio sull'anima da perdere completamente la voglia di vivere, da lasciarsi andare all'apatia senza reagire e alla fine soccombere. Quando tutti i suoi valori crollano, e le speranze e i sogni sono distrutti, la realtà può apparire priva di ogni interesse rispetto a ciò che ha perso; con il vuoto intorno e dentro di sé, senza più energia per affrontare gli eventi quotidiani, avverte il bisogno di annullarsi, di sparire. È ciò che accade a Giovanni, uomo e avvocato di successo, quando conosce la sfuggente e sensualissima Sara, che lo coinvolge in una passione totale e devastante. La donna è spietata con lui come lo è stata con gli altri uomini che ha incontrato nella sua vita, prendendo da loro solo pochi, distillati momenti di piacere fisico senza mai concedersi completamente, senza rivelare se stessa, e lasciandoli quando se ne è stancata. Abituata a condurre il gioco, a stabilire il Circe , Lorenzo Garbieri 1580-1654, Olio su tavola cm. 66 x 51 come, il dove e il Bologna, Pinacoteca nazionale mo la forza dissolvitrice della conoscenza: poiché, mio Fedro, la conoscenza non possiede dignità né rigore; è consapevole, comprensiva, clemente, priva di riserbo e di forma; ha simpatia per l’abisso, è l’abisso medesimo. Noi dunque la ripudiamo energicamente, e da questo momento ogni nostro studio avrà di mira la bellezza, ossia la semplicità, la grandezza e il nuovo vigore, la rinnovata spontaneità, la forma. Ma forma e spontaneità, mio Fedro, conducono al desiderio delirante, facilmente portano il nobile animo a orribili colpe sentimentali, che a lui stesso, nel suo armonioso rigore, appariranno infami; portano, insomma, anch’esse all’abisso. Vi portano, intendimi bene, noi poeti: perché a noi non è dato elevarci, è dato soltanto imbestiarci. E ora, Fedro, io me ne andrò e tu rimarrai qui; e aspetta di non vedermi più, per andartene.” Thomas Mann, La morte a Venezia amoroso, il tuo amore che m’arde mi dà un tale tormento che il suo fuoco avrei spento col mio mare di lacrime. P. DE MARBEUF, “Amore amaro”, in Le miracle d’amour, a cura di M. Lever, Obsidiane, s.i.l. 1983. un'indifferenza che rasenta la crudeltà, inaspettatamente tronca la relazione. Giovanni, allora, con il cuore dilaniato, incapace di convivere con il dolore e di gestire la sua vita dopo il rifiuto, cade in uno stato di cupa depressione che, nonostante le cure del suo medico, lo conduce alla morte. Eppure... Eppure, Sara non è una donna perfida, che si diverte a fare del male senza una ragione. In realtà è lei stessa un'anima graffiata, che non ha ricevuto mai amore sin da quando era bambina, e dunque non solo non è capace di amare, ma si è convinta che l'amore non esista. Quando capisce che Giovanni vuole con lei un legame vero e completo, ella si spaventa e lo abbandona. Sara ha paura di confrontarsi con gli altri, ha paura d'amare perché ha paura di soffrire, e così maltratta i suoi uomini prima che questi maltrattino lei. Nasconde l'anima perché è incapace di mettersi in gioco, perché cerca di difendersi; il suo vuoto di affettività le ha fatto credere di poter fare a meno dell'amore, e quando si accorge che questo suo ennesimo rapporto superficiale rischia di tramutarsi in qualcosa di più importante, fugge spaventata. Soltanto quando Giovanni non c'è più, Sara si accorge del suo errore e capisce di aver imparato ad amarlo, di avere bisogno di lui; ma ormai è troppo tardi. I ricordi, i rimorsi, una dolce e leggera follia si insinuano lentamente nella donna, che mette fine alla propria esistenza affinché il loro amore possa continuare per sempre in un'altra dimensione. Un amore che ha corroso due vite, che ha annientato due anime. Silvia Camicia N. 2 Febbraio/Marzo 2004 7 Allegato al n. 2 de L’Orioli Periodico di cultura, costume e società Xenia Perchè gli “Xenia” sono soprattutto un colloquio, un tenerissimo racconto a due voci. Palmo su palmo palmo contro palmo e le dita intrecciate per ancorarsi al suolo a questo silenzio di odori, di pelle di gocce clandestine perché il vento che è più grande di noi non ci porti via a questi istanti per farci appartenere all’universo che su di noi in questo momento vigila e si compiace attento. FERNANDO RIGON, “Rima baciata”, in Dimore, Einaudi, Torino, 1989. LA Quando si parla troppo L’amante ostinato Giorno dopo giorno invecchio, e non sono più saggio dell’anno passato. Un altro si lagnerebbe della propria sorte e si darebbe molto degni consigli. Ma io non ho per me che consigli cattivi. Del resto so assai bene ciò che m’ha nociuto: che non le ho mai nascosto il mio tormento. Gliene ho parlato tanto e tanto che non vuole più ascoltarmi. Ora me ne sto zitto e m’inchino davanti a lei. In fondo ai flutti posa una perla bianca. Il vento può soffiare, il mare scatenare la sua furia, non avrò requie finché non l’avrò presa. REINMAR VOV HAGENAU, “Quando si parla troppo“, in Chants d’amour, trad. di B.Weis, Arfuyen, Paris, 1990. ANONIMO GIAPPONESE, “L’amante ostinato”, in Anthologie de la poésie japonaise classique. Le foglie morte ... Ma la vita separa chi si ama piano piano senza nessun rumore e il mare cancella sulla sabbia i passi degli amanti divisi. Jacques Prévert (Venezia, Marsilio, 2002, pp. 117-9) L a polarizzazione dimensionale è stata spesso considerata, a ragione, una delle caratteristiche fondamentali del panorama industriale italiano. Il quale appariva quindi costituito, per un verso, da poche grandi imprese, pubbliche e private, operanti in settori ad alta intensità di capitale, e per l’altro da un gran numero di piccole aziende, in molti casi piccolissime, labour intensive, attive soprattutto nei comparti tradizionali e legate a circuiti locali di formazione, reddito, risparmio e consumo. In un contesto così delineato, era però quasi inevitabile che si tendesse a trascurare la presenza e il ruolo delle medie imprese. Con Il quarto capitalismo – un’espressione coniata da Giuseppe Turani per distinguere tali aziende dalle grandi nonché dalle microimprese dei distretti, la cosiddetta “Terza Italia” – Andrea Colli intende invece analizzare lo sviluppo di un universo, quello del Mittelstand italiano, che appare in condizione di fornire risultati eccellenti in termini di produttività, valore aggiunto e redditività complessiva. Utilizzando il metodo della business history, egli ha pertanto preso le mosse dall’esame delle varie vicende aziendali, le ha messe a confronto, ed è riuscito poi a ricavare alcuni tratti comuni di un processo di considerevole crescita. È uno sviluppo che sembra aver tratto beneficio sia dalle difficoltà in cui versavano le grandi imprese attorno alla fine degli anni Ottanta, sia dall’avvento delle privatizzazioni in seguito alla crisi della finanza pubblica. Le dismissioni delle holding di Stato avrebbero consentito a molte imprese di dimensioni non grandi, ma neanche trascurabili, di conoscere e assorbire delle pratiche gestionali moderne. Afferma in proposito Colli: “Se da un lato è innegabile che le proiezioni di carattere internazionale siano andate progressivamente, e in particolare nel corso degli ultimi due decenni, svincolandosi dalle dimensioni d’impresa – per cui è proprio dai segmenti dimensionali minori ma anche dalle agglomerazioni distrettuali che sono giunti i contributi più dinamici al processo di espansione sui mercati esteri dell’industria italiana, anche in termini di investimenti diretti – è altrettanto vero che tale sviluppo va ad esaltare il ruolo degli attori dotati di una N. 2 Febbraio/Marzo 2004 IL MOTIVO DI UN SOSTEGNO “Una vita senza amore è come gli alberi senza fiori e senza frutti. E un amore senza bellezza è come i fiori senza profumo” (Kahlil Gibran): le parole del poeta, scrittore e pittore libanese sono perfette per introdurre il tema a cui il secondo numero de L’Orioli dedica il suo speciale, l’amore. Questa scintilla della vita, infatti, motore del mondo, ispiratore di ogni azione, nella storia del pensiero dell’uomo non è mai apparso disgiunto dal concetto di bellezza: già Platone, ad esempio, afferma tra l’altro nel Convito che “l’amore è l’attrazione esercitata dalla bellezza”, che “esso nasce a contatto della bellezza sensibile”; e sempre, dall’età classica in poi, Eros (egli stesso fanciullo incantevole) è stato raffigurato nelle opere dell’arte e della letteratura in compagnia di Afrodite, la dea della bellezza e dell’armonia, della quale molto spesso viene addirittura indicato come figlio. Ecco allora perché abbiamo accolto con gioia la proposta della Dolomia di sostenere attivamente la nostra associazione; nulla ci è sembrato più appropriato che avere come sponsor un’azienda che ha fatto della bellezza e dell’amore per il corpo la sua filosofia. PROSSIMAMENTE A TEATRO RECENSIONE Andrea Colli, Il quarto capitalismo. Un profilo italiano 8 Febbraio/Marzo 2004 minima massa critica, in grado di agire con successo avviando percorsi di crescita svincolati dai tradizionali modelli di fabbrica integrata”. Ecco dunque emergere, nel corso degli anni Novanta, un consistente numero di imprese dalle dimensioni medio grandi, presenti sui mercati internazionali sia attraverso una rete commerciale sia mediante acquisizioni di unità produttive, e organizzate in forma di gruppo, con una holding a proprietà familiare che è a capo di un ampio ventaglio di aziende. Ma cosa si intende per media industria? Colli prende in esame circa 350 gruppi industriali a controllo italiano, ciascuno dei quali impiega almeno 500 addetti e totalizza un fatturato netto consolidato non superiore a 1,5 miliardi di Euro. Si tratta di gruppi che, alla fine dello scorso decennio, realizzavano circa il 30% del fatturato delle principali società industriali rilevate da Mediobanca, occupando il 40% dei loro dipendenti. Sotto l’aspetto della distribuzione settoriale, occorre aggiungere che i comparti maggiormente rappresentati sono quelli ad alta intensità di lavoro ed elevata specializzazione: per esempio il settore meccanico, con la produzione di beni strumentali e di macchine utensili, l’edilizio, l’alimentare, il tessile e dell’abbigliamento. Riguardo infine alla collocazione geografica, sembra che la stragrande maggioranza delle imprese considerate affondi le proprie radici nei sistemi locali e nei distretti, ma anche nelle aree a più antica industrializzazione. Il Mezzogiorno appare invece sostanzialmente estraneo a questa ondata di sviluppo. I gruppi hanno sovente avuto origine da piccole aziende che, negli ultimi decenni, hanno dimostrato la capacità di adattarsi rapidamente all’evoluzione sia qualitativa che quantitativa della domanda, dando luogo al consolidamento e alla successiva espansione, soprattutto all’estero. Le iniziative imprenditoriali sono dunque andate a soddisfare solo dei segmenti di domanda, magari in vorticosa crescita. Non si è quindi trattato di produzioni di massa, ma estremamente specializzate (le lavatrici nel caso della Candy, o i televisori in quello della Mivar), e realizzate in maniera flessibile grazie al terzismo e al decentramento. Va pure rilevato che, a partire dagli anni Sessanta, le medie imprese hanno realizzato acquisizioni sia per li- nee orizzontali – cioè in settori contigui – sia verticali: nel tessile, ad esempio, è stata frequente l’integrazione a monte attraverso l’acquisto di quote maggioritarie in aziende produttrici di macchine utensili, o fornitrici di materie prime. Si sono così formati dei gruppi assai concentrati sulla propria attività fondamentale, composti da unità operative che godono di un certo grado di autonomia. Altri hanno invece mostrato una spiccata tendenza alla diversificazione. L’aspetto forse più interessante del “quarto capitalismo” è però la sua proiezione internazionale, che si manifesta in particolare sotto due profili: l’elevata incidenza delle esportazioni sul fatturato e, come già accennato, la costituzione all’estero non solo di reti commerciali ma anche di complessi produttivi. Sono infatti molti i gruppi che realizzano oltre confine più della metà delle proprie vendite, mentre per alcuni di essi le esportazioni arrivano a rappresentare i quattro quinti del fatturato. Tuttavia, anche se internazionalizzati, i gruppi continuano ad avere rapporti assai stretti con le istituzioni bancarie locali, visto che tendono a non chiedere risorse né al mercato obbligazionario né a quello azionario: d’altra parte, l’elevata redditività consente alla stragrande maggioranza delle medie imprese di evitare forme di finanziamento eccessivamente onerose. Per concludere, alla decadenza dell’impresa pubblica e al parziale ridimensionamento degli esponenti tradizionali del capitalismo italiano ha corrisposto una notevole trasformazione dei distretti, orientati a seguire la strada della presenza sui mercati mondiali mediante lo strumento del gruppo gerarchizzato. Sono questi i protagonisti che sono andati emergendo, nell’ultimo quarto di secolo, sulla scena economica italiana, e che Colli considera “una nuova, ennesima concretizzazione del modello industriale italiano, in grado di adeguarsi alle trasformazioni e ai cambiamenti imposti dalla fase di internazionalizzazione dei mercati e di globalizzazione delle produzioni”. Ci chiediamo tuttavia se il “quarto capitalismo” sia in grado di contrastare efficacemente anche il declino industriale del nostro Paese, che non ha più un comparto informatico, vede la chimica e la farmaceutica relegate in un ruolo marginale e registra un aumento costante della propria dipendenza energetica. Se dunque il successo della media impresa attesta da un lato la vitalità del capitalismo italiano, esso ne conferma dall’altro la collocazione nei settori maturi del sistema economico mondiale, nei quali si fa sempre più minacciosa la concorrenza di nazioni che riescono a raggiungere degli standard qualitativi accettabili, potendo però contare su un costo del lavoro assai più basso del nostro. Enrico Paventi L a storia. 1968: poco più che tredicenne Oliviero Piacenti abbozzò la sceneggiature di un film, Il vento del Nord, e insieme al suo amico di sempre Antonio Maria Frascarelli (Tonino) coniò il nome di una ipotetica casa di produzione: la EuroSperimentalFilm. Muniti di una cinepresa 8mm appartenente al padre di Tonino, e di un traballante treppiede, i due iniziarono a lavorare coinvolgendo un gruppo di coetanei alla realizzazione del film. Ogni bobina di pellicola da impressionare durava circa tre minuti e aveva un costo tra le 2500/3000 lire, un prezzo altissimo se si pensa che un litro di benzina costava all'epoca 100 lire. La "produzione" ebbe delle grosse pause di lavorazione perché occorreva reperire i fondi necessari per l'acquisto della materia prima. Così i mesi e gli anni passavano inesorabili fino a quando nel 1971 un giovane laureato, Zefferino Cerquaglia, venne a conoscenza della loro impresa; aveva ottenuto da poco un posto di insegnante in UN Sardegna e, interessatosi al progetto, decise di aiutarli inviando ogni mese 5000 lire. Questo insperato aiuto permise loro di finire le riprese e giungere alla proiezione del film nel 1973. Il vento del Nord aveva una durata di un ora e quindici minuti e venne proiettato al Teatro Sociale di Avigliano Umbro dove ottenne un notevole successo di pubblico e di critica. Seguirono altri lungometraggi, questa volta in S8: Pensavo a noi due (1974), Storia di un autonomia (1974), Io cittadino italiano (1975), TG1 - TG2 - TG speciale (1976), A.A.A. Assassino cercasi (1977). Con l'avvento del SVHS nacquero Rural Comics (1988), La vera storia di Sir Lancillotto del Lago (1992) e i documentari Te lo do io il Venezuela (1989), Paris (1992), Otto giorni dall'Est all'Ovest (1993), Un caliente viaje por la Espania (1994), Praga (1995), Laghi città monti e valli d'Italia (1996), Fino alla grande diga (1997); gli spot pubblicitari Erboristeria Monterotondo (1992), Distributori Automatici Illy Caffè - D.A.C. (1997); le videoclip del 1992: Pellicceria Elisa, Sartoria Pozzi, Maglieria Novella, Lingeria Gil'Asso; il back stage per il calendario Rimembranze 1993; ed infine le parodie di films Robin Hood al castello di Sismano (2000) e Casablanca secondo noi (2002). Dopo sette anni di pausa la ESF un sogno mai dimenticato, ha ripreso vita grazie a Paola Contili, che insieme ad Oliviero Piacenti è stata promotrice del nuovo gruppo di appassionati di arte e cultura cinematografica che ha come scopo quello di realizzare produzioni video e cinematografiche privilegiando soggetti di autori umbri girati sul territorio; entrambi sono direttori di tutto il progetto dal 1999. RICORDO Riflessioni in posa poetica di Maria Cristina Bigarelli La nostra Africa L’Africa che conosco è quella che respiro senza sentirne il sole cocente sulla pelle, è quella che emana odori sottili e gradevoli senza che io ne assorba le impurità. La nostra Africa non è solo il penetrante linguaggio dei tam-tam, è quella che suscita la magica illusione dello scorrere dell’acqua dei maestosi fiumi plastici e dei mille luccichii senza correre il rischio di inzupparsi le membra. La nostra Africa è quella delle forti sensazioni, dei misteriosi rumori, dei mille colori della foresta, del fruscio dell’immenso cupo mare verde, dell’orchestra gaia, varia, insidiosa, letale, infinita della fauna tropicale che scuote le orecchie. La nostra Africa è quella degli Yoruba, degli Ibo, degli Hausa, dei Fulani che nelle loro ricchezze tribali e nelle loro leggi semplici, vivaci, rigorose, severe, nel contempo crudeli, ma estremamente vere, ci insegna ad amare, è quella che ci rende cittadini di un mondo che in realtà ci appartiene, e che ci fa soffrire ed anche gioire, che ci rattrista e ci esalta, che ci separa per poi stringerci tutti come uniti da uno splendido anello d’avorio sottile ma resistente e pregiato. RIFLESSI D’ARTE RIFLESSI D’ARTE Emilio Troncarelli di Nicola Piermartini Bernd Rosenheim A lla ricerca di echi del passato, di atmosfere colte in condizioni particolari d’animo e di luce, di dimensioni forse sognate, ammirando le opere pittoriche di una mostra. Gli acquerelli e gli oli di Emilio Troncarelli stimolano quella ricerca, che in fondo è un viaggio interminabile nei territori delle proprie esperienze, della propria sensibilità, del desiderio - forse mai affiorato nitidamente - di varcare le soglie del reale. Nonostante l’impianto dei quadri sia figurativo, l’atmosfera che li anima, però, è quasi atemporale. Una luce ovattata, discreta, crepuscolare a volte, avvolge e lega i primi piani alle diverse lontananze: tutto sembra sul punto di mutare, di annullarsi nell’ombra, o di incendiarsi nella luce. Le nature morte travalicano la pura rappresentazione: comunicano atmosfere metafisiche, nelle quali gli oggetti esprimono la propria quotidianità ma assurgono, nel contempo, a modelli universali. Pur collocabili in una spazialità definita, in uno spazio cioè chiaramente individuabile, un frutto, un vaso, una pianta diventano attori di un momento unico, irripetibi- le, senza dimensioni spaziali e temporali. Nature morte, quindi, che sono illuminazioni improvvise dell’anima, più che fenomeni ingadati dagli occhi, sia per l’essenzialità dei volumi e della composizione, sia per la luminosità della pennellata. I brani del paesaggio romano assumono caratteristiche particolari se impreziositi dall’olio, o se centellinati dagli acquerelli. In questi ultimi dominano cupole eteree, veleggianti nell’infinito, al di sopra della quotidianità; non si scorge figura umana, ma le mura e i tetti sono vivi: trasmettono i fremiti di un’attività instancabile con la contrapposizione, la variazione, il dialogo di colori e toni. In splendido isolamento si stagliano monumenti conosciuti universalmente. Gli oli sono più intimi; gli elementi del paesaggio bisbigliano, a volte nella penombra, a volte nella luce mattutina, a volte in quella pomeridiana, sempre però interpretati dall’originale sentire del pittore. Ponti, cupole, monumenti, case: il respiro dell’antico e i segni del presente si legano in maniera nuova, inusitata, nelle opere di Troncarelli, generando emozioni particolari. Le evoluzioni delle pennellate sono sempre guidate dagli intenti espressivi. Il mondo pittorico di Eraldo Bigarelli di Claudio Strinati B igarelli è un uomo che ha visto molto e ha molto viaggiato. La sua attività gli ha permesso di conoscere realtà remote rispetto alla nostra, situazioni diverse, retaggi di civiltà multiformi. Ma il pittore Bigarelli è piuttosto colui che mira a descrivere una grande “galleria” di personaggi, come accadeva un tempo quando i pittori antichi costituivano delle “serie” di tele rievocanti una famiglia nobiliare o la storia di un ordine religioso . E’ una forma moderna e del tutto insolita di “rappresentazione storica”, riproducente un ideale visivo che l’artista si è portato e si porta dietro ormai da molti anni di ricerca continua e coerente. Lavora con passione e con singolare capacità produttiva, in un esercizio continuo della mano che potrebbe sorprendere in tempi come i nostri, dediti a ben scarsa attenzione per il momento tecnico nel campo figurativo. Ma è stretto il rapporto che c’è nell’artista tra l’amore dell’arte in sé e il senso di dignità etica che egli conferisce alle sue immagini. Il suo occhio è ravvicinato e partecipe, sente con intima partecipazione e, si può dire, ben poco condi- zionato dal peso delle tradizioni pittoriche che lo hanno preceduto. Il suo è un rapporto immediato, dal punto di vista della sensibilità emotiva, con la materia pittorica e non ha bisogno di particolari supporti storiografici per essere compreso e apprezzato. Il mondo pittorico di Bigarelli nasce e si sviluppa integralmente nella fantasia dell’artista, una fantasia tutt’altro che aliena da suggestioni culturali ma determinata da un approccio quasi magico e meditativo con le figure che si accinge a rappresentare. Non si saprebbe se sia più giusto riferirsi a quel concetto di “conoscenza” interiore che anima tutte le cose e le trasfigura nell’immagine pittorica o piuttosto a quello di adesione a una realtà sentita senza alcun intellettualismo e quindi propria, nel senso più intimo del termine. Certo è che dalla visione dei lavori di Bigarelli si ricava una compattezza e una unitarietà di intenti degna di segnalazione nel panorama artistico dell’Italia contemporanea ed è da augurarsi che alla sua opera possano accostarsi con interesse soprattutto i giovani che sono alla ricerca di prospettive estetiche di contenuto e di rispetto per il mestiere stesso dell’arte. N on è facile inquadrare questo eclettico artista dai molteplici interessi. È scultore, pittore, grafico, architetto, cineasta, poeta, saggista impegnato. Che egli abbia una cultura a tutto campo lo dimostrano i suoi studi, le ricerche, le opere, i libri e i telefilm dai quali traspare l’ammirazione per la cultura orientale, in particolare quella indiana e soprattutto cinese. Però influenze non ce ne sono. Possono affacciarsi solo approcci, e vanno lontano. Vanno all’arte cinese e alle collezioni grafiche di poesie cinesi. Qualcosa va anche all’antica arte egizia, indiana, azteca; qualcosa sembra - all’Ordine dei Cavalieri Teutonici, alle loro favolose armature, teste immense in quegli elmi a gorgiera “a profilo”. Maschere? Teste metafisiche. Il segno, oggi, della plastica multimaterica dell’artista. Bernd Rosenheim nasce a Offenbach nel 1931 e qui inizia gli studi alla Kunstschule, studi conclusi alla Städelhochschule della vicina Francoforte sul Meno. Attualmente ha tre case-laboratorio: a Michelstadt, a Offenbach e in Irlanda, a Kenmare. Qui, in particolare, lo studio è attrezzato per la produzione di grandi sculture di acciaio inossidabile. Fa tutto lui, progetto e manualità. Rosenheim ha lavorato anche a Roma, città di cui è innamorato. Parla benissimo l’italiano. Preso dalle tinte di Roma, dell’Appia antica, negli anni dal 1958 al 1961 dipinge molto, ma il colore predomina talmente sulla forma che a un certo punto sparisce, ovvero è tutto colore. A seguito di un incidente - degente ingessato per lunghi mesi - ha una pausa. Poi torna ai pennelli, ma non c’è più il gran colore; ci sono il bianco e il nero, e un terzo elemento: la luce. Ecco la vibrazione. La luce è inclusa nella forma, è la forza concettuale della forma, anzi della Gestaldt che è qualcosa di più della semplice forma. Infatti le opere di questo periodo sono tutt’altro che prive di contenuto, perché quelle forme astratte il contenuto ce l’hanno, almeno così dicono i titoli. Spesso appare un segno criptico, una gran virgola, un becco, un segno appunto. A Rosenheim non interressano i contenuti ideologici, ma la Gestaltung, la forma in sé, e il Kunstbetrieb, l’esercizio dell’arte, la manualità. L’artista tende allo spazio, pittura e scultura, tende alla terza dimensione, alla ricerca della materia, all’unione dei tre elementi spazio-luce-vibrazione. Arriva allora l’acciaio inossidabile, che secondo lui cattura la luce. Rosenheim entra anche nell’arte integrata, progetta complessi architettonici, alcuni anche utopici, ma l’utopia altro non è che un irraggiungibile traguardo. Un fine che non c’è mai. Nel 1970 Rosenheim crea, e allestisce con le sue mani, una grande struttura sferica tubolare del diametro di cinque metri, che è una trasparente, intricata ma geometrica composizione di tubi e tubicini di acciaio inossidabile in parte saldati e in parte imbullonati. Lavoro da ingegnere, esibizione tecnologica, ma pur sempre opera d’arte. Per la città natale di Offenbach compone nel 1971 una struttura di acciaio inossidabile di 4,5 metri: lamiera saldata, una forma in equilibrio su un punto, che non titola, ma che i concittadini battezzano “Flamme”. E fiamma rimane. Da allora si susseguono numerose grandi sculture di acciaio inossidabile. C’è però, in tempi recenti, anche un approccio all’arte antica, alla mitologia. Rosenheim si mette al di fuori della propria cultura. È un punto - dice - come il punto di Archimede, al di là della leva. L’incontro con l’acciaio inossidabile apre una ricca stagione di scultura monumentale. C’è sempre il “segno” dell’artista, e c’è un’allitterazione del segno in quelle sculture lamellari stratificate. Dopo il 1983 lo scultore trascura l’acciaio per introdurre nuovi materiali, specialmente legno, bronzo, leghe, cuoio, pelle. In certi casi distende il colore e al di sopra dipinge a tempera e grafite. Dall’astratto e dall’astrazione Rosenheim si inoltra nel surreale. Probabilmente memorie affondate nel surreale che in questi anni emergono dall’inconscio. C’è un occhio allucinato che esce dalle tenebre del ricordo e affiora in molte composizioni di questo periodo. Talvolta i calligrammi sono i segni, quasi arabeschi, che sulla tela portano i versi dell’artista. Potrebbero essere opere finite, ma si sublimano. In questa atmosfera, dopo “Testa di Sfinge” del 1991, è importante l’opera polimaterica “L’Ombra del Samurai”, che egli chiama impropriamente installazione ma che tale non è nel senso di collocamento in un sito di pezzi o frammenti più o meno banali. È invece una poetica opera pittoscultorea che si presenta come una specie di collage a distacco, come un trittico parte in seconda e parte in terza dimensione, nel quale la scultura esce dal piano dipinto. Sono i calligrammi, i versi di Rosenheim, e su di essi grava un’ombra che non è propriamente l’ombra del soggetto, ma una stele, il trascendente Samurai. Non è un’ombra reale, è un’ombra virtuale. Oltre a essere un autentico artista, Rosenheim è un autentico, candido operatore artistico. Ama l’arte ma sa che essa è un mondo troppo chiuso in se stesso. Lo controllano i critici, i galleristi, i direttori dei musei, coloro che comprano influenzando il mercato. Se non riesce a entrare nella gilda, l’artista viene buon ultimo. Nell’ottica di questi rigetto della corporazione, Rosenheim che di per sé non ha problemi di mercato - si inoltra sulla pericolosa strada delle fondazioni. A Francoforte istituisce generosamente una fondazione per la valorizzazione dei giovani nel campo del disegno, della pittura e della scultura. Nell’ambito della fondazione comincia ad assegnare un premio per la pittura e pubblica il catalogo dei premiati. Immerso in tali meritevoli attività, ha poco tempo per il resto; ma poi riesce a tornare alla scultura, con la grande “Sfinge” di acciaio inossidabile situata a Grosswangen, Lucerna. L’opera monumentale (5x2,30x2 metri) sorge ora sul lato della strada statale davanti all’Officina Held (tecniche laser). Im- di Alessandro G. Amoroso pressionante l’installazione, avvenuta in pochi minuti. I tecnici della Held avevano preparato nel prato il basamento su adeguate fondazioni: una semplice lamiera di acciaio inossidabile con quattro fori agli angoli. La “Sfinge” attendeva su un autocarro, coperta da un telone. Al via una gru altissima l’ha sollevata contro il cielo e l’ha abbassata rapidamente con precisione sopra il basamento. Quattro bulloni agli angoli e tutto era fatto. L’opera è stata creata e realizzata con fatica interamente dall’artista stesso. La lamiera piegata a freddo sull’incudine, lentamente: un lavoro da fabbro, da calderaio. Un lavoro anche da saldatore, effettuato con bacchette Tig. Creatività e manualità. Kunstberieb. Ovviamente Rosenheim è orgoglioso anche di questa sua raffinata manualità. Rondò apocalittico Il Cielo però è vuoto Ed è un grande specchio Nel quale si specchiano le paure degli uomini Lo specchio restituisce a loro Le immagini dei loro pensieri E gli uomini si piegarono Di fronte alle loro proprie immagini Si prostrarono E le implorarono Ed egli parlò: “Non dovete crearvi idoli, Né immagini, né colonne, Né pietre dipinte nel vostro paese, Davanti a cui pregare”. Non lo ascoltarono Perché era morto già da lungo tempo. Invece diedero un nome a quelle figure Le richiamarono alla vita E conferirono loro potere Ed esse dominarono Gli uomini E le creature degli uomini Mandarono a loro piaghe di ogni genere Sotto varia forma Visibili e invisibili Così che i popoli videro la fine dei tempi. Delle piaghe le più temibili Sono le invisibili. Arrivano sulla Terra Simili a un’invasione di cavallette E il loro numero è uguale ai granelli di sabbia In riva al mare E le cavallette sono simili a cavalli Bardati per la guerra E sul loro capo ci sono corone Simili all’oro E il loro volto è simile a quello umano. E hanno corazze come carrarmati di ferro, E il fragore delle loro ali È come il fragore dei carri trainati da tanti cavalli Lanciati alla guerra. E hanno code come gli scorpioni E aculei ... E in quei giorni gli uomini Cercheranno la morte E non la troveranno, Desidereranno morire E la morte li sfuggirà Ma il cielo sarà vuoto Come un grande specchio ... Bernd Rosenheim N. 2 Febbraio/Marzo 2004 9 DENTRO L’OPERA D’ARTE Eugenio Montale L’arcano della melanconia di Nicola Piermartini M elanconia. Etimologicamente: nera bile, ossia umore nero. Uno stato d’animo che vive di silenzi, di solitudine, di penombre ed ombre. “Melanconia” è scritto sul piedistallo di una statua al centro di un quadro, dal titolo omonimo, di Giorgio De Chirico. Dipinto nel 1912, fu esposto per la prima volta a Bruxelles nel 1934, in occasione della mostra “Minotaure”. L’invenzione del pictor optimus è magnetica, ammaliante. L’osservatore sensibile è calamitato nel quadro: calca l’infinita distesa verde dell’erba, curatissima, con passi incomprensibilmente esitanti; si smarrisce, si stordisce, sovrastato dagli ieratici portici incombenti; volge le spalle alla luce radente mattutina, accecante, che lancia ombre lunghissime e vibranti; si avvicina con l’animo sospeso alla figura femminile marmorea distesa mollemente: l’espressione del volto, con le palpebre abbassate e la testa reclinata su una mano, le membra possenti, opulente, le pieghe sontuose del panneggio ric- chissimo comunicano abbandono e maestosità nel contempo. Forse l’ombra in basso a sinistra appartiene ad ogni ipotetico osservatore, forse no: un pilastro cela l’identità di chi origina quell’ombra: un mistero nel mistero. Il cielo terso e la distesa di monti lontanissimi sono esclusi da quel mondo circoscritto e immenso insieme: mondo di pietra, nel quale la presenza umana è ospite, tollerata, transitoria. Anche se l’uomo lo ha costruito. Una sorta di ribellione della creatura contro l’artefice. I palazzi con portici debordano dal quadro. Non c’è, però, curiosità di conoscere dove e come essi si risolvano. Tutto è compiuto, concluso in quell’ambientazione: perfezione computerizzata, scaturita dalla mente di un demiurgo, che ha voluto, più o meno consapevolmente, stupire e atterrire l’umanità. Umanità, esemplata in due figure lontane: ombre nel controluce, ombre su ombre, delle quali non si scorgono lineamenti ed espressioni. Nei loro atteggiamenti si leggono titubanza, sottomissione, ma anche attrazione irresistibile verso la fonte della Melanconia. Si avvicinano lentamente a quella fonte: forse per sapere, forse per rendere omaggio, forse per annullarsi. E lei, nell’impassibilità e nella grazia ellenistiche, è il cuore pulsante di quel microcosmo: cuore di roccia viva, ora forse insensibile, malato incurabilmente della Melanconia di chi ha visto, e sofferto, gli splendori e i declini di tante civiltà. TEATRO Lo Zoo crudele di Macbeth I l Macbeth è uno zoo? così pensa Daniele Scattina, giovane allievo di Leo de Berardinis: gufo, falco, nottola, gazza, corvo, pipistrello, topo, serpente, biscia, istrice, rospo, ranocchia, ramarro, lucertola, capra, capriolo, tigre, pantera, leone e così via. Sono solo alcuni degli animali evocati nel dramma di Shakespeare. Sembra motivato, pertanto, il titolo dato allo spettacolo: “L’animalità di Macbeth”. Ma l’animalità è del personaggio o del dramma? Sulla scena non si risponde a questa domanda. Ciò che il Bardo denuncia è la vanità della violenza e la lotta per il potere - si sa. La vita è un’ora di recita insensata, futile e cruenta. Nel Macbeth non si parla della crudeltà, che è scontata, ma della grandezza del male. Scattina ha scelto la traduzione di Salvatore Quasimodo: un capolavoro in una lingua viva e pungente che fomenta buone prove d’attore. Il regista ha sfrondato e interpolato il testo e definisce il suo laoro “d’avanguardia”. Un pò frettolosamente, credo. La sua lettura non è avanguardistica, ma classica: riporta in auge l’aura novecentesca di lady Macbeth (Danila Bellino è una vera scoperta) rendendola motore della tragedia. L’interpretazione “classica” l’ORIOLI PERIODICO DI CULTURA, COSTUME E SOCIETÀ Anno 1 - N. 2 Febbraio/Marzo 2004 Iscritto al tribunale di Viterbo al N. 513 del Registro Stampa con decreto del 7-2-2003 Sede Via Gramsci 11 - 01030 Vallerano (VT) Sede amministrativa “Francesco Orioli” (associazione culturale europea onlus) editing: Via Gramsci 11 - Vallerano (VT) CF 90055020565 www.orioli.it E-mail: [email protected] E-mail:[email protected] Consiglio di amministrazione Ludovico Pacelli presidente Vittorio Arista vicepresidente Nicola Piermartini direttore responsabile Progetto grafico Rosanna Cori Hanno collaborato Francesca Rossi, Filippo Sallusto, Mario Mariani, Miriam Nori, Sandro Piccioni, Silvia Camicia, Vittorio Arista, Franco Lanza, Enrico Paventi, Stefania Iurescia 10 N. 2 Febbraio/Marzo 2004 prosegue nella malinconia conferita ai ruoli principali, in particolare Banquo, già un’ombra prima di diventarlo effettivamente (l’ottimo Marco di Campli San Vito). E le streghe, vera invenzione, a metà sospese fra Tim Burton e il Rocky Horror Picture Show, fluttuano nel buio, lacerano di suoni e voci le tentazioni degli ambiziosi (sono Rita Gianini, Alesssandra Dell’Atti e Manuela Di Salvia). Godibili gli inserimenti di Vasco Montez e ben calibrati anche gli altri. Daniele Scattina come interprete sconta un pò il doppio lavoro (meglio il regista). Ma questo bello spettacolo sempre coinvolgente scivola verso una meta con coerenza e una disperata maieutica, credo non involontaria: la progressiva distruzione della virilità di Macbeth da parte della lady, l’irrisione costante e silenziosa dell’uomo infecondo, ispiratrice di sangue e follia, come se la cieca violenza predatoria fosse una rimozione sessuale, o addirittura - sembra - un atto non compiuto. L’allestimento del Teatro delle Ombre è coaduivato da opportune scelte musicali (da Stockhausen a Arvo Part) di Giandomenico Finamore. Luca Archibugi Associazione culturale europea “Francesco Orioli” ONLUS Assessorato alla Cultura del Comune di Vallerano Compagnia Teatro delle Ombre associazione culturale presentano Spesso il male di vivere ho incontrato di Nicola Piermartini Spesso il male di vivere ho incontrato: era il rivo strozzato che gorgoglia, era l’incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza: era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, [e il falco alto levato. Il male di vivere: un argomento che fa da sottofondo a tante liriche di Eugenio Montale (1896-1981), premio Nobel per la letteratura nel 1975. Il male di vivere: un sentimento, una miscela di sentimenti, che, seppure mai nitidamente connotato, getta una colorazione particolare su ogni azione umana e, naturalmente nel caso di Montale, sull’espressione poetica. Sentimento, stato d’animo, angoscia indistinta, che è esemplificata in frammenti di realtà nella lirica “Spesso il male di vivere ho incontrato”. Sette endecasillabi e un doppio settenario di chiusura: una breve, incalzante, fragorosa cascata di versi, che svela, però, un panorama culturale e umano amplissimo. I palpiti di sofferenza interminabile, spossante, del “rivo strozzato che gorgoglia”, seppure riscontrabili realisticamente in tante laude del mondo, non possono non richiamare alla mente e al cuore le pene, interminabili, disumane, di tanta parte d’umanità, che, in silenzio spesso recita il rosario tristissimo di giorni, mesi, anni, sostenuta soltanto da un inesausto istinto di sopravvivenza. Naturalisticamente, ne “l’incartocciarsi della foglia riarsa” sono avvertiti distintamente gli spasimi, gli scricchiolii, i gemiti, il frangersi inarrestabile, sadico, impetuoso, insensibile, dell’anima, di un miracolo del creato, che aveva affidato al vento, all’infinito, il suo canto d’amore, di giovinezza, di felicità traboccante. A questo riguardo, la cronaca quotidiana offre una serie interminabile di esempi di anime belle e entusiaste seviziate, demolite internamente dagli accidenti più diversi. Come la superba, apollinea vitalità prostrata del “cavallo stramazzato”. L’immagine della “statua nella sonnolenza del meriggio” rimanda prepotentemente alle atmosfere sospese, dense di mistero delle “Piazze d’Italia” di Giorgio De Chirico. Piazze spesso sorvegliate da capolavori della statuaria greca classica o ellenistica, che assumono il ruolo di numi tutelari dei luoghi o di presenze evocatrici, ammonitrici, che il decadente riverbero meridiano rende ancora più ammantate di fascino. Presenze inquietanti: aggettivo, che riconduce a un celeberrimo dipinto di De Chirico, “Le muse inquietanti” del 1917-1918, che sussurrano in maniera tragicamente chiara, comprensibile, di splendori tramontati, di età dell’oro cancellate dal tempo, di fremiti commossi di un’umanità ingenua, ottimista, sgretolati e precipitati nell’oblio. Nel verso di chiusura, lo sguardo e l’anelito del poeta sono rapiti in alto, verso l’irraggiungibilità delle nuvole, del falco, dei dominatori dell’aria, così lontani eppure così fragili; manifestazioni di istanti eternamente, incessantemente, mutevoli. Personificazioni del male di vivere; incisioni ermetiche, nelle quali, in pochi attimi di riflessione, è possibile ritrovare le immagini di tante angosce oscure, mai analizzate, mai fatte affiorare dall’inconscio. Per chi apprezza i nostri sforzi Agevolazioni fiscali Le persone fisiche possono: Detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle ONLUS fino ad un massimo di 2065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86). Le imprese possono: Dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 65, comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 917/86). L’ASSOCIAZIONE L’ I.a STREGA II.a STREGA III.a STREGA DUNCAN MALCOM DONALBAIN LENNOX ROSS PORTIERE BANQUO MACDUFF LADY MACBETH MACBETH ADATTAMENTO TESTI COLONNA SONORA TECNICO LUCI REGIA DIRETTORE DI SCENA Rita Gianini Alessandra Dell’Atti Manuela Di Salvia Vincenzo Sartini Massimiliano MagniChiara Gioncardi Marcello Rinaldi Pierre Bresoliun Vasco Montez Marco di Campli San Vito Cristiano Vaccaro Danila Bellino Daniele Scattina Paola Bianchi Giandomenico Finamore Francesca Prosciutti Daniele Scattina Raffaella Leproni Associazione Culturale Europea “Francesco Orioli” o.n.l.u.s., costituita nell’anno 2000, persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociali nel campo della promozione culturale e dell’arte. La sua attività spazia dalla realizzazione e gestione di spettacoli all’organizzazione di manifestazioni, seminari, rassegne, mostre, festival, concorsi, con l’intento di propagandare e valorizzare ogni aspetto culturale ed artistico. L’associazione intende anche organizzare riunioni e conferenze con personalità del mondo della cultura e istituire premi nel campo artistico e letterario. Attenzione speciale sarà riservata alla tutela e al recupero del patrimonio artistico del territorio come mezzo di salvaguardia delle tradizioni, di arricchimento individuale e di promozione turistica. Perché il nome “Francesco Orioli”? Nato a Vallerano nel 1783, morto a Roma nel 1856, fisico, medico, etruscologo, storico, poeta, saggista, drammaturgo, poeta e filantropo, Orioli è stato una tra le ultime incarnazioni dell’universalismo umanistico, interprete di una cultura globale che nulla rifiuta di quanto eleva l’uomo verso la scienza, la creatività, la liberalità, la giustizia e la bellezza. Dato l’orizzonte europeo delle sue esperienze, il suo nome si raccomanda anche nel segno dell’attualità interdisciplinare ed internazionale come modello per un sodalizio valleranese e viterbese, che nella cultura persegua ad ampio raggio i valori che informarono la sua vita. TEATRO COMUNALE “FRANCESCO ORIOLI”DI VALLERANO SABATO 21 FEBBRAIO 2004 ORE 21,00 Per informazioni ed eventuali adesioni si prega si consultare il sito www.orioli.it o contattarci tramite le nostre e-mail: [email protected] [email protected] Per prenotazioni Tel. 0761 751001 Cell. 328 1235718 Infoline 335.414687 fax 0761.751914
Scarica