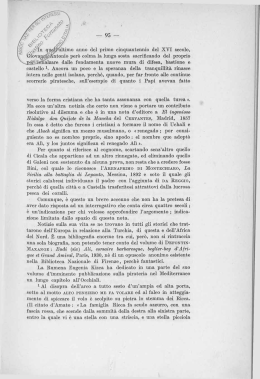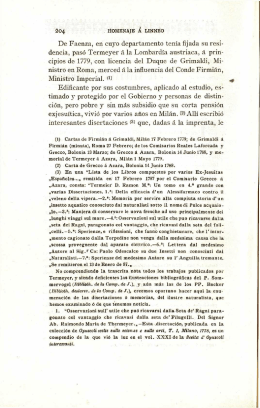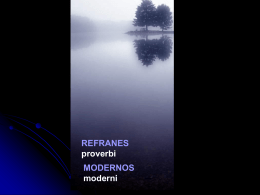Numero 1 marzo 2012 semestrale la rivista dell’Arte sezioni: Arti Terapie e Terapie Espressive Direttore: Vincenzo Bellia Alessandro Tamino Kuma&Transculturazione Direttore: Armando Gnisci Direttori: Vincenzo Bellia Armando Gnisci Marino Midena Maria Pompa Alessandro Tamino Art Director: Rita Campolo Le illustrazioni di questo numero sono di Alessandro Tamino Rivista semestrale N.1 anno 1 in attesa di registrazione Sede: Elma soc.coop.soc. Via Livorno, 45 00162 Roma Tel. e fax: 06. 64220566 Questa rivista nasce dal confluire di varie aree di pensiero, gruppi di lavoro e discipline dalle identità non sempre facili da definire. Prima di tutto c’è stata La Scuola di Arti Terapie, www.scuoladiartiterapie.it, che mosse i primi passi nel 1997, grazie ad Alessandro Tamino e a pochi altri colleghi, tra i quali Vincenzo Bellia, disposti a scommettere su quella strana creatura. Potremmo quindi considerare come nucleo primigenio della nostra nebulosa proprio l’area delle Arti Terapie, un insieme di discipline dall’ambigua collocazione, tra due universi così vasti e poco delimitabili come quello delle arti e quello delle terapie. Nei paraggi di questo nucleo, Alessandro Tamino e Vincenzo Bellia, con la loro storia di psichiatri, di analisti e di direttori l’uno del modulo formativo di Arte Terapia, l’altro di quello di Danza Movimento Terapia della stessa scuola, fin dai primi anni di percorso comune hanno cominciato a pensare a un periodico che permettesse loro di condividere e far fermentare le loro esperienze con quelle dei loro allievi, dei colleghi e di una comunità la più ampia possibile. Da tempo avevano persino già trovato il nome per la rivista, appunto La Rivista dell’Arte, considerandola anche potenziale strumento mediatico di una nuova associazione professionale, A.R.T.E. (Associazione per la Ricerca nelle Terapie Espressive), www.assoarte.it, nata per sviluppare interconnessioni tra i vari ambiti del settore. 2 la rivista dell’ Arte La progettazione di strumenti di comunicazione per allargare l’orizzonte di contatti non era però ancora ben definita, anche se i primi passi della web tv www.aliasnetwork.it nelle tendopoli di L’Aquila nella primavera del 2009, mentre la terra ancora vibrava per il terremoto, avevano permesso di capire cose nuove, grazie soprattutto al generoso contributo creativo degli utenti del centro diurno psichiatrico di quella città ferita. Era necessario qualcos’altro, però, per non rifare il solito già visto e già letto “bollettino dell’associazione” o la classica, validissima ma troppo settoriale, rivista scientifica a tema. Molte le idee in movimento, ma ci voleva un contributo esterno al mondo delle terapie sensu strictiori in grado di catalizzare le reazioni del crogiolo ormai ben caldo. Questo ruolo di catalizzatore va attribuito, del tutto a suo merito, ad Armando Gnisci, uno dei più riconosciuti esperti dei fenomeni di transculturazione, cioè della spontanea tendenza delle diverse culture a imbastardirsi reciprocamente. Da sempre tesi a collocare la loro prassi medica, psichiatrica, analitica e arte terapeutica su basi antropologico-culturali, Alessandro Tamino e Vincenzo Bellia sentivano il bisogno del confronto con uno studioso qualificatissimo dei fenomeni artistici nella loro intrinseca tendenza a creare nuove sintesi grazie alle interazioni tra le culture. Armando Gnisci, con la sua competenza specifica nella critica letteraria comparata e sugli scrittori migranti, portava la ricchezza che mancava, lo sguardo del critico attento ai fenomeni artistici esplicitamente legati al processo a cui tutti noi annettiamo l’unica speranza per un futuro: la creolizzazione del pianeta. Armando Gnisci ha portato in dote a La Rivista dell’Arte non solo il suo patrimonio di natura squisitamente teorica, la costola decisiva che ha permesso il varo di questo veliero è stata infatti strappata dalla sua prestigiosa creatura, la rivista “Kúmá, Creolizzare l’Europa che ora evolve per diventare “Kuma&Transculturazione”. e rinascere nel corpo vivo de La Rivista dell’Arte, donando alla nuova creatura anche il suo marchio, un ideogramma rappresentante un uccello pronto a volare, proprio come nella storia dell’araba fenice. Il logo nacque ispirato da un ideogramma che in lingua Bambara - dell’Africa occidentale subshariana - indica il concetto di “parola”. A La Rivista dell’Arte mancava ancora qualcosa, un giornalista coraggioso come Marino Midena, con molti anni di esperienza nel campo delle pubbliche relazioni, pronto a svolgere un ruolo di certo non semplice, il compito di “regolare il traffico” delle idee - apportandone anche di proprie - in un’agorà sicuramente movimentata e potenzialmente caotica. Così promette di diventare questo nostro “sinodo”. Una parola, ci ricorda Armando Gnisci, che prima di cristallizzarsi nell’uso ecclesiastico, indicava niente di più e niente di 3 la rivista dell’ Arte meno che un comune viaggio creativo. E poi un editore che, oltre ad avere grande esperienza clinica in ambito psicosociale possedesse anche una cultura imprenditoriale autentica e non assistenzialistica nel cosiddetto terzo settore, quella dell’Associazionismo etico non parassitario e che fosse, questo editore, quindi in grado di articolare progetti nei quali coniugare rigore scientifico, rigore morale e conti in pareggio. Maria Pompa, che nonostante la giovane età può infatti vantare un consolidato curriculum che rispecchi appieno queste caratteristiche, era quello che mancava perché l’alchimia potesse finalmente avvenire. Ci auguriamo, quindi, che il nostro viaggio sia assai movimentato, perché non temiamo il disordine. Pur nella molteplicità degli innesti, infatti, tutti noi abbiamo un punto in comune. Si tratta della convinzione che il benessere individuale, inseparabile dal benessere collettivo, nasca dalla possibilità di condividere esperienze; si tratta dell’idea che a generare le cose ci siano i linguaggi e la necessità di esprimersi e comunicare. La Rivista dell’Arte non è quindi solo una rivista, ma il franco tentativo di realizzare un altro pezzo di quel particolare modello di comunità terapeutica che ormai da tempo assume fisionomia nella nostra mente, una comunità terapeutica ancora non ben delineata, ma sempre più certa negli affetti, nella quale a curarsi saremo tutti noi; non solo quelli che si siano meritati in sorte una tradizionale diagnosi, ma proprio tutti, tutti quelli che possano condividere almeno una parte, anche piccola, del nostro percorso, del nostro comune percorso. 4 la rivista dell’ Arte Indice: Arti Terapie e Terapie Espressive Editoriale Alessandro Tamino, Il corpo del terapeuta Vincenzo Bellia, Arte, per piacere! Alessandro Tamino, “La Genesi” dell’Arte Roberta Mazzullo, Ammalarsi in rete, l’esperienza di gruppo in internet Vincenzo Bellia, Un corpo tra altri corpi. Introduzione alla DanzaMovimentoTerapia EspressivoRelazionale Alessandra Tuozzi, Arte Terapia in borgata Kuma&Transculturazione Armando Gnisci, Nuova Kuma&Transculturazione & Manifesto transculturale Armando Gnisci, Editoriale Yue Daiyun, Changing the Spiritual World Nourished in the Colonial Era Letteratura mondiale Speciale 2011 - 150 Unità d’Italia Introduzione alla sezione monografica Laila Wadia, Ascolta il silenzio Ron Kubati, Appartenenze Ali Mumin Ahad, Da un emisfero all’altro Gëzim Hajdari, Poesie: Tu sei nata dall’esilio e in esilio; Vado via Europa, vecchia puttana viziata Rita Marnoto, Esuli e figure di esuli risorgimentali nel Portogallo dell’Ottocento Flavia Caporuscio, A sud del Risorgimento: Noi ci credevamo 5 la rivista dell’ Arte Transculturazione Roberto Fernández Retamar, Varias maneras de mirar a un mirlo, digo, a una literatura Yue Daiyun, Development and Problems of Chinese Comparative Literature Yue Daiyun, La licorne et le dragon Miguel León-Portilla, Ihcuac tlahtolli ye miqui/Cuando muere una lengua/Quando muore una lingua Shirley Carreira, Imigrantes libaneses no Brasil: a representação literária do processo de aculturação Hussein Mahmoud, L'integrazione alla rovescia: la scelta del dialetto nella poesia migrante egiziana in Italia Laila Wadia, Ironia Francesco Armato, Sui prati, ora in cenere, d’Omero Manuela Derosas, La letteratura portoricana: luogo di resistenza al dominio coloniale Gëzim Hajdari, I canti dei nizàm & Slogan dell’Albania di Enver Hoxha & Epicedio albanese Rosa Di Violante, Novità della Collana “Kumacreola”; Hussein Mahmoud, Postfazione a La Melodia del piano di Abou Shareb; Rosa Di Violante, Nota a proposito della redazione transculturale de La Melodia del piano di Abou Shareb Christiana de Caldas Brito, 500 Temporali in Brasile Ricciarda Ricorda, Archivio delle Scritture e Scrittrici migranti - Università Ca’ Foscari Venezia Armando Gnisci, FAG: Fondo Armando Gnisci BASILI Bollettino BASILI Che cosa ne facciamo dell’Arte Alessandro Tamino, Omaggio ad una sorella Colloqui dell’Arte 6 la rivista dell’ Arte Arti Terapie e Terapie Espressive Direttori: Vincenzo Bellia Alessandro Tamino Redazione: Rita Campolo Zaira Donarelli Assunta Izzo Maria Teresa Mattioli Paolo Travagnin Alessandra Tuozzi Prima dei due editoriali dei responsabili di questa sezione, con queste righe vogliamo darvi il benvenuto nel mondo delle arti terapie e delle terapie espressive. Dopo i due editoriali il primo testo che incontrerete, “La Genesi dell’Arte”, ha caratteristiche molto particolari e potrebbe sembrare più adatto ad una rivista di teologia che ad un ambito come questa sezione della nostra rivista, ambito che riguarda in maniera esplicita soprattutto la questione della cura. In realtà gli studi sull’antropologia della cura rendono chiari, invece, i nessi strettissimi tra la concezione del sacro e la costruzione dei modelli di terapia, sia espressiva che più classicamente intesa. Basterebbe aver modo di assistere, in un qualunque reparto medico, alla visita di un primarione con il suo codazzo; o, più salutarmente, anche solo appostarsi in un bar nei pressi di un grande ospedale, a godersi il planare ieratico dei camici bianchi e osservare le posture di chi li indossa… se non sembrano processioni quelle, ben poco ci la 7 rivista dell’ Arte manca. A parte gli scherzi, la costruzione del setting (analitico come arte terapeutico), lo stabilire regole che trasformino quello spazio in “un buon contenitore di emozioni”, non coincide in larga misura con la trasformazione di uno spazio geografico “qualunque” in un qualcosa di diverso dalla scontata somma delle parti? Non ci fa venire in mente l’augure che stabiliva il punto e il momento giusto per realizzare un tempio? O, ancora, Romolo, che fa di una rozza traccia di bastone per terra una questione di vita o di morte per suo fratello? La storia delle religioni è importantissima per comprendere molti dei modelli con i quali cerchiamo di spiegare il comportamento umano, in particolare per quanto riguarda due specifiche modalità relazionali, l’ammalarsi e il curare. Molti sono gli Dei dell’Olimpo che, così come il Dio dei monoteisti, possiedono tra i loro attributi principali quello del guaritore. Vi è poi un’altra ragione per la quale a “La Genesi dell’Arte” annettiamo una grande importanza, perché vi si parla, in maniera un po’ diversa dal solito, di Eva. Quando si discute della funzione della cura, delle terapie espressive e delle arti terapie, infatti, la questione del femminile è centrale. Le donne operano nelle arti terapie in grandissima percentuale; ciò si deve unicamente all’”inevitabile avanzata” del femminile nelle professioni della cura? Pensiamo di no. Le arti terapie sono intrinsecamente collegate a una fase della nostra storia nella quale il curare era declinato pressoché esclusivamente al femminile, una fase caratterizzata da sistemi di credenze che ora definiremmo genericamente “naturalistici”. Le arti terapie, rispetto ad approcci più classicamente consolidati nell’immaginario collettivo, come ad esempio la psicoanalisi, reintegrano nel dominio terapeutico almeno quattro aree in qualche modo marginalizzate da tempo: a) l’area del corpo, tenuto - come il diavolo - il più possibile distante del contesto psicoterapeutico, per fare spazio esclusivo a ciò che qualcuno chiama “psiche”; b) la cultura specifica, l’etnos dei contesti, invece dell’universalismo edipico etnocentrico che per tanti anni ha animato il furore interpretativo; c) la comunità di appartenenza come risorsa irrinunciabile per la cura, invece del blindatissimo setting duale (o anche di gruppo), per il quale per due pazienti prendersi un caffè insieme fuori dal gruppo avrebbe potuto rappresentare il peggiore dei sacrilegi; d) la ricerca del piacere, contrapposta all’idea che più il paziente soffre meglio è; del resto per i modelli di terapia giudaico-cristiani non vi è alcuna via di guarigione se non attraverso il dolore, non sia mai che un paziente rida in seduta, quello non potrà che essere considerato un pericoloso agito da interpretare hic et nunc, possibilmente con l’aiuto di ferri roventi. Per farla breve (tanto su tutto questo torneremo, e spesso!), le arti terapie sono modalità di cura non dissimili da quelle che per il novanta per cento delle sua storia ha usato l’homo sapiens (anzi, la foemina sapiens), quando eravamo cacciatori-raccoglitori. Modalità da sciamane, modalità da donne abituate a vivere sopratutto in gruppo, a trasmettere un sapere della cura legato alle erbe che raccoglievano mentre gli uomini tiravano tardi a caccia. Il femminile era ed è infatti molto più legato al corpo, alla comunità e alla cultura, che è tipicamente madre - ancor oggi si dice lingua-madre, non lingua-padre. 8 la rivista dell’ Arte Per non parlare del piacere e dell’eros, demonizzati per secoli forse per assoggettare la donna: anche per questo “La Genesi dell’Arte”, lo “scoop” con cui inauguriamo la nostra sezione ci appare, assai, assai pertinente per i temi che ci stanno a cuore. la 9 rivista dell’ Arte Arti Terapie e Terapie Espressive Alessandro Tamino Il corpo del terapeuta Perché fondare e dirigere una rivista? Per il piacere di diffondere vera e sana cultura in tutto l’orbe terracqueo? Per dare la possibilità ai giovani di esprimersi che, poverini, noi cariatidi dal culo di pietra sempre glielo impediamo? Balle, o almeno semiballe. La questione che mi interessa sul serio riguarda la buona gestione dei miei preziosissimi nuclei psicotici e della mia fondamentale struttura onanistica che forse, come poi ipotizzeremo, potrebbe invece rivelarsi ancora più gradevolmente, orgiastica. Prima di tutto c’è il problema che non so mai decidermi se vorrei scrivere con lo stile dello scienziato o se giocare a fare il vero e proprio scrittore. È per questa ragione che, almeno finora, posso dire di non aver mai saputo scrivere veramente come anche di aver sempre saputo scrivere benissimo. Perché il fatto è che ci ripenso in continuazione su quelle righe che son sempre lì lì per affidare al mondo e poi non le faccio quasi mai uscire di casa. Che genitore perverso che sono, nel dubbio rischio di non mandare i figli all’università e nemmeno di permettergli la discoteca. Se sapeste quante figuracce nella mia storia professionale con le più varie menzogne. redazioni e soprattutto quante 10 la rivista dell’ Arte “Cooome?! Non le è ancora arrivato il mio pezzo? Ma le giuro sugli ovuli della mia donna che glielo avevo spedito l’altra settimana. Oggi? Peccato, proprio non posso, perché sa, di Venere e di Marte… ma che mi dice, oggi è giovedì? No, non è possibile lo stesso, sa com’è, emotivamente sono già nel weekend lungo… queste maledette mail poi, con il fax era tutta un’altra cosa, me sa che me s’è persa, ancora, è un virus, un virus ha cancellato tutto, devo rifare tutto, uffaaa, ma stia tranquillo, ma le pare, è interesse anche mio, no?” Perché quasi ostento con soddisfazione tutta ‘sta patologia? Perché la patologia a me mi sta simpatica, ho imparato che può essere anche uno straordinario atto creativo, a volte salvifico, per giunta. Quella che pomposamente in psicanalese chiamiamo “analisi didattica” – o, a seconda del segno zodiacale dell’analista, “analisi propedeutica” o “seconda analisi” - la intrapresi, ormai son tanti anni fa, con il buon Paolo Aite. Il quale a sua volta aveva lavorato con Ernst Bernhard che a sua volta si era formato con Karl Gustav Jung in persona. I gesti e i modi di fare che sono anche modi di pensare passano tra le persone, soprattutto se molto significative. Facevo l’analista già da vari anni quando mi accorsi che tra i miei spontanei rituali di chiusura delle sedute c’era spesso un piccolo gesto, insignificante forse, ma era lo stesso di Paolo Aite. Chissà quanti altri frammenti del suo corpo vivo mi ha passato e magari alcuni erano di Bernhard e magari qualche cosina anche di Jung. Con due sole stazioni intermedie è sicuro. Mi dà sempre una piccola, momentanea tranquillità pensare che nei movimenti del mio corpo c’è qualcosa di qualcuno che ho conosciuto, stimato e anche amato, forse anche odiato. Come anche, per passaggi di testimoni corporei, qualcosa di chi non ho conosciuto direttamente, ma ho amato oppure odiato per interposta persona e via via, per tappe intermedie, fino a chissà chi, fino a chissà dove e quando. E per questi anonimi contributi alla mia esistenza proverò soprattutto dell’amore indifferenziato e leggerissimo o nella peggiore delle ipotesi un lieve fastidio anch’esso indifferenziato perché dopo qualche passaggio i nostri corpi l’odio riescono quasi sempre a stemperarlo. Quindi, in quel mosaico di tessere migranti che su una patente rilasciata dalla Prefettura di Roma viene definito come Alessandro Tamino, c’è persino qualcosa di Jung e figuriamoci, anche di Freud e di chissà chi altro. A me, sapere che il mio corpo non appartiene solo ai vivi, mi fa percepire i miei stessi gesti e quelli delle persone nei miei paraggi come carezze, quasi sempre anonime, a volte tiepide, raramente come sfioramenti fastidiosi. E sempre più raramente, fastidiosi, ora che sto finalmente invecchiando. Quindi i fantasmi, i numi tutelari, gli angeli custodi esistono, sono però “semplicemente” soltanto iscritti nei nostri corpi vivi. Ma non per questo sono meno potenti, efficaci, protettivi come a volte, per fortuna solo a volte e per pochi infelici, crudelissimi. 11 la rivista dell’ Arte Ma la soddisfazione più grande me la dà la condivisione delle patologie. Quando con Paolo Aite mi lamentavo delle mie difficoltà a finire molte delle cose che iniziavo, e forse speravo ancora di guarire dal difettaccio, lui mi raccontava che il grande Bernhard avesse un problema simile, che lui stesso definiva come una franca nevrosi. Ma mi diceva anche che Bernhard se ne vantasse spesso, ripetendo ai suoi allievi con il tono da massima apodittica: “La mia nevrosi mi ha salvato”. E da quello che poi aggiungeva ci si rendeva conto che la sua non era per nulla una pomposa metafora. Pare infatti che Bernhard soffrisse soprattutto da giovane di una sorta di timidezza patologica che gli rendeva difficile sia di parlare in pubblico che di licenziare un suo scritto. In tutta la sua vita, nonostante la sua fama, ha praticamente scritto un solo libro, “Mitobiografia”, anzi nemmeno se l’è fatto lui tutto da solo perché dovette intervenire la sua allieva Hèléne Erba-Tissot per organizzargli il suo materiale vario e sparso, proprio alla Wittgenstein. Ma questo suo apparente limite gli era tornato assai utile negli anni ’30 del secolo scorso, in un periodo nel quale, come tutti avrebbero il dovere di sapere, in quasi tutto il mondo tirava un’ariaccia per gli Ebrei, più di quanto da quasi due millenni tirasse già e in quel periodo soprattutto in Europa e in particolare nelle terre teutoniche. E la faccenda riguardava molto gli psicoanalisti che, come Bernhard, erano in larghissima percentuale, a quei tempi, per l'appunto ebrei. “Scienza giudaica” e con disprezzo, i nazisti chiamavano la psicoanalisi. Poiché per quei galantuomini vigeva dunque l’equazione psicoanalista uguale ebreo, per la stesura delle prime liste di proscrizione i nazisti avrebbero attinto, tra le altre fonti, persino agli indici delle rivista psicoanalitiche. Bernhard, per la sua ritrosia ad esporsi, non era inizialmente schedato e riuscì quindi, per il proverbiale pelo, a sfuggire alle prime retate. Oddio, qualche problema ce lo ebbe poi in ogni caso perché la sorte lo colse nel 1938 a Roma, proprio mentre nel paese degli “italiani brava gente” - come mistificò Benedetto Croce - venivano promulgate le leggi razziali. Ma nonostante tutto, questo ritardo nella deportazione lo salvò comunque perché l’italianissimo lager dove lo spedirono, a Ferramonti di Tarsia in quel di Cosenza, per la sua posizione geografica venne raggiunto dagli alleati – che stavano risalendo da sud dopo lo sbarco in Sicilia – già nel settembre del ’43, poco prima quindi che potesse essere eseguito l’ordine fatidico di spostare quei miscredenti al nord, proprio in quel che ancora restava della tana del mostro. Quindi, “La mia nevrosi mi ha salvato” per Bernhard non era solo una metafora ad effetto ma una vera e propria esortazione a considerare certi nostri limiti come affettuosi consigli dell’inconscio. Per omaggio a lui, parlando prima dei miei nuclei patologici li ho definiti “psicotici” e non “nevrotici”, perché ammesso e non concesso che sia sempre chiara la differenza e che i primi siano sicuramente peggiori dei secondi, nelle mie intenzioni c’era quella di fare un inchino al 12 la rivista dell’ Arte maestro, che sarebbe ben tristo se non venisse superato dai discepoli, anche se di seconda generazione. Tornando alla nostra impresa, nutro la speranza che una rivista “ai mezzi” con amici che ben conoscano la mia natura di persona incerta e di saltuario quanto abilissimo mentitore, sia il modo per scrivere finalmente tutti quegli articoli e quei libri che, ci crediate o no, allievi, colleghi e pazienti mi chiedono sempre più spesso di scrivere. Diciamo che lo scopriremo solo leggendo e scrivendo. Poi c’è la questione dell’onanismo. L’onanismo è tra le più importanti, diffuse e spesso ben riuscite forme di autonomia creativa. La sua potente logica sarebbe nella sua essenza assai semplice: “Se una cosa non me la danno, faccio per conto mio”. Anche la Scuola di Arti Terapie in fondo è nata grazie a questa logica. Mi è sempre piaciuto insegnare, mi rende il cervello più fino sforzarmi di far capire qualcosa che poi capisco ancora meglio dopo averlo spiegato agli altri, ma non avrei mai avuto lo stomaco, la disonestà e soprattutto la capacità di autocastrazione necessari per fare una buona carriera universitaria. E allora sapete che vi dico? Che qualcosa che assomigli all’università me la faccio per conto mio, con quelli bravi che dico io! Ed ecco la Scuola di Arti Terapie. E così, per quanto riguarda la pubblicazione dei miei scritti, quale sapiente rivista dei settori che mi interessano avrebbe mai pubblicato anche solo uno degli articoli che qui potrò farvi leggere? Secondo me avrebbero cestinato persino questo “timido” editorialetto. Quale editore mai mi permetterebbe solo un decimo delle innovazioni grafiche, relazionali, culturali e vattelappesca che mi cullo ancora in segreto? Sapete perché dico “Onanismo”? Perché la logica è la stessa: se non me la danno, l’università o la possibilità di pubblicare quello che dico io, come lo dico io, me le faccio con le mani mie, le lezioni e le scritture! Nel caso della Scuola di Arti Terapie la faccenda mi è andata infatti molto meglio che se avessi vinto una cattedra universitaria. La possibilità di piacere creativo, le cose che con i miei sodali, siamo riusciti a fare, le innovazioni che siamo riusciti a mettere in campo ce le saremmo scordate se avessimo dovuto costantemente trattare con i tromboni che comandano all’università. Ma non mi va di finire questa presentazione troppo in alto, con un tono troppo in erezione e allora chiudo in maniera interlocutoria ricordando che in un delizioso testo, Il Libro dell’Es, Georg Groddeck afferma una cosa ovvia ma a cui ben pochi pensano e che cioè dall’onanismo abbiamo cominciato e nell’onanismo tutti finiamo, quindi non è certo da considerarsi solo uno squallido surrogato di qualcosa ma un qualcosa di fondamentale in sé e per sé, a cui concedere una dignità autonoma. E questo qualcosa, potrebbe essere la filiazione delle prime esperienze motorie del bambino, prima ancora che si possa parlare di franca 13 la rivista dell’ Arte erotizzazione. La masturbazione sia dei maschietti che delle femminucce si innesterebbe quindi su uno stato fusionale e sarebbe, come altre esperienze corporee sia individuali che condivise, la memoria di quando toccarci, essere toccati dalla madre o toccare la madre non erano poi cose tra loro così tanto diverse. Tacciano i freudiani ortodossi che alle mie incestuose parole già si leccano, golosi, i loro vetusti baffi. Tacciano per darmi il tempo di provocarli ancor più brutalmente. Quel toccare toccandosi arcaico da cui, ricordiamoci, nasce quella particolare attività corporea che chiamiamo il pensiero, non è uno sterile onanismo perché è un fondersi ed un distaccarsi dal corpo unico dei viventi, proprio come la Scuola di Arti Terapie e La Rivista dell’Arte nascono da incontri emotivamente significativi in una comunità di persone che professino sistematicamente il pensiero critico, il suo gioco e il suo piacere. Concediamoci il dubbio che il biblico punitivo concetto stesso di onanismo fosse stato creato a bella posta per limitare proprio la nostra relazione con i corpi della comunità. Relazione non esclusivamente finalizzata alla riproduzione ma al contatto, alla creazione di una cultura condivisa con le comunità entrambe autentiche, perché corporee, dei vivi e dei morti. E il cristianesimo, percorrendo quella stessa punitiva strada ha sistematicamente cercato di sradicare il culto degli antenati, come proverà anche di fare con altre forme culturali basate sul corpo condiviso. Tobie Nathan, per dimostrare proprio questa ostilità nei confronti del culto degli antenati, ci ricorda come la religione più diffusa del pianeta, dal Vangelo di Luca ancora ci ammonisca con la terribile frase di Gesù“ lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio”. Proprio con questo minaccioso proclama Gesù ammonisce con disprezzo un giovane che prima di unirsi ai suoi discepoli aveva solo chiesto gli venisse concesso il tempo per seppellire suo padre. Quindi mi permetto di dire che forse non è semplice onanismo, farsi da soli le cose che le istituzioni potenti ci negano e se facciamo outing facciamolo bene. Quello che proponiamo ne La Rivista dell’Arte, e ci piacerebbe assai di realizzare è invece un’orgia, una vera e propria orgia di corpi e di gesti che si accoppiano con le loro figlie più belle, i pensieri, le immagini e le parole. E di riuscire a scrivere come piace a me, divertendomi e sotto traccia discutere con il mondo di filosofia. E di non farlo da solo ma sempre con qualcuno a cui voglio bene e che mi dica se sto ad esagerare o se ci sto, forse, ad imbroccare. Prima di lanciare la bottiglia per il varo vi propongo solamente un’altra breve annotazione. La grandezza delle avanguardie artistiche del secolo scorso passano sempre per una caratteristica che le differenzia 14 la rivista dell’ Arte dalle botteghe dei grandi del Rinascimento, essere costituite da gruppi di pari e non di scolari. O di semipari, perché i ruoli sempre oscillano. Senza comunque un leader indiscusso, e proprio negli stessi anni in cui il fascismo, il comunismo e il nazismo stavano affilando le loro lame crudeli. A ricostruire la storia dell’arte con l’occhio degli studiosi dei gruppi, o per meglio dire, delle comunità, si scoprono cose assai curiose. Per esempio che tra i primi a lavorare in maniera consapevole con tecniche relazionali nel dipingere c’erano i buoni vecchi macchiaioli; a Castiglioncello, nella tenuta del loro mecenate, il critico Diego Martelli, si erano inventati, pensate, tra i vari altri giochi, di dipingere enpleinair lo stesso paesaggio, ma di spalle l’uno all’altro per poi discuterne le differenze. Ed eravamo in pieno Ottocento. Quindi, tirando il collo al povero Michelangelo ci permettiamo di dire che questi sono i soli che ci illuminano, questi i soli che ci fanno innamorare. Grazie a queste luci e grazie alle inevitabili quanto a volte carezzevoli ombre, grazie a questa comunità tra pari e semipari, restituendo ciò che rubo in continuazione ai maestri, siano questi consapevoli e dal nobile pedigree o inconsapevoli come quel tassista dell’altra sera che m’ha parlato della nonna, mi piace assai di abbandonarmi al dolce saccheggiare e all’altrettanto dolce farmi saccheggiare da vicini conosciuti e lontani sconosciuti. la 15 rivista dell’ Arte Arti Terapie e Terapie Espressive Vincenzo Bellia Arte, per piacere! Comincia l’avventura de La rivista dell’arte. È uno spazio ancora virtuale. Il mio desiderio vorrebbe che si popolasse di pensiero divergente, nell’epoca in cui il regime delle frasi fatte colonizza le menti. Vorrei che fosse uno spazio popolato da esperienze, nel tempo in cui il pensiero sempre più spesso si sgancia dal vivere. Vorrei che diventasse uno spazio di scambio, nel tempo dell’esperienza solitaria e del consumo senza mercato. Sarà certamente uno spazio di elaborazione culturale. Di dibattito scientifico, anche? Ce lo auguriamo. Intenzionalmente sarà uno spazio di espressione artistica. Se La Rivista dell’Arte è uno spazio, quali sono le coordinate che lo definiscono? Due coordinate sono certamente ciò che chiamiamo transculturazione e ciò che definiamo arti terapie. In questo periodo di gestazione della rivista, l’associazione di arti terapie di cui faccio parte, ARTE (studiatissimo acronimo di Associazione per la Ricerca nelle Terapie Espressive) è entrata a sua volta a far parte della CNA (acronimo meno fantasioso di Confederazione Nazionale Artigiani). La cosa mi piace, non solo per concretissime ragioni attinenti alla politica professionale. In quale comunità professionale allargata collocare le arti terapie? Certamente non solo nella cerchia medica: oltre a non sollevarvi travolgenti entusiasmi, indovino, la cosa non sarebbe neppure auspicabile; neppure una psichiatria degna di questo nome, del resto, può essere confinata nell’enclave delle professioni sanitarie, visto che, per svolgere la propria funzione al servizio della salute mentale, deve abitare gli spazi 16 la rivista dell’ Arte più ampi della comunità civile e intrecciarsi con le sue processualità culturali, politiche ed economiche. Ancor più triste sarebbe se le arti terapie finissero per fare le “parenti povere” alla corte dell’aristocrazia psicologico-clinica, che le impoverirebbe ulteriormente: Beneduce cita lapidariamente «Psychology is the American cultural idiom» (Littlewood, 1994). In realtà, le arti terapie devono molto al sapere psicodinamico e alla meno enfatizzata ma almeno altrettanto importante ricerca neuropsicologica. Credo però che gli eccessi di “mimesi psicoanalitica” abbiano più nociuto che giovato al loro sviluppo. Discipline di frontiera, dall’identità in continua ridefinizione al confine tra i territori della medicina, della psicologia e dell’arte, credo che a quest’ultima delle tre matrici di riferimento le arti terapie debbano la propria specifica ragion d’essere. È questa l’opzione filosofica e metodologica di ARTE, come leggiamo nel suo statuto. L’arte può essere considerata come la più antica e diffusa forma di terapia sociale: è questo il fondamento antropologico delle terapie espressive, risorse della comunità per la comunità. Le terapie espressive... incontrano l’essere umano a livello del corpo vissuto, dei suoi linguaggi, della dimensione sensomotoria e dell’azione rappresentativa, per svilupparne la creatività, intesa come processo compartecipato, eminentemente soggettivo e intrinsecamente relazionale e ritenuta un insostituibile fattore di benessere personale e collettivo… il nucleo specifico delle terapie espressive è in quell’area che viene tradizionalmente definita “arte” e che costituisce anche l’elemento discriminante rispetto alle discipline di confine. Gli arte terapeuti, insomma, sono innanzitutto… artisti o artigiani? Se traguardassimo il palinsesto delle culture, troveremmo probabilmente ben più di un esempio storicamente rilevabile in cui una siffatta distinzione è del tutto priva di significato. Oltre alle ben più note dicotomie mente-corpo, individuo-gruppo, natura-cultura, non sottovalutiamo quella non meno importante dicotomia che ha scorporato dal mestiere la valenza estetica e creativa, o che ha sottratto all’arte la sua primitiva funzione sociale! Come sarebbe, allora, ricominciare a fare arte e tornare a fare i terapeuti da veri artigiani? C’è però ancora un elemento basilare nella pratica artistica: l’esperienza elementare del piacere. Ebbene, il piacere, ci piaccia o no, è anche il nucleo essenziale delle arti terapie, per coloro che delle arti terapie fanno esperienza. In molte culture contemporanee il piacere è talora esiliato dall’esperienza artistica, a volte è 17 la rivista dell’ Arte mortificato dalla disciplina tecnica, più spesso è svilito in un edonismo che rende l’arte un prodotto meglio monetizzabile. Il piacere provoca spesso imbarazzo anche tra i terapeuti espressivi, forse per una mai superata soggezione nei confronti della casta medico-psicologica, che il piacere lo riconosce con facilità quando manca (nell’anedonia di tante sindromi psicopatologiche), ma che è meno disposta a tollerarlo quando rinasce, magari perché ritenuto inappropriato alla situazione terapeutica! L’esperienza del piacere, però, è indispensabile per vivere. Nelle arti terapie l’esperienza del piacere la si fa, è indiscutibile, e scaturisce altrettanto indiscutibilmente dal fare arte, e dal farla insieme. Allora arte, per piacere! la 18 rivista dell’ Arte Arti Terapie e Terapie Espressive Alessandro Tamino “La Genesi”dell’Arte Con grande orgoglio e qualche emozione condivido con i lettori del primo numero della nostra rivista un testo che a tutti gli effetti potremmo considerare, nell’ambito della storia dell’arte, una nuova quanto clamorosa acquisizione. Come spiegheranno le righe qui a seguire, sono venuto in possesso, in maniera assai fortunosa, delle prime due, più antiche e finora segrete versioni della Genesi Biblica. Anche solo dopo una superficiale lettura di questo straordinario manoscritto apparirà chiaro a tutti che non fu peregrino per l’arcaico estensore titolarne un capoverso “La nascita dell’arte”. Un mio paziente, di cui non posso ovviamente rivelare l’identità completa, lavorava fino a pochi anni fa come archivista restauratore della biblioteca del Vaticano. 19 la rivista dell’ Arte Era gay ma non era questo, ovviamente, in sé e per sé un problema. Il disagio che gli aveva fatto intraprendere il percorso analitico era la coazione a ripetere, nelle sue storie sentimentali, situazioni molto frustranti. All’origine della questione vi era presumibilmente il rapporto difficile con il padre, che non aveva mai accettato l’omosessualità del figlio e che di suo era anche stata una persona che si rapportava con il mondo secondo modalità a volte persecutorie e a volte teatralmente affettuose. Per questa ragione Ugo, con questo nome di fantasia chiamerò il paziente, tendeva ad avere rapporti soprattutto con uomini sadici che vivevano molto male la loro identità di genere e che per questo non solo dovevano nascondere le loro relazioni omosessuali ma anche sfogare la rabbia che scaturiva dal proprio conflitto identitario sul partner. Una delle sue relazioni più burrascose fu quella con un cardinale grazie proprio agli auspici del quale, Ugo era stato assunto a tempo determinato con un contratto di formazione lavoro dalla Biblioteca Vaticana. In quel periodo la sua intimità era periodicamente martirizzata dalle terribili sfuriate del religioso, durante le quali veniva insultato e picchiato in quanto maschio puttana corruttore e corruttrice della rettitudine di un sant’uomo. Passata la tempesta il prelato era uso farsi perdonare con regali preziosi e confidenze intriganti sui retroscena della politica vaticana. In un’occasione, dopo un episodio di sadismo più crudele del solito, il porporato per cercare di rendere credibile il suo amore ed ottenere una riconciliazione, gli rivelò i codici di accesso al segreto più intimo degli Archivi Vaticani. Si trattava di un breve testo vergato su papiro, la cui datazione, confermata dagli esami sia con Carbonio 14 che con Stronzio 69, lo collocherebbe in un periodo precedente a quello che siamo abituati a considerare il teatro delle prime stesure bibliche. Questo scritto venne ritenuto credibile da una commissione vaticana che lavorò nella massima segretezza, e corrisponderebbe per l'appunto nietepopodimeno che alle prime due versioni della Genesi Biblica. A concepirlo sarebbe stata una fase storica di transizione, poiché le parole e i concetti risentirebbero dell’eco di culture molto ma molto più antiche di quella che ne ha concepito il testo. Purtroppo di più non posso dirvi poiché la stessa commissione sentenziò che l’esistenza di quelle parole non doveva essere condivisa con il mondo e il manoscritto sprofondò nel più recondito caveau della Biblioteca Vaticana perché, come vi apparirà ovvio dopo averlo letto, quegli spaventati ecclesiastici lo considerarono scardinante per tutto l’apparato di fede ufficiale. E si trattò di un peccato gravissimo al quale ora noi poniamo rimedio poiché questo intombamento ha impedito agli studiosi il necessario lavoro esegetico che il testo ancora merita e che da questo momento può finalmente riprendere. Rigoroso lavoro esegetico per il quale sono richieste le competenze del biblista esperto, competenze che certo non mi appartengono. Ma nonostante questo limite mi voglio concedere ugualmente qualche annotazione, azzardandomi a farvi notare come in questi scritti, soprattutto nelle due diverse versioni del Primo Capitolo della Genesi, si manifesti con evidenza un conflitto tra diverse visioni del mondo, in una parte prevalendo l’una e dopo solo qualche riga prevalendo invece l’altra. A me pare, forse ingenuamente, che proprio la sua particolare, molto più evidentemente discontinuità 20 la rivista dell’ Arte rispetto la Genesi riconosciuta dalla Chiesa possa essere considerata paradossalmente una prova dell’autenticità di queste versioni giudicate apocrife della Genesi. L’armonia e l’organicità non possono che essere solo occasionalmente caratteristiche di una testimonianza storica autentica. Giusto i miseri possono credere che la costanza di un buon ritmo narrativo renda credibile una serie di affermazioni. Se è infatti necessario per la stabilità di una ambiente sociale che gli svantaggiati vivano offuscati e non percepiscano appieno la loro minorità il trucchetto è ben collaudato: I disgraziati tollereranno meglio la fame se almeno gli si garantisce, non importa quanto distante nel tempo e nello spazio, l’esistenza da qualche parte di un’armonia comunque ben strutturata e come prova si accontenteranno, gli illusi, anche solo una metrica ben lubrificante. Anzi, poiché secondo vari biblisti anche la Genesi tradizionalmente diffusa evidenzierebbe comunque delle disomogeneità, potremmo dire che la forza di un testo istituzionalmente imposto consisterebbe anche nel suo determinare quasi spontaneamente nei miseri, nei subalterni un percetto di armonia anche quando questa armonia non è poi così palese. Comunque, digressioni a parte, la Genesi Biblica come noi la conosciamo altro non sarebbe che una successiva, ulteriore e, almeno apparentemente, assai più fluida riscrittura di sé stessa, fluidità ben capace di convivere con la vaghezza necessaria di un efficace testo fondativo per una comunità e comunque resa evidentemente possibile, sempre questa fluidità, solo grazie al superamento di buona parte dei conflitti che ne animavano le stesure precedenti qui pubblicate. Superamento dei conflitti che purtroppo non immagino sia avvenuto in maniera pacifica. Quel che resta della vera Genesi come la troviamo stampata sui volumi che, ancora oggi, a ridicolo monito per i fornicatori possiamo trovare negli States sul comodino di quasi tutte le stanze d’albergo, consisterebbe quindi in una versione emendata dai contenuti sgraditi a chissà quale arcaico censore, degno antenato degli inquisitori attuali. Salta agli occhi, infatti, confrontando le righe qui per la prima volta pubblicate, con il testo finora condiviso della Genesi, quanto il loro palinsesto sia simile, solo alcune frasi sono state eliminate e a tratti riplasmate ma nella struttura generale le diverse scritture appaiono in buona parte sovrapponibili. Come e più della Stele di Rosetta sono redatte in quattro lingue: Ieratico, Aramaico, Spanglish e Lumbard. Il mio paziente, violando una promessa fatta al suo amante aveva fotocopiato la trascrizione del testo e la sua traduzione, a tratti stentata e con termini che paiono arbitrariamente moderni ma, mi garantì, nella sua sostanza filologica del tutto corretta. Ugo ha finito la sua analisi da qualche anno. Ha chiuso con cardinali e deputati ed ha trovato un uomo che finalmente lo sa amare per quello che ognuno di noi merita. La coppia aveva in animo di trasferirsi in un paese africano non a moltissima distanza, per ironia della sorte, da dove secondo i paleontologi la storia dell’Homo Sapiens Sapiens è cominciata e dove quindi delle persone dalla pelle nera, le prime versioni della Genesi le hanno vissute per davvero. Fu all’ultima seduta, poiché gli era nota la mia curiosità per l’origine delle cose, che Ugo mi volle donare una copia del manoscritto, autorizzandomi a farne ciò che volevo, a patto ovviamente di non rendere riconoscibile né lui né il suo antico amante che tutto sommato non meriterebbe questa punizione 21 la rivista dell’ Arte sputtanante, nemmeno lui, che altro non è che un povero cristo come tutti noi. Anche se dai giornali scopro che sta facendo molta carriera, distinguendosi, proprio come nella sua vita privata, per una sapiente alternanza di equilibrio e furore. Alessandro Tamino 22 la rivista dell’ Arte Genesi - Capitolo 1 1. LA CREAZIONE E LO SVELAMENTO (prima versione) [1] Non c’è mai stato un inizio Non c’è mai stata una fine E la fine e l’inizio danzano nel sogno Perché la danza genera il sogno Perché il sogno genera la danza Perché il sogno e la danza sono la stessa cosa E quando il sogno fu l’universo, la danza rese gravide le femmine E le femmine partorirono persone Alcune di queste persone erano donne, altri erano uomini Alcune persone dissero subito che non era giusto che i frutti della terra appartenessero in egual misura a tutti. E allora quelli che erano nati vicino al grande albero dissero che loro meritavano più frutti degli altri perché erano nati vicino al grande albero. Ma quelli che erano nati vicino al largo cespuglio li presero a pernacchie e sostennero che erano loro, in quanto nati vicino al largo cespuglio, a meritare più frutti. E allora soprattutto gli uomini cominciarono a litigare tra loro ma nessuno dei due schieramenti riusciva ad avere definitivamente la meglio sull’altro perché nessuno dei due schieramenti quando si trovava in vantaggio era capace, finita la rissa, di ammazzare anche i superstiti dell’altro partito. E così dopo un po’ quelli che avevano perso l’ultima battaglia ritornavano di nuovo forti e numerosi fino a quando non riuscivano a ribaltare le sorti della guerra. Ma a loro volta nemmeno loro, vincenti, riuscivano ad assassinarli proprio tutti i loro nemici perdenti. Appena finita la battaglia sembrava che ogni belligerante non vedesse l’ora di smettere di uccidere. Prevaleva infatti la loro natura animale, incapace di ammazzare a freddo, in grado di farlo solo nell’immediatezza di un pericolo o per un bisogno impellente. 23 la rivista dell’ Arte E così i perdenti di un giorno tornavano vincenti dopo poco tempo e questo ciclo sembrava non esaurirsi mai. Finché il più sofferente di uno dei due partiti che litigavano per i frutti e che odiava le donne perché non riusciva a ridere con loro ed invidiava il loro potere generatore e ne aveva quindi paura, non trovò in uno dei suoi sogni, che altro non era che un incubo ricorrente, il sistema per risolvere la questione una volta per tutte e poter quindi finalmente scannare con la massima tranquillità tutti ma proprio tutti quelli del partito avverso. Fu così che in un incubo l’uomo creò Dio, a immagine e somiglianza dei suoi aspetti più violenti. E questa creatura terribile, appena creata, disse che quelli che erano nati con la testa rivolta verso le colline erano il suo popolo eletto. A quel popolo spettavano i frutti e tra gli appartenenti a quel popolo i discendenti del suo inventore avevano diritto ad avere più frutti degli altri. E chi non accettava tutto questo non meritava di vivere e doveva essere messo a morte se uomo e stuprata se donna e le sue figlie e i suoi figli fatti schiavi nel nome del Signore Dio Misericordioso che agiva a sua volta sempre e comunque nel nome segreto dell’uomo. E questa creatura terribile disse anche che era stato lui a creare il cielo e la terra. E l’uomo si dimenticò di avere creato Dio lui stesso e gli credette, tanto l’unica cosa veramente importante per l’uomo era trovare una giustificazione per uccidere e sentirsi anche nel giusto per poi dividere i frutti del pianeta a vantaggio di un popolo rispetto gli altri popoli e, all’interno di quello stesso popolo, a vantaggio di una casta rispetto un’altra e poi sentirsi il padrone del mondo in generale e della donna in particolare. Perché sia la donna sempre maledetta che nel suo generare figli compie un assalto al cielo dal quale Dio, Il Sempre Invidioso, non può che sentirsi minacciato. 1. LA CREAZIONE E LO SVELAMENTO (seconda versione) [1] E quindi la storia venne scritta e si proclamò a gran voce: [2] Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e la leggenda di Dio, grazie soprattutto al controllo dei principali mezzi di informazione, aveva uno straordinario successo di pubblico e di critica. [3] Dio disse: «in nome dell’uomo sia la luce!». E la luce fu. 24 la rivista dell’ Arte [4] Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. [5] e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: questo fece Dio nel sogno dell’uomo e questo fu il primo sogno di Dio e gli uomini lo chiamarono il primo giorno. [6] Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque.» [7] Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento, dalle acque che son sopra il firmamento. E così avvenne. [8] Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: questo fece Dio nel sogno dell’uomo e questo fu il secondo sogno di Dio e gli uomini lo chiamarono il secondo giorno. [9] Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto.» E così avvenne. [10] Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E ordinò al confine tra la terra e il mare di non spostarsi mai, perché ad un massimalista come lui questo tipo di incertezze davano profondamente sui nervi. E Dio vide che era cosa buona. [11] E Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie.» E così avvenne. [12] la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie che Dio ordinò fosse per sempre fissa e inamovibile e maledì la progenie di chi s’azzardava a parlare di processi evolutivi. Dio vide che era cosa buona. [13] E fu sera e fu mattina: questo fece Dio nel sogno dell’uomo e questo fu il terzo sogno di Dio e gli uomini lo chiamarono il terzo giorno. [14] Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte; siano segni per le feste, per le stagioni, per i giorni e per gli anni [15] e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra.» E così avvenne. [16] Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte e le stelle. [17] Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra [18] e per governare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. Perché per Dio ogni cosa che nascesse doveva avere in sé e per sé una finalità regolatrice. E Dio vide che era cosa buona. [19] E fu sera e fu mattina: questo fece Dio nel sogno dell’uomo e questo fu il quarto sogno di Dio e gli uomini lo chiamarono il quarto giorno. [20] Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo.» [21] Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo 25 la rivista dell’ Arte la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. [22] Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra.» [23] E fu sera e fu mattina: questo fece Dio nel sogno dell’uomo e questo fu il quinto sogno di Dio e gli uomini lo chiamarono il quinto giorno. [24] Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie e tutti durante il sonno ristoratore siano in grado di sognare sogni che come la danza appartengano a tutto l’universo.» E così avvenne: [25] Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E tutti durante il sonno ristoratore nascano dai loro sogni e possano vivere nei sogni degli altri navigando nel mare immenso della danza. E Dio vide che era cosa buona. [26] E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini con la sua forza ingiusta che gli proviene da me che provengo da lui, sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.» [27] Dio e l'uomo quindi si plasmarono reciprocamente a loro immagine; a immagine di Dio lo creò, l’uomo perché potesse dire che assomigliava a Dio; E Dio disse che li aveva creati esclusivamente o uomini o donne, e li minacciò quindi a non accoppiarsi tra uomini o tra donne o a mettere in atto qualsiasi altra strana maledetta mescolanza non autorizzata direttamente ed esplicitamente dal Signore Dio Delle Regole Sessuali A Suo Piacimento, perché per la questione del reciproco rispecchiamento tra Dio e l’uomo, avrebbe minato la sua immagine di Dio vero uomo con il fallo più grande e più duro di un obelisco egizio, la cui solidità si doveva basare sulla certezza dell’unico, voracissimo e stabile desiderio femminile verso il fallo e solo il fallo. [28] Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e lordatela a vostro piacimento e convenienza, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra e mi raccomando, dimenticate la vostra origine terrena e dimenticatevi anche che le altre creature sono generate dai loro sogni come voi e che danzano con voi, perché altrimenti scuoiarle ancora palpitanti vi costerebbe un fastidioso imbarazzo.» [29] Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo e fregatevene della sofferenza del pianeta. [30] A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde.» E qui si dimenticò degli animali carnivori, ma le generazioni future degli uomini per millenni non avranno il coraggio di correggere le sviste del Signore Dio Dell’Universo E Delle Distrazioni. E così avvenne. [31] Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Contento lui contenti tutti. E fu sera e fu mattina: questo fece Dio nel sogno dell’uomo e questo fu il sesto sogno di Dio e gli uomini lo chiamarono il sesto giorno. 26 la rivista dell’ Arte Genesi - Capitolo 2 2. L’INGANNO INSOSTENIBILE DELLA FINTA LIBERÀ: IL PARADISO TERRESTRE [1] Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. [2] Allora Dio, nel settimo sogno dell’uomo che gli uomini chiamarono il settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò in quel sogno che gli uomini chiamarono giorno, ogni suo lavoro. [3] Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. E dio disse che il settimo giorno anche la danza dovesse cessare e i sogni smettessero di essere sognati. Questo Dio ordinò. Ma sulla danza e sui sogni pressoché nullo era il potere di Dio, Il Signore Che Fa Spesso Cilecca. [4] Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati dal Signore Dio Al Servizio Del Popolo Eletto E Dei Discendenti Di Chi Faceva Comodo A Lui o per meglio dire a coloro i quali lo aveva inventato. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo [5] nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo, [6] ma una polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. [7] Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. [8] Poi il Signore Dio si accorse dell’esistenza di una rigogliosa foresta che si chiamava Eden, a oriente, disse che era stato lui a crearla e vi spedì l'uomo che aveva plasmato. [9] Il Signore Dio aspettò che germogliassero dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e appena germogliati disse che era stato lui a farli germogliare e l’uomo gli credette ancora una volta. [10] Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. [11] Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione di Avìla, dove c'è l'oro [12]e l'oro di quella terra è fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. [13] Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre attorno a tutta la regione d'Etiopia. [14] Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Anche la faccia tosta di Dio ha un limite e qui almeno non millantò che la disposizione di questi fiumi fosse opera sua. [15] Il Signore Dio chiamò l'uomo e gli donò con gran pompa il giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Tanto non gli era costato nulla e poi sapeva che in quel momento storico nessun altro lo avrebbe potuto reclamare come suo. Ma il Signore Dio aveva sempre più paura che l’uomo si ricordasse che era stato lui a generarlo ed allora 27 la rivista dell’ Arte pensò che un sistema per tenere l’uomo soggiogato consistesse nel dargli delle regole meglio se assurde ed incomprensibili perché i misteri più sono fasulli e più fascino e potere riescono ad esercitare sull’uomo, la creatura più ingenua e crudele dell’universo costruito e conosciuto dall’uomo stesso. E il Signore Dio allora scelse a caso un albero qualunque tra i tanti del giardino di Eden. [16] Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, [17] ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui ne mangeresti, certamente dovrai morire.» A dimostrazione della sua grandezza, nel dire questa balla, enorme persino per Dio, nemmeno un vago rossore pervase il suo grande faccione delle dimensioni del firmamento. E disse tutto questo invece come se stesse descrivendo l’architrave dell’universo e con il suo solito tono minaccioso, Lui Il Signore Dio Delle Scenografie, Re Dei Prestigiatori e Imperatore del “Ti Avevo Avvertito”. Era sereno Dio perché era chiaro a chiunque che le sue parole non fossero minacce ma inviti a trasgredire, e grande sarebbe stata la sua tristezza se i suoi ordini fossero sempre stati ascoltati. Questo pensava Dio, il Signore che si nutre dei peccati dell’uomo. Questi i pensieri di Dio che voleva accadesse un evento terribile al confine tra lui e l’uomo, questo aspettava Dio, il Signore del Tanto Peggio per l’Uomo Tanto Meglio per Lui. [18] Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo e che passi tutto il suo tempo a masturbarsi: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile.» [19] Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Poiché il primo baluardo del potere del Signore Dio e del suo creatore, l’uomo, è sempre stato e sempre sarà il controllo delle classificazioni e delle nomenclature. [20] Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile e gradito, quindi a parte qualche sfogo zoofilico, continuava a masturbarsi dalla mattina alla sera. [21] Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto che nemmeno un chirurgo egiziano avrebbe fatto di meglio. [22] Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. [23] Allora l'uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta.» E la donna si dimenticò che era stata lei a creare l’uomo che a sua volta aveva creato Dio e credette anche lei all’ennesima balla di Dio. [24] E Dio disse: «Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 28 la rivista dell’ Arte saranno una sola carne.» [25] Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. E questa mancanza di vergogna preoccupò assai Il Signore Dio della Colpa E Della Punizione Quando Fa Comodo A Qualcuno Dei Suoi. Genesi - Capitolo 3 LA SCOPERTA DELL’INGANNO DI DIO E LA NASCITA DELL’ARTE [1] Ma la vita nell’Eden era terribilmente noiosa, l’uomo non aveva nemmeno più la voglia di fare caso ai sogni e di godere del proprio corpo vicino e dentro il corpo di un’altra persona, trovando molto più gratificante rispecchiarsi nella figura di Dio. Poiché ogni grande fede altro non è che una raffinatissima forma di amore esclusivo per sé stessi. Anche perché Dio, ogni giorno che passava, si convinceva sempre più di esistere veramente. E la donna incontrò il serpente che si stava scaldando al sole sempre caldo dell’Eden. E la donna disse: «è vero che sei la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio?» «Assolutamente no, » rispose il serpente, «è solo un sistema che si è inventato il Signore Dio per sentirsi autorizzato a calpestarmi, è la vecchia storia che più stai in basso e più gli altri ti maltrattano e per non sentirsi in colpa si sforzano di immaginare che sei pericoloso e mica gli basta, dopo un po’, a causa del vuoto che hanno creato in loro per il presunto bisogno di separarsi dal resto del mondo e della continua ricerca di qualcosa di grande che riempia quel vuoto terribile, cominciano pure a fantasticare che hai chissà quali capacità particolare o poteri nascosti, ed allora sei proprio fottuto.» E la donna disse al serpente: «ho fatto un sogno. Ho sognato che incontravo un serpente e il serpente entrava nella mia vagina e ne godevamo entrambi, il mio uomo non si dispiaceva di questo perché il serpente insegnava ad entrambi come fare vibrare delle foglie di fico suonando una musica che non aveva mai sentito e poi ci insegnava a noi persone a danzare al ritmo di quella musica e tutto l’universo ne godeva.» Il serpente disse alla donna: «E' vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». [2] Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, [3] ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete.» [4] Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Del resto, come si suol dire, un Dio che Dio è se non esagera almeno un po’?» E continuò il serpente: [5] «Comunque il fatto è che Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e vi rendereste conto che Dio altro non è un vostro sottoprodotto, comprendendo quanto siano relativi il bene e il male. Mettiti nei suoi panni, impedirvi di mangiare i frutti di quell’albero ha una sua logica, per Dio.» 29 la rivista dell’ Arte [6] Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. [7] Allora si aprirono gli occhi di tutti e due, il torpore in cui il Signore voleva che vivessero scomparve e si accorsero di essere nudi e di avere freddo; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero degli indumenti per proteggersi dal freschetto della sera. E le loro dita danzavano mentre intrecciavano quelle foglie. E mentre intrecciavano quei rami il vento dell’Eden li fece vibrare e si sentì una musica come mai si era sentita nell’universo. E quella musica fece danzare l’uomo e la donna come non avevano mai danzato e fece loro ricordare che era stata proprio la danza a generarli. E le vesti che avevano intrecciate con le foglie di fico gli apparvero, improvvisamente, rozze e poco funzionali. E allora la donna disse all’uomo: «tutto questo è stato generato prima in un sogno ed è figlio della danza, e il sogno e danza non possono essere fermati e nemmeno appartenere solo e per sempre a qualcuno; quindi ora potremmo rendere le nostre opere e le nostre vite ancora migliori, se gli dedicheremo, insieme, un po’ di tempo.» la 30 rivista dell’ Arte Arti Terapie e Terapie Espressive Roberta Mazzullo AMMALARSI IN RETE: L’ESPERIENZA DI GRUPPO IN INTERNET Una ricerca sull’Internet Addiction in adolescenti siciliani La ricerca dell’identità nell’era del web Con la ricerca della propria identità ogni individuo si confronta continuamente nel corso di tutta la sua esistenza. Sin dalla nascita ciascuno percepisce il proprio esistere nella relazione con la madre, in uno scambio simbiotico fatto di intrecci e intese; ma l’identità individuale tesse ben presto la sua trama nello spazio del sociale. Attraverso gli altri, l’individuo riconosce e investe di significato parti di sé altrimenti inconsapevoli, in un gioco di proiezioni e rappresentazioni. La relazione con l’altro consente di appropriarsi di sé, ma anche di trasformarsi ed evolversi: in atre parole, conferisce dinamismo all’identità. In adolescenza, epoca di massicce trasformazioni psicocorporee, il percorso che porta alla conquista di un’identità adulta è fisiologicamente caratterizzato da inquietudine e insicurezza, ma al tempo stesso da curiosità e desiderio di cambiamento. Sebbene la costruzione dell’identità sia un percorso che coinvolge in diversa misura tutte le epoche della vita, è proprio nel corso dell’adolescenza che appare più suscettibile alle possibilità evolutive, ma anche al viraggio in senso psicopatologico. Nell’avventura della crescita dell’adolescente, il rapporto con i gruppi familiari e sociali del suo ambiente rappresenta uno spazio evolutivo, un terreno di scambio e scontro, opportunità di rispecchiamento ma anche 31 la rivista dell’ Arte di contrasto. Gli studiosi dei processi di gruppo hanno descritto il piccolo gruppo come quello spazio protetto i cui componenti ricreano insieme una condizione di intimità che ricorda per certi aspetti la protezione materna. Nel piccolo gruppo ogni singolo componente trova un contenitore per l’identità che è proprio quello spazio creato dallo stringersi assieme identificandosi nell’essere gruppo. È proprio il piccolo gruppo che l’adolescente sperimenta come possibilità di transito dal gruppo familiare al gruppo sociale allargato. Nel grande gruppo, invece, la condizione idealizzata di protezione materna viene meno; in un anonimato collettivo si può sperimentare un vissuto di smembramento e di perdita, ripagato però da una nuova possibilità di pensare e porsi in rapporto con la realtà circostante. Mentre il piccolo gruppo è lo spazio privilegiato dell’intersoggettività, il grande gruppo rappresenta lo spazio dell’identità collettiva. Nella ridefinizione dei confini del sé, il soggetto accede al senso di appartenenza comunitaria e ad uno spazio di pensiero comune e condiviso. Il fenomeno Internet ha reso ancora più complessi questi fenomeni gruppali, aggiungendovi la fondamentale variante costituita dalla possibilità di sperimentare queste dinamiche individuali e collettive all’interno di un contesto virtuale. Come i gruppi della vita reale anche i gruppi virtuali possono essere molto vari e diversi tra loro. Alcuni gruppi sono formati da persone che si conoscono e che si servono della rete semplicemente come mezzo per tenersi in contatto e scambiarsi idee tra un incontro e l’altro. Altri gruppi virtuali raccolgono via internet persone che hanno interessi comuni, ma che non si conoscono nella vita reale e non hanno alcuna prospettiva di incontrarsi. È proprio in questi gruppi che il senso di appartenenza e la gruppalità possono emergere soltanto attraverso le dinamiche della comunicazione on-line. Nel cyberspazio è possibile ricreare il piccolo gruppo e, nonostante la natura spesso fragile ed effimera di molti forum e social network in cui si chatta tra due o pochi membri, questa possibilità consente a vari piccoli gruppi di ritrovarsi insieme e confrontarsi, magari enfatizzando l’idealizzazione del proprio gruppo in opposizione alle mancanze e imperfezioni degli altri gruppi. In rete, però, si sperimenta anche e soprattutto qualcosa che ci ricorda il grande gruppo e i fenomeni di collettivizzazione dell’identità: la mente produce con facilità immagini, emozioni, vissuti corporei riferibili non tanto a sé, bensì al contesto in cui si è immersi. Il senso di appartenenza è centrale nell’esperienza di gruppo, dove ha anche potenzialità terapeutiche. Il 32 la rivista dell’ Arte gruppo assolve una funzione di “pelle mentale”: regola i livelli percettivi ed emotivi dell’esperienza individuale, delimita uno spazio mentale collettivo in cui i singoli membri elaborano e metabolizzano pensieri individuali, attraverso funzioni mentali che si attivano nel gruppo e di cui ciascun singolo individuo a suo modo si appropria. Sul web lo spazio collettivo non è visibile né tangibile: si tratta di uno spazio virtuale i cui confini sono i sentimenti di appartenenza e di differenziazione tra ciò che è gruppo e ciò che non è gruppo. Tuttavia, nel caso di gruppi esistenti nel cyberspazio “uscire dal gruppo” significa rituffarsi nel reale, un reale spesso socialmente impoverito, dato lo scarso investimento relazionale di chi, alle prese con l’attività on-line, ha diradato i contatti con il proprio mondo. Risulta perciò assai interessante studiare l’epidemiologia di questo fenomeno: di come cioè nella popolazione degli adolescenti l’impoverimento delle relazioni sociali, sempre più massivamente sostituite da una socialità virtuale, contribuisca allo strutturarsi di condizioni psicopatologiche. Il seguente lavoro fa riferimento a una ricerca esplorativa attuata sul fenomeno di abuso e dipendenza da Internet, realizzata in tre istituti scolastici medi superiori della Sicilia orientale. Effettuata con questa prima ricerca una iniziale ricognizione del fenomeno Internet Addiction nella realtà locale, il lavoro mira ad individuare fattori predittivi e indicatori di rischio e ad enucleare fattori protettivi nei confronti dell’esito sindromico, nella prospettiva della prevenzione e del supporto ai clinici e agli educatori. Internet Addiction Disorder (IAD) Il disturbo da dipendenza patologica (addiction), da sostanze ma anche da comportamenti (ad es. gioco d’azzardo, sesso, internet, shopping complusivo), rappresenta oggi un fenomeno assai diffuso e di grande interesse sociale. L’avvento di Internet ha avuto grandi risvolti in termini di evolutività e crescita personale e sociale e ha modificato profondamente in senso antropologico, come tutti i grandi cambiamenti culturali, il nostro modo di stare al mondo. Negli ultimi anni sono stati descritti numerosi casi di abuso, dipendenza, dissociazione dalla realtà (confusione ideativa tra ciò che è reale e ciò che è virtuale), impoverimento delle relazioni e, paradossalmente, della cultura, originariamente intesa come “processo cognitivo umano che avviene dentro e fuori le menti delle persone e i membri di una società” (Edwin Hutchins). Oggi assistiamo al diffondersi di una cultura “tecno-mediata”, in cui portali di informazione rapida e sintetica rappresentano spesso l’unica 33 la rivista dell’ Arte fonte di sapere. Adolescenza e fenomeni di dipendenza La fase adolescenziale sembra particolarmente critica quanto allo sviluppo di comportamenti dipendenti. Dalla ricerca di Baiocco e coll. (2003, 2004) emerge chiaramente che già intorno ai 13 anni si evidenziano i primi comportamenti problematici e che questi iniziano a configurarsi come una vera e propria sindrome da dipendenza verso i 17 anni. La ricerca sulle dipendenze, oltre ad indagare la prevalenza e la rilevanza del fenomeno, è indirizzata a comprenderne la natura e a evidenziarne i fattori di rischio e di protezione, al fine di sviluppare adeguati programmi di prevenzione. In questa direzione, abbiamo implementato un protocollo di indagine finalizzato ad una prima ricognizione esplorativa sul fenomeno nei giovani del nostro territorio, nel quale, a differenza di quanto realizzato in altre aree geografiche, non è ancora stato condotto uno studio sistematico sul fenomeno dell’Internet Addiction. La popolazione oggetto del nostro studio è costituita da studenti delle scuole superiori. Dipendenze e identità di genere Uno studio italiano del 2003-2004, attuato in diverse scuole secondarie di Roma e provincia su circa 800 studenti, ha analizzato l’incidenza delle principali forme di dipendenza in adolescenza, la relazione tra le dipendenze e altre variabili connesse a tale forma di disagio (variabili di personalità, variabili motivazionali, cognitive e psicosociali). Nello studio citato i ragazzi mostrano punteggi più elevati alle scale che misurano la dipendenza da sostanze e da tecnologia e alla scala della dipendenza da sesso, mentre le ragazze presentano scores più alti alle scale del comportamento alimentare, da shopping e alle diverse dimensioni che misurano le dipendenze affettive. Fattori predittori L’esperienza clinica con adolescenti evidenzia, in ogni caso, una forte relazione tra le difficoltà nella sfera personale e relazionale e i comportamenti problematici in merito alle nuove tecnologie. In merito all’item “uso/abuso di tecnologia”, i fattori predittivi maggiormente significativi si riferiscono alle seguenti variabili: impulsività, suscettibilità alla noia, ricerca di esperienze. Altri studi hanno evidenziato la presenza di altri fattori che influenzano significativamente lo sviluppo di la 34 rivista dell’ Arte comportamenti di Internet Addicition: - l’applicazione ad attività di studio o professionali in cui è previsto l’uso costante del computer (es. ingegneri e giornalisti); - il tipo di attività svolta su Internet: l’utilizzo di Internet per socializzare è maggiormente associato al rischio di dipendenza. Correlazione tra IAD, depressione, rendimento scolastico e abilità di auto-controllo Recentissime ricerche suggeriscono la presenza di una correlazione positiva tra uso patologico di Internet e rischio di depressione. Uno studio prospettico, condotto su adolescenti di età compresa tra 13 e 16 anni, svolto in Guangzhou (Southeast China) nel Giugno 2008, ha evidenziato che il rischio di sviluppare depressione è 1,5 volte superiore in coloro che fanno un uso patologico di Internet. Le spiegazioni addotte in merito alla correlazione positiva tra rischio depressivo e uso patologico di Internet enfatizzano la perdita di sonno e l’importante coinvolgimento emotivo indotto dalle attività svolte on line, che talora inducono stati di agitazione, frustrazione e perdita del controllo. Se è vero che un uso patologico di Internet incrementa il rischio di depressione, d’altra parte è da notare anche il circolo vizioso che si instaura tra l’isolamento sociale e un uso di Internet che può diventare patologico. Si è inoltre evidenziato che il grado di Internet Addiction influenza in maniera inversamente proporzionale il profitto accademico, determinando un peggioramento del rendimento scolastico. Inoltre, il grado di Internet Addiction si correla anche con la corretta percezione che il soggetto ha di controllare il proprio comportamento: buone risorse cognitive e di controllo si associano infatti a un basso livello di Internet Addiction. L’indagine esplorativa preliminare: materiali e metodi Il nostro studio ha voluto esplorare quanto i sintomi dell’IAD siano rappresentati nella popolazione adolescenziale in relazione a variabili sia individuali (quali il sesso e l’ età) che socioculturali (quale il tipo di istituto superiore frequentato). Allo studio hanno partecipato 186 adolescenti (111 maschi e 75 femmine). La loro età media era 16,7 (± 1,5). I ragazzi partecipanti allo studio frequentavano la scuola superiore: in particolare, 36 ragazzi la 35 rivista dell’ Arte frequentavano il Liceo Scientifico (19 M e 17 F), 70 ragazzi l’Istituto Alberghiero (18 M e 52 F), 80 ragazzi l’Istituto Tecnico per geometri. In relazione all’età il campione è stato suddiviso in tre gruppi: - età inferiore a 16 anni; - età compresa tra i 16 e i 17 anni; - età pari o superiore ai 18 anni. In tabella è riportata la distribuzione del campione per sesso, per età e per istituto di appartenenza. maschi femmine <16 aa 16-17 aa ≥18 aa 19 17 0 21 15 36 19,35% Ist. Alberghiero 18 52 25 22 23 70 37,63% I.T. Geometri 74 6 26 36 18 80 43,01% 111 75 51 79 56 186 59,68% 40,32% 27,42% 42,47% 30,11% Liceo Scientifico TOTALE Totale Lo strumento testologico utilizzato nel nostro studio è stata la scala CIAS (Chen Internet Addiction Scale), validata in lingua italiana (traduzione di R. Mazzullo). La scala CIAS è composta da 26 item che fanno riferimento a cinque dimensioni patologiche correlate all’uso di Internet: • compulsività • tendenza all’isolamento • tolleranza • problemi nelle relazioni interpersonali e problemi di salute • difficoltà di gestione del tempo. Le sottoscale “problemi nelle relazioni interpersonali, problemi di salute” fanno riferimento alla sintomatologia manifestata in situazioni di abuso (nella scala vengono indicati come sintomi correlati all’uso di Internet), le sottoscale “tendenza all’isolamento” e “tolleranza” fanno invece riferimento alla la 36 rivista dell’ Arte sintomatologia manifestata in situazioni di dipendenza (nella scala vengono indicati come sintomi core). È già dimostrata in letteratura una correlazione positiva tra punteggio totale alla scala CIAS e numero di ore trascorse su Internet. Scopo dello studio è stato esaminare nel campione la presenza e il grado dei sintomi da dipendenza e abuso di Internet in relazione alle seguenti variabili: - fascia di età; - sesso; - tipo di Istituto frequentato. Risultati Dallo studio emerge che: - gli alunni del Liceo Scientifico risultano avere comportamenti problematici correlati all’uso di Internet di entità significativamente maggiore rispetto agli alunni dell’Istituto Tecnico per geometri e rispetto a quelli dell’Istituto Alberghiero; - i maschi presentano, rispetto alle femmine, punteggi significativamente più elevati sia dei sintomi core che dei sintomi correlati all’uso di Internet, quindi in maggior grado sia sintomi di abuso che di dipendenza. 37 la rivista dell’ Arte Discussione Dall’analisi dei risultati è possibile individuare un cluster sintomatologico, comune alle altre patologie da abuso e dipendenza, in cui i sintomi cardine sono descritti dagli item della scala relativi ai problemi correlati all’uso di Internet. Tale cluster sintomatologico è frequentemente manifesto nella popolazione dei sedicenni e dei diciassettenni, con particolare espressività negli studenti liceali. Esso costituisce per il clinico una “spia” che permette di individuare il problema al suo esordio, suggerendo un’analisi più approfondita delle condotte di vita quotidiane del paziente. La maggiore rilevanza nei liceali dei sintomi d’abuso (rispetto ai coetanei dell’Istituto Tecnico) e dei sintomi di abuso e di dipendenza (rispetto ai coetanei dell’Istituto Alberghiero) suggerisce come una maggiore applicazione in attività tecniche e pratiche possa in qualche modo proteggere dall’utilizzo 38 la rivista dell’ Arte eccessivo del PC e, di conseguenza, dall’insorgenza di sintomi di abuso e dipendenza da Internet. Le attività proposte da queste scuole, attraverso un fare che è innanzitutto pratico, concreto e inserito in un tempo e in uno spazio (ad es. esercitazioni di disegno, attività di tirocinio presso strutture turistiche, etc.) forse contengono il rischio dell’”alienazione” dalla realtà e orientano a un maggior investimento nel “qui e ora”, presupposto fondamentale per i processi di simbolizzazione. È interessante notare come coloro che presentano in grado maggiore sintomi di abuso e di dipendenza, al punto da raggiungere alla scala significatività clinica, a prescindere dal tipo di istituto superiore frequentato, sono i ragazzi di età maggiore o uguale a 18 anni, probabilmente per un maggiore grado di consapevolezza legato alla maturità acquisita e anche per il maggiore utilizzo di Internet che viene fatto in relazione alle necessità di informazione e alle possibilità offerte dal web. Con il decrescere dell’età diminuiscono anche i sintomi d’abuso e quelli di dipendenza, che raggiungono di rado significatività clinica. Conclusioni L'informatica, la telematica e la multimedialità hanno generato una vera e propria rivoluzione culturale. La nostra epoca muove i primi passi verso una seconda alfabetizzazione; dall'era di Gutenberg all'era elettronica, dal libro stampato al libro digitale, il computer si è rivelato non solo una macchina per l'elaborazione di dati, ma anche un potente strumento per la comunicazione di contenuti, in grado di influire in misura insospettabile sulla formazione delle strutture psichiche stesse. Più l'informatica e l’utilizzo di Internet invadono la nostra dimensione quotidiana, più generano sospetti e preoccupazioni. In particolar modo assistiamo, già nei giovanissimi, all’emergere di problematiche psicosociali strettamente connesse all’uso di Internet che vanno dall’abuso di informazioni all’isolamento sociale e alla perdita di contatto con la realtà (confusione dissociativa tra il reale e il virtuale). La nostra indagine, rivolta a quella fetta di popolazione che vive il periodo più stressante e difficile della crescita, evidenzia problematiche di abuso di Internet che, pur non raggiungendo spesso significatività clinica, si collocano parimenti oltre il limite della normalità. Tali problematiche vengono espresse con sintomi secondari legati all’eccessivo uso di Internet: difficoltà di gestione del tempo, problemi fisici, problemi nelle relazioni interpersonali. In alcuni casi, e ciò avviene prevalentemente in coloro che hanno età pari o superiore ai 18 anni, emergono anche sintomi di dipendenza, quali isolamento, compulsività e tolleranza. Le riflessioni seguite a questa analisi del territorio mettono in evidenza sia fattori predittivi che fattori 39 la rivista dell’ Arte protettivi rispetto all’insorgenza di IAD. Tra i fattori predittivi evidenziamo innanzitutto la latente positività al cluster dell’abuso, riscontrata in molti ragazzi della fascia di età 16-17 anni, prevalentemente coloro che frequentano il liceo. Tale cluster sintomatologico, i cui sintomi cardine sono rappresentati da difficoltà di gestione del tempo, problemi fisici e nelle relazioni interpersonali, deve rappresentare un’importante spia del problema per i genitori, gli insegnanti e i clinici. Tra i fattori protettivi menzioniamo innanzitutto la possibilità di condividere in un contesto sociale le esperienze di crescita culturale, anche quelle che hanno come apparente protagonista Internet. Le agenzie formative, la scuola in primo luogo, dovrebbero prevedere un utilizzo delle risorse della rete che sia in primo luogo condivisibile nel gruppo in formazione e, in secondo luogo, condizionabile dal processo di sviluppo creativo del gruppo. In altre parole, è fondamentale che tutto ciò che proviene dalla rete, materiale spesso di grande interesse e poliedricità, possa essere sottoposto a discussione tra i membri del gruppo, elaborato secondo le risorse personali di ciascun individuo e divenire quindi prodotto originale, creazione di un gruppo “pensante”. Uno strumento formidabile e dalle mille risorse quale Internet ha un delicato “tallone d’achille”: illudere l’individuo di poter far tutto da solo, alimentare cioè il delirio narcisistico del nostro secolo. Da un vertice clinico, gettiamo allora un ponte verso un ambito disciplinare di strategica importanza sociale: la pedagogia scolastica. Compito fondamentale di genitori e insegnanti è cogliere lo spirito del proprio tempo, seguire i giovani sul terreno fertile delle nuove esperienze e acquisizioni, valorizzandone gli aspetti positivi ed evolutivi, portando il proprio bagaglio di umanità anche nel cyberspazio e nel cybertempo, dove abita il presente di molti ragazzi. In una frase di Tibor Vamos, professore all'Accademia delle Scienze ungherese, troviamo il senso profondo di tutto ciò: «occorre che gli studi di base includano l'epistemologia e la sua evoluzione storica nella nostra cultura. Ciò favorisce lo sviluppo di un atteggiamento a vedere le cose in profondità e da differenti punti di vista, a pensare nella misteriosa metrica del tempo, ed anche a considerare la continuità e il cambiamento come processi tra loro paralleli. Le scienze e le arti sono espressione, documentazione e prova di questo procedere che è eterno, per quel che ciò possa significare per l'uomo. In sostanza, perché si sviluppi rapidamente un contesto di macchine intelligenti, abbiamo bisogno di una educazione che sempre più consideri la cultura nel suo senso storico tradizionale». 40 la rivista dell’ Arte La cultura, nel suo senso storico tradizionale, è proprio questo: il precipitato e la continua ricombinazione di un processo di gruppo, il continuo discutere degli individui per trovare, attraverso un processo adattivo, «soluzioni parziali a problemi incontrati di frequente» (Edwin Hutchins). Con le parole di Dan Sperber, «la cultura è il precipitato della comunicazione in una popolazione umana». Nell’epoca della rivoluzione informatica, Internet si situa a un decisivo crocevia: così come può offrire il fianco al gioco perverso dell’isolamento e dell’addiction, altrettanto può assumere il ruolo di amplificatore dei processi comunicativi e creativi nelle comunità umane, segnatamente di quelle giovanili; quanto sarà valorizzata questa potenzialità e quanto arginati i rischi dipenderà allora in misura significativa dal ruolo svolto dagli educatori, dalle famiglie, dai tecnici e dai clinici. È nella comunicazione tra le persone che vanno ricercate le possibilità che offre lo strumento e i limiti affinché il modo di utilizzarlo non diventi malattia. Bibliografia Baiocco R., Couyoumdjian, Del Miglio Carlamaria Le dopendenze in adolescenza in ( a cura di) Caretti V., La Barbera D. (2005) Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia. Raffaelo Cortina, Milano, 2005. Caretti V., La Barbera D. (2001) Psicopatologia delle realtà virtuali. Masson, Milano Caretti V., Di Cesare G. “Psicodinamica delle dipendenze” in ( a cura di) Caretti V., La Barbera D. (2005) Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia. Raffaelo Cortina, Milano, 2005. Caretti V. La Barbera D., Craparo G. Mangiapane E. La correlazione tra alessitimia e dissociazione nella dipendenza patologica. Nuove prospettive di ricerca sull’addiction in ( a cura di) Caretti V., La Barbera D. (2005) Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia. Raffaelo Cortina, Milano, 2005. Chen K., Chen I. e Paul H. (2001) Explaining online behavioural differences: an Internet dependency perspective. The journal of computer Information Systems, 41 (3): 59-63. Chen K, Tarn M. e Han B. T. (2004) Internet dependency: its impact on line behavioural patterns in ecommerce. Human System Management, 23: 49-58. Chen S. H., Weng L. J. , Su Y. J. , Wu H. M., Yang P. F. (2003) Development of a Chinese Internet Addiction Scale and its Psychometric Study. Chin J Psychol. La Barbera D. La Rete che connette, La Rete che cattura: metafore della “esperienza” Internet in (a cura di ) La Barbera D. Le dipendenze tecnologiche. La mente dei nuovi scenari dell’addiction “tecno-mediata” in ( 41 la rivista dell’ Arte a cura di) Caretti V., La Barbera D. (2005) Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia. Raffaelo Cortina, Milano, 2005. Li S.M., Chung T.M. (2004) Internet function and Internet addictive behaviour. Computers in Human Behavior 22 (2006) 1067-1071. Neumann P.G., 1998. Are computers addictive? Communications of the ACM, 41(3): 128. Palmonari A. (1990) Fenomenologia e funzionamento dei gruppi di coetanei nell’adolescenza, in G. Setter e F. Tessari (a cura di), L’associazionismo educativo, La Nuova Italia, Firenze Russo C., Bellia V. “Le matrici sociali nell’adolescenza” in Barone R., Bellia V., Bruschetta S. (a cura di) “Psicoterapia di comunità. Clinica della partecipazione e politiche di salute mentale”. Franco Angeli, Milano, 2010. Soule L.C. Shell W. e Kleen B. A., 2003. Exploring internet addiction: demographic characteristics and stereotypes of heavy internet users. The Journal of Computer Information Systems, 44 (1): 64-73. Young K. S. , 1998. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology & Behavior, 1:237-244. Wang W. (2001). Internet dependency and psychosocial maturity among college students. la 42 rivista dell’ Arte Arti Terapie e Terapie Espressive Vincenzo Bellia UN CORPO TRA ALTRI CORPI Introduzione alla DanzaMovimentoTerapia Espressivo-Relazionale Sulle due opposte sponde dell'oceano Atlantico, intorno alla metà del secolo scorso, in due ospedali, entrambi affollati da traumatizzati di guerra, vedevano la luce pressoché contemporaneamente due discipline che, nei decenni successivi, avrebbero dato importanti contributi all’universo clinico: la gruppoanalisi e la danzaterapia. Nel suo primo libro dedicato alla gruppoanalisi, Foulkes (1948) affermava che «Il mondo della realtà, il corpo e la comunità sono le coordinate della terapia». Nei primi scritti (1942) di Marian Chace, cui si devono gli inizi della danzaterapia, leggiamo che «non esiste un corpo: un corpo è un corpo tra altri corpi». In un contesto clinico-scientifico sino ad allora dominato dalla centralità dell’individuo e di uno psichismo 43 la rivista dell’ Arte per certi aspetti disincarnato, non è un caso forse che due approcci alla cura fortemente orientati alla dimensione relazionale, al corpo vissuto e alla realtà comunitaria dell’umano esistere siano nati entrambi in un’epoca di emergenza sociale ed entrambi nei luoghi del bisogno. L’approccio di Marian Chace alla danzaterapia e alla gruppoanalisi sono due ingredienti fondamentali della Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale (Dmt-ER), per giungere alla quale, però, dobbiamo fare un salto di circa mezzo secolo. La Dmt-ER, infatti, è una realtà tutta italiana che si è sviluppata negli anni novanta del secolo scorso, anch’essa in un contesto psichiatrico, specie ai suoi inizi. Nata dalla forte impronta antropologica della nostra formazione in Dmt e da tanti laboratori di Expression Primitive nei centri diurni, nelle comunità, nei servizi per le tossicodipendenze, nelle scuole medie, la Dmt-ER si è ben presto configurata come un metodo utile a rendere disponibili le potenzialità terapeutiche e aggregative del corpo creativo nei diversi spazi della cura e della convivenza sociale. Danzaterapia… in che modo la danza può curare? Presi dalla suggestione antropologica, scorriamo attraverso le epoche e i continenti le tante pratiche di guarigione che si svolgevano e si svolgono sugli scenari della danza, in una dimensione rituale di vibrante partecipazione comunitaria. France SchottBillmann (1994, 1995) si rifà a Lévi-Strauss (1958) per spiegarne la funzione in termini di efficacia simbolica. In particolare, sottolinea l’importanza rivestita dalla riattivazione delle strutture ritmiche che costituiscono la trama stessa dell’organizzazione dello psichismo e della vita di relazione, oltre che della fisiologia del corpo. Rileggendo Marian Chace, in effetti, ci sentiamo dire che il razionale della danzaterapia risiede proprio nella spontanea risposta motoria allo stimolo ritmico musicale. Il corpo vivente, ogni corpo vivente, qualunque sia il suo grado di disorganizzazione psichica, risponde sempre spontaneamente con il movimento ritmico alle sollecitazioni ritmiche, e ciò costituisce il presupposto stesso della vitalità e della comunicazione. Anche le stereotipie motorie, però, le percepiamo come ritmiche. Come un disco incantato, la psicopatologia ripropone la caricatura della ritmicità in movimenti autoreferenziali e afinalistici. I ritmi vitali, invece, si svolgono in un’intrinseca relazionalità (con gli altri, con l’ambiente, con l’altro-in-sé) e obbediscono a una fors’anche inconsapevole intenzionalità. Non a caso, dopo le prime esperienze in 44 la rivista dell’ Arte ospedale psichiatrico Marian Chace ebbe a osservare che lo scopo principale della danzaterapia è articolare l’individuo al gruppo. Quest’affermazione non è riducibile a una valenza meramente socializzante della Dmt. Alla luce delle recenti acquisizioni scientifiche sui neuroni-specchio, sembrerebbe che innanzitutto sul piano neurofisiologico la vita di relazione sia essenziale allo sviluppo, al mantenimento e all’evoluzione dell’essere umano. In effetti, la Dmt esplica la sua funzione terapeutica specifica entrando nei processi di organizzazione dell’immagine del corpo, che oggi sappiamo alimentati pressoché interamente dall’intreccio di rispecchiamenti che sottende la vita di relazione. In un’epoca culturalmente inebriata dalla suggestione kleiniana, in cui l’immagine del corpo era considerata mera proiezione di oggetti interni, Marian Chace affermava già che «l'immagine del corpo è soprattutto un prodotto sociale», individuava nell’isolamento relazionale una determinante fondamentale dei disturbi dell’immagine corporea e indicava nella riconnessione individuo-gruppo (mediante un’esperienza di diretta implicazione corporea) la via da seguire per l’intervento terapeutico. Non esiste un corpo (svincolato dalle sue interconnessioni relazionali e dalla dinamica dell’incontro): un corpo è un corpo tra altri corpi, l’esperienza vitale è un essere-con, la vita emozionale è nutrita dall’esperienza della com-mozione, che è un muoversi insieme – una danza. Già negli anni settanta, d’altra parte, gli esperimenti sulla deprivazione sensoriale avevano ampiamente dimostrato come dalla disconnessione senso-motoria discendesse immediatamente la psicopatologia: allucinazioni, deliri, distorsioni dell’immagine corporea. Danzaterapia come specifico intervento sull’immagine corporea, dunque, come intervento specificamente relazionale… Per la Dmt-ER questo assunto è addirittura basilare, sia che si tratti di pulsare ritmicamente con il gruppo nell’azione collettiva, sia che invece ci si trovi a co-inventare inedite tracce coreografiche in un gioco di dialogo motorio. L’intrinseca relazionalità dei processi di (trans)formazione dell’immagine corporea in Dmt-ER ben si armonizza, del resto, con l’influenza gruppoanalitica. Foulkes, infatti, considerava l’individuo come concepito da una matrice relazionale; Napolitani (1987) ha descritto il processo creativo nella cornice della dialettica tra Idem (istanza di identificazione) e Autos (istanza di differenziazione), in altre parole tutto all’interno di una dinamica relazionale. Nella filosofia e nel modo di procedere della Dmt-ER c’è un altro elemento essenziale, che risulta però 45 la rivista dell’ Arte culturalmente indigesto: il piacere. I colleghi francesi della SFDT (1997)1 lo hanno preso in considerazione: pur sottoposto a un po’ di maquillage (parlano di piacere funzionale), è stato inserito in una lista di cinque obiettivi della Dmt, tra i quali però non mi sembra sia stata individuata alcuna particolare priorità. Tra i danzaterapeuti2 non c’è accordo sulla centralità dell’esperienza del piacere nella Dmt; tra i pazienti invece sì. Del resto, tra i danzaterapeuti non c’è accordo neppure sulla centralità della danza. Ahimè, quanto perturbante ed eversivo continua a risultare lo spirito dionisiaco, che nel piacere e nella danza emerge sfrontato! Il piacere è un’esperienza di cui, come psicopatologi, riconosciamo con prontezza l’importanza quando è assente (nell’anedonia, per l’appunto), ma alla quale, come terapeuti, siamo assai meno inclini a conferire diritto di cittadinanza nel processo clinico, men che mai un ruolo protagonista! Il piacere, però, è dimensione fondante dell’esistenza. Non sono molte le metodologie cliniche che possono far appello direttamente all’esperienza del piacere, forse solo le arti terapie. È nella capacità di provocare uno “choc estetico”, osserva France Schott-Billmann, che risiede il genio delle arti terapie, il loro potenziale terapeutico; e, tra le arti terapie, la Dmt è quella in cui con maggiore immediatezza il corpo è protagonista. Nella Dmt-ER la matrice artistico-espressiva è centrale: la danza è il testo del processo terapeutico, non il pretesto per una terapia supposta svolgersi in un’area analitico-elaborativa. La Dmt-ER si colloca in una tradizione nella quale «l’arte può essere considerata come la più antica e diffusa forma di terapia sociale» (dallo statuto dell’ARTE, Associazione per la Ricerca nelle Terapie Espressive). Con Alessandro Tamino (verbatim) potremmo dire che le arti terapie esprimono oggi l’autentica vocazione dell’arte popolare, se nell’arte popolare sono fondamentali la celebrazione dell’evento collettivo, il gioco, la festa, la catarsi tragica, la condivisione di ritmi che fanno risuonare le profondità del singolo nella vibrazione del corpo collettivo. Protagonismo del corpo. Ma di quale corpo parliamo? Di “un corpo tra altri corpi”, non certo del corpo imprigionato in un circuito narcisistico riverberante e autoreferenziale. Più che di un “io corpo” parliamo del “me corpo”, di quel corpo che, parafrasando Franco Basaglia, mi fa esistere come alterità agli occhi l’altro, nell’inedito spazio dell’incontro intersoggettivo; di quel corpo che introduce nella consapevolezza di sé anche lo sguardo dell’altro, e che apre un spazio per lo sguardo sull’altro. 46 la rivista dell’ Arte In Dmt-ER questa intenzione si realizza mediante un’attenzione metodologicamente consapevole ai modelli e ai dispositivi con cui ci si accosta al corpo individuale (alle sue strutture dinamiche) e al corpo sociale (nella concretezza dei gruppi). È per questo che la Dmt-ER si riferisce a precisi modelli psicomotori e ha sviluppato un sistematico know-how relativo all’approccio psicodinamico multipersonale. Questo permette, senza nulla sacrificare della spontanea vitalità dell’esperienza, di svolgere un lavoro consapevole e mirato, quel lavoro per cui «la via allo sviluppo di sé passa sempre dall’altro» non è solo una frase a effetto, bensì un preciso programma metodologico. Bibliografia AA.VV., La funzione sociale della danza, Milano, Savelli, 1981. ADORISIO ANTONELLA, GARCIA MARIA ELENA (a cura di), Danzamovimentoterapia. Modelli e pratiche nell’esperienza italiana, Roma, Magi, 2004. BARONE RAFFAELE, BELLIA VINCENZO, BRUSCHETTA SIMONE, Psicoterapia di comunità. Clinica della partecipazione e politiche di salute mentale, Milano, Franco Angeli, 2010. BELLIA VINCENZO, Danzare le origini. Elementi di danzamovimentoterapia espressiva, Roma, Magi, 2000 BELLIA VINCENZO, Dove danzavano gli sciamani. Il setting nei gruppi di danzamovimentoterapia, Milano, Franco Angeli, 2001 47 la rivista dell’ Arte BELLIA VINCENZO, Se la cura è una danza. La metodologia espressivo-relazionale nella danza terapia, Milano, Franco Angeli, 2007. CHAIKLIN HARRIS (a cura di), Marian Chace: her papers, Adta, Kensington, 1975. FOULKES SIGMUND, Introduzione alla psicoterapia gruppoanalitica, Roma, Ed. Universitarie Romane, 1948. NAPOLITANI DIEGO, Individualità e gruppalità, Torino, Bollati Boringhieri, 1987. SCHOTT-BILLMANN FRANCE, Quand la danse guerit, Paris, Chiron, 1994. SCHOTT-BILLMANN FRANCE, Le besoin de danser, Paris, Odile Jacob, 2001. 1 Così sono stati definiti dalla Societé Française de Danse-Thérapie gli obiettivi prioritari della disciplina: a) risvegliare il piacere funzionale, b) promuovere la restaurazione narcisistica, c) ripristinare l’unità psicocorporea, d) promuovere la differenziazione dall’altro, e) promuovere la simbolizzazione corporea. 2 Chi di noi si trova a disagio fuori dalle consuetudini del cerimoniale para-psicoanalitico, considera l’esperienza del piacere sostanzialmente inappropriata alla terapia, che non è una pratica di animazione; guarda con sospetto all’esperienza del piacere, quando non la considera una regressione o un acting out… la 48 rivista dell’ Arte Arti Terapie e Terapie Espressive Alessandra Tuozzi Arte Terapia in borgata Si sa che l’approccio terapeutico basato sul processo creativo ha la funzione di modulare le emozioni individuali e collettive e di creare un contesto relazionale valido al quale l’individuo senta di appartenere e dal quale si senta protetto. Nel mio lavoro nell’ambito del Servizio di riabilitazione della ASL Roma B, questo approccio, l’Arte Terapia, rappresenta una risorsa fondamentale. Ha applicazioni importanti nell’intervento riabilitativo con i bambini o con gruppi, ma anche in contesti più allargati come le scuole o i gruppi di genitori dove l'obiettivo non è la cura di una patologia, ma il miglioramento della qualità della convivenza o delle relazioni genitore-figlio. La metodica applicata è la Memart (Metodica Espressiva Modulare Arteterapeutica), la metodica della Scuola di Arti Terapie di Roma, che si definisce modulare in quanto nelle procedure, che pure sono sempre diverse a ogni laboratorio, si possono ritrovare una serie di fasi ( o moduli) (fondazione del gruppo – fase fusionale, fase immaginativa - identificativa, fase ricompositiva, verbalizzazione finale) che si ripetono adeguandosi di volta in volta al contesto, al gruppo e agli individui che si hanno davanti e ai contenuti su cui si vuole lavorare. 49 la rivista dell’ Arte Trattandosi di Arte Terapia il linguaggio usato è quello grafico-plastico-pittorico, di tecniche video, di drammatizzazione e di performance, ma il linguaggio verbale ha un’importanza fondamentale. Non è corretto, infatti, definire l’Arte Terapia un linguaggio alternativo, poiché la parola è parte integrante di essa così come lo è il corpo, che, quanto il linguaggio, appartiene alla dimensione culturale dell’uomo. La metodica arte-terapeutica si può considerare, in altre parole, un insieme di dispositivi che permettono l’integrazione delle visioni culturali del corpo, della psiche e della dimensione collettiva dell’individuo per la costruzione di un ecosistema relazionale efficace. Il progetto che ho realizzato con un gruppo di adolescenti nella borgata di Ponte di Nona, parte da queste premesse e dall’idea che per promuovere il benessere di un individuo non basta occuparsi della sua salute psico-fisica, ma del suo stare al mondo, cioè delle sue relazioni, del contesto e dell’idea stessa che l’individuo ha dell’esistenza. L'esigenza di accoglienza e cura dei ragazzi della borgata romana ha profonde radici nella loro storia personale e nel luogo stesso nel quale vivono. Storia e Luogo mi sono sembrate, alla luce della riflessione sul percorso attivato, le parole chiave di questa esperienza, poiché proprio da esse scaturiscono i modelli culturali che appartengono al gruppo dei ragazzi. La messa in comune e la riflessione su questi modelli durante i laboratori ha consentito la modulazione di essi e attivato, di conseguenza, la capacità di costruire un senso condiviso della realtà. Il luogo è lo spazio della borgata di Ponte di Nona nella quale le nuove case popolari si mischiano a case, altrettanto nuove, di proprietà. Uno spazio che non ha una sua storia e una cultura condivisa alle spalle e nel quale, anche architettonicamente, non è rintracciabile un centro. Un luogo di transito, le cui strade lunghe e dritte non sono destinate ad essere calpestate, ma attraversate. Uno spazio che con le parole di Marc Augé si potrebbe definire un non-luogo, nel quale l'identità storica dell'individuo è annientata. Marc Augé definisce il luogo antropologico come lo spazio nel quale «possono essere lette le inscrizioni del legame sociale e della storia collettiva» e queste caratteristiche normalmente sono attribuibili alle zone residenziali, ma la mancanza di vita collettiva, di negozi, di artigiani sulla strada rendono la borgata molto più simile ad un non-luogo che ad un luogo. La vita va cercata un po’ più in là nel grande Centro Commerciale che si espande con le sue luci, i suoni e il fermento delle automobili, ma anche questo ha poco a che fare con il vivere in comune, si cala molto poco nella storia collettiva e nella realtà individuale, la nega, anzi, attraverso processi di spostamento dal la 50 rivista dell’ Arte qui e ora al mondo dell’illusorio. In questo contesto, fuori da riferimenti forti, ci sono i ragazzi con il loro bisogno di esistere e di essere visibili. Le loro sono storie difficili, fatte di abusi, allontanamenti familiari, o più semplicemente difficoltà sociali e loro si muovono su esperienze di sconfitta, anche quando appaiono i sopraffattori, e di rottura con il mondo incomprensibile delle regole. L’analfabetismo emotivo che hanno sperimentato e che li allontana dal pensiero di poter essere capiti e di capire, di organizzarsi su comportamenti di regolazione reciproca, annichilisce la loro competenza sociale. Hanno percorsi scolastici spesso fallimentari e difficili relazioni con i pari improntate su rapporti di forza nei quali sono vittime o aguzzini. Quando mi è stato proposto di lavorare con alcuni di loro, in tutto otto ragazzi di 13-14 anni, con gli strumenti dell'Arte Terapia, ho pensato di usare un linguaggio a loro familiare, che fosse socialmente e culturalmente da loro accettato: quello della fotografia e dei video. Abbiamo quindi iniziato ad uscire insieme, calpestare le strade per andare ad esplorare il territorio, inseguendo le idee di qualcuno o semplicemente il caso e quindi fotografare e filmare insieme muri, case, scritte e tutto ciò che incontravamo, dando vita, con questo materiale, ad un video. Uscire all'aperto insieme è stato importante perché il gruppo, che si era costituito attraverso la fase fusionale nell’ambulatorio e aveva assunto una sua identità, si è dovuto aprire e confrontare con la realtà che aveva intorno e non rimanere isolato da essa. Una realtà guardata con gli occhi di tutti e sulla quale è stato possibile confrontarsi. L'opportunità di focalizzare, attraverso le foto o i filmati, l'attenzione sul mondo circostante ha svelato scenari che erano conosciuti, ma non visti e ha fissato frammenti di vita che sono diventati stimoli per una narrazione collettiva. Il lavoro sul materiale raccolto, la scelta delle immagini da usare, delle musiche da inserire, ha convogliato l'attenzione di tutti, attivando le risorse creative di ognuno e creando, intorno a questo nucleo, una piccola comunità che sperimentava l'appartenenza. Il contenitore relazionale nel quale il gruppo si è mosso è diventato a questo punto il luogo non trovato nel mondo circostante, ma collocato nell'immaginario, i cui confini erano dati dalle relazioni stesse. La comunità era tenuta insieme, non da forze esterne ad essa, ma dalle spinte intrinseche al gruppo stesso al quale ogni membro sentiva di appartenere e nel quale si sentiva riconosciuto come appartenente. Al suo interno i ragazzi hanno sperimentato la possibilità di raccontarsi attraverso le proprie scelte, senza tante parole, e di ascoltarsi costruendo una narrazione condivisa. «Ognuno cresce solo se sognato» scrive in una poesia Danilo Dolci, in altre parole, per vivere l’individuo 51 la rivista dell’ Arte ha bisogno di esserci per gli altri, di sperimentare il senso di appartenenza al contesto, non tanto in senso materiale, quanto nella sua dimensione emotiva. Il percorso di Arte Terapia ha condotto i ragazzi a sperimentare la condivisione, ha permesso, in conclusione, ad ognuno di loro di vivere nella mente degli altri. AUGE' MARC, Nonluoghi, Milano, Elèuthera, 2009; DOLCI DANILO, Poema Umano, Torino, Einaudi, 1974. la 52 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Direttore: Armando Gnisci Redazione: Armando Gnisci Nuova Kuma&Transculturazione Flavia Caporuscio Manuela Derosas Rosa Di Violante Veronica Orfalian Riprende nel 2012 il suo cammino la rivista Kuma che vive e opera dal 2001 e che ora, dopo due anni di pausa, dovuta alla mia uscita dall’università, si rinnova partecipando ad una nuova avventura e ad una nuova sede, la Rivista dell’ARTE. La novità non consiste solo nell’annuncio di un trasloco ma anche della novità di una trasformazione, o meglio, di una co-evoluzione dentro una “nuova alleanza”. Mi spiego: la prima Kuma, i cui 17 numeri, pubblicati dal 2001 al 2009, sono consultabili interamente su questo sito, era accompagnata da un sottotitolo programmatico, simile quasi a un comando: “Creolizzare l’Europa”. Dopo 10 anni a tutti noi risulta che l’Europa stenti a creolizzarsi, e che tenda addirittura sempre più spesso a volersi suicidare, anche se gli immigrati non occupano più le pagine di cronaca nera dei giornali come criminali ma sempre più come vittime. Noi andiamo avanti per la nostra strada che non c’è, se non guardandola all’indietro per ri-assumerla e innanzi, o meglio, costruendola avanti ai piedi su sentieri semi- 53 la rivista dell’ Arte selvaggi e dune mobili, come fecero i nostri antenati romani. “Strada”, infatti, viene da stratum, parola che indicava la costruzione a strati delle nuovissime vie lastricate e destinate a raggiungere e connettere tutti i punti di quell’impero. Noi non siamo un impero centralizzato ma una rete di forme e di energie. Ed è assurdo aspettare che tutti ci vengano dietro compatti, come se fossimo cani-pastore che controllano continuamente il gregge e lo compattano, oppure, che tutti ci superino. Andiamo in avanti sulla via della creolizzazione mentale dandoci ora una veduta che focalizziamo in una diversa conformazione: Kuma&Transculturazione. Questa ultima linea, per ora, della nostra cosmovisione prevede e induce a una azione vera e propria che deve squillare nel lavoro del congiungere e del tradurre la complessità di un valore transitivo, mondiale e condiviso, partito dalla mia po-etica degli anni 90 della decolonizzazione e della creolizzazione. In concreto, Kuma&Transculturazione – uso spesso la & così detta “commerciale”, non nel senso del commercio delle imprese di mercato o delle velenose agenzie di rating yankee, ma di particella minima che segna una giusta e gioiosa “alliance”, anche attraverso la sua storia: una “et” latina che i copisti dell’Età di Mezzo man mano trasformarono in un nuovo segno grafico, che sembra un sigillo e non più una abbreviazione; non so da quando e come la “&” fu chiamata commerciale – presenta una fase più avanzata della ricerca-azione letteraria e umanistica sintetizzata nella quartina scalare e unitaria di Decolonizzazione-Mondializzazione-Creolizzazione-Transculturazione. Questo trio marca il percorso delle mia lunga carriera mentale e politica – o, meglio, della repubblica – che risale agli inizi degli anni Ottanta del secolo passato. La Transculturazione è una apertura più vasta alla mondializzazione delle menti. Eccoci al punto: nel 1992 scrissi un piccolo libro che si intitolava Il rovescio del gioco, presso l’amico Beniamino Carucci, editore in Roma. Quell’opera, ormai introvabile, trovò ospitalità nel successivo Creolizzare l’Europa. Letteratura e Migrazione, pubblicato presso l’editore Meltemi di Roma nel 2003. Anche questo libro, però, è difficilmente trovabile ormai, ma molte biblioteche italiane lo posseggono. Ne Il rovescio del gioco, lessi e scoprii i primi volumi scritti da stranieri in Italia in italiano, opera anch’essa neo-stradale perché registrava una novità assoluta dentro l’orizzonte molto longevo delle nostre patrie lettere. Più tardi (1998) avrei definito la “Letteratura Italiana della Migrazione” [LIM] come un nuovo “soggetto transculturale”, per la prima volta attivo nelle nostre patrie lettere millenarie. Nel 1992 commentai quei primi libri come manifestazioni di una “letteratura nascente” in Italia, lanciando davanti a me e ai miei allievi l’idea che quella letteratura che nasceva in Italia era un’impresa plurale che si andava manifestando per la prima volta dentro l’alveo transoceanico della Grande Migrazione planetaria. E la pensai, contemporaneamente, come una descrizione-traduzione di un “Nuovo Mondo” che si affermava come una vera nuova forma della “Letteratura del Mondo” colta, addirittura, nel suo avvenire, nascente e crescente 54 la rivista dell’ Arte verso il futuro. Anzi, per le letterature nazionali europee e per quelle in lingue europee – ex-coloniali, come nelle Americhe e in Africa – cominciai ad elaborare l’idea di una loro mondializzazione in atto da parte non solo e non più dei premi Nobel caraibici e africani, o USA neri, ma più concretamente e popolarmente, degli scrittori migranti. Del resto, l’inizio del mio cammino nella comparatistica letteraria accademica era stato il volume La letteratura del mondo, pubblicato da Carucci nel 1983. In quel palinsesto sedicente mondialista avevo convocato solo autori europei, da Goethe e Mazzini fino ad Auerbach e Rüdiger. Quella manovra era stata dettata dall’adesione del mio spirito di allora, era fermo e incantato nello sguardo all’Europa come “Illuminatio mea”, centro di irradiazione concettuale della letteratura del mondo. Insomma, ero in pieno eurocentrismo interiore. 10 anni dopo, mi venne innanzi sulla strada della ricerca il “caso” di una nuova forma della Letteratura mondiale, diventata la più diversa da quella sognata da Goethe. Essa era espressa nella pancia dell’Europa, oltre che nelle Americhe, nelle lingue europee, ma era scritta da autori di madrelingua spesso non europea, come gli africani, gli asiatici ecc., o di madrelingue del Centro e dell’Est dell’Europa, né neo-latine né germaniche e quindi non circolanti, e spesso ignorate, come le loro nazioni, nell’Europa occidentale. Il cammino della mia ricerca sulle nuove letterature mondiali in lingue europee mi portò al risultato, molti anni dopo, di arrivare a traslocare stabilmente la LIM, e tutte le altre opere di scrittori migranti contemporanei in Europa, nella letteratura del mondo (World Literature) come la vera novità nel gioco-orizzonte più ampio della mondialità letteraria a cavallo di due secoli-millenni. Questo percorso è certificato dal saggio “Di cosa parliamo quando parliamo di letteratura mondiale nel XXI secolo?”, nel volume scritto con le mie allieve, F. Sinopoli e N. Moll, La letteratura del mondo nel XXI secolo, Milano, Bruno Mondadori 2010. Ora, dopo il “Manifesto transculturale” del maggio 2011, proprio in questa nuova Kuma&Transculturazione, l’azione transculturale e mondialista, dettata dal lavoro critico e editoriale negli anni a cavallo tra i 90 del XX secolo e gli 1-10 del secolo XXI, si è concretizzata e si è resa manifesta e condivisibile. Come vedete, infatti, la Sezione transculturale centrale della nuova Kuma, è intitolata “Letteratura mondiale”. Punto e basta. Essa comprende scritti di saggisti cubani e cinesi, egiziani e brasiliani, e anche testi di scrittori italiani migranti. Migranti tra le lingue, tra le vite e tra i continenti, come l’albanese-italiano Ron Kubati, a Chicago, e il somalo-italiano, ora cittadino australiano, Ali Mumin Ahad, a Melbourne. Loro sono migranti responsabili che dopo il trasferimento in Italia hanno dovuto migrare anche dall’Italia, per “cause di forza maggiore”, come si diceva una volta. Ma continuano a scrivere in italiano, oltre che in inglese, come nelle loro tesi di dottorato anglofono. Il percorso pubblico della mia ricerca è stato spesso travisato e non accettato, in Italia, sia da parte degli 55 la rivista dell’ Arte studiosi di Italianistica che dei pochissimi “studiosi” o recensori dilettanti e scrittori della LIM. Spero che ora i giovani e bravi nuovi critici italiani non si lascino traviare dalla logica accademica dei concorsi e riconoscano, anche se non condividendo, una traccia più precisa del mio lavoro svolto lungo quasi 30 anni, e che i vecchi e nuovi scrittori della migrazione in Italia non mormorino stancamente che quelli come me hanno costruito una gabbia-ghetto per gli scrittori immigrati in Italia che meritavano e meritano, piuttosto, di essere riconosciuti come scrittori tout court ecc. Una sciocchezza che ho tante volte cercato di spiegare e demistificare nella sua ingenua mendicanza; ancora una volta, e direi l’ultima, nel 2011 in un saggio uscito a giugno sulla rivista “Prometeo”. Andiamo avanti. La Via della Transculturazione, come vedete qui, ora ha riunito, oltre che scrittori di tutti i continenti, una compagnia di psichiatri arteterapeuti con una di letterati, stringendo una “nuova alleanza” che speriamo sia gioiosamente cooperativa e longeva, come sta avvenendo già nelle varie azioni dell’Associazione Alias Network www.aliasnetwork.it: da questa Rivista dell’ARTE alla webtv avviata ad aprile 2011 con le mie “Lezioni transculturali”, alla fondazione, presso la Biblioteca Comunale di Lanuvio, nel circondario dei Castelli romani, di un Centro di Ricerca e Formazione Transculturale che affiancherà il Fondo Armando Gnisci (FAG) dei libri e delle carte della LIM, della Transculturazione mondiale e della Letteratura Comparata (LC) in Italia. Fondo la cui catalogazione è finita e che è disponibile dal febbraio 2012 ai lettori e ai ricercatori come anche agli studenti, sul sito http://sbcr.comperio.it/. Contemporaneamente riprende la pubblicazione di testi nella collana Kumacreola dell’editore Cosmo Iannone, diretta ora da me insieme a Rosa Di Violante, sulle cui novità vi informeremo come sempre attraverso la mailing list di Kuma, oltre che nella rivista, che per ora ha una cadenza semestrale. Invito gli editori e gli autori della LIM, ad inviare una copia dei loro libri o altro, o due, meglio, affinché una copia sia disponibile al pubblico e al prestito della Biblioteca Comunale di Lanuvio, dove il FAG vive. La “nuova alleanza” – una parola che viene dal francese “alliance” e che non riguarda patti militari, ma una coevoluzione di spiriti, come ci insegna Michel de Montaigne – produce già i suoi primi frutti: gli psichiatri ci hanno insegnato a meglio riconoscere e incrementare la nostra azione, che per loro è la prima e l’ultima linea delle cose, e, viceversa, ad avere loro più attenzione e ascolto della poesia e del suo potere. Dal secondo numero di questa rivista troverete i primi esperimenti di scrittura a 4 mani e diverse menti. Infine, la nuova Kuma non si interessa più e soltanto alla LIM e a creolizzare l’Europa, ma si ricongiunge al mio pensiero eurocentrico dei primi anni 80 del XX secolo per emendarlo e rilanciarlo come pensiero 56 la rivista dell’ Arte mondialista in cammino dal 1991. Oggi questo pensiero in comune propone una conversione inconclusiva, secondo il pensiero poetico di Lucrezio & Wallace Stevens & Édouard Glissant, in una cosmovisione transculturale matura. La nuova Kuma mette in scena questa imprevedibile transculturazione mondialista, antagonista verso la società globalizzata identificatasi come traffico mercatorio del capitalismo sfrenato e disumano nella sua più grande manifestazione di potenza e di opaco orrore. Dentro questo orizzonte la LIM fa ciò che sa fare meglio: una via e un tratto del nuovo sapere della mondializzazione, decolonizzazione, creolizzazione, e transculturazione del nostro vivere e pensare oggi, per meglio andare verso un mondo nuovo che non vogliamo smettere di costruire. Oltre che di sognare. La trasformazione di Kuma in una rivista più “militante” (come si diceva una volta in Italia) o meglio, “in una azione transculturale”, è accompagnata dal mio “Manifesto transculturale” del maggio del 2011, che gira nel web tradotto in spagnolo, francese, inglese, galego, arabo, porto-brasiliano, e ora anche in cinese per la rivista on line Dialogue transculturel e presto in serbo. È stato pubblicato sulle riviste terrestri Casa de las Américas de La Habana di Cuba, n. 264, 2011, e A trabe de ouro. Publicación galega de Pensamento crítico di Santiago de Compostela, tomo II, ano XXII / 2011. Lo ripubblico in versione italiana in questo primo numero della nuova Kuma&Transculturazione, a marzo 2012. Intanto, il Fondo Editorial della Casa de las Américas di Cuba pubblicherà il pamphlet Manifiesto-Ensayo de la Transcultural européa nel 2012, nella forma di libro che gli ho dato, e che per ora non è disponibile in italiano. Aggiungo, per finire, un aneddoto che accompagna la nuova impresa di Kuma&Transculturazione. Accanto al “transman” le mie redattrici hanno voluto che fosse postato lo scritto di mutuo riconoscimento (“Changing the Spiritual World Nourished in the Colonial Era”) della mia cara collega cinese Yue Daiyun, dopo 15 anni di nostra reciproca dispersione della presenza. Avevo previsto direttorialmente di collocare quel breve testo come terzo pezzo della performance della capostipite della Letteratura comparata in Cina, anch’ella intanto evolutasi sempre più verso la transculturazione. Quando le fanciulle badanti il mio senile rimbambimento espressero una proposta di simpatica preliminarità in coppia dei due testi sul primo numero della nuova Kuma, mi sono accorto che la pregiudiziosità accademica attanagliava ancora nel profondo della mia esistenza l’automatica resistenza della sua “forza anti-vitale” a “non vedere” e a “non udire” modi diversi, più giovani, di comunicare. Sorpreso e convinto, votai a favore del desiderio transculturale delle mie supervisore. Così vincemmo insieme, tutte noi: win win, come dicono gli inglesi. Per mandarci le donazioni cartacee e le comunicazioni delle vostre varie iniziative interculturali e/o 57 la rivista dell’ Arte transculturali potete rivolgervi ad Armando Gnisci Via delle Costellazioni, 183 00144 Roma e agli indirizzi e-mail: [email protected], [email protected], [email protected] Adieu donc la 58 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Armando Gnisci Manifesto Transculturale 16 maggio 2011, Roma La Transculturazione deve sperimentare e promuovere pratiche critiche di azione transculturale tra i saperi contemporanei allo scopo di produrre una nuova cosmovisione comunitaria attraverso forme di azione creativa e di salute generale: tra le persone umane, tra generi e tra generazioni, tra le culture; tra le persone umane e le non-umane, tra i viventi e il pianeta abitato da noituttinsieme e il cosmo, di entrambi i quali siamo partecipi. Noi crediamo, ma non da soli, che il Multiculturalismo e l’Interculturalità siano due parole-concetti che debbono essere revisionati profondamente nell’Europa occidentale e nell’Unione Europea, dove abitiamo: il Multiculturalismo attraversa una evidente crisi politica, la Interculturalità, a sua volta, sembra una barchetta in balìa mediterranea di una crisi di senso. Noi pensiamo che la crisi politica, di recente annunciata clamorosamente dalla premier germanica Angela Merkel, rappresenti l’ultima conseguenza della persistente e confusa visione eurocentrica della politica unitaria degli europei uniti nel cerchio di stelle. Ma, anche, dal nostro punto di vista, l’esito della mancata decolonizzazione degli europei da se stessi, dall’essere stati e tuttora esserlo: coloni e padroni. Una richiesta 59 la rivista dell’ Arte che fu fatta negli anni 50 del XX secolo agli europei da due grandi intellettuali: uno francese e l’altro francofono, della Martinica antillana: Jean Paul Sartre e Frantz Fanon. Le parole-concetti, multiculturalismo e interculturalità, sono state logorate dalla mancata, ma sempre più urgente, decolonizzazione delle nostre menti ancora coloniali: prima, nei confronti delle civiltà violentate da noi co-co [conquistatori-coloni] planetari della modernità, e poi riadattata in Europa per “accogliere” africani e asiatici, soprattutto, dopo la decolonizzazione incompiuta e fallita dei popoli da noi devastati, ma soprattutto come reazione alla recente Grande Migrazione dei “dannati della terra” negli stretti territori già superaffollati della coda peninsulare dell’Eurasia. L’Italia, ad esempio, conta 60 milioni di abitanti. Per sperare di essere “felici”, dovremmo diventare la metà, con il 20% di immigrati, in coevoluzione. Ripulendo tutto ciò che ricopre il Bel Paese: dall’immondizia dalle strade e dai campi, dal cemento e dall’eternit, dalla corruzione e dalla menzogna della vita politica, dalla sventura di essere la nazione europea unita più ammalata di criminalità, l’unica forma sociale che coevolva con la società civile anomizzandola, ammazzandola. Gli europei oggi hanno scoperto di essere razzisti in casa propria. Questa specie di “neo-razzismo nella democrazia” è il sintomo più forte del fallimento della politica del multiculturalismo coatto e della interculturalità astratta che, nel migliore dei casi, possiamo definire: volenterosa e caritatevole. Noi crediamo che la crisi di quei modelli di adattamento sociale stia portando allo scoperto la rimozione nelle menti europee delle vecchie pretese coloniali (sia nelle antiche colonie che in casa) delle ex-potenze imperiali: l’assimilazione, la Francia, e l’integrazione: l’UK, la Germania e, molto confusamente, l’Italia. È necessario riconoscere che il nodo della grande relazione interculturale tra noi europei e le personemoltitudini che vengono da noi, è distorto e ingiusto. I migranti, infatti, arrivano non per conquistarci e colonizzarci, ma per vivere con noi una vita più giusta e salutare in una nuova comunità transculturale da costruire insieme, in Europa. Invece, continuiamo a rimuovere questa “banale” visione coevolutiva. Perché può diventare minacciosa. Se continuassimo a pensarla per bene e fino in fondo, infatti, dovremmo arrivare alla presa d’atto che proprio e solo i migranti hanno la capacità di desiderare questa “utopia giusta e concreta”. Anzi, che sono loro oggi portatori di sana umanità e di futuro. Questa scoperta, invece che al panico identitario e alla rabbia razzista, dovrebbe portare gli europei a costruire una visione più larga della convivenza tra le genti. Come hanno fatto alcuni piccoli comuni del Sud dell’Italia, quel Meridione senza meridiano, quella terra senza ora, perché mai è stata la sua ora. Un paese devastato dalla povertà, 60 la rivista dell’ Arte dall’emigrazione e dalla criminalità. I calabresi hanno pregato i migranti arrivati come naufraghi nei barconi alle sponde del Mare Ionio, di rimanere insieme a loro nei piccoli paesi della Calabria: Badolato, Riace, Caulonia e altri, per darsi la vicendevole speranza di poter ri-vivere insieme una vita diversa. Per avere un’ora migliore. Il regista tedesco Wim Wenders, nel 2010, ha girato “Il Volo”, un documentario-narrativo su questo fenomeno non tanto di mera “accoglienza” quanto di proposta agli stranieri di ridarsi-vita insieme. Ma gli alti europei che governano le vite, di noi e degli altri e dei futuri, sono capaci solo di difendere i privilegi della civiltà moderna creata con la violenza e l’usurpazione: affari, in tutti i modi, e comando, sempre. Le macchine governative europee non sono capaci di assicurare ai migranti nemmeno un trattamento da civiltà “borghese e illuminata”: nemmeno una “porca politica” [come dice la figlia di Barney a Barney] adeguata a prevedere e a rimediare difficoltà e conflitti, leggi di polizia e razzismo, carità e solidarietà. Il che significa che non siamo capaci di pensare alcun futuro e tantomeno di preparare una società transculturale, insieme con chi la desidera, anche senza saperlo. La Transculturazione è nata e prospera – come concetto antropologico culturale e come parola comune anche se di origine colta: transculturación e transculturação – nella parte centrale, in quella antillana e in quella meridionale del Mundus Novus delle Americhe. Come nazioni non povere ma impoverite e devastate, e non domate, dal colonialismo europeo e poi da quello nordamericano. La Transculturazione aiuta a riconoscere come evidente la storia propria di ogni cultura a ibridarsi con altre culture e a generare nuove forme “creole” e imprevedibili. Così come ci hanno insegnato Fernando Ortiz, Oswaldo de Andrade, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Èdouard Glissant, Walter D. Mignolo, Roberto Fernández Retamar, Eduardo Galeano, Sub-comandante Marcos, Leonardo Boff e tanti altri. Il pensiero e la prassi transculturali indicano che ciò avviene nella mutualità dello scambio e nella trasformazione imprevedibile, aldilà della violenza e del comando. Seguendo il pensiero latino-americano, vogliamo proporci come coloro che rispondono ad esso dalla parte europea, in contrappunto e in relazione. Noi abbiamo individuato ed articolato l’idea e il progetto della Transculturazione in tre movimenti, non tanto successivi quanto, invece, contemporanei e coevolutivi: Decolonizzazione, Creolizzazione e Mondializzazione, tutte mutue. Perché possiamo salvarci solo l’un l’altro, come scrisse il filosofo epicureo Filodemo di Gadara. Solo così la nuova poetica dell’Interessere e della Relazione può sostituire pacificamente, anche se implacabilmente, le marche metafisiche dell’“antico regime europeo”: l’Essere, l’Identità e l’Universalità. Noi pensiamo che queste categorie filosofiche, diventate poi ideologiche e ormai solo parole abusate e indegne a dirsi, perché menzognere, siano ancora le potentissime marche delle superstizioni della cosmovisione eurocentrica che 61 la rivista dell’ Arte tuttora governa retoricamente le guide politiche e grande parte della “gente” europea, anche se la sua estinzione è già in cammino. La cosmovisione transculturale e la sua missione pratica e formativa, che è l’azione che sta dentro alla parola transcultura-azione e nella nuova intenzione del fare insieme, servono a noi europei per decolonizzarci, per creolizzarci e per mondializzarci. Il primo passo da fare è proprio la liquefazione e il licenziamento del nucleo di ferro del pensiero eurocentrico della modernità: la pretesa che possiamo fare tutto e sempre da soli, in quanto portatori della luce della civiltà superiore. Quel “The White Man’s Burden” dell’Ode di Kipling, del 1898, al quale opponiamo il motto cannibale di Oswaldo de Andrade, dal suo “Manifesto Antropofago” del 1928: “Prima che i Portoghesi scoprissero il Brasile, il Brasile aveva scoperto la felicità”. Dobbiamo imparare ad educarci e salvarci insieme con i migranti e con tutte le culture del mondo, che proprio noi abbiamo avviato all’estinzione con la “scoperta”. Tutto ciò non significa affatto la rinuncia all’identità europea, o meglio: la fuga dalla nostra responsabilità storica. Ma significa il nostro voler decidere di ri-educarci, per arrivare a vedere e a riconoscere che ci è offerta, nel XXI secolo una straordinaria chance per creare un Mundus Novus anche in Europa. Noi pensiamo che la Modernità non potrà finire mai prima che ciò accada o senza che ciò accada. Come quando l’Europa diventò Europa avendo a che fare con i Goti della Scandinavi, i magiari delle steppe e con i Mori arabi e africani. La Transculturazione è una via per riconoscere e comprendere per bene (à propos, diceva Montaigne) i fenomeni migratori e sociali del nostro tempo, e per proporre e costruire nuovo statuti del benessere individuale e comunitario. Con le pratiche della “convivenza nella sana umanità” e della “coevoluzione creativa”, intendiamo fare ricerca e sperimentare una revisione della disposizione e della consistenza dei saperi, dei percorsi formativi della scuola e delle pratiche comunitarie, della creatività condivisa. Se non ora, quando? scriveva Primo Levi, uno dei testimoni delle vittime della folle disumanità europea. 62 la rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Care/i Lettrici & Lettori, i logoi (non è un errore, ma il plurale alla maniera del greco-antico dell’italianizzato “logo”) che rappresentano l’alliance da cui è nata la nostra nuova rivista sono: quello anatolico di 30 secoli fa che designa aliasnetwork: un gruppo di tre omini o fanciulle danzanti e di un omino o di una fanciulla che sta da parte a guardare tranquillo o serena, ma pronto/a rientrare nel gruppo danzante, da una parte, e dall’altra quello che sembra un uccello che sta come una bandiera volatile tenuta in verticale da un vento che non si vede. Il disegno è la versione iconica della parola Kuma che vuol dire “parola” nella lingua bambara, parlata tuttora da una nazione translinguistica dell’Africa nord-occidentale. Si tratta, allora, di una “parola alata”, proprio come appare nel tesoro di formule metaforiche dei poemi omerici. Già questo incontro di graffiti vetero-mediterranei ancestrali e quasi sconosciuti con graffiti e parole africane sub-sahariane di genti viventi, trascurate dal mondo degli spreads, in giro intorno alle dune del deserto, entrandovi e uscendone, con le formule dei pilastri poetici del più antico rapsodo del Mediterraneo, già questo luminoso e chiaro groviglio di immagini lingue e pensieri aduna e significa i nostri intenti transculturali. E non si tratta della vecchia favola-menzogna europea dell’“universalità universale” – che ha un solo verso, quello occidentale, vedi: Hegel, Kipling & Co. – ma di trasversalità. Quella che passa tra noi viventi e operanti adesso con i tempi antichi e le forme vitali delle civiltà vicine e lontane, per portare in alliance i nostri stessi incroci e i nostri desideri, le parole che pronunciamo svegliandoci e i gesti che facciamo per amicarci i portatori della salute e i compagni di strada, danzando, se possiamo. “Alliance” è una parola francese del secolo XVI europeo che sta nei Saggi di Montaigne e che vuol dire: “vivere insieme in uno spirito in comune”. Se a qualcuno tra noi non piacesse la parola “spirito” basta che pensi a cosa mira l’espressione “in comune”. Se qualcosa di importante e buono ci porta a camminare insieme – tutte, direi, le cose buone – forse possiamo pensare che questa maniera di co-evolvere a vicenda provenga dalla forma vitale che vive nell’alliance e che possiamo esprimere anche con la parola “spirito”. Si può addirittura sognare che la Kuma bambara alata, proprio quando la fanciulla rimasta fuori dal giro della danza ritorna nel turbine calmo della 63 la rivista dell’ Arte condanza, entri insieme con lei nel girotondo e si trovi bene con i fratelli che danzavano da tempo senza di lei, kuma e fanciulla al tempo stesso. Ormai tutti insieme nell’arte, e allo stesso tempo più umani. È il motto, e la moto, della Transculturazione. Armando Gnisci la 64 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Yue Daiyun - Peking University Changing the Spiritual World Nourished in the Colonial Era Reviewing the Friendship with Professor Armando Gnisci L’articolo ripercorre le diverse fasi del dialogo interculturale e transculturale tra due eminenti studiosi di Letteratura Comparata: Yue Daiyun e Armando Gnisci. A contraddistinguere la storia di questo scambio intellettuale sono le insegne di un’amicizia, nata nel 1996 in occasione del Congresso annuale dei comparatisti cinesi, riallacciata nel 2011 e proiettata verso una alleanza transculturale, ma anche transcontinentale e transoceanica. In October, I unexpectedly received a letter via an Italian graduate student from Professor Armando Gnisci at Rome University, Italy, whom I haven’t seen for more than ten years. I knew Prof. Gnisci back in 1996, when he traveled afar to attend the 5th Annual Conference of Chinese Comparative Literature Studies and International Symposium held in Changchun, Jilin Province. His thesis was on “Comparative Literature as a Discipline of Decolonization”, giving me the impression that he took a relatively new view of comparative literature and raised some problems which I hadn’t pondered. Why did he regard comparative literature as a subject of decolonization? He approached comparative literature from the perspective of changing the human spiritual world and explicated it in two aspects. On the first level, «to those countries that have shaken off their Western colonial states», «comparative literature represents a way of understanding, researching and decolonizing». That is to say, they could rely on the theories and practice of comparative literature to struggle free completely from the 65 la rivista dell’ Arte shackles of the past colonial ideology. On the second level, «to all of our European scholars», comparative literature «represents a form of thinking, self-criticizing and learning, or a way of liberating ourselves from our own ‘colonial’ (system)». He particularly stressed that the European scholars who have lived long in the colonial countries «must really realize that they belong to a 'post-colonial world', where the ex-colonizers and the ex-colonized should learn to live the same life and coexist». Professor Gnisci argued that by no means was it easy to do this. First and foremost, the Westerners must abandon their sense of cultural excellence that had been nourished during the hundreds of years’ formation of the colonial system. This is «a kind of self-criticism as well as cultivating and remoulding themselves and others, just like ‘askesis’ in Greek culture». Professor Gnisci put, «As Europeans, we must go beyond that kind of poor but radical criticism of Eurocentrism, translating it into the criticism of comparative literature. Namely, great importance should be attached to the criticism from non-Europeans on Eurocentrism. [...] because this kind of askesis cannot be carried out by our own strength based on the psychological state of our philosophical tradition; on the contrary, it can be fulfilled only by making comparison, lending an attentive ear to others as well as surveying ourselves from others’ angle of view. Only in these ways (comparison) can we ultimately learn from others and ourselves what we cannot develop through other methods». This speech inspiring me greatly was published on the 31st issue of Chinese Comparative Literature Newsletter in 1996. Ever since Prof. Gnisci has emphasized that world literature is not separable from colonial system. In 2002, he elaborated in his “Global Literature and World Literature Today”, «I must reiterate that European literature subdued the world accompanying the gradual subjugation of the colonial empire in the 19th century, just as Marx and Engels understood in 1848 rather than ‘universal poetry’ bursting into thriving from Germany, the heart of Europe, as Goethe and F. Schlegel dreamt of. Edward Said explicitly pointed out the connection between European literature and colonialism in his Culture and Imperialism»1. After World War II, many newly independent nation-states have been founded, but they have still been ideologically in the state of being colonized. In other words, they ideologically or unconsciously comply with the past colonial cultural values; moreover, they explore less intrinsic value of their own traditional culture. On this basis, dialogues with other cultures are carried on to modernize their traditional culture, but their own culture is still manipulated by others. Gayatri Spivak strongly denounced this phenomenon in her A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present, «dominant global capital” has carried out a new cycle of exploitation of the ex-colonies, making the colonial people mute. 66 la rivista dell’ Arte This is also what she has repeatedly put forward when concerning comparative literature, that is, in postcolonial era close attention should be paid to the problems that “powerful cultures ‘appropriate’ at will the newly independent cultures and how the newly independent cultures achieve final emancipation from the ideological colonization thoroughly». Prof. Gnisci makes unremitting efforts to change the spiritual world nourished in the colonial era as well as the literature as the reflection of the spiritual world. In October, having got my address via a graduate student, he wrote me three letters in succession, in which he holds the view that to the Europeans, it is of leading importance to banish colonial ideology and cultural superiority firmly planted in their minds; to the Chinese, they should deeply explore the characteristics of their own culture, not letting their culture disappearing in the global “melting pot”. This also corresponds with another famous Italian scholar Umberto Eco’s consistent idea. He affirmed many a time that globalization does not mean a crucible without cracks; the interface of multicultures results not in an “amalgam” but in constructing a multicultural community with the characteristics of different ethnic cultures. He told me he was at pains to learn Chinese culture, and then he talked with me about how he felt after reading Chuang Tzu’s Autumn Floods. Prof. Gnisci hopes many more Chinese scholars’ articles can be published in La Rivista dell’ARTE which he presides over and that Italian scholars can participate in our journal Cross-cultural Dialogue. He mailed me his draft of Transcultural Manifesto, inviting my comments. He in particular stressed that since we have witnessed the injustice of colonial system, we should fully lay colonial system bare, well aware of its revival in another form and trying to make up the interpersonal chasm that the system has brought about, especially a chasm between “North and South”. He suggests creating a transcultural, transcontinental, and transoceanic network: Beijing — New Delhi — Cairo — Tokyo — Rome — Rio de Janeiro, appealing us to work together to build a new spiritual world of non-colonial culture. I am greatly touched as well as abashed by Prof. Gnisci’s letters. Should we open up a newer way of thinking, show deeper solicitude for others’ well-being and take more serious action? Since we have had new intrinsic motivation as well as new international environment to develop Chinese culture, what are we waiting for? 1 GNISCI ARMANDO, “Global Literature and World Literature Today”, trans. Wang Lin, Shi Chuan, Comparative Literature in China, 2, 2002. 67 la rivista dell’ Arte 68 la rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Letteratura mondiale Speciale 2011 - 150 Unità d’Italia Per il primo numero della Rivista dell’ARTE, il cui esordio coincide, anche se qualche mese dopo, con il centocinquantenario dell’unità d’Italia, abbiamo voluto inserire una rubrica intitolata “Speciale 2011 – 150 anni dell’unità d’Italia”. Questa scelta non è stata dettata dalla volontà di unirci alle tante - troppe celebrazioni dell’anniversario, quanto piuttosto dall’esigenza di ripensare ai nostri 150 anni di storia italiana da una prospettiva transculturale, grazie ai contributi di quelli che Armando Gnisci, nell’ultimo numero della rivista Kúmá. Creolizzare l’Europa, ha definito i nuovi itagliani, con la “g” in corsivo, così: “g”. Per distinguerli da noialtri “italiani”, che non siamo portatori di luce nuova del mondo. Questa rubrica vuole dare voce a un’Italia diversa, fatta non solo da coloro i quali nel bel paese sono nati e cresciuti, ma anche da chi ha scelto l’Italia come tappa finale del proprio iter migratorio. Tra questi abbiamo scelto soprattutto i casi di chi poi è stato costretto a lasciare quella che credeva essere una seconda patria ed emigrare di nuovo. Anche loro ci avevano creduto. la 69 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Laila Wadia Ascolta il silenzio Amo vestirmi di parole – indosso metafore, allegoria, ironia - ma da quando sei entrato nella mia vita, amore mio, il mio soprabito preferito è un mantello di seta color tramonto infuocato fatto di silenzio. Le sue soffici pieghe permettono ai miei pensieri – pensieri di donna, di migrante, di madre – di fluire in un caldo ventre liquido dove il linguaggio si scioglie fino a diventare brodo primordiale e dove l’unico rumore è il sorriso del Creatore mentre srotola il suo contratto preliminare con l’umanità. Nel silenzio posso spogliarmi dalla pesante armatura che le parole indossano per proteggere il loro cavaliere – identità, appartenenza, alleanza. Nel silenzio, le parole sono apsara – creature divine della mitologia indù - che ballano per il dio dell’amore.Nel suono diventano flaccide cortigiane dal passo pesante. Ma so che dovrò arruolare al mio servizio quel esercito chiassoso raramente fedele al suo re. E come ogni sovrano che cerca di sopravvivere ai complotti, dovrò imparare dosare astuzia, saggezza, insicurezza, ipocrisia e crudeltà, prima di trasformarli in 70 la rivista dell’ Arte acustica. Prima di te non mi sono mai posta il problema della lingua. Nella mia madrepatria, l’India, la poligamia linguistica è la norma. Anche i meno istruiti masticano due o tre idiomi, e molti mescolano il tutto in un unico boccone ruttando un piccante masala in cui l’inglese scolastico viene finemente pestato per privarlo dell’accento colonizzatore e man mano vengono aggiunte manciate di hindi, di punjabi, di urdu... Quell’amalgama di suoni profuma di me. Tradurmi in un unico sapore, mi rende incompleta. Per i primi due anni del mio soggiorno in Italia, l’inglese mi è bastato perché frequentavo solo altri stranieri. Per il resto, la moderna vita occidentale ha eliminato la necessità di dialogo. Dal supermercato, alla lavanderia a gettoni, dal parcometro al distributore automatico delle medicine – l’uomo contemporaneo può trascorrere un’esistenza intera senza mai aprire bocca. La decisione di mio marito Prakash di prolungare il contratto alla SISSA, la Scuola di Matematica Avanzata di Trieste, venne presa sulla scia dell’attacco terroristico di Mumbai. Io, orfana di madre dall’età di sedici anni sapevo che quell’orrendo 26 novembre del 2008 avrebbe significato che in quanto mussulmana ora sarei rimasta anche orfana di madrepatria. Il mio paese natale sarebbe ripiombato in una guerra fratricida distruggendo l’esistenza di quelli come me e Prakash – una coppia mista – due che credono fermamente che l’unico rimedio all’intolleranza è l’amore. Quindi optammo per restare all’estero e trovammo un piccolo appartamento in una pittoresca zona della città vecchia a Trieste e io mi rimboccai le maniche per pulire i mobili dalle impronte di altri viandanti, arabescandoli con il lucido delle mie speranze. La nuova residenza implicò anche uno sforzo affinché l’italiano diventasse la mia nuova lingua franca, la lingua dei mercatini ortofrutticoli, della burocrazia, delle opinioni meteorologiche scambiate con i vicini di posto in autobus. L’inglese retrocesse a mezzo di lavoro, mentre il mio India-masala rimase il profumo della dimensione domestica. Solo in quest’ultima rimuginavo sullo sradicamento. Che mia suocera nutrisse solo rancore nei miei confronti fu ovvio sin dall’inizio. Ma per amore di suo figlio, ignoravo le sue malvagie insinuazioni su come io, mussulmana e orfana, avrei adescato Prakash, sottraendo alla comunità indù un brillante scapolo, e a lei, una dote strepitosa da sperperare in vestiti e gioielli. Un 71 la rivista dell’ Arte giorno, dopo un battibecco particolarmente acceso in cui mi accusò di essere sterile – e di averlo sempre saputo – replicai che lei non sapeva distinguere tra l’amore e la tirannia. In risposta, quella sera lei presentò al figlio la fotografia di una mia possibile sostituta e il numero di telefono di un avvocato divorzista. Vedendo il volto di una giovane donna dalla carnagione chiara ritenuta idonea per le esigenze di casta e non di cuore, quella sera stessa Prakash compilò online dieci domande per una borsa di studio in matematica applicata all’estero. Risposero entusiasti dalla SISSA di Trieste e nel giro di una settimana partimmo per una città che fino a ieri non avremmo saputo indicare sul mappamondo. Alla partenza piangemmo tutti. La suocera per la battaglia persa, Prakash per sollievo, io per la grande prova d’amore. Mi dispiacque lasciare il mio lavoro da giornalista per una nota rivista femminile di Delhi, ma la direttrice mi disse che potevo mandare dei contributi via mail e questo attutì un po’ lo shock della perduta indipendenza economica. Tuttavia non avevo messo in conto che alla distanza fisica segue un distacco intellettivo e elettivo. Da lontano, riuscii a trasmettere solo fatti, non più emozioni, e per rispetto dei lettori, cessai la collaborazione. Accortosi del mio disagio, Prakash mi incitò a realizzare il mio sogno nel cassetto, quello di scrivere un romanzo storico. Sistemata nel nuovo appartamento gli diedi retta e l’esito mi lasciò senza fiato. Ero convinta che avrei scritto nella lingua di Shakespeare. Ma fu così solo quando scrivevo commercialmente. Se scrivevo per piacere, usavo un curry anglo-indiano. E se avevo l’esigenza di scrivere una poesia, questa nasceva solo in urdu, una lingua che pensavo d’aver del tutto perduto dopo la morte dei nonni materni. Con il tempo avrei capito che le poesie si possono scrivere solo nella lingua della felicità. Per me era sinonimo di quella degli antichi poeti persiani che sapevano plasmare una facoltà umana in una dimensione celeste. Il mio urdu è la voce di mio nonno che recita Faiz, l’immagine della nonna che appoggia la testa sulla spalla del consorte e sussurrando, ripete le parole come se fossero un incantesimo. È la magia. La magia delle serate di soffice pioggia che foderava il nostro giardino ancestrale di smeraldo liquido, distillando il profumo delle rose finché l’aria satura di piacere e la terra rossa inebriata di desiderio, sospiravano all’unisono. Io ero ancora una farfalla che svolazzava nell’arcobaleno dell’infinito quando, seduti sulla veranda a Julunder, nel Punjab, i miei nonni si amarono con gli sguardi e soprattutto con la voce. Mia madre nacque dall’alchimia della poesia. Me la trasmise con il suo latte, anche se dalla sua bocca non uscì mai più un verso da quando, assieme a centinaia di migliaia di persone innocenti, fu costretta a scegliere, in quella che fu una delle più traumatiche e barbare 72 la rivista dell’ Arte scelte per l’umanità. Nel 1947 l’India venne scissa in due. Mia madre aveva sei anni – un’età per imparare la poesia, non per dimenticarla. I nonni mussulmani decisero di rimanere lì dov’erano nati – nella terra che una volta era di tutti, ma che ora veniva decretata la patria degli indù. Pagarono il prezzo altissimo dell’isolamento sociale, del pignoramento dei loro terreni, del silenzio. Impararono a soffocare l’urdu per compiacere i nuovi padroni. Trasferitasi a Delhi dopo il matrimonio, mia madre non si è mai rivolta a me nella lingua in cui è stata concepita. Ho imparato i suoi melliflui segreti solo quando sono tornata a vivere con i nonni per un breve periodo dopo il trapasso dei miei genitori. In quel breve frangente di quiete tra due temporali mi riappropriai di quella lingua che mia madre aveva forse amato quando l’umanità era ancora rispettosa di Dio, di un dio poliglotta e pluriforme, e aveva rinnegato quando si rese conto che al mondo di credenti ce n’erano troppo pochi. Ma queste sono vecchie cicatrici che ho nascosto sotto le faccende e le fatiche del quotidiano. Comunque, se è vero che la poesia è la lingua dell’anima – beh, allora, grazie ad una nuova terra, grazie ad una vita diversa e ad una esistenza non più condizionata dalle esigenze di fede e di famiglia – scopro che la mia anima è un giardino di rose persiane. *** Io e Prakash siamo qui per restare. La mattina ci diverte bere un dolcissimo e schiumoso cappuccino e abbiamo cominciato a salutarci con un ciao. Abbiamo anche comperato due bellissimi cappotti. Finché ti senti di passaggio pensi che non valga la pena investire in una lingua nuova. Non investi nemmeno in un guardaroba adatto. Io finora sono andata in giro in abiti tradizionali, ma non per nostalgia. Il meglio del mio mondo antico me lo sono portato dentro di me. Tutto quello che non trova spazio nel mio petto è superfluo. Strano ma vero, è fuori dall’India che sento davvero il battito dell’India, che la amo, che la sono. Immersa nella sua realtà quotidiana avevo cominciato ad odiarla. Faccio parte forse di quel gruppo di indiani anacronistici, il cui cuore rifiuta di entrare negli sfarzosi templi costruiti in onore dei soldi e del successo – le uniche divinità universali adorate dai contemporanei. L’India che ho lasciato sembra aver svenduto la sua storia, le battaglie di Mahatma Gandhi e l’insegnamento di Swami Vivekananda. Sono venuta via da un mondo smanioso di opportunismo, sperando di trovare un mondo ancora pervaso di opportunità. 73 la rivista dell’ Arte Sarebbe sbagliato affermare che in Italia abbiamo trovato l’eldorado. Prakash ed io abbiamo costatato che anche qui l’humus è stanco, concimato chimicamente fino a diventare quasi sterile – un giardino di diritti sommerso dall’erbaccia, con i guardiani, i giardinieri della cultura costretti al prepensionamento. Lasciando la mia patria, dopo un primo periodo in cui ho voltato le spalle a quell’universo in cui non mi riconoscevo più, mi sono anche resa conto delle sue ricchezze. Ma non ho un cuore pieno di rammarico. Non ho una bocca nostalgica. Ho le corde vocali ansiose di vibrare di nuove note. Galoppo in inglese, sono un derviscio vorticoso in urdu, l’hindi è il mio kamasutra. In italiano procedo ancora carponi, ma presto mi alzerò in piedi, poi un giorno mi metterò a correre. E per te, solo perché ora ci sei tu, forse mi farò spuntare persino le ali. Il primo seme d’integrazione l’ho piantato nove mesi fa. Sei tu. Sarai figlio mio e di tuo padre, ma anche di questo suolo. Nel mio ventre, le mie arterie diventate corde di sitar ti hanno cullato con i raga di Tansen. Nel mio respiro hai sentito un concerto di bansuri – il flauto traverso amato dal dio Krishna. Allah accompagnato dagli angeli di ogni colore e credo ha benedetto ogni goccia di sangue che ti nutriva. E per completare il lavoro il mio essere madre ha filtrato il suono dell’amore da quello dell’odio che rende torbida l’esistenza umana. Tu hai aspettato anni prima di venirmi a cercare. Hai voluto che trovassi la mia indipendenza e il mio equilibrio prima di illuminare il mio ventre con il tuo sorriso. Sapevi che la maternità esige serenità e che solo un bimbo sereno può costruire un mondo di pace. *** Ero al corso preparto del Consultorio quando la domanda che mi frullava in testa dal momento in cui sei stato concepito è diventata manifesta. Distesa per terra a fare yoga con una decina di altre mamme – due delle quali straniere come me, la musica della foresta amazzonica che usciva dallo stereo è stata sormontata dalla voce dell’ostetrica: «In che lingua vi rivolgete al figlio che portate dentro di voi?». Nella lingua dell’amore, ho risposto io, tra lo stupore di tutti. La mia compagna di corso romena, sposata con un italiano ha detto che si sarebbe rivolta al suo nascituro nella sua madrelingua. La nostra amica turca gliel’ha sconsigliato. Troppi bambini nati all’estero crescendo si vergognano dei genitori che non parlano bene la lingua del paese ospite, ci ha avvertito. Essendo autoctone, le altre donne non si erano mai poste il problema. Ho letto tanto sull’argomento. Saggi, ricerche, romanzi. Ho sentito testimonianze, assistito a conferenze – in Inghilterra, in America e in Italia. I figli degli immigrati crescono tra più culture e più lingue, ovviamente doppiamente ricchi, ma anche doppiamente confusi, a volte molteplicemente infelici. Gli ostacoli che io e te 74 la rivista dell’ Arte incontreremo lungo la nostra strada sono stati vissuti da milioni di persone che si spostano come il vento, in ogni direzione. È questo vento della migrazione che sta lentamente erodendo l’arrogante stanzialità della montagna che crede di aver diritto assoluto al suolo che occupa. È la forza del vento che sbriciolerà la roccia in sabbia, offrendo ad ogni granulo uguale opportunità e la medesima dignità. *** Alcune coppie fanno figli per colmare la solitudine, per riempire i silenzi. Io, la solitudine la colmo con le parole – con la poesia, con i personaggi a cui do vita nei miei racconti. Io ti ho voluto perché il mio ventre sentiva la tua mancanza, perché il mio sangue mormorava il tuo nome, giorno e notte. Ma sono consapevole di non essere altro che il ricettacolo messo a disposizione della tua anima dal Creatore. Il Sommo Maestro ci ha voluto allievi della stessa scuola di mosaico; lavoreremo fianco a fianco, incollando tessera dopo tessera, per creare un disegno che certamente non sarà perfetto, ma che sarà senz’altro unico. Nostro. La colla che userò sarà quella dell’amore incondizionato. Cercherò anche di rafforzarla con la pazienza. Ma so che avrò bisogno anche di una base linguistica perché una volta venuto al mondo, nel frastuono del quotidiano perderai il dono della telepatia. Che lingua devo scegliere per amarti, per incitarti e rispettarti, mio tesoro? Ironia della sorte, questo paese in cui sei nato e che celebra quest’anno il centocinquantesimo anniversario della sua unità, ti ha dato un benvenuto in una lingua straniera. Era Michael Jackson che intonava Black or White alla radio nella sala parto. È stato seguito da Mino Reitano che cantava il suo amore per la patria. Quanti segni per uno che è superstizioso! Quanta titubanza. Quanta paura. Alterno smodata gioia con previsioni nefaste. Nella mia sfera di cristallo purtroppo vedo che fino alla maggiore età il Bel Paese ti nutrirà di illusioni d’appartenenza. Per quasi quattro lustri crescerai sentendoti indiano forse solo di pelle. Preferirai la pizza ai paratha, Rosi a Ray, e conoscerai Pascoli meglio di Tagore. Per non complicarti la vita, non interferirò con le tue scelte. Sarò la tua àncora, ma mi nasconderò sotto la sabbia dell’Adriatico per non farti sentire il mio peso. Per renderti felice e far sì che tu non debba mai vergognarti d’avere una mamma ‘diversa’, imparerò a cucinare la pizza, andrò al cinema, studierò i classici. Speriamo che non sia invano. Speriamo che non arrivi la doccia fredda di sapere che dopo tutti i nostri sacrifici per alcuni conta solo un pigmento. Ahimè, se non cambiano le cose, la vedo dura. Puramente per la tua ancestralità, l’Italia ti negherà una patria e un passaporto. Arrivato alla maggiore età mi auguro che non pignorino la tua affiliazione culturale, la tua alleanza identitaria perché a 75 la rivista dell’ Arte quel punto, se la politica metterà all’asta tutte le tue certezze, forse rimprovererai tua madre per non averti fatto investire nella cultura dei tuoi avi. Amore mio, l’incubo di ogni madre è quello di sbagliare. Per poco amore. Per troppo amore. Per inesperienza, arroganza, fragilità. Per il semplice fatto di essere umani. L’istinto di una madre dovrebbe dirle quello che è giusto, ma l’istinto di una brava madre è punteggiato da mille dubbi. Dalla mia placenta hai assorbito il canto del Brahmaputra, ma temo che venuto al mondo quelle antiche melodie ti sarebbero straniere. Nel mio latte hai sentito ridere il Kunchenjunga innevato solleticato dai monsoni, ma crescendo tu non rideresti, né di commuoveresti per le stesse cose. Figlio mio, stringendoti tra le braccia mi interrogo su che lingua ti devo parlare. E soprattutto mi chiedo: tu come mi risponderai? I miei seni straripano di incertezze. Ma tu, placido come un lago di loti, sembri accettare quel nutrimento interrogativo. Frantumarlo. Digerirlo. Eliminarlo. La tua esistenza non è ancora stata contaminata dalla paura della diversità. Succeda quel che succeda figlio mio, ricordati che tuo padre ti ha benedetto in sanscrito. Le infermiere ti hanno detto ciao. E ora che hai aperto gli occhi, riconoscendomi per la prima volta come entità da cui ti sei scisso, in un flash nei tuoi occhi ho letto tutti i libri di tutte le vite che hai trascorso prima di comporre un nuove volume di poesie con me. E ho taciuto. Farò del mio meglio per imparare una nuova lingua per comunicarti tutto il mio amore – tradotto e intraducibile. Per te diventerò occidentale nell’aspetto e nell’appetito. Mi abituerò ad una colazione dolce, a pranzi meno odorosi. A fine pasto prenderò un caffè al posto di masticare dei semi di finocchio zuccherati. Non sarà un sacrificio, sarà un’evoluzione. Ma sappi che in me una sola cosa non potrà mai mutare: il mio silenzio. Il mio silenzio è, e non può che rimanere, orientale. Non è un silenzio rancoroso o intriso di sfiducia. Non è il mero opposto del rumore. Non implica una chiusura verso un mondo troppo suscettibile e troppo solipsistico. Il silenzio orientale è privo di giudizio, e di conseguenza scevro di dolore. È il silenzio 76 la rivista dell’ Arte dei swami – un’assenza che implica liberazione dal desiderio e dall’attaccamento, elevazione dello spirito, etere in cui trasmettere sentimenti puri. È l’unica dimensione in cui, in nome dell’amore, l’io può essere scalfito. Quindi, figlio mio, ricorda sempre che quando vorrai davvero ascoltare la voce di tua madre, ascolta i suoi silenzi. la 77 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Ron Kubati Appartenenze Guidare nuovamente a Roma dopo un periodo trascorso all’estero è importante. Altrove i guidatori devono ciecamente obbedire agli stop, che spesso ci sono ogni decina di metri, ai segnali stradali, ai limiti della velocità. Certo non al 100%, ma un bel 70% sì. A Roma invece il non scontrarsi è del tutto nelle mani dei riflessi dell’individuo. L’entropia è notevole. Il “fai da te”, la relatività del tutto qui si esaltano. La densità delle periferie, le case che sembrano costruite una sopra l’altra, la gestione dello spazio, l’arte dell’arrangiarsi colpisce l’occhio e sorprende per la reazione stessa chi ritorna. La ragione della collettività, le regole, anche perché devono gestire una generale frustrazione economica, sono viste come qualcosa a cui riferirsi con approssimazione. C’è allora questa percentuale maggiore di entropia che ha conseguenze plurali. L’insufficienza economica abbinata all’entropia dà vita a sfortunate sinergie che creano qua e là forme locali e postmoderne che sanno di feudalesimo neoliberista o di neoliberismo feudale. In queste circostanze in cui non ci sono possibilità lavorative per tutti, la combinazione di un vuoto dell’applicazione delle regole con qualche forma di potere locale, o di potere politico, o di potere professionale, o di potere criminale, fa sì che quest’ultimo badi all’utile economico con tendenze aggressive e monopolizzanti, finendo così per frammentare ulteriormente il panorama complessivo. Queste sinergie sono presenti a tutti livelli, sia verticalmente, sia orizzontalmente 78 la rivista dell’ Arte dando vita a una per così dire insufficienza sistemica cronica. Il mondo dei favori, delle conoscenze, delle scorciatoie in un sistema impoverito, con meno opportunità, diventa una soluzione di sopravvivenza che fornisce autolegittimazione a chi le scorciatoie le imbocca. Senza entrare qui in analisi economiche, lo stesso neoliberismo come sistema ha bisogno di un certo livello di ricchezza e di regole certe ed efficaci. La via d’uscita passa esclusivamente attraverso lo sviluppo economico da un lato e attraverso una migliore condivisione delle regole dall’altro. Non ci sono soluzioni immediate. Serve un lavoro lungo e continuo. Tuttavia, questa relativa entropia non necessariamente ha risvolti solo negativi. Lo spazio viene in un certo senso dilatato per lasciar coesistere vari gruppi. Roma per esempio, ha un centro storico internazionale dove si parla inglese, francese, tedesco, giapponese e italiano, e delle periferie meridionali, esteuropee e nordafricane. Roma è il volto mediterraneo della globalizzazione, certo una globalizzazione classista e problematica che però non può fermare le contaminazioni. A Roma si può cominciare a raccontare una storia diversa, quella di piazza Vittorio, quella che alcuni chiamano mondializzazione, quella che avvicina Berlino e Il Cairo, quella che può mantenere legata l’Europa al Mediterraneo senza rinunciare a New York. Le idee, la loro storia, si attaccano al suolo, agli alberi, alle case e sono un’architettura o geografia invisibile con cui devi imparare a fare i conti. Attento qui c’è una collina, là di solito piove, stai camminando sulla stradale... dove ci sono stati decenni di comunismo italiano, dove le parrocchie e le loro campane hanno scandito la loro vita, dove i megafoni elettorali sono importanti, dove una certa architettura fascista resiste ai tempi, dove ci si sposa sempre di meno e alle parrocchie nelle cittadine del sud fanno concorrenza i circoli politici di Vendola; dove Modugno viene splendidamente reinterpretato in napoletano e in arabo dai Radio Dervish; dove gli amici del sud hanno fatto quasi tutti i conti con un periodo di emigrazione interna, maggiormente a Milano, ma sempre più spesso anche a Roma; dove esiste già la seconda generazione Erasmus; dove i migranti dell’Est ora arrivano senza bisogno di visto e popolano sempre più le università italiane; dove il confine si è spostato dove la differenza economica è maggiore, quasi unicamente a Lampedusa. Ma che cosa significa oggi essere non italiani in Italia? I migranti entrano in conflitto con le circostanze avverse e, quindi, con le politiche e le concezioni della società destinataria che tendenzialmente percepisce i migranti come forza lavoro (anche il così detto Permesso di soggiorno è legato ad un contratto di lavoro) da inserire nella parte meno qualificata del mondo lavorativo, creando così il ceto più povero della società. Naturalmente, i migranti hanno progetti molto più audaci per loro stessi. Insieme all’identificazione dei migranti con la forza lavoro, un altro aspetto importante da notare nella concezione dei migranti dalla parte della società ospite è la loro identificazione con il loro paese d’origine. Gli aggettivi principali che 79 la rivista dell’ Arte qualificano gli individui non nati in Italia sono: la nazionalità dell’origine, extracomunitario, immigrato, straniero, slavo (nel caso di individui originari dell’Est Europa, molto spesso chiamati così impropriamente), arabo (e anche qui a volte in modo improprio), mussulmano ecc. Tutti questi aggettivi esaltano lo stesso elemento: la non italianità (in casi più specifici, anche la non cristianità). E fa niente che molto spesso si tratta di persone che vivono nel paese da molti anni, che parlano un italiano impeccabile, che prendono gli accenti regionali, che conducono lo stesso stile di vita degli indigeni, che lavorano e riposano negli stessi giorni degli altri, che riempiono i bus e i tram come tutti ogni mattina e ogni sera, che fanno la fila in autostrada appena scatta il cosiddetto ponte breve, che pagano le tasse, che mandano i figli nelle stesse scuole, che hanno dei figli che sono italiani per nascita e per cultura. La non italianità a sua volta è funzionale al desiderio collettivo di non subire competizione per quanto riguarda i posti di lavoro qualificati. La collettività vorrebbe dare un lavoro ai non italiani soltanto se nessun altro italiano vuole quel posto di lavoro. Sociologi e politici scomodano spesso le statistiche per sottolineare come gli immigrati riempiano quei vuoti del mercato lavorativo che altrimenti rimarrebbero tali. E visto che la concezione del migrante è implicitamente associata al disagio economico, l’intera società non si aspetta altro che il loro inserimento nei suoi strati più bassi. Per impedire che le cose vadano diversamente, il mercato lavorativo del settore pubblico (il mestiere del giornalista compreso), tranne rare eccezioni forse in accademia, vincola le assunzioni al possesso della cittadinanza, il cui ottenimento richiede un percorso lunghissimo, tortuoso e incerto. Durante questo percorso, il soggiorno del migrante nel territorio italiano rimane incerto e più che precario in quanto il permesso di soggiorno gli deve essere periodicamente rinnovato, con facilmente immaginabili ripercussioni sul piano psicologico. Agli aspetti legislativi ed economici vanno aggiunti altri, numerosi e complessi, di natura per così dire culturale che appesantiscono la condizione del migrante dal punto di vista esistenziale. Perché dire migrante per un certo discorso ideologico-culturale che influenza il senso comune vuol dire povero, disagiato, non attrezzato con i dovuti strumenti culturali del contesto, precario, infelice, spesso di religione differente (non certo fonte di simpatie nell’Occidente dell’inizio del XXI secolo) e probabilmente anche incline a scorciatoie criminose. Questa articolata e svantaggiosissima condizione umana è dovuta soltanto ad un elemento: alla non italianità. L’impressione è quindi che sia sempre l’identità nazionale ad offrire quel grande numero di articolazioni che descrivono l’uomo senza naturalmente spiegarlo. Mentre la migranza è uno dei movimenti più potenti che spinge al ripensamento della rigida e tradizionale concezione dell’identità nazionale, nel mondo e persino in Europa c’è chi continua a battersi per l’emancipazione dell’identità nazionale. La caduta dell’impero sovietico ha fatto saltare molti equilibri instabili e l’Europa si affretta a coprire molti vuoti problematici cercando di includere 80 la rivista dell’ Arte nell’Unione Europea nazioni dell’Est, una aggregazione che funge di fatto da una nuova identità sovranazionale a venire. È tuttavia evidente che dietro l’identità nazionale problematizzata dall’immigrazione, si celi una questione economica. L’appartenenza ad una determinata nazione si è spesso tradotta nell’appartenenza ad un ceto economico di un mondo gerarchizzato che usa aggettivi come primo, secondo e terzo, oppure altri come sviluppati, in via di sviluppo e non sviluppati. I cittadini del mondo uno, ossia di quello sviluppato, possono circolare liberamente ovunque perché implicitamente in possesso dei mezzi economici necessari. I cittadini degli altri mondi, no. Di conseguenza la non italianità, o la non comunitarietà, altro non indica che un sommario ceto sociale a cui i non- “mondoprimi” dovrebbero appartenere. Naturalmente si tratta di indicazioni generalizzanti perché tra i migranti in Italia sta avanzando un vasto gruppo di piccoli e medi imprenditori e un gruppo di professionisti di ogni settore. Non è un caso però che un fattore indispensabile (se non il principale) per la regolarizzazione dei migranti rimanga quello economico. Il passaggio dalla clandestinità alla legalità è stato possibile durante le diverse cosiddette sanatorie degli ultimi anni solo attraverso un contratto di lavoro. È sempre la logica economica a dominare e tutti i cittadini provenienti da aree non sviluppate sono potenziali clandestini-criminali. I mezzi economici danno ai migranti il diritto di fare parte della comunità del mondo uno. Da questa prospettiva diventa ancora più chiaro come l’emancipazione dell’individuo migrante sul piano dei diritti passi necessariamente anche attraverso l’emancipazione economica. Il problema dell’identità nazionale che vincola negativamente i cittadini esclusi dal cosiddetto mondo uno, oggi come mai sembra conservare una forte connotazione economica. I diritti umani nel ventunesimo secolo non possono più prescindere dall’emancipazione economica. Se l’ingresso e la permanenza dei migranti passa attraverso il posto di lavoro e i mezzi economici, sembra evidente che il profilo corrente dell’uomo in Occidente tendenzialmente implichi un grado minimo di sufficienza economica. Il discorso etnico sembra contare ora non più come un mero aspetto biologico quanto come un significante del significato economico e, in una certa misura, anche culturale. Il capitale culturale di partenza è in grado di fare la differenza tra i migranti. L’istruzione universitaria può non venire riconosciuta come titolo ma è sempre lì, non sparisce, si trasforma in abilità per accelerare la risalita. Di fatto, da un paese come l’Albania, la cui immagine è stata a lungo penalizzata dai media italiani, sono venuti fuori un grande numero di medici, ingegneri, economisti e letterati. Questo anche grazie alle caratteristiche dell’organizzazione sociale in Italia, dove la mobilità sociale verso i primissimi strati della classe media è possibile. Ciò che è più difficile è la mobilità sociale all’interno della classe medio-alta. Il fattore che ha reso e rende possibile questa relativa mobilità sociale è l’istruzione pubblica. Smantellare il sistema dell’istruzione pubblica e della sanità pubblica sarebbe un errore madornale 81 la rivista dell’ Arte perché essi sono i pilastri del futuro della collettività, sono tra le condizioni migliori perché ci sia una collettività. È l’istruzione pubblica che permetterà alla ricchissima eredità culturale dell’Italia di essere trasmessa ai nuovi arrivati e far sì che l’italianità si emancipi dal fattore biologico e monoetnico, anche per non cadere, come accade nell’ultimo ventennio, in presupposte ma inesistenti differenze etniche nord-sud. In un paese la cui crescita sarebbe negativa senza l’apporto degli immigrati, ci vuole uno sforzo istituzionale lungimirante per favorire anche le carriere umanistiche dei giovani di altra provenienza. Il tempo necessario per un investimento culturale adeguato è molto lungo. Il vincolo della cittadinanza per carriere giornalistiche o nel settore pubblico è un errore. Le urgenze della vita sottraggono energie e senza un sostegno finanziario la trasmissione dell’eccezionale patrimonio culturale italiano è impossibile. Il rischio di omologazione invece può essere sventato da una fortunata percentuale di esteriorità del creolo. È difficile che l’immigrato multippartenente, specie se di prima generazione, sia un automa che replica senza elaborare quanto gli viene impartito. E non per merito ma semplicemente perché ha più di un sistema di riferimento. I seminari e le conferenze che celebrano e riflettono sull’anniversario dell’Unità d’Italia si susseguono. Ma come si è fatta l’Italia? Quale percorso ha fatto? Quale tradizione ha messo a fuoco e a credito? E di conseguenza, quale progetto ha per il proprio futuro? La risposta è una narrazione che s’impara tra i banchi di scuola, in famiglia, all’università, nei gruppi degli amici, leggendo romanzi, giornali, guardando la Tv. Quello che approssimativamente viene chiamata mentalità italiana ha radici in queste narrazioni. Sono convinto che non ci sia una mentalità italiana ma tante. Tuttavia spesso tra i giovani italiani umanisti si nota un atteggiamento verso la modernità per cosi da “nobile offeso” dallo scempio della modernità, dal macchinale che sostituisce l’umano, dalla contemporaneità troppo meccanica e affannata, dis-umana, con uno sguardo rivolto più all’indietro che in avanti, con una sottile nostalgia inarticolata e indeterminata i cui riferimenti si perdono nei secoli e spesso diventano illusioni idealizzate. Bisogna cambiare o arricchire la narrazione, bisogna conservare il meglio del passato ma per rilanciarlo nel presente, nel domani, in una nuova chiave. Bisogna capire che siamo mediterranei, che dobbiamo condividere un progetto comune in Europa e nel mondo; che anche noi siamo gli uomini che decidiamo di essere. Bisogna capire che la tecnologia e lo sviluppo hanno grandi potenzialità liberatrici e non vanno lasciate esclusivamente nelle mani delle multinazionali. Bisogna capire che la democrazia non può vivere di solo pane e pomodoro ma che ha bisogno di sviluppo sostenibile e continuo. Bisogna capire che le migrazioni fanno parte della vita e della storia della specie umana, e che spesso esse sono necessità e progresso, che le lingue anche se operate imperfettamente sono importanti, che le identità nazionali sono appartenenze a cui lungo la strada se ne 82 la rivista dell’ Arte possono aggiungere altre. Migrare oggi non è come migrare all’inizio del ‘900. Le comunicazioni via internet e i voli lowcost permettono l’esistenza di reti sociali che trascendono lo spazio di una città e di una cultura monolingua. I migranti sono agenti contaminatori della mondializzazione e, migrare, sempre più spesso, può trasformarsi in un privilegio. Sarebbe un errore tuttavia saltare le articolazioni che ci sono in mezzo. Le esperienze tragiche del Novecento ci hanno insegnato che non si può essere semplicemente “cittadini del mondo”. La non appartenenza a nessuna entità politico-culturale è impossibile. Le retoriche vuote sono rischiose. Al contrario, la pluri-appartenenza è possibile ma deve essere rigorosamente coltivata. Essere italiani oggi significa essere italiani in Europa e nel Mediterraneo. Mentre essere italiani nati altrove, significa essere italiani in Europa e nel Mediterraneo di altra origine. [dall’Albania in Italia e ora a Chicago, come tanti giovani ricercatori e intellettuali italiani emigrati altrove, negli anni del nuovo millennio] la 83 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Ali Mumin Ahad Da un emisfero all’altro I. Un percorso di vita con/ed/attraverso la lingua italiana Il 150simo anniversario dell’Unità di un’Italia Nazione-Stato indipendente e sovrano dalle diverse potenze coloniali e dai molteplici poteri locali, è segnato, dal mio punto di vista esterno di studente e di studioso della cultura e della storia italiana, da due “argomenti” che non possono essere passati in silenzio né tantomeno soppressi. Il primo argomento è la nascita chiara e ben definita fin dall’inizio, due decenni fa, di una letteratura dell’immigrazione (o, se si vuole caratterizzarla giustamente come parte di un fenomeno piú generale, di una letteratura italiana della migrazione) in Italia. Si tratta di un inestimabile contributo culturale. Bisogna dirlo con riconoscenza, senza dubbi di sorta, che uno degli artefici di questa emersione dal fondo marginale, al quale altrimenti sarebbe stata destinata questa letteratura, è un accademico italiano, l’amico Armando Gnisci. È soprattutto tramite il suo impegno accademico e letterario-umanistico se oggi l’Italia puó vantare il fiorire di una letteratura in lingua italiana che è il prodotto di persone provenienti da tutto il mondo. Il loro contributo alla letteratura italiana è 84 la rivista dell’ Arte l’assoluta novità epocale, come sostiene Armando Gnisci. Sin dagli inizi, alla fine degli anni 80, egli ha “compreso” la validità e l’importanza culturale del fenomeno migratorio dal Sud del Mondo verso l’Europa. Non era facile, ma egli, di quel fenomeno, ne aveva intuito la portata e vi ha creduto nel suo sviluppo futuro. L’epicentro di questo movimento di umanità non poteva non essere l’Italia. Per varie ragioni. Una tra le quali, la vicinanza geografica con l’Africa e con il Vicino Oriente. Un’altra ragione è storica. L’Italia è da sempre stata contaminata e dominata da tutte le civiltà fiorite intorno al Mediterraneo e, attraverso queste, da altre piú distanti. È crogiuolo di popoli per conseguenza dell’Impero Romano che vi ha avuto la sua sede centrale. È sede di una delle religioni monoteiste con missione universale. Non sto parlando di missione civilizzatrice, ma piuttosto di attitudine pratica di essere al mondo e in mezzo al mondo. È patria, infatti, di quelle repubbliche marinare che avevano interessi commerciali sia ad occidente sia ad oriente. Patria di illustri nomi come Marco Polo, Lanzerotto Malocello, Nicoló Da Conti, Cristoforo Colombo, Ludovico di Varthema, Antonio Pigafetta, Amerigo Vespucci. Solo per citarne alcuni, a caso. Esploratori, mercanti, navigatori e avventurieri che hanno avuto l’audacia di attraversare gli oceani alla scoperta ed al contatto con il resto del mondo, alla ricerca di altri spazi. Seguiti da nomi ben piú vicini alla nosta epoca e storia. Vale a dire, di apri-strada per l’esodo coloniale che dall’Europa porterà un’altra umanità verso l’Africa e il Vicino Oriente. Ancora con posti al sole vuoti. Sappiamo che molti italiani subito dopo l’unificazione dell’Italia come nazione, cominciarono ad emigrare soprattutto nelle Americhe, ma anche in Europa, in Africa e in Australia. Pur con queste credenziali storiche, è strano che agli italiani di oggi non è piú comprensibile il significato profondo di questo movimento di umanità che è l’immigrazione in Italia e in Europa. Siamo (e mi includo in questo noi per esprimere l’appropriata autocritica) fuori dalla storia. Per comprenderlo, invece, basterebbe rammentare e tenere in grande considerazione la vicenda del grandissimo auto-esodo di milioni di italiani verso il mondo che si è chiuso da pochi decenni (definitivamente?) relativamente al tempo lungo della storia, un’epoca che ha visto in movimento italiani e europei “in fuga” dalla povertà. Tutto ciò sembra così distante, ora. Così come anche il periodo storico post-unitario comunemente conosciuto come coloniale, e coevo della Grande Migrazione. Quanti secoli fa? Da questo punto di vista, infatti, l’Europa (e più ancora l’Italia) sembra quasi essersi velocemente “decolonizzata”, ma dimenticando una parte importante della sua memoria storica e, con essa, di ogni “responsabilità storica” coloniale che le possa aprire gli occhi sul significato e sulla portata degli attuali movimenti di umanità dall’Africa, dal Vicino e dal Lontano Oriente e dall’Europa orientale. Scoprire e conoscere il mondo significa anche essere conosciuti e scoperti da parte dei popoli che si presentano per la prima volta alla vicendevole conoscenza, e che invece sono stati deviati dal loro cammino di civiltà. I grandi viaggiatori 85 la rivista dell’ Arte italiani, a cominciare da Marco Polo in poi, segnano i sentieri che dovranno poi ridurre le distanze, combinando le polarità reciproche, per creare un mondo veramente globale. Sono loro gli epitomi della globalizzazione, la sua disconosciuta forma vitale. Ad ogni andare, inesorabilmente, segue un venire. La storia delle vicende umane ha corsi e ricorsi. Altri italiani, invece, hanno esplorato ben altre dimensioni che, pur esse, avrebbero poi costruito ponti tra culture tra loro distanti, e non solo geograficamente. Inconsapevolmente, forse. Mentre il suo contemporaneo Marco Polo compie viaggi in terre più lontane dall’Europa, Dante compie il suo metaforico viaggio nel mondo di là. Metaforizzando il suo esilio da Fiorenza, scrive quella Commedia che diventa il fondamento sul quale si ergerà la lingua italiana. E cioè un formidabile mezzo di espressione, e il più efficace, per presentarsi al mondo, per farsi conoscere e far conoscere agli altri ciò che siamo. È da questa conoscenza dell’altro di noi stessi che deriva la possibilità di abbracciare l’altro con il mondo. Di condividere il mondo con l’altro. Sono questi sentieri che accorciano le distanze geografiche e culturali e, al tempo stesso, arricchiscono lo spirito. È con questa prospettiva che io guardo il lavoro di quanti utilizzano, in maniera creativa, la lingua italiana. La lingua di Dante diventò anche la lingua di scrittrici e scrittori “italiani” le cui radici culturali sono radicate in contesti culturali e storici non propriamente italiani. Scrittrici e scrittori moderni (non postmoderni, ma postcoloniali sì) scrivono nella lingua italiana, senza essere italiani. Vivere in Italia, vivere-con e condividere la cultura italiana, fa di loro degli italiani più che un semplice atto d’ufficio. Beninteso, un riconoscimento come la cittadinanza sarebbe la cosa piú giusta nei confronti di chi con il suo lavoro contribuisce al bene pubblico. E la lingua è un bene pubblico. Tuttavia, essi possono bene rivendicare di essere riconosciuti, tout court, come scrittori italiani, parte integrale e integrante di quella Letteratura Italiana della Migrazione che il mio amico Armando Gnisci ha preconizzato. Ciò non toglie che essi possano riconoscersi anche nelle loro radici culturali primarie. Proprio qui sta, secondo me, il valore di quella ricchezza a cui accennavo prima. Un reciproco contribuire all’accorciamento delle distanze. La validità di questo contribuito va anche misurata dalle differenze di prospettive sulle esperienze storiche. La produzione letteraria di quanti non-italiani scrivono nella lingua italiana rispecchia anche quelle esperienze. Deve farlo. Altrimenti, non è possibile quel reciproco conoscersi a fondo per apprezzarsi a vicenda. All’interno di questa vasta e multiculturale letteratura dei migranti, si sviluppa e prende coscienza di se stessa un’area che ho preferito definire senza mezzi termini, letteratura postcoloniale italiana. Il suo punto di riferimento, un’area geografica molto ristretta, il Corno d’Africa. In altre parole, le ex-colonie italiane sul Mar Rosso e l’Oceano indiano. Qui, non solo l’uso della lingua italiana è il segno distintivo dell’italianità, 86 la rivista dell’ Arte ma anche di una certa specificità culturale tutta italiana (che le scrittrici e gli scrittori provenienti da quest’area portano con sé) e che non viene acquisita con l’immigrazione in Italia. Si tratta, invece, di un’opera di un quasi secolare processo di acculturazione italiana. Questo processo di acculturazione nel Corno d’Africa, si potrebbe dire, inizia addirittura con l’unità d’Italia di cui ricorre il 150simo, dal momento che è la prima generazione di italiani del dopo-unità ad esserne il promotore. Per questo, propendo a pensare che se l’Italia fosse stata l’Inghilterra, una letteratura postcoloniale non avrebbe avuto difficoltà a emergere e a influenzare positivamente la letteratura italiana già da mezzo secolo. Per due motivi. Innanzitutto, avrebbe offerto maggiori possibilità di istruzione ai propri soggetti coloniali, cosa che la politica coloniale italiana non prevedeva affatto. Secondo, avrebbe dato l’opportunità di emergere a quanti, provenienti dalle ex-colonie italiane, potevano contribuire creativamente con idee e prospettive differenti o diverse da quelle italiane. Rushdie, Naipul e Soyinka sono espressioni viventi, simboli, il risultato di una politica coloniale diversa da quella italiana. Il secondo argomento che dovrebbe caratterizzare, sempre secondo la mia personale opinione, questo anniversario dei 150 anni dell’unità dell’Italia riguarda la sua storia o, per meglio dire, il “destino” che la storia ha riservato alle sue ex-colonie africane nel Corno d’Africa, e alla Libia. Qui non c’è bisogno di dilungarsi, tutto è attualità: la situazione di isolamento dell’Eritrea, il fallimento dello stato postcoloniale in Somalia, la tragedia della guerra civile in Libia. Tre situazioni tragiche di altrettanti tre paesi che sono stati colonie italiane. Detto questo, per me è importante sottolineare come tale “destino” storico fatale influenzi quella che io amo chiamare “letteratura postcoloniale italiana”. Non potrebbe essere altrimenti, se è vero che la letteratura è la traduzione delle nostre vite e vie e la lente o binocolo per “vedere” a distanza quanto umanamente è prevedibile del nostro futuro. Ad altri riservo la riflessione sul destino fatale di queste excolonie italiane. Le esperienze politiche e le vicende storiche dell’ex-Somalia italiana sono note oggi al grande pubblico italiano, piú di quanto non lo furono alla fine degli anni Ottanta allorquando le vicende della Cooperazione Italiana allo Sviluppo cominciarono ad apparire sui giornali in Italia. Che grande confusione, tra bene e male, tra fatti e misfatti. Un’altra epoca, un’altra storia. Ma sotto il sole dell’Equatore, ancora si muore e non solo di fame. Che tristezza la nostra/vostra condizione postcoloniale! Preferisco passare a note meno impegnative per dare colore (e calore) al grandioso avvenimento dell’anniversario. Come potrei farlo se non attraverso cenni autobiografici e con immagini letterarie che tradiscono un’italianità di lingua e di cultura? Di cui sono anche orgoglioso, nonostante la Bossi-Fini. Parto da lontano. Dalla scuola. Italiana, naturalmente. La familiarità con la lingua antecede anche l’età scolare. Ma è con la scuola che la lingua italiana assume 87 la rivista dell’ Arte per me una dimensione particolare. Negli anni Sessanta gran parte delle scuole in Somalia aveva l’italiano come lingua veicolare. Soltanto a metà degli anni Sessanta la scuola inizia ad aprire all’inglese, lingua già in uso nelle scuole di quella che era (ed è ritornata ad essere) la ex-Somaliland. Si trattò di un passaggio favorito dai ministri dell’Istruzione provenienti dal Nord (attuale Somaliland) ex-colonia Inglese. A ragione o a torto, non lo so ancora. Essendo nato a Beled Weyne (Belet Uen, nella trascrizione italiana dell’epoca), alla fine degli anni Sessanta, l’inglese aveva completamente sostituito l’italiano nelle scuole elementari, mentre per le Medie Inferiori continuava ad essere ancora la lingua veicolare. I diplomati dalle Medie Inferiori di Beled Weyne, però, dovevano andare a Mogadiscio per proseguire le Medie Superiori. Come ogni città o paese di provincia, le possibilità di studi erano limitate. La lingua somali, non aveva ancora trovato un alfabeto. I dibattiti parlamentari sull’adozione di un alfabeto per la lingua nazionale, erano piuttosto faziosi. La lingua somala rimaneva pertanto nella dimensione orale. A Beled Weyne, come pure a Mogadiscio, con la presenza culturale egiziana in quegli anni, l’arabo faceva concorrenza sia all’italiano che all’inglese insegnato nelle scuole pubbliche. Tra scuola Araba-Egiziana, Inglese-Pubblica e Italiana, la scelta dei miei cadde su quest’ultima. Per me, fu una scelta felice per certi versi. Si trattava di una scuola privata cattolica. Sebbene possa suonare strano che una famiglia musulmana che da secoli è stata in prima fila nella diffusione e nella difesa dell’Islam in Somalia, mandi i propri figli a una scuola di una Missione Cattolica, la cosa era del tutto pacifica per la mia famiglia. I tempi erano cambiati, cosí come gli atteggiamenti. Non si trattava piú di fronteggiare un potere coloniale, ma di relazionarsi con un altro paese e con la sua cultura, da una posizione sovrana e di parità. Nel rapporto con l’ex-potenza coloniale non vi era piú antagonismo, né timore di essere sopraffatti, o rifiuto dello straniero. La lunga convivenza, tra lotte e pacificazioni e, persino, di militanza nelle stesse file (penso ai nostri dubat illusi dal Fascismo con l’ideale di una Grande Somalia), aveva maturato nelle famiglie la prospettiva di dare alle nuove generazioni un atteggiamento in sintonia con i tempi. A cominciare da scelte ragionate di istruzione per i propri figli. Una nuova generazione. È in questa condizione di serenità di rapporti che fui iscritto in una scuola italiana. Dove le Suore della Consolata ci insegnavano tutto, tranne la religione. Questa era l’intesa tra la scuola e le famiglie che mandavano i loro figli a studiare nella scuola italiana della missione. Un’intesa mai venuta meno, debbo dire, da parte della scuola. È in questa scuola della Missione Cattolica di Beled Weyne che conosco, per la prima volta, Dante Alighieri, vale a dire, la lingua di cui egli è considerato il padre. Le suore della Consolata che furono le mie prime maestre delle elementari in quella scuola di Beled Weyne, hanno contribuito molto al mio attaccamento a questa lingua, nella quale sto scrivendo dall’Australia, ed alla cultura di cui essa è il mezzo 88 la rivista dell’ Arte espressivo piú alto. Suor Isidora Fossat e Suor Adelina Londero, in particolare. La prima fu la mia prima maestra della scuola elementare. Una delle cose che imparai da lei è l’ascolto degli altri e della natura intorno a noi. Ogni mattina, per qualche minuto, ci affacciavamo tutti (eravamo in pochi, in quella classe di prima e seconda insieme) alla finestra della nostra aula scolastica che si apriva su un meraviglioso giardino con aiuole fiorite ed altre piante. Per ascoltare, ci diceva, il canto degli uccelli, oppure il silenzio della natura. Quanta pace, quanta serenità in quella scuola a ridosso del Campo Militare di Beled Weyne. Infatti, la Scuola della Missione ed il Campo Militare occupavano insieme la penisola formata da quell’ansa del fiume Shabelle (Fiume dei Leopardi) visibile su google. È un’ansa strategica. Lo avevano scoperto anche i dervisci dello Sceicco Mohamed Abdille Hassan - il cosiddetto Mad Mullah dagli Inglesi contro i quali egli si ribellò nelle regioni del Nord - che arrivarono a occuparla nel 1913, secondo quando riferisce Francesco Saverio Caroselli, dopo avere sconfitto i Makanne, la popolazione originaria del posto con i quali avevano pure precedentemente stabilito un patto tribale di non aggressione1. Italiani e Inglesi, in successione, avevano fatto di quell’ansa del Fiume Shabelle la roccaforte della loro occupazione. Dunque, la Scuola Italiana della Missione Cattolica si trovava su quella stessa penisola insieme al Campo Militare occupato dall’Esercito. Naturalmente, non avevo ancora letto Ferro e Fuoco, titolo spaventosamente profetico oltre che storico. Se la generazione precedente alla mia, che aveva pure studiato con questa lingua, aveva avuto testi scolastici preparati dall’AFIS (Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia) che rispecchiavano la realtà locale, nella nostra scuola noi studiavamo sugli stessi Sussidiari in dotazione degli studenti italiani del nostro stesso livello in Italia. I Sussidiari erano grossi volumi con una copertina pregiata sulla quale erano riprodotte opere d’arte molto famose: il Mosè di Michelangelo Buonarroti, i ritratti di Dante Alighieri, di Leonardo Da Vinci, di Galileo Galilei, ecc. Con oleografie di Giovanni dalle Bande Nere, di Antonio Pigafetta, di Garibaldi e dei suoi Mille, dei miti Risorgimentali. Questi grossi tomi offrivano un compendio di Italiano, di Storia e Geografia, di Scienze e di Matematica. E costavano, eccome! Questa comunanza di programma con la scuola italiana portava, sin nella nostra città sul confine con l’Etiopia, gli Ispettori del Ministero dell’Istruzione Pubblica in Italia. Ricordo ancora il nome di uno di loro, Dott. Pasquale Di Natale, se ricordo bene, giunto da noi per parlare dei preparativi per il 110 anniversario dell’unità, oltre che per creare delle classi medie. Il colpo di stato in Somalia interruppe i preparativi per le celebrazioni e, di lí a un anno, anche la scuola della Missione Cattolica di Beled Weyne dovette chiudere le porte. Per mia fortuna, proprio in quell’anno scolastico terminavo le elementari, insieme ai miei pochi compagni. In quella classe di quinta elementare eravamo soltanto in otto. Di cui tre, un maschio e due femmine, erano i figli di 89 la rivista dell’ Arte Warsame Roti, un’illustre famiglia di Beled Weyne. Cosí dovemmo essere iscritti, per le Medie, nella nuovissima Scuola Media Inferiore “Mons. Filippini” di Mogadiscio. Non tutti, alcuni, meno fortunati (secondo me), rimasero a Beled Weyne per passare alla scuola pubblica che non aveva più l’italiano né come lingua veicolare né come seconda lingua. Soltanto in quattro andammo a frequentare la scuola media “Mons. Filippini” di Mogadiscio. Per fortuna avevamo lí altri due compaesani ed amici (Abdirashid Farah Isse ed Omar Ali) che erano venuti a studiare lí l’anno prima di noi. Altri, invece, andavano già al Liceo Scientifico Italiano. Tra di loro ricordo Ali Sabriye (un amico con il quale mi sarei ritrovato dopo anni a frequentare la stessa Università Nazionale Somala di Mogadiscio) e le sorelle Jamad e Rabi’a Warsame Roti, sorelle maggiori delle mie due altre compagne di classe e del fratello. Con entrambe le sorelle Warsame Roti ci ritroveremo, dopo le Medie, all’Istituto Tecnico per Ragionieri, avanti un paio di anni. A Mogadiscio, noi della “Mons. Filippini”, alloggiavamo all’esclusivo Collegio Nuova Somalia pagando una rata mensile di 120 Scellini. Una somma relativamente alta in quel periodo. La “Mons. Filippini” era una scuola privata per i ceti piú abbienti di Mogadiscio. Si pagava una retta di iscrizione annuale. Piú il costo, esorbitante anche allora, dei libri di testo. Devo ancora capire come mai i libri di testo costano sempre cosí tanto. E non solo in Italia. La consolazione (non giustificazione) è che da quei libri imparammo tutto ciò che oggi sappiamo. Voglio dire un sapere del mondo attraverso una visione aperta. A Mogadiscio, la mia immagine della Somalia assunse il suo carattere nazionale. Non ero più il ragazzo di provincia che sapeva appena chi fossero i nostri vicini di casa. I contorni di quell’immagine allora si espansero. Acquisii una coscienza della mia nazione. Questo processo di crescita e di maturazione personale coincise con l’idea della nuova Somalia della Rivoluzione. Non era ancora un regime dittatoriale, ma un governo di militari illuminati che assunsero il potere. Naturalmente, a Mogadiscio, non celebrammo più l’anniversario dei 110 anni. Rimase una faccenda tutta italiana. Tuttavia, Mogadiscio era allora la città più italiana di tutta l’Africa. Nel Nuovo Planetario Italiano, il racconto “I Vecchi coloni al Savoia”2, è ispirato dalla realtà di un’atmosfera che ancora rispecchiava il crepuscolo di una società coloniale in Somalia. La presenza culturale italiana, però, non era data soltanto dalle attività ricreative dei concessionari italiani alla Casa d’Italia, ma dall’Istituto Dante Alighieri, dal Liceo Italiano, dalle varie Scuole Medie Superiori pubbliche che ancora avevano l’italiano come lingua veicolare, dall’Istituto di Scienze Giuridiche ed Economiche che sarebbe divenuto poi la facoltà di Economia dell’Università Nazionale Somala, la stessa nella quale avrei studiato dopo essermi diplomato all’Istituto per Geometri e Ragionieri di Mogadiscio. In questo istituto, così come all’università, l’insegnamento era impartito nella lingua italiana. All’Istituto per Ragioneri e Geometri, nonostante la 90 la rivista dell’ Arte preponderanza delle materie tecniche, ricordo con gratitudine gli studi umanistici e classici italiani (comprese materie come stilistica e retorica) ricevuti sia da docenti taliani, tra i quali ricordo in modo particolare, il nostro professore di italiano, Massimo Buzzoni da Ferrara, sia da non-italiani, vale a dire somali. Guicciardini e Machiavelli erano i soggetti preferiti da uno di questi, il professor Abdullahi. Quelle lezioni, nell’insieme, ci aprivano gli occhi e ci fornivano strumenti utili per la riflessione filosofica e per la conoscenza dei sistemi politici ed economici. Un altro docente, suo omonimo, professor Abdulle, invece, ci insegnava diritto privato e diritto commerciale in lingua italiana. Mentre, per tecnica bancaria, il nostro professore era Abdisamad Ali Farah (il padre dell’amica Cristina) prima e, successivamente, il professor Hassan Kulan. Mentre per ragioneria e per matematica attuariale, i nostri professori erano rispettivamente Ali Abdulle e Mohamed Amer. Si trattava del fior fiore dei tecnocrati prodotti dalle università italiane di Roma, di Padova, di Bologna, di Firenze e di Milano, a cavallo degli anni Sessanta e Settanta per la Somalia. Essi stavano allora sostituendo i docenti italiani nelle scuole secondarie. Alcuni di loro, come Ali Abdulle e Mohamed Amer, li avrei rivisti alla Facoltà di Economia e Commercio come docenti prima, e come colleghi dopo, entrando a far parte anch’io del corpo dei docenti dell’Università Nazionale Somala, continuando la tradizione dell’insegnamento nella lingua di Dante. Insieme ad altri docenti somali anche loro o provenienti da università italiane (o da altre), con una straordinaria preparazione nelle scuole della Somalia nel periodo precedente o a cavallo dell’indipendenza. Due esempi di straordinaria preparazione come docenti dell’università sono stati Prof. Mohamed Ali Abukar e Prof. Col. Farah Ahmed Omar, poi Ammiraglio, della rinascente Marina Somala. Il primo, che è stato il mio relatore della tesi di economia, insegnava Economia Politica (micro e macroeconomia), il secondo, Economia del Pensiero Politico. Mohamed Ali Abukar, studente di Federico Caffé alla Sapienza di Roma, pur conoscendo molto bene la lingua somala, si esprimeva soltanto in italiano, durante e dopo le lezioni. Farah Ahmed Omar, sempre nella sua divisa di colonnello della Marina Militare Somala (perché si divideva tra la Scuola di Guerra e la Facoltà di Economia), si esprimeva in somali, pur insegnando da un testo scritto in italiano. Entrambi erano molto preparati nelle loro materie di insegnamento. Cosí come erano preparati tutti i docenti della facoltà di Economia. Ibrahim Mohamed Abdi in Statistica, l’altro Ibrahim in Geografia Politica, Osman Addow, Ali Moallim e Andirizak in Matematica, Mohamed Said Samatar in Economia Politica dello Sviluppo, Said Adan Firdhis in Economia Internazionale, Hawa in Economia della Finanza, Faduma Barahow in Economia Aziendale. Tutti questi docenti somali della mia università parlavano in italiano ed utilizzavano testi italiani. Questa volta, però, i testi erano distribuiti gratis dall’università. 91 la rivista dell’ Arte Credo che questa particolare esperienza con la lingua italiana abbia creato nella mia formazione una relazione profonda e salda con la cultura italiana. Una cultura coltivata con la scuola e raffinata meglio nei quasi dieci anni passati come bibliotecario dell’Istituto Italiano di Cultura di Mogadiscio. Questa biblioteca mi era stata fatta conoscere nel 1974 da due miei cari amici che purtroppo ora non ci sono piú: Hassan Hasci e Nuruddin Ahmed Abdi Gaboose, detto Fouzi. Due delle migliori personalità della mia generazione. Grandi lettori come me di opere letterarie in italiano. Insieme, credo abbiamo letto piú della metà delle opere custodite nella piccola biblioteca dell’Istituto (che allora veniva chiamato ancora Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia). Dopo essermi iscritto come socio della biblioteca, ne diventai un assiduo frequentatore a tal punto che il nuovo direttore, Lodovico Cardellino, mi chiese di assumere il ruolo di curatore con funzione di bibliotecario. Dopo la mia assunzione dell’incarico di bibliotecario, l’Istituto di Cultura di Mogadiscio divenne uno dei punti di riferimento culturale per giovani della mia generazione e non. Altri amici si aggiunsero al nostro club semi-ufficioso di lettori. Il primo è stato Abdirizak Mohamed Nur, uno dei miei migliori amici. Siamo stati sempre molto uniti, sia all’istituto per Ragionieri e Geometri (dove lui si è diplomato Geometra, mentre io Ragioniere) sia all’Università Nazionale Somala (dove lui si è laureato in Ingegneria, mentre io in Economia). Entrambi, poi, fummo selezionati a far parte del corpo docente di quell’università. Dopo la Specializzazione in Ingegneria Strutturale all’Università di Padova, Abdirizak rientra in Somalia. È uno dei pochi professionisti e intellettuali che non hanno abbandonato la Somalia dopo la tragedia della guerra civile. Infatti, recentemente, Ing. Abdirizak Mohamed Nur è diventato il governatore della regione del Benadir. Incarico da cui in seguito si dimetterà, credo, per non dover abbandonare la sua professione di ingegnere civile. Peccato, con lui come governatore del Benadir, Mogadiscio poteva essere ricostruita tenendo conto delle esigenze dei ceti meno abbienti, così come egli si era pronunciato al suo insediamento nel Settembre del 2009. Al club di lettori affezionati della biblioteca vi erano anche gli amici Abdirizak Hassan Addow, Keynan Mohamed Sheikh, Abdisalad Ahmed Mohamud ed altri, compagni di scuola e di università. Non solo, ma vi erano anche altri che pur non essendo compagni di studi, condividevano la nostra pasione per i libri e per la lettura. Tra questi, in primo luogo Said Muhiddin e l’Ingegner Abdulkadir Sheikh Ali, quest’ultimo allora ufficiale dell’Esercito. Entrambi oggi vivono in Inghilterra. L’alta frequenza della biblioteca da parte di tanti giovani somali creava una domanda maggiore di cultura italiana. L’Ufficio Culturale diventava l’Istituto Italiano di Cultura, erede della Società Dante Alighieri di Mogadiscio degli anni ’60. È qui che durante la mia permanenza all’Istituto di Cultura, si sono avvicendati ben tre direttori, se non metto nella conta Argentieri, già in partenza al mio arrivo. Si sono susseguiti mentre ero all’Istituto Italiano di Cultura 92 la rivista dell’ Arte di Mogadiscio, Cardellino, Stopponi e Arcella. Con i primi due, Lodovico Cardellino e Elisa F. Stopponi (e in parte con Luciano Arcella), ho collaborato in qualità di curatore della biblioteca dell’Istituto assistito da un pensionato italiano, Caffarelli. Chissà se quei grossi registri dei prestiti della biblioteca sono stati messi in salvo da qualche parte, prima del saccheggio. È stato qui, nella piccola biblioteca dell’Istituto di Cultura che, nella prima metà degli anni Ottanta, accogliamo Oscar Luigi Scalfaro, allora ministro degli Interni, in visita in Somalia. Cosí fecero pochi altri, in visita a Mogadiscio, negli anni successivi. Ma è stato lui, si puó dire, l’unico che ha avuto un occhio di riguardo alla piccola biblioteca dell’Istituto, frequentata sia da giovani somali sia da italiani della comunità di Mogadiscio. Di questi ultimi, in particolare, i docenti italiani dell’Università Nazionale Somala e il personale della Cooperazione allo sviluppo. È in quegli anni che l’Istituto Italiano di Cultura di Mogadiscio stabilisce dei corsi di lingua italiana, frequentati soprattutto da giovani somali di una generazione che non poteva piú usufruire dell’insegnamento della lingua italiana a scuola. Per loro era importante imparare l’italiano, perché nel caso dovessero andare all’università (eccezione fatta per l’Istituto di Lafole per maestri di scuola che aveva l’inglese come lingua di insegnamento), l’italiano era la lingua di insegnamento. Lafole è una località storica tra Mogadiscio ed Afgoi. È qui, infatti, che nel 1896 Antonio Cecchi e una sua spedizione verso l’entroterra di Afgoi vennero massacrati. Tra questo ultimo fatto storico all’inizio della colonizzazione italiana della Somalia e la politica di Cooperazione postcoloniale, si potrebbe dire, si snoda la travagliata storia della lingua italiana in Somalia. Con la Cooperazione universitaria, infatti, si era di fronte ad un revival della lingua italiana in Somalia. Con questo riassunto della mia formazione ho provato a tratteggiare oltre che un mio personale percorso con/ed attraverso la lingua italiana, anche una testimonianza della presenza e della rinascita di questa lingua in Somalia in quegli anni. Penso che per miopia politica l’Italia, non offrendo maggiori opportunità di insediamento ai tanti profughi e rifugiati somali giunti a Roma dopo la guerra civile in Somalia, abbia perso una grande opportunità per coltivare un importante legame con la Somalia. È stato conveniente opportunismo? Gli italiani, purtroppo, inebriati dall’unione con l’Europa, coltivarono il concetto di “extracomunitari”, inserendo in questa categoria anche somali, eritrei ed etiopi insieme a tutti coloro che, con la loro presenza, potevano disturbare il loro nuovo stato di cittadini europei. Amo questa lingua e la cultura di cui è la massima espressione, continuo a coltivarla anche se nel lavoro e nello studio cosí come nella vita quotidiana, l’inglese sta lentamente assumendo preminenza. Un tempo parlando con gli amici discorrevamo in italiano, perché questa era la lingua della nostra educazione/istruzione. Ora non piú. Come fai a parlare in italiano con qualcuno che quotidianamente pensa 93 la rivista dell’ Arte in inglese, perché vive in Inghilterra, in Canada, in Australia o negli Stati Uniti? Non viene piú spontaneo come un tempo. Nonostante questo, il mio libro Memorie del Fiume resta un volume italiano, anche se continua a non essere pubblicato in Italia, ma solo consultato e studiato nel chiuso dell’accademia, perché è un testo che parla a un pubblico di italiani. Scrivo ancora in italiano, ma sempre su invito di un Maestro qual’è per me Armando Gnisci. II. Roma e l’Italia della mia personale esperienza È con queste credenziali che, in qualità di docente dell’Università Nazionale Somala, arrivo in Italia alla fine degli anni ’80 per un corso di preparazione/specializzazione post-universitaria. La scelta dell’Italia per la mia preparazione accademica è stata fatta dalla mia università su suggerimento della Facoltà di Economia. Potevo discutere e chiedere di andare negli Stati Uniti, dove alcune Fulbright scolarships erano disponibili. Invece, accolsi la proposta perché mi sentivo culturalmente più vicino all’Italia. Venni a Roma e vi rimasi quasi venti anni (e che ventennio!). Sono contento che il mio primo incontro con Roma non sia stato qualcosa anche lontanamente somigliante all’arrivo all’aeroporto di Roma del personaggio-protagonista di Il Latte è buono di Garane Garane. Né quella volta né di lì a un anno, nel 1988, di ritorno da Mogadiscio per quella che sarebbe stata l’ultima volta che vidi la Somalia. Gli agenti all’Aeroporto di Roma erano gentili e professionali. Non mi avevano neanche chiesto il passaporto che, probabilmente, sapevano in ordine, visto che ero tra i docenti dell’Università Nazionale Somala che venivano a Roma su invito del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Dall’Aeroporto prendemmo la Linea Acotral (con quegli autobus azzurri, un colore familiare e rassicurante per un somalo, perché gli ricorda sempre la bandiera nazionale) che faceva capolinea esattamente a fianco della Stazione Termini. Penso che questa linea di autobus non sia più utilizzata per il collegamento con l’aeroporto. Oggi, al suo posto si usa, invece, il treno diretto che assicura il collegamento. Il tragitto tra Aeroporto e centro di Roma fu piacevole. Nonostante la stanchezza del lungo viaggio da Mogadiscio con scalo al Cairo, era un piacere guardare quel verde della campagna romana, anche se eravamo già in pieno autunno. La campagna intorno a Roma è magnifica. Non è la pianura padana, piatta e fumosa, d’estate e d’inverno. La campagna romana, meno ricca di coltivazioni rispetto alla pianura padana, è meno monotona di quest’ultima. Ora pianeggiante, ora ondulata con piccoli valli e fossati, boschi ancora intatti e, di tanto in tanto, le rovine di qualche antico abitato. È questa varietà di paesaggio che fa di essa il 94 la rivista dell’ Arte soggetto preferito da grandi pittori di paesaggi. Il primo impatto con la città viva da Piazza Cinquecento è stato uno spettacolo mai visto prima. Un brulicare di gente, un frastuono fino allora sconosciuto, un’immersione nell’umanità di quella Roma conosciuta attraverso i libri e, successivamente, attraverso le grandi opere cinematografiche, Fellini in primo luogo. La lingua dal vivo, sembrava destare sorpresa. Col tempo, nella pratica quotidiana, avrei scoperto che la lingua italiana (grammatica e sintassi) apparteneva soltanto ai libri e al parlato, magari, sui banchi di scuola o nelle aule universitarie. Non era affatto il mezzo di comunicazione qui a Roma. Il dialetto romanesco, quello delle borgate della cinematografia di Pasolini e di Monicelli o quello con l’accento pugliese e siciliano, era la lingua. Era interessante viaggiare sui tram e sugli autobus, così come facevo per andare all’università, ed ascoltare i dialoghi ed i monologhi dei romani. Destava sorpresa se mi rivolgevo a qualcuno nel mio italiano quasi senza accento, e non era raro che mi si chiedesse dove avessi imparato la lingua. Nel mio paese, rispondevo solitamente. E quale era il mio paese? Era l’immancabile successiva domanda. La Somalia. Ai più anziani, questo nome sapeva dire qualche cosa. Di solito, un lampo di ricordi si accendeva negli occhi del mio interlocutore. Un sorriso di gentilezza illuminava il volto. La conversazione procedeva piacevole. Nel momento della discesa dal mezzo pubblico, ci si salutava come due amici. Ai meno anziani, quasi sempre, la mia risposta creava confusione. Non era, per caso, il Marocco? La Tunisia? Oddio, quanta innocenza. Allora capivo che l’orizzonte del mio interlocutore era limitato alle sponde del Mediterraneo. Una visione romana del mondo! Vale a dire, coeva del basso impero, un’età in cui le glorie dei Cesari eran già divenute storia. Se con la gente comune il mio italiano poteva essere la chiave per una conversazione con una persona sconosciuta che alla fine poteva anche diventare una persona amica, nel rapporto con la burocrazia l’italiano era un fardello e spesso un fastidio. Il burocrate, appena subodora la buona qualità della lingua si impenna, diventa sospettoso, in guardia pronto all’attacco. Addio buon esito della pratica. È difficile spiegare questa reazione. Forse, in qualche misura, il burocrate romano si sente depauperato di un bene di cui, secondo il suo concetto, solo e soltanto lui doveva essere il detentore in assoluto. Soprattutto, se a contendergli il territorio della lingua è un non-italiano, come è immediatamente e chiaramente visibile dal colore della pelle. Forse no, è umano sentirsi in competizione con gli altri, così come è umano tendere la mano a chi ne ha bisogno. Con un italiano un po’ sgrammaticato, del tipo verbo all’infinito, il burocrate è mosso da compassione e, riscossa la valuta-in-risata con i suoi colleghi, ti assicura che è pronta la tua pratica. Per fortuna, le occasioni in cui era necessario ricorrere a questi stratagemmi erano pochi. 95 la rivista dell’ Arte Piazza dei Mirti, Largo Preneste, il Tram 19. All’inizio, la geografia della mia Roma era delimitata da un itinerario ben preciso. Essa comprendeva la borgata Alessandrino, Centocelle, il Quarticciolo, la Prenestina, San Lorenzo e La Sapienza. L’itinerario per l’università coincideva con il percorso del tram 19 che parte da Piazza dei Gerani, passa per Largo Preneste, Porta Maggiore e San Lorenzo. La Borgata Alessandrino (Centocelle) è stata per me la casa. Vi ho quasi messo radici. Nel lunghissimo tempo del mio abitare in questo quartiere, feci tante amicizie. Dall’edicolante al Bar, dalla Sezione di partito al Parroco della chiesetta di S. Giuliano. Qui mi sono sentito come di casa. Il quartiere, che si trova tra la Casilina, il viale Palmiro Togliatti ed il Quarticciolo, era molto tranquillo. Piazza 500 (Stazione Termini). Al tempo del mio arrivo a Roma, la Stazione Termini era una normale stazione ferroviaria. Era poco frequentata dalla piccola comunità di somali, in maggioranza studenti e docenti universitari. Col tempo, in coincidenza con la caduta del regime e la guerra civile in Somalia, la stazione divenne il punto di ritrovo e di riferimento per la crescente popolazione di profughi somali dalla guerra civile. Era inevitabile recarvisi per una ragione o per un’altra. Una delle ragioni era anche la presenza della SIP (Telefoni) nei sotterranei della stazione. Tutti, senza eccezione, dovevano recarsi lì per telefonare a casa, in Somalia. Per avere notizie delle famiglie e dei parenti, per chiamare amici e congiunti negli Stati Uniti o in Canada. Chi conosceva la città come me poteva recarsi fino a Piazza S. Silvestro, alla sede provinciale delle Poste dove era possibile chiamare. Le chiamate alla SIP costavano, ma nessuno lesinava quanto poteva disporre di piccoli risparmi per dare e avere notizie dai propri cari. I telefoni cellulari non erano ancora arrivati. A Roma, i profughi dalla guerra in Somalia continuavano ad arrivare sempre più numerosi. Venivano accolti in strutture gestite dal comune o da altri enti, con molti disagi. Noi docenti dell’Università di Mogadiscio residenti a Roma, eravamo privilegiati rispetto a coloro che scappavano dalla guerra civile. Ma come è consuetudine tra somali, offrivamo ospitalità a conoscenti e amici che si trovavano in difficoltà. Questo creava disagio e screzi nel rapporto tra affittuari (noialtri) e proprietari italiani. La soluzione per i proprietari era quasi sempre un aumento della pigione. Gli appartamenti in affitto che un tempo potevamo ottenere senza grandi difficoltà ora diventavano irreperibili e inaccessibili. I proprietari italiani, non tutti in verità, avevano scoperto una miniera: l’affitto a immigrati. Il mercato degli affitti registrava una domanda sempre in ascesa. I prezzi non potevano più essere regolati dall’equo canone. Nella difficile situazione che si era creata in Somalia ai primi anni ’90, la nostra condizione di permanenza in Italia come docenti dell’Università Nazionale Somala, si faceva sempre più ambigua e indecifrabile. Certo, in teoria, eravamo “ospiti” del governo italiano, eppure la nuova legislazione sull’immigrazione in 96 la rivista dell’ Arte Italia ci considerava immigrati come tutti gli altri. In un certo senso, questa poteva essere considerata una condizione migliore rispetto alla semplice qualifica di studenti, perchè, sempre in teoria, con la nuova legislazione potevamo ora lavorare in Italia. Solo che il lavoro, un lavoro con le nostre qualifiche professionali, non era spendibile in Italia. Un paese difficile, per noi. Parlo dell’Italia concreta e pratica, quella della nostra esperienza, non quella dei nostri ideali che ci accorgevamo, nostro malgrado, non esistere. Personalmente, fu una grande delusione, allorquando venni a capire questa condizione. Non subito. Non sicuramente con l’entrata in vigore della legge Martelli sull’immigrazione che tutti i non-italiani consideravano una normativa in grado di risolvere tanti problemi degli immigrati ed offrire tutte le opportunità per chi volesse lavorare in Italia. La legge Martelli certamente aveva risolto, anche se solo in parte, la difficile situazione di coloro che, sempre più numerosi, lasciavano i propri paesi (soprattutto dall’Africa e dall’Asia) in cerca di lavoro dignitoso in Italia, di un benessere maggiore rispetto a quello che era possibile godere nei paesi di provenienza, alcuni dei quali, come la Somalia appunto, era martirizzata dalle guerre civili (tribali) che impedivano di vivere una vita normale. Dalla prospettiva, dunque, di chi non ha più uno stato-nazione, che deve considerarsi immigrato pur senza esserlo, la legge sull’immigrazione, nella pratica, non poteva offrire nulla se non i disagi derivanti dalla reazione degli italiani alla normativa sull’immigrazione stessa. L’etichetta di “immigrato”, un soggetto senza diritti di cittadinanza, diventava col passare del tempo insopportabile. Gli immigrati sarebbero stati seguiti negli anni da altre etichette ugualmente discriminanti, come “vucumprá” ed “extra-comunitari”, fino ai clandestini fuori-legge. Non era discriminazione razziale (anche se l’italiano comune attribuiva al termine immigrato una forte connotazione del colore della pelle), ma nemmeno tanto lontano. Queste reazioni popolari da parte degli italiani verso gli immigrati, creavano condizioni pericolose per molti. I problemi di convivenza (dopo la Legge Martelli) vennero spesso ingigantiti e strumentalizzati. Il fenomeno dell’immigrazione (migranti, profughi di guerra e rifugiati erano messi indistintamente nella stessa categoria) cominciava ad assumere, nell’opinione comune degli italiani, i contorni sinistri che la stampa e la televisione avevano contribuito a definire. Intanto, la Somalia entrava nel ciclo infernale della guerra civile più lunga d’Africa. Che ancora oggi non si è completamente conclusa. Molti somali, sperimentato il grande disagio in cui erano costretti a vivere a Roma, iniziavano a iscriversi nelle liste dei rifugiati alla Caritas Internazionale, per trovare rifugio sicuro e trattamento dignitoso in Canada e negli Stati Uniti. Parecchi dei miei colleghi si iscrissero anche loro nelle liste della Caritas. Io non lo feci. Una delle ragioni (sbagliate, come dedussi a posteriori) era che mi sentivo, pur senza avere che un permesso di soggiorno, italiano anch’io. Avevo sperato in un’Italia migliore, cioè più giusta. Le sue istituzioni 97 la rivista dell’ Arte democratiche, la vitalità dei partiti, i dibattiti intorno ad ogni cosa che potesse avere un interesse pubblico, mi avevano convinto della possibilità di essere riconosciuto come cittadino italiano. Soprattutto ora che la Somalia, così come l’avevo conosciuta, non c’era più. Infatti, lo stato che l’Amministrazione Fiduciaria Italiana in Somalia (AFIS) aveva portato all’indipendenza e alla democrazia era totalmente al collasso. Al suo posto, il vecchio sistema tribale tornava a presentarsi come sostituto. Più tardi, quasi dieci anni dopo la legge Martelli, questo mio personale sentimento verrà completamente disilluso dalla famosa legge Bossi-Fini del secondo governo di centro-destra guidata dal più longevo presidente del consiglio in Italia, Silvio Berlusconi. La destra, nella sua ascesa al potere, aveva cavalcato anche l’onda dei sentimenti anti-immigrati della maggioranza degli italiani. Forza Italia attraeva più dei partiti storici. La Lega, pur non essendo un partito con un seguito nel Centro-Meridione d’Italia, si era presentato sulla scena politica italiana come il partito della vitalità e della rinascita dell’attivismo delle regioni del Nord. Alleanza Nazionale era sorta dalla trasformazione-scioglimento del Movimento Sociale Italiano, a sua volta erede della fede fascista. Nell’insieme, questi tre partiti popolari (o populisti, a seconda il giudizio) diedero formazione a governi più duraturi anche di quelli nelle mani del Partito Socialista Italiano. Una compagine governativa che era arrivata sull’onda di Forza Italia, probabilmente anche in risposta ai sentimenti anti-immigrati che facevano leva sulle paure dei posti da lavoro da dividere con gli immigrati. Soprattutto dopo l’illusione di quel Milione di Posti da Lavoro promessi da Forza Italia. Un’efficace marketing politico nazionalista che gli italiani accoglievano con speranza. Silvio Berlusconi riusciva a iniettare nell’immaginario italiano senza più anticorpi (il PCI si era completamente disfatto rinascendo in altre forme, tutte devastate dai suoi eredi litiganti e che non concordavano più su niente) la forza prorompente dell’illusione mediatica. Le esperienze effimere dei Progressisti e dell’Ulivo non scalfirono minimamente le solide basi di un nuovo partito populista e personale che però sapeva toccare le corde più sensibili (non sempre le più nobili) della gente comune del paese. La “filosofia politica” del nuovo corso di centro-destra manifestò la sua influenza anche nelle istituzioni burocratiche che, come la gente comune, adottò un atteggiamento sempre più ostile nei confronti dei “nonitaliani”, non voluti, noialtri immigrati. Se alla gente comune si potrebbero perdonare certi atteggiamenti di ostilità verso chi viene da fuori, lo stesso non si potrebbe fare con il “sistema burocratico” e le istituzioni che sempre di più impersonano la politica del nuovo corso. Una certa Italia, di valori celebrati e di ideali democratici, veniva ora sommersa da una valanga di sentimenti viscerali che resero difficile la vita per chi non era italiano. Questo in generale. Nel particolare, invece, gli italiani restavano sempre quelli, amichevoli e, persino, fraterni quando li conoscevi e ti conoscevano da vicino. Con le loro, comprensibili, simpatie ed 98 la rivista dell’ Arte antipatie. Nel mio caso particolare, posso dire di avere avuto più amici italiani che somali. Alcuni di loro, da lunga data, per quanto sono fedeli e meritevoli di fiducia. Durante la prima metà degli anni ’90, la Stazione Termini divenne sovraffollata, con un’alta densità di persone provenienti dalla Somalia. Gli italiani (romani) sopportavano con una certa tolleranza questa alta concentrazione di “immigrati”. Somali, Eritrei e Filippini, non infastidivano nessuno con la loro presenza intorno alla Stazione Termini. Per i Senegalesi che non frequentavano la Stazione, ma che esponevano le loro mercanzie sui marciapiedi, l’atteggiamento era sempre lo stesso. Albanesi e Nord-Africani destavano, non sempre ragionevolmente, un fastidio negli italiani. Questa differenza di reazione negli italiani valeva soltanto per gli spazi all’aperto. Ma la reazione verso il non-italiano immigrato era sempre la stessa sui mezzi pubblici. Era davvero mettere tutte le erbe in un fascio. Questa reazione indistinta era provocata dall’esserci tra gli immigrati di Roma una relativamente alta percentuale di borseggio sui mezzi pubblici, soprattutto sugli autobus. In particolare, ciò accadeva immancabilmente sulla linea 64 diretta al Vaticano. Ma bisogna precisare che non erano soltanto gli immigrati a praticare quest’attività fastidiosa e intollerabile, come peraltro era riconosciuto da molti italiani. Vi erano anche un numero di italiani con forte accento del Sud, compreso il romanesco. All’università, tra gli studenti, questi atteggiamenti di intolleranza verso i non-italiani erano del tutto assenti. Per cui, questa constatazione confermava la mia opinione secondo la quale la manifestazione di sentimenti di antagonismo verso gli immigrati era relativa al grado di istruzione e di senso civico, se non di solidarietà, degli italiani. Questa opinione, tuttavia, vacillava di fronte a situazioni chiaramente (o velatamente) ostili all’interno dell’accademia stessa. Dei docenti italiani, ne ricordo alcuni con grande stima, altri con amicizia e di altri ancora preferisco dimenticarmi. Tra quanti ho stimato e hanno lasciato in me un profondo ricordo, cito il professor Paolo Sylos-Labini. Non è stato mio docente, ma un giorno, quando ero a Economia alla Sapienza, abbiamo avuto una lunga e intensa conversazione, quasi una lezione magistrale ad personam. Abbiamo camminato dall’università fino alla sua abitazione sulla Nomentana attraversando Villa Torlonia. Quello che mi ha colpito in lui era l’intelligenza del cattedratico unita alla saggezza e alla semplicità dell’uomo saggio. Quella conversazione-lecture mi ha ridato fiducia in un momento di sconforto, uno sconforto provocato da qualcun altro, docente della stessa università. Per Paolo Sylos-Labini, la ragione era dalla mia parte e dovevo assolutamente mantenere la mia prospettiva nella scienza economica. Altri docenti, come Salvatore Coscione e Paolo Palazzi, sono stati amici con reciproca stima. Con il primo avevamo stabilito un rapporto di fiducia reciproca sin dall’inizio del mio arrivo in Italia, tanto da lasciarmi 99 la rivista dell’ Arte in affidamento per un anno intero la sua casa in San Vito, a ridosso di Piazza Vittorio a Roma. Eravamo nel 1989, mi pare. Credo che tanta fiducia la si debba, in parte, anche alla sua esperienza recente in Africa. Salvatore Coscione era stato allora di recente docente in Mozambico, all’Università Eduardo Mondlane, dove tuttora penso continui a insegnare economia. Anni dopo, sempre all’università di Roma incontro un altro italiano che comprendeva bene l’animo dell’africano. Mi riferisco ad Armando Gnisci, con il quale intrattengo un solido rapporto di collaborazione. Con Armando Gnisci, oltre l’amicizia e la reciproca stima, vi è anche una fraterna solidarietà. È con lui che sono riuscito a costruire un dialogo intellettuale con gli italiani, attraverso i miei scritti contenuti in opere da lui curate come Diaspore Europee & Lettere Migranti, Poetiche Africane (2002), Nuovo Planetario Italiano (2006), Decolonizzare l’Italia (2007). Il suo interesse al mio “pensiero” portò inoltre alla pubblicazione di interessanti lavori di tesi da parte di studenti italiani, non solo a “La Sapienza” di Roma. Tra queste tesi ricordo e cito La Letteratura Postcoloniale Italiana tra due Secoli (XX e XXI) di Gianluca Iaconis, Roma 2004-2005; I Decolonizzatori: La Letteratura Postcoloniale di Ali Mumin Ahad e Garane Garane di Serena Morassutti, Venezia 2006-2007; Gli Scrittori Somali decolonizzano l’Italia. Memorie del Fiume ed Altri Racconti del Benadir di Ali Mumin Ahad di Mariagrazia De Luca, Roma 2009-2010. In quest’ultima tesi di M. De Luca, forse perché analizza un’opera mia molto importante come Memorie del Fiume, ella è riuscita a mettere in risalto il mio stato di esilio comparandolo con quello dell’Alighieri da Firenze. Un grande onore per me, ma anche un piacere, visto che sono partito proprio dal rapporto con Dante durante la mia infanzia a Beled Weyne, ancora studente alla scuola della Missione Cattolica. Devo dire che in queste tesi di laurea, gli studenti italiani scoprono un vivo interesse intellettuale per il passato coloniale, ma soprattutto, dimostrano un atteggiamento libero ed aperto verso il contributo spesso critico di chi voglia capire a fondo l’influenza coloniale italiana nell’Africa Orientale. Nei primi anni in Italia, mi sentivo quasi deluso nel constatare che l’interesse verso le ex-colonie mancava completamente negli italiani. Non solo, ma era del tutto assente un dialogo con i giovani. Con gli studenti italiani all’università non era facile entrare in rapporti di amicizia. Dalle aule universitarie, dove la solidarietà tra studenti era di norma, ognuno andava con il proprio gruppo. A volte ci si aggregava, ma era una cosa temporanea. Si scherzava per passare il tempo d’attesa per il pasto alla mensa. A volte ci si conosceva di più ed i rapporti diventavano più amichevoli. La maggior parte di questi studenti non erano di Roma, spesso provenivano dalle regioni del Sud. Di alcuni di loro ricordo i nomi: Tano (Gaetano che abitava con alcuni studenti sempre del Sud a Via del Teatro Brancaccio), mi pare da Taranto, la cui figura (fisica) mi ricordava sempre Antonio Gramsci; Raffaele da Reggio Calabria e qualcuno che 100 la rivista dell’ Arte successivamente è divenuto famoso alla televisione, come Fiorello, anche allora grande intrattenitore durante la fila per i pasti alla Mensa Studentesca di Via della Cascina. La Basilica di S. Maria Maggiore (da Piazza Cinquecento o, a volte, da Via Merulana) era diventata per me una tappa quotidiana nel cammino verso la Mensa universitaria La Cascina. Inoltre, per aver abitato proprio a ridosso di Piazza Vittorio, alla fine degli anni ’80, sono stato testimone della rinascita della piazza e della sua trasformazione come mercato, come spazio vitale di una nuova Italia riconoscibile dall’intreccio culturale. Ho preso parte alle prime manifestazioni culturali sotto le arcate di Piazza Vittorio. A Piazza S. Giovanni in Laterano, Piazza Venezia, Piazza della Repubblica, Piazza Mazzini, Piazza del Popolo, mi sono sentito spesso parte integrante di un’Italia che sapeva esprimere a voce alta alcuni ideali condivisi. Tali valori, sebbene ancora solo ideali, contenevano la possibilità di creare una società multiculturale in Italia. III. Da un emisfero all’altro Per i somali la mobilità è abitudine, tradizione. Un atavico istinto nomade spinge le persone, una dietro l’altra, come in carovana, a spostarsi da un luogo verso un altro, spesso senza una ragione apparente. È opinione comune questa. Come tutte le opinioni, però, è a sua volta opinabile. D’altra parte, non c’è nulla di male nel muoversi da un luogo all’altro del pianeta. È stato sempre così nella storia del mondo. Infatti, in nessun posto uno si dovrebbe sentire estraneo all’umanità. Certo, ci sono varie barriere, alcune facilmente superabili, mentre altre sono difficili da sormontare. Il nomadismo, una qualità spesso riferita ai somali, per me non è stata una scelta scontata. Anzi, sono sia per carattere sia per cultura, un sedentario. Preferisco la stabilità alla peregrinazione. Metto radici profonde nel luogo in cui mi sento a mio agio. Per trovarsi a proprio agio, però, è essenziale concepire un sentimento di affezione per il luogo in cui vivi, che senti come il tuo posto. Per me l’Italia è stata, soprattutto dopo il collasso dello stato in Somalia, la mia patria d’adozione. La cultura, insieme al lungo periodo di soggiorno in Italia, hanno nutrito in me il sentimento di una seconda patria. Fino a quando non mi sono trovato a disagio, di fronte a una situazione di quasi rigetto strutturale, fatto di barriere artificiali, e sempre di più istituzionalizzate. L’incongruenza tra l’amore per la patria adottiva, e la distanza, burocratica, che ti separa da essa e ti impedisce di abbracciarla con fedele sentimento, ti mette in una disarmante condizione senza prospettive. Individualmente, si potrebbero anche sopportare certe angherie principalmente burocratiche, con la giustificazione che queste derivano da situazioni momentanee e condizioni temporanee. In altri termini, giustificare ogni attitudine contro e mettersi in attesa, sperando che tutto passi, che torni il bel tempo, che, forse, non esiste più. “Tutto passa, 101 la rivista dell’ Arte tranne il Suo Volto” recita, infatti, il sacro Testo del Corano. In attesa della Divina Provvidenza. Umanamente, uno non può pensare solo a se stesso, ma deve pensare anche a coloro che dipendono da lui. Persone in carne ed ossa, meritevoli di vivere con dignità. Pensare al futuro, in questo caso, diventa una inderogabile responsabilità. L’incertezza è una condizione umana, normale, ma essa diventa mostruosa nei confronti di chi è costretto a vivere esiliato dalla propria patria, senza veramente trovarne un’altra. Certo, c’è la patria dell’intelletto, la conoscenza, lo studio, il luogo privilegiato di coloro che pensano. In certi casi, però, anche questa possibilità è incapace di riempire il vuoto creato dall’incertezza e dalla precarietà, in esilio. Dall’altra parte, il sapere è pesante; penosamente pesante. La leggerezza sarebbe ovviamente una condizione meno asfissiante, ma inconciliabile col pensiero. È in questa penosa condizione di chi è in grado di immaginare un differente stato di cose, che l’idealismo della cultura si scontra con il dettame della realtà crudele del quotidiano. Il sadismo del burocrate che profetizza (interprete di una volontà politica dalle proprie istituzioni) un permesso di soggiorno anche per i tuoi piccoli, nel luogo prescelto come patria adottiva, ti lascia in grande disagio. Non se lo meritano questo! È in mezzo a un tale disagio che ti chiedi: tanto amore per l’Italia vale la pena? Ti interroghi allora sulla disponibilità di questa patria adottiva; ti chiedi chi sono io in questo luogo, che cosa mi debbo aspettare dal futuro continuando a stare in questo posto. Quali diritti ho, o saranno riconosciuti a me? Cogito, Ergo Sum, ma non al posto giusto. La ragione suggerisce allora di cercare un luogo più accogliente, una patria capace di riconoscere i tuoi diritti di cittadinanza, oltre che di chiederti i tuoi doveri; così come hanno fatto, prima di te, tanti tuoi colleghi che, fuori da una Italia “inospitale”, sono riusciti a trovare, finalmente, in qualche altra parte nel mondo, una terra d’accoglienza, una nuova patria generosa perché è dignitosa. Nel lasciare l’Italia con la mia famiglia, dunque, ho dato ascolto a questa voce della ragione. Ciò nonostante, l’Italia rappresenta ancora qualcosa per me. Di tutti i posti da me visitati in Italia: Trieste, Trento, Milano, Torino, Genova, Piacenza, Lodi, Cremona, Modena, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Pescara, Matera, potrei parlare della bellezza dei luoghi, ma di Roma, posso parlare, oltre che dei luoghi e dei monumenti, anche delle persone. Roma era diventata, infatti, una parte importante di me stesso. È stata anche il luogo delle mille privazioni, della vita grama. Dove dovevi sfiorare l’umiliazione per potere avere un lavoro, uno qualunque. Dove ti sentivi parte della città senza che gli altri ti vedessero o ti considerassero come tale. A dire il vero, non sempre. La città è abitata da persone comuni, e meno comuni, spesso eccezionali. Roma, così come l’Italia, è piena di persone eccezionali. Per mia fortuna, ho avuto più rapporti con queste ultime che con il resto. Ho incontrato tante volte persone capaci di fiducia, e che hanno avuto fiducia in me. Non solo di pane si vive. Spesso la mente è più esigente di nutrimento, più che il corpo. In difficili momenti, il mio spirito è stato 102 la rivista dell’ Arte sostenuto dalla conoscenza, dai libri di cui potevo disporre, grazie a due librerie romane, dove ero conosciuto e dove potevo prendere qualsiasi volume che mi interessava, per poi pagarlo più tardi quando potevo. Si tratta della Libreria Rinascita di Via delle Botteghe Oscure, e della più piccola Libreria dei Gesuiti in Via degli Astalli. Entrambe sono state (grazie a splendide persone che vi lavoravano, e che spero vi lavorino ancora) una fonte per la mia sete di quella particolare conoscenza che nutre la mente e rinforza lo spirito. Così come pure l’edicola di Piazzale Alessandrino. Sono piccole cose, ma che hanno un immenso valore umano. Questa generosità della gente ti fa capire quanto è grande la loro fiducia nei confronti di chi meglio conoscono. Roma era anche il luogo in cui ti sentivi, anche se per pochi istanti, onorato alla presenza della storia. Il luogo del dialogo inter-religioso, nelle scuole come nelle grandi occasioni d’incontro. Nel 2004 mi sono sentito onorato di essere invitato al Concerto di Riconciliazione alla presenza di Giovanni Paolo II. Di avere avuto in quell’occasione la possibilità d’incontrare e di stringere la mano ad Elio Toaff, di dirgli quanto era grande la rassomiglianza fisica tra mio padre e lui. Le parole di questo uomo saggio furono: siamo tutti fratelli, non importa il colore della nostra pelle, bensì ciò che contiene, il cuore. Indimenticabili parole. Roma è anche questo. Il mio sentimento verso la città è nutrito da questo e da altro. Tale sentimento della città di Roma è così intimo che non potrei esprimerlo pienamente in nessun modo. Lasciarla, significava lasciare qualcosa di se stessi. Per tutti gli anni che ho vissuto a Roma, ho assorbito l’atmosfera, interiorizzato il paesaggio, ho sognato il Tevere come fosse il mio Webi Shabelle nel paese natio, ho fatto della città parte di me stesso, parte della mia identità nel mondo. Ho certo nostalgia dei luoghi della storia, dei monumenti. In un certo senso, mi sento ancora romano, ma non ho assolutamente rimpianto per avere cercato e trovato la mia patria altrove. L’Australia è la mia patria oggi, il luogo che mi ha fatto sentire di essere ancora una persona, un cittadino del mondo come tutti gli altri. Ho ritrovato qui, infatti, quella patria perduta (la Somalia) per causa della guerra perpetua tra i clan. I grandi spazi della mia infanzia a Beled Weyne sono qui, una realtà davanti ai miei occhi. Se guardo lontano, sull’orizzonte scorgo la sagoma dei rilievi montuosi e delle colline a ponente della mia città natale. La dolce sensazione di appartenere al luogo è di nuovo ritornata. Tra i miei concittadini australiani, ci sono tantissimi che provengono dall’Italia, o i genitori o nonni dei quali sono emigrati dall’Italia, tanto tempo fa. Così come pure ci sono altri provenienti da tutte le parti del mondo. La nostra è una società multiculturale, rispettosa delle differenze, dentro la quale nessuno è o si sente straniero; la cittadinanza dà forma ai nostri valori comuni e condivisi. È questo il mio luogo, la mia patria, la terra prescelta per il nostro futuro. Per quanto riguarda la terra d’origine, noi preghiamo Dio, affinché possa restituirle la perduta pace. 103 1 2 la rivista dell’ Arte CAROSELLI FRANCESCO SAVERIO, Ferro e Fuoco in Somalia, Roma, Sindacato Italiano Arti Grafiche, 1931. Cfr. AHAD ALI MUMIN, “Corno d’Africa. L’ex-impero italiano”, in GNISCI ARMANDO (a cura di), Nuovo Planetario Italiano, Troina, Città Aperta, 2006, pp. 241-293. la 104 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Gëzim Hajdari Tu sei nata dall’esilio e in esilio, sulla terra del Fato, promesso dall’oracolo di Apollo, in memoria dell’ultima notte di Troia in fiamme. Qui un giorno Enea giunse sulle sponde del Tevere e pose la prima pietra della città eterna, accompagnato dai miei avi dell’antica Butrint. Roma: patria degli esuli, città in fuga verso la leggenda e il destino… * Secondo la leggenda, dopo la caduta di Troia, Enea parte in esilio con il figlio Iulo e il padre Anchise mentre Troia è in fiamme. A Delo, l’oracolo di Apollo promette a Enea una nuova patria nell’antica madre. Un sogno gli rivela che si tratta dell’Italia. Dopo aver fatto tappa a Butrint (Albania), Enea giunge in Italia… Furono proprio gli albanesi ad accompagnarlo con le loro navi in Italia, dove fondò Roma vicino alla foce del Tevere. 105 * Vado via Europa, vecchia puttana viziata. I tuoi sacri ruderi non m’i incantano più, i tuoi specchi e i tuoi abissi hanno ingannato il mio esilio, ferito il mio mesto corpo dell’Est davanti ai falsi altari impietriti. Addio Europa di muri, impronte delle dite e tombe d’acqua. La mia patria mi ha costretto ad andare via, l’Italia non mi ha voluto, la Storia mi ha respinto, l’amore mi ha rifiutato. Domani, a buon ora, partirò con la prima nave del Tirreno, dal porto del Circeo, accompagnato dai canti mortali delle Sirene, verso la Croce del Sud senza voltarmi indietro. Nei deserti lontani m’aspettano viandanti sconosciuti, guerrieri di tribù antiche, danzatrici del ventre; ruberò fanciulle dalle corti dei re di confini, la rivista dell’ Arte 106 come Halìl1 di Jutbìna2 delle Bjeshkëve të Nëmuna3, per donarle in sposa al mio Signore e dare vita ad una nuova stirpe. Incendierò le vecchie lingue arrugginite, mi scrollerò di dosso identità, cittadinanze e patrie matrigne; voglio trascorrere i miei anni in prigione, lontano dai miei libri, con banditi onesti e fuorilegge. Addio Europa del sangue versato in nome dei confini assassini e delle bandiere insanguinate. Domani, a buon ora, partirò con la prima nave del Tirreno, dal porto del Circeo, accompagnato dai canti mortali delle Sirene, verso la Croce del Sud [dalla raccolta inedita “Zaira”] 1 Halìl: personaggio leggendario dall’epos albanese. Jutbìna: territorio di confine tra l’Albania e l’ex Jugoslavia. 3 Bjeshkët e Nëmuna: le Montagne Maledette, così vengono chiamate le Alpi albanesi del nord. 2 la rivista dell’ Arte la 107 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Rita Marnoto Esuli e figure di esuli risorgimentali nel Portogallo dell’Ottocento 1. Un’avanguardia Le migrazioni, l’esilio, l’espatrio, i vari spostamenti di persone ma anche di risorse, beni e sistemi di produzione sono tra gli aspetti più evidenti dell’evolversi di qualsiasi società. Migranti spinti oltre le frontiere dalla precarietà delle condizioni di vita, da guerre sanguinose o da sogni mirifici, esiliati che devono cercare altrove uno spazio vitale per dare spazio ai propri ideali, uomini e donne rifiutati come elementi spuri di un corpo sociale che si auto-amputa. Così i migranti disegnano le vie attraverso le quali si fanno strada le nostre società del mondo, che mostrano in una certa epoca una chiusura di spazi, quelli lasciati vuoti dai migranti emigrati, che poi si aprono altrove, in altri luoghi in comuni, in altri tempi e società, quelle che si aprono, più o meno e a seconda dei casi, ai migranti immigrati. Mediante flussi continui nelle diverse direzioni del mondo. In questo senso, esuli, migranti, clandestini e ribelli sono un'avanguardia che cammina nel futuro, come scrive Armando Gnisci: 108 la rivista dell’ Arte Creoli, meticci migranti clandestini e ribelli, insieme a certi musici e poeti, formano una avanguardia della specie che cammina nel futuro, il futuro «che proviene davanti» (come dice il poeta arabo nostro contemporaneo Adonis) verso di noi. (GNISCI 2004: 111) Segnale vivo di un cambiamento futuro, questi spostamenti sono pure forme di irrequietezza e di resistenza all’immobilismo dell’ordine stabilito, cautamente controllate e sorvegliate. 2. Esuli risorgimentali nel Portogallo dell’Ottocento In periodo di celebrazione dell’anniversario dell’Unità d’Italia, la figura dell’esule è stata molto studiata e il suo ruolo rivalutato proprio in quanto germe di un nuovo ordine nascente, italiano ed europeo. Comunque, in confronto all’attenzione dedicata ai fuggitivi in Gran Bretagna, nella Svizzera o in Sudamerica, il caso portoghese non ha attirato in modo particolare gli studiosi. Ultimo lembo occidentale d’Europa, umile fiancheggiatore di vicende europee a mezza strada tra Africa e America, il Portogallo è per se stesso un margine su cui uno sguardo generale europeo stenta a posarsi. Il fatto che nell’Ottocento sia stato destinazione o punto di passaggio per tanti esuli italiani coinvolti nelle vicende risorgimentali ci dice, dunque, quanto meditata sia stata la loro scelta di un terreno dove germogliassero le condizioni per una complicità di latitanza. La maggior parte dei fuggitivi continuò il suo percorso europeo e extra-europeo, mentre altri vi si fermarono. Vi passarono da avvocati a librettisti, da melomani a imprenditori, trovando in quell’orlo costiero un porto sicuro. Qualcuno, poi, vi trovò la fine a giorni più o meno gloriosi. Alla risaputa simpatia dei portoghesi nei riguardi della patria-nazione degli italiani, si aggiungevano delle motivazioni cocenti. La posizione geografica di quei porti della costa occidentale d’Europa era strategica, in quanto scala di una piattaforma di collegamento tra Gran Bretagna, Paesi Bassi, Nord Africa e tutto il Continente americano. Inoltre, le accese lotte che si ingaggiavano in Portogallo tra liberali e assolutisti, fratricide in senso letterale, si offrivano come meta programmatica di quell’ideale di collaborazione e di fratellanza universale tra popoli a coloro che intraprendevano la propria battaglia per la libertà. Le due fazioni erano capitanate dai due figli del re João VI di Braganza, Pedro, il fratello liberale, e Miguel, il fratello assolutista. Pedro divenne simbolo della conquista di un nuovo assetto politico, in quanto figura di spicco dell’indipendenza del Brasile, proclamata nel 1822. Lo spostamento della capitale portoghese da Lisbona a Rio de Janeiro, nel 1808, fu già di per sé un movimento migratorio eccentrico, con l’esodo di João VI, della sua corte e della sua biblioteca, e l’assegnazione al Portogallo di un centro statale nella colonia americana. Per Pedro si trattò della mossa chiave che portò alla dichiarazione dell’indipendenza brasiliana, dopo di che egli tornò in Portogallo per continuare la lotta in difesa della causa liberale. Benché il numero degli esuli italiani non fosse quantitativamente elevato, essi svolsero un ruolo fondamentale nella società portoghese, e non soltanto sul piano ideologico, militare e diplomatico, ma anche sul piano della vita quotidiana. Arrivarono in due principali ondate migratorie: la prima agli inizi degli anni Venti dell'Ottocento, la seconda al volgere del decennio successivo (RAMOS 1992). Si trattava, in ogni caso, di élites dell’esercito e di intellettuali, letterati e artisti, molti dei quali legati al mondo del 109 la rivista dell’ Arte teatro. Il primo movimento migratorio si distinse per la presenza di vari membri dell’aristocrazia italiana, mentre il secondo flusso vide protagonisti patrioti appartenenti ai più diversi ceti sociali. Tanti dei partecipanti ai moti che scossero l’Italia intorno al 1820 si associarono alla rivincita liberale di Pedro di Braganza, svolgendo un importante ruolo di propaganda nel triennio 1820-1822. I duri colpi subiti a Napoli e in Piemonte dai patrioti spinsero fino al Portogallo piemontesi come il conte Giacinto Provana di Collegno, il conte Camillo Trompeo, Damiano Rittatore, poi caduto ad Atene nei combattimenti del 1861, il conte lombardo Giuseppe Pecchio, napoletani come Giacomo Maldura, Domenico d’Apice, Luigi Pierro e anche militari dell'entourage di Guglielmo Pepe e Vincenzo Pisa. I colonnelli Pepe e Pisa intrapresero, immediatamente e con successo, attività di infiltrazione carbonara. Pecchio rimase in Portogallo soltanto per tre mesi, ma le agitazioni nelle quali fu coinvolto gli lasciarono comunque del tempo per la lettura del poema epico di Camões, Os Lusíadas, da cui rimase fortemente colpito. I commenti che registrò nelle lettere raccolte nel volume Tre mesi in Portogallo offrono un quadro vivace delle istituzioni liberali. Pisa, da parte sua, coinvolto in affannosi viaggi tra il Portogallo, Madrid e Londra, partì subito per l’Inghilterra, ma in breve dovette tornare, richiamato dall’evidenza che «in Portogallo bisogna carbonizzare tutte le milizie» (cit. RIBEIRO 2003: 241). L'orizzonte di questi esuli era caratterizzato da un perenne stato di agitazione. Provana di Collegno avrebbe fatto nuovamente ritorno in Portogallo nel 1849, per visitare Carlo Alberto di Savoia, ritiratosi a Oporto dopo l'abdicazione. Lo troviamo al Teatro de S. João che assiste agli spettacoli della compagnia Corradini, il grande furore di quella stagione lirica. Era diretta da un certo Vincenzo Corradini, un carbonaro arrivato a Lisbona con un passaporto falso che nascondeva il suo vero nome, Piro Borato. La sintonia tra l’illustre spettatore e la compagnia assumeva dunque tonalità forti. Il secondo flusso migratorio rimanda agli anni Trenta, più precisamente al triennio 1832-1834. Pedro di Braganza organizzò una spedizione militare navale con forti appoggi logistici in Francia, che partì dai Paesi Bassi e dalle Azzorre. Sbarcò a Mindelo, località della costa atlantica a nord di Oporto, fu assediato dalle forze assolutiste ma riuscì a capovolgere una situazione difficile in extremis. La vittoria si dovette anche alla partecipazione di portoghesi rientrati dall’estero, a cui si associarono molti italiani: i fratelli Giacomo e Giovanni Durando, Francesco Anzani, amico di Garibaldi, Gaetano Borso di Carminati, che diventò poi comandante del Regimento de Caçadores do Porto, ecc. Furono insigniti da Pedro di Braganza della prestigiosa onorificenza della Torre Espada. Questa compagnia integrò molti esuli mazziniani costretti all’espatrio dalla sconfitta del 1834 e partecipò a vari combattimenti contro gli assolutisti di Miguel di Braganza. Il generale Gerolamo Ramorino pretese, nel 1833, il comando di un’unità militare, ma Pedro di Braganza glielo negò quando capì che aveva sviato dei soldi per la sua causa personale (DI GIUSEPPE 2010: 181-182). La vittoria dei liberali assicurò una certa stabilità e d’allora in poi gli esuli italiani non circoleranno più per grandi flussi, ma attraverso una continua infiltrazione che va ad impregnare tutto il tessuto sociale portoghese (VARGUES 1996). Cesare Perini, che arriva nel 1837, diventa subito professore al Conservatorio e si afferma in quanto autore drammatico, essendo pure il padrone del Caffè Toscano, noto punto di raduno per i simpatizzanti di Mazzini. Il conte di Gigliucci, elevato a socio del Grémio literário, la 110 rivista dell’ Arte partecipò alle riunioni degli scrittori aderenti a questa insigne istituzione. Luigi Tinelli, profugo italiano nel Nuovo Continente, fu console a Oporto in rappresentanza del governo americano. Invece, il carbonaro Simone Gattai è ricordato come un personaggio pittoresco molto apprezzato nelle Memórias di Bulhão Pato, poeta e accademico, a tutt’oggi ricordato come ideatore della deliziosa zuppa di vongole à Bulhão Pato. Non di rado, la situazione dell’esule rifiuta delle facili definizioni. Si può anche dare l’esempio di un italiano che, chiamato in Portogallo per svolgere il suo mestiere, dovette passare alla latitanza, come il parmense Angelo Frondoni. Il barone di Quintela, Joaquim Pedro Quintela, colpito dalla sua fama, lo ingaggia come direttore d'orchestra. Il barone amava la musica, sposò una figlia di Francesco Antonio Lodi, primo impresario del Teatro de S. Carlos, a Lisbona, diventando poi lui stesso impresario di quello stesso teatro. Frondoni divenne uno dei più alti interpreti musicali della furia popolare contro l’austerità governativa di Costa Cabral, una personalità molto controversa. Cabral aveva combattuto accanto ai liberali nello sbarco di Mindelo, però le misure che aveva preso successivamente, in qualità di primo ministro nominato dalla regina Maria II di Braganza, provocarono una sollevazione generale. Suscitarono una rivolta popolare nel Nord del Portogallo, a Póvoa do Lanhoso, di iniziativa prevalentemente femminile e capitanata da una contadina, Maria da Fonte. Dal Nord del paese, la ribellione si allargò ad altre zone, tra l’aprile e il maggio del 1846, e gli assolutisti si appropriarono della rivolta di Maria da Fonte facendola diventare un loro moto. Frondoni ne scrisse l’inno, subito proibito, e dovete vivere in clandestinità per un certo periodo. Questo inno, Hino da Maria da Fonte, ebbe un significato politico pregnante e di lunga durata. Eccone il testo poetico: Viva a Maria da Fonte Evviva Maria da Fonte a cavalo e sem cair a cavallo senza cadere com a corneta na boca con la cornetta in bocca a tocar a reunir. che suona a raccolta. Eia avante, portugueses Su avanti, portoghesi eia avante, não temer su avanti, non temere pela santa liberdade per la santa libertà triunfar ou perecer! [refrão] trionfare o soccombere! [ritornello] Lá raiou a liberdade Là splendé la libertà que a nação há-de aditar che la nazione conquisterà glória ao Minho, que primeiro gloria al Minho, che per primo la 111 o seu grito fez soar! rivista dell’ Arte il suo grido fece suonar! Essa mulher lá do Minho Quella donna del Minho que da foice fez espada che della falce fece spada há-de ter na lusa história avrà nella lusa storia uma página dourada! una pagina dorata! In effetti, il direttore d'orchestra avrebbe superato di molto le aspettative del Barone. Il pezzo continuò a essere intonato in quanto codice di una ribellione silenziosa. Successivamente fu ripreso dalla Repubblica, fondata nel 1910, come inno ministeriale e a tutt’oggi continua a essere il brano con cui si salutano i Ministri portoghesi ed è suonato anche nell'ambito di varie cerimonie civili e militari. José Afonso, cantautore esule nel Portogallo di Salazar e di Marcelo Caetano, ne raccolse una versione popolare, As sete mulheres do Minho, che fu simbolo della resistenza al totalitarismo dello Estado Novo: <http://www.youtube.com/watch?v=daU4y4dLeL8> Un cantautore più giovane, Vitorino, l’ha interpretato con i suoi toni militari: <http://www.youtube.com/watch?v=jbEk0WzUk4w> Nel 1849, tre anni dopo la sollevazione di Maria da Fonte, arriva in Portogallo il più celebre esule italiano, Carlo Alberto di Savoia. Dopo la sconfitta di Novara, il Re di Sardegna abdicò in favore di suo figlio Vittorio Emanuele e partì per un viaggio che si concluse a Oporto quando, sfinito, varcò la soglia di una pensioncina chiamata Hospedaria do Peixe (il cui padrone era il Senhor Peixe, e che oggi corrisponde al Palácio de Balsemão, situato a Praça Carlos Alberto, dove si trova pure il Teatro Carlos Alberto, importante sede dell’attività drammatica portoghese). Per arrivarci, Carlo Alberto dovette sopportare un lungo e faticoso viaggio e sentire i non brevi discorsi che la comitiva di autorità locali proferì in una prima cerimonia di accoglienza alle porte della città. Riuscì a seguirla con uno stoicismo stupefacente. I Savoia avevano sostenuto la fazione assolutista di Miguel di Braganza e la fazione legittimista dei carlisti in Spagna. Solaro della Margherita aveva addirittura chiuso i rapporti diplomatici con il Portogallo e soltanto nel 1842 Maria II di Braganza era stata riconosciuta come regina. Se per Carlo Alberto, dopo il disastro di Novara, l’occidente era l’unica direzione di fuga possibile, il ritiro a Oporto lo manteneva a una distanza ravvicinata della corte. Trascorse tre mesi in una piccola camera di una casetta (attuale Museu Romântico) accanto al fiume Douro dove, tranne le popolazioni che acclamavano il loro Re, nessuno lo ricordò. E lì si spense, lasciando sulla città un'ombra intensa che coinvolge luoghi, memorie e miti. Inoltre, inoculò nell’immaginario portoghese un pathos di Principi sfortunati, nelle varianti del Principe avventuriero, fallito o dimesso, indissolubilmente legato alle vicende risorgimentali italiane. La sua morte provocò una forte emozione a cui neanche i Savoia furono indifferenti, se nel messaggio di ringraziamento alle popolazioni la famiglia Savoia dichiarò che gli abitanti della città di Oporto si sarebbero potuti considerare allora e per sempre italiani (DUARTE 2005). 112 la rivista dell’ Arte 3. Figure di finzione L’impatto di queste ondate migratorie nel Portogallo dell’Ottocento fu tale che la figura dell’esule italiano da subito si eresse a elemento ricorrente nell’immaginario dell'epoca, misto di sostrato storico e di sogno, di aspirazioni, delusioni e idee stereotipate. La sua consistenza può anche disperdersi tra le colonne dei quotidiani e le righe dei romanzi, o dileguarsi in notizie che volano di bocca in bocca, ma è sempre notevole. Se gli esuli che abbiamo sin qui presentato ebbero la possibilità di stendere i loro resoconti di viaggio, di scrivere lettere e di registrare le loro memorie, o di esprimersi attraverso l’arte musicale e il disegno, esiste però anche una tipologia di fuggiasco più flessibile, che convive con la storia in un altro modo. Non può parlare, avendo bisogno di qualcuno che parli con la sua voce, e non può neanche agire, visto che pure le sue mosse sono dettate dalle parole altrui. A dargli spessore e a farlo parlare, è la voce della storia calata nell’immaginario antropologico. Ecco perché sono figure di finzione che hanno esistenza sulla carta stampata o tra le invenzioni della fantasia. Per cui, persone reali come Mazzini e Garibaldi occupano i primi posti di una folta galleria di “personaggi” della narrazione. Quando, nel 1851, il maresciallo-duca Saldanha osò organizzare una marcia militare che reagiva ai soprusi di Costa Cabral, il paese tremò, incredulo della temerità di un uomo benpensante. Cabral stesso aveva dato ordini a Girolamo Ramorino di abbandonare il Portogallo, allo scopo di allontanare qualsiasi minimo ed eventuale focolaio di dissenso. Partito da Lisbona, Saldanha traversò il centro del Portogallo, le Beiras, e si diresse a Oporto. La sua vittoria scrisse un nuovo capitolo delle vicende politiche del Portogallo liberale, la Regeneração, e Maria II di Braganza affidò subito a Saldanha la formazione di un nuovo governo costituzionale. Un tale successo non si potrebbe spiegare se non attraverso un intervento esterno e, addirittura, ai limiti dell’umano. Fu così che si sparse la voce che Mazzini era venuto a Lisbona espressamente per organizzare la rivolta. Infatti, sui giornali legittimisti si leggono, in quei giorni dell’aprile 1851, violenti attacchi contro il terrore alla Robespierre che si dice caratterizzare la politica terroristica mazziniana. A un Mazzini comandante degli eserciti portoghesi, si accosta un Garibaldi cerimoniere. Quando Maria Pia di Savoia arrivò in Portogallo nel 1862 accompagnata dal fratello Umberto, si sparse la voce che Garibaldi facesse parte della comitiva. Il matrimonio di Maria Pia di Savoia con Luís I di Braganza offriva alla giovane Italia la possibilità di trovare un ponte di collegamento con il più antico alleato storico del Portogallo, la Gran Bretagna, e di rivedere i suoi rapporti con le colonie africane. I giornali legittimisti non persero l’opportunità di notare che il Re portoghese sposava la figlia di uno scomunicato, ma il matrimonio della principessa di Savoia con il re Luís I di Braganza ripristinava un'ancestrale attrazione. Il fondatore del Regno di Portogallo, Afonso Henriques di Borgogna, aveva sposato, nel 1146, Mahaut o Matilde, figlia di Amedeo III conte di Savoia. Nel Cinquecento, l’infanta Beatriz, figlia del Re delle Scoperte Manuel I, sposò il duca Carlo III di Savoia da cui ebbe nove figli, quattro dei quali ereditarono il nome del Re delle Scoperte, che poi entrò a far parte dell’antroponimia savoiarda nelle varie combinazioni di Emanuele. Il circolo vizioso si avvita su se stesso quando, in epoca risorgimentale e fino a tutt’oggi, si comincia a diffondere, in Portogallo, l’antroponimo Vítor Manuel. Da segnalare, inoltre, a fine Seicento, i due matrimoni regali di Maria Francesca Elisabetta di 113 la rivista dell’ Arte Savoia Nemours, figlia di Carlo Amedeo di Savoia-Nemours, conte di Amale, prima con il re Afonso VI di Braganza, e poi con Pedro II, suo fratello, acclamato Re quando Afonso VI fu dichiarato invalido al titolo regale. Si ricordi, inoltre, che la gioia che il matrimonio della figlia più giovane di Vittorio Emanuele II procurò al padre fu tale che il monarca dichiarò un’amnistia. Di conseguenza, Garibaldi poté lasciare il carcere di Varignano e farsi operare dal chirurgo fiorentino Ferdinando Zanetti che gli estrasse la palla di fucile che lo aveva colpito in Aspromonte. Quando si recò in Gran Bretagna nel 1864, pare che la nave sui cui viaggiava si fermasse per qualche ora a largo di Lisbona, ma che tuttavia il comandante non fosse sbarcato. Il seguito che accompagnava Maria Pia di Savoia fu accolto con eleganza, ma fu a Coimbra che l’accoglienza si rivestì di colori più festivi. Gli studenti elessero come loro rappresentante un gruppo vivace, in cui spiccava la personalità di Antero de Quental, fondatore della Sociedade do Raio. Era un’organizzazione segreta in odore di carboneria che combatteva tutti i dispotismi e con una efficienza tale che riuscì a deporre il rettore Basílio Alberto de Sousa Pinto. L’allegro gruppo ricevette gli illustri ospiti reali all’entrata della città, accanto al ponte sul fiume Mondego, e Antero lesse la Saudação ao Príncipe Humberto, che accompagnava Maria Pia e guidava il seguito della corte dei Savoia: Os Estudantes da Universidade de Coimbra, filhos e netos dos heróicos defensores do Porto, saúdam, em nome da fraternidade de dois povos irmãos, o neto de C. Alberto: a mocidade liberal Portuguesa saúda, em nome da liberdade do mundo católico, o filho do amigo de Garibaldi, o filho de Victor Manuel. (QUENTAL 1982: 141) Gli Studenti dell’Università di Coimbra, figli e nipoti degli eroici difensori di Oporto, salutano, in nome della fratellanza di due popoli amici, il nipote di C. Alberto: la giovinezza liberale portoghese saluta, in nome della libertà del mondo cattolico, il figlio dell’amico di Garibaldi, il figlio di Vittorio Emanuele. Umberto era figlio dell’amico di Garibaldi e, affinché non ci fossero dubbi nei riguardi di questa formulazione verbale, lo studente, con un simpatico sorriso, consegnò una traduzione italiana del suo discorso al Principe e lo salutò con cortesia. La menzione di Garibaldi che guariva dalle ferite dell’Aspromonte al corteo nuziale è segnale dell’enorme popolarità che l’eroe italiano raggiunse in quel periodo (DI GIUSEPPE 2010: 129-146). La terza ed ultima figura di finzione di cui ci occuperemo esce delle pagine del famoso romanzo di José Maria Eça de Queirós, Os Maias. Episódios da vida romântica, grande emblema della narrativa ottocentesca portoghese di tendenza realista, nel quale ad un esule italiano viene assegnata una funzione narrativa essenziale. Il romanzo si svolge intorno alle vicende dei due superstiti della famiglia Maia che abitano un antico 114 la rivista dell’ Arte palazzo, il Ramalhete, situato presso Rua das Janelas Verdes, affacciato sul fiume Tago, nella zona ovest di Lisbona. Afonso, il vecchio nonno, crede alle nuove idee libertarie e anche lui, che recitava odi poetiche alle adunanze massoniche, è esiliato in Inghilterra. Carlos da Maia, suo nipote, è un giovane colto ed elegante, educato all’inglese, laureato in medicina all’Università di Coimbra e che dopo un grand tour europeo si stabilisce a Lisbona. Congeda senza battere ciglio l’architetto che si proponeva di restaurare il Ramalhete «col progetto di una scala sfarzosa, fiancheggiata da due statue che simboleggiavano le conquiste della Guinea e dell’India», portandosi da Londra un architetto e decoratore di tutt’altra fibra, «perché vi creasse, esplicando il suo gusto, una dimora comoda, di un lusso intelligente e sobrio» (EÇA 1959: I 11-12). Tra nonno e nipote, c’è il salto di una generazione, quella del figlio di Afonso da Maia, Pedro da Maia, ed è qui che l’esule italiano ha la sua parte attiva. Come si spiega nelle prime pagine del libro attraverso un movimento di analessi, in una tragica sera, Afonso da Maia è sorpreso dalla visita del figlio, lontano da casa da alcuni anni. Irrompe stravolto e dichiara di colpo: — Ero stato assente da Lisbona due giorni... Sono tornato questa mattina... Maria era fuggita di casa con la piccola... Se n’è andata con un uomo, un italiano... Ed eccomi qui. (EÇA 1959: I 47) Lo indispettisce quel bigliettino, dove si legge il nome dell’italiano: È una fatalità: parto per sempre con Tancredi. Dimenticami perché non sono degna di te, e porto con me Maria [la sorellina di Carlos], perché non posso separarmene. (EÇA 1959: I 48) Tancredi, o Tancredo, come scrive Eça nell’originale portoghese: il nome buttato in faccia a un marito innamorato di una donna travolgente chiamata Maria Monforte, e poi tradito e abbandonato dal fuggiasco che aveva accolto in casa sua. Quella sera, Pedro da Maia non cena, si ritira nella sua camera di scapolo, da molto disabitata, ma quando l’alba sta per spuntare, si sente uno sparo fatale. Giace in una pozza di sangue, pistola in pugno. Ricordo vivo di quel figlio sventurato è, per Afonso, il nipotino Carlos Eduardo, che la madre non ha portato via con sé e alla cui educazione il vecchio aristocratico si dedica con amorevole impegno. In seguito, andranno entrambi ad abitare il Ramalhete, ed è dalla convivenza tra nonno e nipote orfano che la narrazione prende vita. Tutta colpa di quell’esule. L’intimità dell’italiano con la casa e la famiglia di Pedro da Maia aveva già avuto un triste inizio: il ferimento procuratogli dallo stesso Pedro durante una battuta di caccia, quando il suo fucile aveva sparato involontariamente, offrendo occasione al profugo di dispiegare tutto il suo eroismo: 115 la rivista dell’ Arte Quella sera Maria stava pranzando sola nella sua camera, quando sentì alcune carrozze che si fermavano alla porta e la scala fu invasa da un gran frastuono. Quasi subito Pietro le comparve dinanzi, pallido e tremante. — Maria, è capitata una gran disgrazia! — Gesù mio! — Ho ferito quel giovanotto, ho ferito il napoletano. — Come? Uno stupido incidente... Mentre egli saltava un fosso, il fucile aveva sparato e la carica — paffete! — era andata a colpire il napoletano. Non era possibile curarlo alla Tojeira, ed erano tornati subito a Lisbona. Naturalmente Pietro non aveva permesso che il giovanotto da lui ferito andasse all’albergo, lo aveva portato lì ad Arroios, nella camera verde del piano superiore, aveva mandato a chiamare il medico, due infermiere che lo vegliassero, ed egli stesso avrebbe passato la notte al suo capezzale. — E lui? — Un eroe! Sorride, dice che non è nulla, ma io lo vedo pallido come un morto. È un giovanotto simpaticissimo. Solo a me poteva capitare un fatto simile, diamine! E pensare che Alencar era proprio vicino a lui... Almeno avessi ferito Alencar, un amico intimo col quale ho confidenza! (EÇA 1959: I 41) Pedro da Maia prova sin dall’inizio un senso di colpa nei riguardi di quello straniero dal quale mai sarebbe stato in grado di liberarsi. Quella sera fatale, nella sua camera da scapolo al Ramalhete, sprofonda in un forte stato depressivo, quando trasforma quel sentimento avviluppante di auto-annullamento nel colpo che spara a se stesso, incapace di affrontare la fuga della moglie, incapace di inseguire la coppia, di denunziarla alla polizia, o anche solo di ubbidire un’ultima volta a Maria Monforte dimenticando tutto, come lei stessa afferma nel bigliettino, per poi salpare alla volta dell’America come in un certo momento pensa di fare (EÇA 1959: I 50). Scherzi della mala sorte, se la «fetta di pane» del patrimonio dei Maia era arrivata dall’Italia, addirittura da Napoli, da «un ultimo parente, Sebastiano da Maia, che dal 1830 viveva a Napoli, occupandosi soltanto di numismatica» (EÇA 1959: I 11). La battuta di caccia era stata organizzata da Pedro da Maia in onore dell’esule napoletano, nipote dei Principi di Soria, che aveva dovuto abbandonare l’Italia per essere stato condannato a morte dai Borboni. L’immagine del suo eroismo, che sorride di fronte alle ferite che tanto preoccupano Pedro da Maia, con due infermiere al capezzale, si dilegua poi nella nuvola del sigaro che subito comincia a fumare, nelle serate di ponce caldo e chitarra, proprio lì sopra la camera della padrona di casa. «Un principe entusiasta, cospiratore, condannato a morte», che Maria non aveva ancora visto, ma la cui presenza di per sé la eccitava (EÇA 1959: I 42), e la cui indolenza e la cui bellezza fecero il resto. Eça sottolinea che era «fatto come un Apollo […] i lunghi capelli castani, capelli da donna, ondulati e con riflessi d’oro» (EÇA 1959: I 44). Maria Monforte lo conosce di persona quando, prima di lasciare la casa, dopo la guarigione, le regala uno splendido mazzo di fiori che nascondeva però una sfavillante sorpresa, un sonetto in italiano scritto su carta profumata. Vilaça lo descrive come «un gesto di Byron» (EÇA 1959: I 44). Invece, alla cameriera arlesiana di Maria Monforte «sembrava il ritratto di Nostro Signore Gesù Cristo. 116 la rivista dell’ Arte Che petto, che bianchezza marmorea!» (EÇA 1959: I 42). La marchesa di Avelga, in occasione del ricevimento offerto per il battesimo del piccolo Carlos, chiede addirittura a Pedro da Maia di appoggiarsi al suo braccio per riuscire ad avvicinarglisi, per poter puntare su di lui il suo occhialino d’oro, come se procedesse all’analisi di un marmo da museo (EÇA 1959: I 44). Tuttavia, è con il padre di Maria Monforte che nasce da subito un’intesa profonda. Il suo francese non proprio perfetto, «ça aller bien... Hein? Beaucoup bien...» (EÇA 1959: I 46), in nessun modo è di ostacolo a quella che si direbbe una complicità al primo sguardo. Di esiliati ce n’erano, a quel circolo sociale, a cominciare da Afonso da Maia, esiliato in Inghilterra, risultato del suo furore libertario. Il passato di esule fuggiasco di papà Monforte, però, era tutta un’altra cosa: E si seppero cose orribili. Papà Monforte veniva dalle isole Azzore; quando era giovanissimo, una coltellata data in una rissa e un cadavere all’angolo di una strada lo avevano costretto a fuggire a bordo di un brigantino americano. Qualche tempo dopo un certo Silva, amministratore della ditta Taveira, che lo aveva conosciuto alle Azzorre, mentre era all’Avana per studiare la coltura del tabacco, che i Taveira volevano introdurre nelle Isole, vi aveva incontrato il Monforte (il quale, poi, si chiamava Forte). Girava per il molo con sandali di sparto, cercando di imbarcarsi per New Orleans. Qui vi era un punto oscuro nella storia di Monforte: sembrava che avesse servito per qualche tempo come fattore in una piantagione della Virginia... Finalmente, quando riapparve alla luce del giorno, era comandante del brigantino «Nuova Linda» e portava carichi di negri in Brasile, all’Avana e a New Orleans. Era sfuggito agli incrociatori inglesi, aveva tratto un patrimonio dalla pelle degli africani, e ora ricco, uomo da bene, andava a sentire Corelli al San Carlo. (EÇA 1959: I 28) Tra negriero e nipote dei Principi di Soria non c’era omogeneità di ceto né di generazione, e neanche una piattaforma linguistica comune era data per scontata. Comunque, il destino di Maria Monforte non si incrociava con quello di Pedro da Maia. L’esule italiano attira talmente la figlia del negriero che questa dimentica famiglia, marito, stabilità, e parte per un viaggio attraverso l’Italia e la Francia. Il matrimonio di Pedro da Maia non era mai stato accettato da Afonso, che nonostante certi avvertimenti della sua cerchia di amici era convinto che si trattasse di un’amante. Quando l’unione fu celebrata sentì il sangue della sua stirpe contaminato (EÇA 1959: I 47). La figura dell’esule di Os Maias, napoletano discendente dei Principi di Soria, ripristina dunque il profilo storico dell’esiliato appartenente ai ceti della nobiltà, ma svuotandolo di contenuti ideologici o di militanza. Se «la tradizione negativa dell’esilio trova il suo riscatto nella trasformazione in chiave eroica dell’esule stesso» (SINOPOLI 2011: 378), Tancredi è un eroe derisorio. Il suo atteggiamento è ricondotto a una sfera fatua, tra raffinatezze e divertimenti, complicità immediate con negrieri, fino all’ultimo gesto, la fuga con la moglie del suo protettore. Eça descrive a chiare lettere la propria condizione sia di fuggiasco - fuggiasco da Napoli condannato a morte dai Borboni e fuggiasco da Lisbona - sia di figura-funzione narrativa. Scavalcando una certa logica, lo scrittore fa dell’Italia destinazione della coppia in fuga, quando Tancredi aveva dovuto scapparne. Questa immagine carica di emozioni e di sfarzosi colpi di scena riconduce proprio a quel romanticismo di maniera evidenziato dal sottotitolo del romanzo, Os Maias. Episódios da vida romântica. Trasformato in una funzione narrativa, l’esule napoletano può dunque rivolgere alla storia delle la 117 rivista dell’ Arte domande cocenti sui valori dell’eroismo, della militanza o della convivenza tra ceti sociali, e in questo senso è un serio elemento perturbatore. Mazzini che collabora all’organizzazione del colpo del maresciallo-duca Saldanha, Garibaldi che esce dal carcere per mettere in atto un matrimonio reale e un nobile napoletano che, sotto un’aura principesca, distrugge la vita di una famiglia liberale, ripristinano l’immagine dell’esule italiano come elemento sovvertitore dell’ordine. Queste tre figure di finzione sono riempite di pezzi di storia dilatati, rovesciati, contorti, ma che mostrano chiaramente, nelle loro vie alternative, fino a che punto la figura dell’esule risorgimentale italiano impregnò il Portogallo ottocentesco, tra vicende storiche e immaginario letterario. 4. Bibliografia DI GIUSEPPE FRANCESCA, Portogallo, Italia e questione iberica (1821-1869), (tesi di dottorato) Università degli Studi di Napoli Frederico II, Dottorato di Ricerca in Scienze Storiche, Archeologiche e Storicoartistiche (XXII ciclo), 2010. DUARTE LUÍS DE OLIVEIRA, «Adagio portuense», Duas Colunas [Porto, TNSJ], Abril 2005, pp. 16-17. GNISCI ARMANDO, Biblioteca Interculturale. Via della decolonizzazione europea, n. 2, Roma, Odradek, 2004. IDEM (a cura di), Nuovo planetario italiano. Geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa, Roma, Città Aperta, 2006. MARNOTO RITA (a cura di), «Dossiê – Unificação da Itália 1861-2011», Estudos Italianos em Portugal, 6, 2011, pp. 7-175. QUEIROS JOSE MARIA EÇA DE, Os Maias. Episódios da vida romântica, Lisboa, Livros do Brasil, 2002. IDEM, I Maia. Episodi della vita romantica, trad. Laura Marchiori, Milano, Rizzoli, 1959, 2 voll. QUENTAL ANTERO DE, Obra completa. Prosas da época de Coimbra, ed. António Salgado Júnior, Lisboa, Sá da Costa, 1982, 2.ª ed. RAMOS LUÍS A. DE OLIVEIRA, «Italianos na génese do liberalismo em Portugal (algumas observações)», 118 la rivista dell’ Arte Estudos em homenagem de José Borges de Macedo, Lisboa, INIC/CAHUL, 1992, pp. 428-431. RIBEIRO MARIA MANUELA TAVARES, «Mazzini e il mazzinianesimo in Portogallo», Nuova Antologia, 2227, 2003, pp. 229-255. SINOPOLI FRANCA, «Patria/esilio nel discorso letterario risorgimentale: alcuni esempi», L’Italia verso l’Unità. Letterati, eroi, patrioti, a cura di Beatrice Alfonzetti, Francesca Cantù, Marina Formica, Silvia Tatti, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2011, pp. 377-389. VARGUES ISABEL, «Liberalismo e independência. Os exilados italianos em Portugal (1820-1850)», Revista Portuguesa de História, 32, 2, 1996, pp. 411-426. la 119 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Flavia Caporuscio A sud del Risorgimento: Noi ci credevamo Centocinquant’anni dopo gli italiani ricordano, o forse scoprono per la prima volta che l’Italia non è sempre stata una nazione, che il percorso per arrivarci è stato più difficile che per altri paesi europei, ma che quella unione è stata fortemente voluta, pensata, studiata e difesa. Certo non da tutti: si è detto che l’unità è stata imposta dall’alto, che è andata a vantaggio di pochi e che è stata osteggiata da molti. La verità è, dicono altri, che eravamo una nazione molto prima di esserlo politicamente e ancor prima di volerlo, e che in quel progetto noi ci credevamo. O meglio, noi letterati. Ed ecco allora le celebrazioni ufficiali dell’anniversario organizzate e presenziate da chi non ci crede, ma spera in questo modo di distogliere l’attenzione degli italiani dalla degradazione presente alla quale la nostra classe politica ha sapientemente guidato il paese. Il rinnovato interesse per il Risorgimento ha coinvolto tutti i canali della comunicazione: dai giornali alla televisione, dal cinema al teatro, e all’editoria, con i tanti, troppi, libri d’occasione, purché si rievochino le gesta degli eroi di un’Italia migliore. Anche a rischio di un recupero indiscriminato dell’intero patrimonio 120 la rivista dell’ Arte risorgimentale che viene omologato e ridotto, in queste nostalgiche commemorazioni, ad un indistinto, ma ben commercializzabile, slogan pubblicitario. Alla storia del Risorgimento viene sovrapposta e sostituita la memoria del Risorgimento, che celebra indistintamente Cavour e Mazzini, Vittorio Emanuele II e Pisacane, Garibaldi e Gioberti. Agli eroi di pietra che popolano le piazze di ogni singolo comune della penisola subentrano così i santini di questo tardo revival risorgimentale, con il quale, però, è stata in parte colmata la lunga marginalizzazione del Risorgimento ad opera della ricerca storica, che è tornata ad occuparsi di questo periodo della nostra storia recente con risultati di indiscutibile valore scientifico1. Con le celebrazioni del centocinquantenario si è anche colmata la singolare lacuna del nostro paese, privo di una festa nazionale che commemorasse la data fondativa della nazione. L’imbarazzo della scelta di una data di nascita, non certo facilmente identificabile, ha probabilmente generato tale impasse istituzionale, che si è però risolto con una singolare elezione, il 17 marzo appunto, che tradisce con evidenza una lettura del Risorgimento in chiave monarchica. Che cosa ricorda dunque, che cosa commemora oggi l’Italia ufficiale, nel nome del «gran re»? […] Forse vive nell’animo dei nostri borghesi, dei banchieri di Milano e degli industriali del Piemonte, dei burocratici, dei generali, e dei professori, un sentimento di riconoscenza verso colui che fu il primo esponente di un programma, il primo seguace di una tattica che doveva portare alla costituzione e al consolidamento della loro autorità e del loro dominio. Postuma riconoscenza […]2. Parole, queste, scritte da Antonio Gramsci ormai quasi ottant’anni fa, ma che descrivono bene il clima delle celebrazioni del 2011. Con l’assunzione da parte di Vittorio Emanuele II (che rimane Vittorio Emanuele II anche dopo l’unità3), il 17 marzo 1861, del titolo di re d'Italia (di un’Italia senza Roma, Venezia, Trento e Trieste), si è scelto, infatti, di commemorare un certo Risorgimento e di eclissarne un altro, ossia quello repubblicano e idealista. La versione semplificata di questo Risorgimento del centocinquantenario, oltre a non rendere giustizia alle diverse radici del movimento, si limita ad identificare il processo risorgimentale con la sola istanza patriottica. Ma il Risorgimento non fu solo un movimento di matrice nazionalista: ciò che lo rende attuale risiede, infatti, nella componente emancipazionista del movimento che si è battuto, anche e soprattutto, per una prospettiva di sviluppo, con lo sguardo rivolto più al paese che al tricolore. Controcorrente rispetto alle scelte istituzionali il cinema, con Noi credevamo di Mario Martone, ci presenta un Risorgimento alla rovescia, sia perché nel film i grandi protagonisti della storia rimangono sullo sfondo, 121 la rivista dell’ Arte spettatori più che attori di una storia agita dal basso, sia perché la direttrice secondo la quale si articola l’azione, e con essa il Risorgimento stesso, è quella da Sud a Nord, con il conseguente capovolgimento dell’immagine tradizionale del Sud ai margini di un movimento che ha come capitali le grandi città del Nord: Milano, Torino, Genova e Venezia. Con questo non voglio dire che il film neghi quella che è passata alla storia come la conquista del Sud4, alla quale peraltro si dà ampio spazio in sceneggiatura, ma che il punto di vista adottato sia quello inedito di tre giovani del Cilento, affiliati alla Giovine Italia, che guardano da Sud al processo di costruzione della nazione. I tre giovani, Domenico, Salvatore e Angelo, non sono degli spettatori ignari di una storia che non li riguarda e che subiscono loro malgrado; al contrario, i tre incarnano quella gioventù idealista e utopista che una certa vulgata del Risorgimento ha da sempre collocato ad altre latitudini. Si tratta di una gioventù che rappresenta un fronte compatto, a Napoli come a Milano, e che condivide gli stessi ideali di libertà, indipendenza e giustizia sociale per la realizzazione dei quali è pronta al sacrificio estremo. Martone mette per la prima volta in scena un Risorgimento di giovani, nel duplice senso di un Risorgimento fatto soprattutto da giovani e di un risorgimento dei giovani stessi. E nel fare questo, il regista non gira un film sul passato, ma rivendica le nobili radici dell’Italia di oggi, che può e deve ancora riscattarsi grazie alla sua “meglio gioventù”5. È quando si è giovani che si «scopre» la nazione. È da giovani che si abbraccia l’idea di battersi per essa. Chi ha lasciato memorie autobiografiche ha regolarmente accreditato questa immagine di sé, che, d’altra parte, getta luce sull’idea coltivata da Mazzini nel 1831 di proibire l’affiliazione alla Giovine Italia ai maggiori di quarant’anni. Il Risorgimento è un fenomeno generazionale. Ed è anche, nessun dubbio su ciò, un fenomeno eversivo6. È su questo Risorgimento che Martone punta la sua macchina da presa, lasciando fuori campo la versione eroica del Risorgimento delle grandi battaglie, tramandata dai libri di scuola. Alla ricostruzione storica degli eventi, infatti, il regista antepone la disamina del movimento politico-culturale risorgimentale e dei suoi protagonisti, che non hanno il volto dei riconosciuti padri della patria ma quelli anonimi dei tre giovani cilentani. Domenico, Angelo e Salvatore rispecchiano non solo le molteplici radici del movimento ma anche le diverse fonti della sceneggiatura: Domenico è il Domenico Lopresti del romanzo di Anna Banti, Noi credevamo7, al quale è liberamente ispirato il film, mentre Angelo e Salvatore, che ricordano in parte 122 la rivista dell’ Arte Giuseppe Andrea Pieri e Antonio Sciandra, riportano in scena il clima del romanzo I traditori8 di Giancarlo De Cataldo, coautore, insieme a Martone, della sceneggiatura. Si tratta di un progetto ambizioso e dalla lunga gestazione9, che paga inevitabilmente con una mancanza di uniformità nella pellicola le diverse penne del soggetto e della sceneggiatura. Al film, però, deve essere riconosciuto il merito di aver recuperato un testo ingiustamente dimenticato come il romanzo della Banti, che risulta ancora oggi di una feroce attualità nella sua lucida denuncia, fatta con rabbia e disincanto, di un ideale tradito. La voce narrante è quella di Domenico, calabrese trapiantato a Torino (nel film cilentano) e convinto repubblicano, che, ormai settantenne e malato, decide di scrivere le sue memorie non per rievocare, come molti, le eroiche gesta di gioventù, ma per rintracciare l’errore che ha condotto il paese ad illudersi che l’unità raggiunta fosse la stessa per la quale in tanti avevano lottato. In vecchiaia ho scoperto che scrivere aiuta a pensare, finché scrivo penso, non ci rinuncerò, checché dica il medico. Non è stato troppo tardi se ho ottenuto di avere tutta la mia vita davanti agli occhi, un campo di battaglia in azione, e gli onori della giornata sono ancora incerti. Non ho taciuto né risparmiato nulla, […] le mie responsabilità e quelle degli altri. Le ho passate al setaccio e non ho rintracciato l’errore in cui siamo caduti, l’inganno che abbiamo tessuto senza volerlo10. Ma scrivere è anche un mezzo per instaurare un dialogo tra “vecchi e giovani” per entrare in contatto con la nuova gioventù rappresentata dal figlio, agli occhi del quale Domenico si sente colpevole di tradimento e sprovvisto di insegnamenti da elargire. Oggi a diciott’anni, mio figlio segue una via che non oso esplorare. […] Ma quando mi compare davanti, la sua giovanile presenza così scattante, così – mi pare – impaziente, mi blocca. Cosa gli direi, in sostanza? Ho veduto, da vivo, il definitivo tramonto dei miei tempi; quel che, bene o male, ha sostenuto la mia tenacia avventurosa, non serve a lui e ai giovani della sua età. Ho cospirato con ebbrezza, mi hanno preso, ho veduto la forca e qualcosa peggiore della forca. Questo lui lo sa, ma ho l’impressione che piuttosto che ammirarmi mi compatisca per non aver giocato con maggior coraggio e fino in fondo tutte le mie carte11. L’unico modo per difendersi di fronte al tribunale dei giovani sarebbe quello di atteggiarsi da eroe, ma la storia ha sconfessato il senso della lotta, rendendo ridicoli i tanti atti di eroismo spesi per il raggiungimento di un falso obiettivo. Tra i sommersi e i salvati la sorte peggiore è toccata a questi ultimi: mentre i primi, 123 la rivista dell’ Arte infatti, hanno avuto il privilegio di morire sul campo di battaglia credendo di sacrificarsi da eroi, ai sopravvissuti non resta che fregiarsi del titolo di sudditi italiani, una misera conquista per chi, prima dello stato unitario, poteva dirsi fratello di chiunque condividesse nella penisola gli stessi ideali di libertà e giustizia. A Napoli, negli ultimi anni, mi era accaduto di imbattermi in qualcuno di questi sopravvissuti: vecchi signori in correttissimo abito civile che avevo lasciati in casacca di pelo d’asino. Dopo un abbraccio formale, rimanevamo imbarazzati parlando di cose insignificanti, il tempo, la salute: su questa, soprattutto, la conversazione ritrovava una certa spontaneità. […] Sapevamo ben poco, adesso, l’uno dell’altro ed esitavamo a chiedere notizie delle famiglie, forse menomate: di politica, poi, neppure un cenno. […] Il presente non ci riguardava più, ci vivevamo da estranei12. Estranei, dunque, in quella stessa nazione che avevano ampiamente contribuito a costruire, e talvolta considerati anche nemici, come lo stesso Domenico, per la fedeltà dichiarata agli ideali democratici e repubblicani, i salvati, scampati alle carceri borboniche o al confino austriaco, vivono l’amara condizione dello straniero in patria, al quale sono perfino negate le care illusioni dell’esilio. Se l’esule, infatti, è confortato dal senso di appartenenza ad una patria ideale, di cui si sente benemerito cittadino onorario, allo straniero in patria è sottratta la consolazione di un futuro riscatto e lo attende il destino del prigioniero, costretto entro sbarre ben più spesse di quelle del carcere di Montefusco. Dal monologo finale del film, affidato alle parole di Domenico, si evince chiaramente quale sia la considerazione degli ex patrioti nella nuova Italia unita: essi sono dei rottami, ormai inutili nell’Italia «gretta, povera, superba»13 che si è insediata a Torino e la loro voce non è rappresentata da nessuno di coloro che occupa gli ambiti seggi del parlamento del Regno d’Italia. Dai luoghi del potere sono stati esclusi quelli che più hanno speso nella lotta senza contare chi, come Carlo Poerio e con lui molti altri, ha liberamente deciso di ritirarsi a vita privata, rifiutandosi di avallare lo scempio di una politica iniqua e scellerata. In molti degli ex patrioti, allora, potrebbero sottoscrivere quanto afferma Domenico con profonda rabbia: Me ne importa molto di questa penisola popolata di gente a cui non ho più nulla da dire? Temo di no, sebbene il suo nome mi abbia empito la bocca per anni e anni, come una giaculatoria di beghine. […] Uno nasce uomo prima che italiano e peruviano e devo confessare che anche nel carcere talvolta il concetto di patria mi è parso una condanna14. 124 la rivista dell’ Arte Per un democratico come Domenico, infatti, il concetto di patria non può esaurirsi nella banale delimitazione di un confine, cosa della quale, al contrario, ci si è accontentati. Se la patria non può essere il luogo dove vengono garantiti pari diritti e doveri per tutti i cittadini, libero accesso all’istruzione e politiche di giustizia sociale, allora quel nobile concetto si riduce ad una bandiera in mano a chi la sventola solo per garantire i propri interessi. Ma qual è stato l’«errore in cui siamo caduti»? Una scena, centrale all’interno del film, sembra indicare le radici di quell’errore. Nel carcere di Montefusco si assiste, infatti, ad una singolare e spontanea ripartizione dei detenuti, incarcerati per i medesimi delitti politici: da una parte ci sono i marchesi, i conti, i proprietari terrieri, i signori-padroni-galantuomini insomma, dall’altra i popolani, che anche in carcere non smettono di servire e di trattare con riverenza i loro ex padroni. Stessa cella, dunque, ma diversa prigionia: una tavola apparecchiata per i signori, una scodella in mano per i contadini; quelli occupati in segreti conciliaboli per pianificare il futuro dell’Italia, questi, prima trascinati sul campo di battaglia, ora esclusi dalle discussioni politiche. Vi partecipai anch’io [afferma Domenico], con pochi altri di civile condizione, ma non mi sfuggiva il senso che essi [i conciliaboli di carattere politico] potevano assumere agli occhi dei contadini e artigiani che avevano sofferto come e più di noi. Lo feci osservare e mi diedero sulla voce: solo Poerio parve appoggiarmi. Cosa potevano capire quei poveri ignoranti dei maneggi di Cavour, delle intenzioni della Francia e dei segreti contatti con gli esuli? Li avrebbero interpretati scorrettamente, si sarebbero montati la testa, con danno di tutti: toccava a noi, responsabili, discuterne e stabilire su quali appoggi si potesse contare. Lo avremmo poi spiegato alla buona ai compagni più sprovveduti […]. Rientrato da quelle chiacchierate […] nella cella dei pezzenti, mi sentivo tutti gli occhi addosso: nessuno però chiedeva cosa si fosse detto […]. Non si sentivano offesi, insomma, per esser così trascurati, eran persuasi di non contare più nulla. Certo la loro secolare saggezza li avvertiva che niente sarebbe cambiato in un mondo diviso fra ricchi e poveri e che ognuno doveva pensare ai fatti suoi […]15. È in quella spiegazione «alla buona» che consiste l’errore del Partito d’Azione, che ha fallito nel coinvolgere le masse popolari minando così la costruzione dal basso dell’unità d’Italia e avallando la politica annessionistica di casa Savoia. La cecità degli intellettuali del movimento risorgimentale, molti dei quali, vivendo la condizione dell’esule e guardando da altrove all’Italia, dimostrano di conoscere ben poco il paese che vorrebbero riscattare, risiede proprio nel non aver compreso l’importanza dell’educazione delle masse contadine, ingenuamente considerate favorevoli ad una lotta i cui obiettivi non erano ai più manifesti, né comprensibili. 125 la rivista dell’ Arte Noi gli [al popolo] abbiamo detto: siete liberi, e la libertà è la bella cosa che vedete. Perché non dirgli invece: queste sono le vie che conducono al libero ordinamento della civile società, questi sono i confini che dividono le schiavitù dell’età di mezzo dalla bene regolata libertà dell’età nostra e dell’avvenire? […] Se così gli parleremo, lo vedremo tosto rasserenarsi; e forse fra non molto troveremo in lui, nelle sue forze, naturalmente superiori alle nostre, quell’appoggio che ora siamo in debito di prestargli, e di cui per avventura potremmo quando che sia alla nostra volta abbisognare. Ricordiamoci dunque, che le moltitudini non possono mantenersi costantemente affezionate ad un ordine di cose da cui non traggono alcun benefizio materiale, né qualche fondata speranza di futuri e prossimi vantaggi. – Sforziamoci di migliorare la sorte delle classi più povere delle nostre popolazioni; e sino a tanto che tale miglioramento non sia da esse effettuato e conosciuto, mostriamo loro le conseguenze che risultar debbono dalle istituzioni nostre […]. Per riassumermi dirò, che lo scopo a cui dobbiamo tendere innanzi tutto, si è lo spargere luce nelle menti delle povere classi della nostra popolazione, onde renderle consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri […]16. Rimaste inascoltate le parole di chi, come Cristina di Belgiojoso, eletta da Martone e De Cataldo a protagonista femminile del film17, riteneva il coinvolgimento popolare un fattore imprescindibile per il compimento del processo di unificazione prima, e per il consolidamento dello Stato unitario poi, e riconosceva all’istruzione una primaria funzione civile e politica, il paese è rimasto vittima di quella mentalità, tuttora tristemente molto diffusa, ben descritta dalle parole della Banti: «ognuno doveva pensare ai fatti suoi». Come altro tutelarsi di fronte ad un sistema che garantisce gli interessi dei soliti pochi? Che senso avrebbe dovuto avere per un contadino sacrificarsi nella lotta per scalzare un sovrano piuttosto che un altro? Il popolo è rimasto spettatore quasi inerte, ha applaudito Garibaldi, non ha capito Cavour, aspetta dal re la soluzione del suo problema, del problema che direttamente egli sente, quello della miseria, e dell’oppressione economica e feudale. Ma il nuovo regno è sorto con un vizio di origine che lo rende incapace, nonché di risolvere, di sentire il problema del popolo, il nuovo regno è sorto dall’incontro di un interesse dinastico con un interesse di classe bottegaia, il nuovo regno non potrà a meno di far servire la forza della Corona a sostegno, contro la maggioranza della nazione, degli interessi di questa classe. L’unità, affermata come risultato, è negata nelle premesse e sarà continuamente contraddetta nella pratica. Dapprima furono i favori e la corruzione individuale, fu il mercato minuto dei posti, delle concessioni, degli uffici, fu la prepotenza della burocrazia regionale. […] Coronamento dell’opera la tariffa protezionistica che spezzò il paese in due parti, che dei tre quarti di esso fece una colonia di sfruttamento aperta alle brame di una minoranza di briganti. Il popolo, quello che aveva creduto e quello che era rimasto spettatore, si ribellò, e la sua ribellione, chiamata brigantaggio mentre era guerra civile, fu maledetta e combattuta in nome dell’unità e del principio monarchico18. 126 la rivista dell’ Arte È questa l’alba della nazione, alla quale Martone dedica il quarto episodio del film che, insieme al secondo intitolato “Domenico”, è il più riuscito. Nei due episodi, strettamente collegati tra loro dal personaggio di Domenico, che è protagonista di entrambi, si riscontra quell’unità narrativa che il film nel complesso non possiede, proprio per l’ambizione di voler raccontare le molte facce del Risorgimento19. È in questa quarta parte del film che Martone inserisce l’ardita e tanto discussa immagine di un odierno ecomostro incompiuto in cemento armato, che non vuole essere un anacronismo fine a se stesso, ma una traduzione iconografica dell’alba della nazione e, allo stesso tempo, dell’Italia che verrà20. Se, infatti, il palazzo in costruzione è chiara metafora del processo, appena intrapreso, di lenta edificazione della nazione, dall’altra parte rimanda con tutta evidenza all’esito stesso di quel processo, all’Italia corrotta dei nostri tempi, che affonda le sue radici proprio in quella rivoluzione tradita e lasciata a metà dell’opera. Il richiamo al presente rappresenta, infatti, la primaria urgenza narrativa del regista, che guarda al passato come l’angelo della storia descritto da Walter Benjamin21, in un perenne alternarsi in campo e fuori campo dell’Italia di ieri e dell’Italia di oggi. Allo stesso modo, la Banti nel 1967, nello scrivere Noi credevamo, guardava al Risorgimento non solo come al periodo storico di costruzione della nazione, ma anche come ad una metafora della Resistenza e degli anni della ricostruzione, segnati dai primi passi del nuovo Stato repubblicano. Il tradimento degli obiettivi rivoluzionari, che è poi la lente attraverso la quale Martone, in accordo con la Banti, rilegge il Risorgimento, è sottolineato dalla stessa struttura circolare del film che si apre con la repressione borbonica di una sollevazione popolare nel Cilento (1828) e si chiude con i fatti di Aspromonte (1862), dove è l’esercito del neo Regno d’Italia a soffocare nel sangue la rivolta. Diverse divise, quindi, ma stessa repressione, con l’unica, drammatica differenza che nel 1862 si assiste ad un folle scontro fratricida tra il cosiddetto esercito regolare e i volontari dell’esercito garibaldino, che solo un anno prima avevano combattuto per la medesima causa unitaria22. Martone, però, non è affatto indulgente nemmeno nei confronti degli stessi garibaldini, ai quali si sarebbe portati a credere che vadano le sue simpatie. Anche nel libero esercito delle camicie rosse, infatti, si annida il germe del dispotismo, che pretende di mettere a tacere ogni manifestazione di dissenso in nome del superiore ideale “democratico”. A questo rimanda la scena del film in cui due ufficiali dell’esercito garibaldino interrompono bruscamente due attori loro commilitoni che recitano un pezzo tratto da I mafiusi de la Vicaria23, nel quale si allude alla collusione di Francesco Crispi, e più in generale dell’intera classe dirigente, con la mafia. L’ingiusta censura, che viene applicata nei confronti dei due teatranti e contro la quale insorge Domenico, tradisce i fragili presupposti 127 la rivista dell’ Arte democratici sui quali si vorrebbe fondare il nuovo Stato e, ancora una volta, rimanda al presente, tragicamente segnato da quel perpetuo rapporto del potere politico con le organizzazioni mafiose criminali e dalla generalizzata azione censoria che è, da sempre, lo strumento per eccellenza di ogni potere non democratico24. Nell’ultima parte del film Martone, attraverso l’incontro, peraltro piuttosto inverosimile, di Domenico con Saverio, il figlio dell’amico Salvatore, apre quel dialogo tra vecchi e giovani, che è sottinteso anche nel romanzo della Banti, come motore stesso della narrazione. Al giovane e ingenuo figlio dell’amico Domenico risparmia l’ignobile verità sulla morte del padre, assassinato non dai Borboni come ritiene Saverio, ma dalla mano di un fratello, Angelo, perché sospettato (ingiustamente) di tradimento. Il regista, così, nel ribadire la disincantata visione della Banti, di una gioventù che, ingenuamente alla ricerca di eroi, non è pronta a confrontarsi con un mondo che non sia manicheamente diviso in buoni e cattivi, apre la discussione anche sulla necessità di una storiografia non partigiana e sul rispetto della verità storica che, celata agli occhi di un figlio cresciuto nel mito del padre, non può essere tuttora negata alla comunità dei posteri. Si tratta di un’operazione ben diversa dal revisionismo storico che, soprattutto negli ultimi anni, è stato piegato ai mutevoli voleri della classe dirigente, ma di una seria rilettura critica che dovrebbe essere applicata tanto al Risorgimento quanto ad altri periodi della nostra storia recente. Ed è proprio questo l’intento che Martone, con profonda onestà intellettuale, si è prefisso nel girare il film, conferendo all’arte non il compito della propaganda ma quello di cercare di ristabilire la verità storica, collocandosi in una prospettiva diametralmente opposta a quella dell’anonimo pittore, descritto nelle prime pagine del romanzo di De Cataldo. Il Pittore […] disegna la scena [della fucilazione di alcuni patrioti]. […] Le colline che circondano la radura, eccezion fatta per due regi funzionari, un prete che offre, sdegnosamente respinto, l’estrema unzione, tre pastori e un pazzo con le braghe calate, sono deserte. I patrioti incedono in silenzio, i soldati sono annoiati e non vedono l’ora di finirla. L’arte prevale sulla commozione, il dovere della propaganda rivoluzionaria sull’emozione. Il Pittore ricostruisce la scena: le colline sono gremite di gente, contadini dai lineamenti fieri, pastori che fissano sdegnati gli sbirri, avvolti in un’aura di universale disprezzo, donne in lacrime che piangono il fiore della migliore gioventù italiana. Sotto il tocco delle sue dita, quella mesta e solitaria cerimonia si fa aggressiva festa di popolo […]25. Niente di tutto ciò nell’epopea amara e disincantata del Risorgimento di Martone, che si astiene dal trasformare «il sangue e la merda in mito»26, ma non manca di indicare la futuribile speranza nel 128 la rivista dell’ Arte risarcimento dei giovani patrioti risorgimentali, allora traditi, attraverso il compimento di quel processo di costruzione della nazione su basi realmente democratiche che non può prescindere dalla conoscenza del nostro passato comune. L'imperfetto [del titolo del film] ci dice della continuità tra le generazioni che si sono passate il testimone. L'idea repubblicana è rimasta viva, l'Italia è stata liberata dal fascismo, quindi negli anni '70 è andata molto avanti sul piano delle conquiste sociali. Ma resta la difficoltà a rendere tutto questo maturazione democratica. La politica di oggi ci dice che si vorrebbe disgregare il paese per un federalismo che è fondato sull'egoismo e sull'idea semplificatoria di un contrasto tra Nord e Sud. Ma l'Italia è separata anche tra l'anima democratica e quella autoritaria rappresentata da Crispi, Mussolini, dallo stragismo di Stato e che arriva fino ai nostri giorni. È impossibile armonizzare le oscillazioni del pendolo come nelle altre democrazie, quella inglese o quella francese. Ma bisogna dire la verità, perché è sulla negazione che nasce il revisionismo: il Risorgimento non è un affare dei padri della patria imbiancati e noiosi. Come possiamo avere la forza di agire, non violentemente ma politicamente, se restiamo impaludati? Quella guerra non è ancora finita27. 1 Non è certo questa la sede per dare esaustive indicazioni sulla copiosa bibliografia risorgimentale degli ultimi anni. Mi limiterò, quindi, a rimandare alla selezione di titoli bibliografici operata dalla Biblioteca della Camera in occasione del centocinquantenario, aggiornata a giugno 2011 e consultabile online all’indirizzo: http://biblioteca.camera.it. 2 GRAMSCI ANTONIO, Il Risorgimento e l’unità d’Italia, Roma, Donzelli, 2010, p. 187. 3 Cfr. MARTONE MARIO, Noi credevamo, Milano, Bompiani, 2010, pp. XXXIII-XXXIV: «Bisogna prestare attenzione a quel “II” re d’Italia, che ha un suo significato. Ogni volta che, nella storia delle dinastie, c’è un senso di rifondazione dello Stato, i sovrani cambiano la numerazione. Noi italiani, invece, non abbiamo avuto un primo re d’Italia. Abbiamo avuto un secondo Vittorio Emanuele di Savoia. Vittorio Emanuele non ha sentito il bisogno di chiamarsi primo re d’Italia, in lui ha prevalso l’affermazione della centralità piemontese. E simmetricamente nella percezione degli italiani del Sud l’unità è stata un’annessione». 4 Cfr. ALIANELLO CARLO, La conquista del Sud. Il Risorgimento nell’Italia meridionale, Milano, Rusconi, 1972. 5 Cfr. MARTONE MARIO, Noi credevamo, cit., p. LV: «Il titolo ci dice che il film è il racconto di una sconfitta, e non c’è dubbio che Noi credevamo sia un film tragico. Ma quando dico tragico, intendo anche catartico, vorrei cioè che desse una spinta all’azione. Il punto non è che tutto è finito, il problema è che tutto è da cominciare». 6 BANTI ALBERTO MARIO, La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Torino, Einaudi, 2006, p. 33. 7 BANTI ANNA, Noi credevamo, Milano, Mondadori, 1967. 8 DE CATALDO GIANCARLO, I traditori, Torino, Einaudi, 2010. 9 Cfr. MARTONE MARIO, Noi credevamo, cit., p. VIII: «A darmi la spinta per il film fu una domanda che a un certo punto cominciò a passarmi per la testa. Dopo l’11 settembre la pressione del terrorismo internazionale era percepita in maniera molto forte e la questione palestinese era sempre molto presente. Non pensavo tanto al passato, alla storia d’Italia, che in fondo non conoscevo affatto, ma riflettendo sul rapporto fisiologico tra terrorismo e lotta per l’identità nazionale, mi chiedevo: com’è possibile che il nostro Paese, che ha così a lungo combattuto per la sua indipendenza, non abbia conosciuto niente del genere? Che la storia d’Italia sia stata soltanto una storia di grandi battaglie, gesti eroici e abilissime diplomazie, senza quel fatale e pesantissimo contrappeso che l’impegno di una lotta del genere comporta?». Si tratta di un nodo centrale, che Martone affronta soprattutto nel terzo episodio del film, dedicato al piano mai realizzato sulla strage di Notre-Dame e all’attentato a Napoleone III all’Opéra. 10 BANTI ANNA, Noi credevamo, Milano, Mondadori, 2010, p. 344. 11 Ivi, p. 11. 12 Ivi, pp. 23-24. 13 Ivi, p. 307. 14 Ivi, pp. 307-308. 129 15 la rivista dell’ Arte Ivi, pp. 122-123; corsivo mio. TRIVULZIO DI BELGIOJOSO CRISTINA, Osservazioni sullo stato attuale dell’Italia e sul suo avvenire, Milano, Vallardi, 1868, pp. 139 e 141. 17 Non si sono, però, sfruttate al meglio le potenzialità di un personaggio come quello della Belgiojoso, intellettuale e patriota di rara lungimiranza. Risulta, peraltro, piuttosto inutile in sceneggiatura la breve storia d’amore tra Angelo e Cristina, attraverso la quale viene riproposta la leggenda della Belgiojoso-seduttrice dal fascino ammaliatore. Dall’analisi delle scene tagliate, che lasciano anche intuire una storia d’amore tra Cristina e Domenico, si evince che la principessa dovesse avere ben altra continuità nel film. La figura della Belgiojoso, troppo a lungo trascurata dalla storiografia ufficiale come, peraltro, il complessivo contributo femminile al movimento risorgimentale, è stata oggetto negli ultimi anni di una seria rivisitazione critica. Cfr. CONTI ODORISIO GINEVRA, GIORCELLI CRISTINA e MONSAGRATI GIUSEPPE (a cura di), Cristina di Belgiojoso. Politica e cultura nell’Europa dell’Ottocento, Casoria (NA), Loffredo, 2010; FUGAZZA MARIACHIARA e RÖRIG KAROLINE (a cura di), «La prima donna d’Italia». Cristina Trivulzio di Belgiojoso (1808-1871) tra politica e giornalismo, Milano, FrancoAngeli, 2010; PROIA GIANNA, Cristina di Belgiojoso. Dal salotto alla politica, prefazione di Ginevra Conti Odorisio e Fiorenza Taricone, Roma, Aracne, 2010. 18 GRAMSCI ANTONIO, Il Risorgimento e l’unità d’Italia, cit., pp. 186-187; corsivo mio. 19 Mi riferisco soprattutto all’episodio dedicato ad Angelo, che spezza la narrazione e apre lo scenario sul Risorgimento visto dall’esilio, dalle grandi capitali europee di Londra e Parigi, e sul mondo delle spie e dei traditori, particolarmente caro a De Cataldo. Nell’episodio, infatti, si riconosce la stessa penna de I traditori, il feuilleton di De Cataldo sul Risorgimento che, nella pretesa di raccontare le complesse vicende degli anni 1844-1872 attraverso una folta schiera di personaggi, alcuni dei quali peraltro disegnati solo per compiacere un certo tipo di lettore, tradisce la natura di un progetto editoriale non sostenuto da una reale esigenza narrativa. 20 Cfr. MARTONE MARIO, Noi credevamo, cit., p. XLVI: «[…] lo scheletro di cemento armato sotto il quale Saverio e Domenico si fermano a dormire prima di raggiungere i garibaldini […] vuole dirci che Domenico e Saverio dormono sotto quello che sarà il futuro del Sud e del Paese». 21 Cfr. BENJAMIN WALTER, Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di Renato Solmi, Torino, Einaudi, 2003, p. 80: «C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta». 22 Cfr. MARTONE MARIO, Noi credevamo, cit., p. X: «Apriamo una parentesi a proposito dell’Aspromonte. Non è curioso, e indicativo, che nella coscienza comune di tutti noi l’Aspromonte abbia sostanzialmente prodotto solo quella canzoncina che i bambini […] canticchiano a scuola? “Garibaldi fu ferito…” […]. Questa canzoncina è l’unico “lascito”, nella nostra coscienza di italiani, di quello che è stata l’alba tragica del nostro Paese […]». 23 Opera teatrale scritta nel 1863 da Giuseppe Rizzotto e Gaetano Mosca. Si tratta del primo testo che mette in evidenza la collusione del potere politico italiano con le mafie. 24 Cfr. l’intervista a Mario Martone di MALTESE CURZIO, “1849, il sogno tradito di Mazzini e Garibaldi”, Il Venerdì di Repubblica, 5 novembre 2010: «Il Risorgimento è la chiave migliore per leggere il presente. In realtà, quando ho cominciato, ne sapevo poco, come tutti. Ma guardando all’eterno malessere del Paese, alla sua disunità, all’odio fra italiani, ho pensato di andare al trauma della nascita e della prima infanzia, come si fa in psicanalisi». 25 DE CATALDO GIANCARLO, I traditori, cit., pp. 40-41. 26 Ivi, p. 174: «Poi arriverà un pittore, e trasformerà il sangue e la merda in mito. E altri illusi crederanno non alla realtà, ma alla sua raffigurazione». 27 PATERNÒ CRISTIANA, “Noi credevamo, quest’Italia è ancora da fare”, Cinecittà News, 9 novembre 2010, http://news.cinecitta.com. 16 la 130 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Transculturazione Roberto Fernández Retamar Varias maneras de mirar a un mirlo, digo, a una literatura* Nel testo della conferenza inaugurale del XVIII Congresso AILC/ICLA 2007 a Rio de Janeiro, Roberto Fernández Retamar, parafrasando il titolo di un componimento di Wallace Stevens, propone alcune prospettive di osservazione, e quindi di analisi e comprensione, della letteratura cubana, con una concezione di letteratura comparata, mutuata da Armando Gnisci, intesa come “disciplina di decolonizzazione”. Questi “sguardi” sono, al contempo, storici, politici, individuali. Partendo da una prospettiva di osservazione spagnola, Retamar assume poi il punto di vista ispanoamericano, fino ad arrivare allo sguardoprospettiva caraibica, la Cuenca del Caribe, come da tempo lui stesso l’ha definita. L’autore rivendica la natura poliedrica della letteratura cubana: una letteratura caraibica e ispanoamericana, di lingua spagnola, prodotto di un “pueblo nuevo” (Darcy Ribeiro), procedente cioè da un complesso processo di “transculturazione” (Fernando Ortiz) ancora inconcluso. Es obvio que he pedido en préstamo el título al poeta estadunidense Wallace Stevens, quien escribió «Thirteen Ways of Looking at a Blackbird», y el poeta cubano Eugenio Florit tradujo con el feliz endecasílabo sáfico «Trece maneras de mirar a un mirlo». Pero lo que en estas líneas invitaré a mirar, desde distintas perspectivas más que maneras, no es un pájaro, sino el bulto de una literatura, la cubana. Prescindo, como se comprenderá, de proponer la tautología de que dicha literatura sea vista sólo desde su mismidad, propuesta inaceptable en general y en particular cuando se habla de literatura comparada. Sobre la relación actual entre esta última y las literaturas nacionales, véase el ensayo de Eduardo F. Coutinho «Literatura comparada, literaturas nacionais e o questionamento do cânone»1. Por otra parte, ya sé que están 131 la rivista dell’ Arte en tela de juicio muchos de los vocablos/conceptos con que trabajamos. Al abordar «Literaturas emergentes y literatura comparada», escribió Wlad Godzich: «No podemos contar con un conocimiento fehaciente de lo que subyace a la agitación teórica de los últimos años, aunque conocemos algunas de sus consecuencias. Éstas han ocupado, sin duda, un lugar prominente en las controversias. Una de las más sobresalientes ha sido la repentina incertidumbre en lo concerniente a nuestro propio objeto de estudio»2. Criterio hasta cierto punto semejante expresó, en «Ejercer la crítica literaria cuando nadie tiene la certeza de lo literario»3, Víctor Barrera Enderle, quien habló allí de «la incertidumbre de un oficio cuya materia prima se ha venido disolviendo con el paso de los años. […] Nuestro oficio, tiempo atrás calificado de ciencia en potencia, hoy en día se esparce y se difumina entre los interminables campos de los estudios literarios […]» (p. 113). Creo que fue Chesterton quien escribió que un pensamiento que debe evitarse es el que al producirse impide la marcha del pensamiento. No pretendo entrar en la manigua de las polémicas terminológicas que a menudo son encarnaciones de la «nueva vulgata planetaria» sobre la cual nos previnieron Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant. Pero, aunque los autores apuntaban mas allá de nuestros estudios, es útil tener en cuenta sus palabras: La diffusion de cette nouvelle vulgate planétaire [...] est le produit d’un impérialisme proprement symbolique. Les effets en sont d’autant plus puissants et pernicieux que cet impérialisme est porté non seulement par les partisans de la révolution néolibérale, lesquels, sous couvert de modernisation, entendent refaire le monde en faisant table rase des conquêtes sociales et économiques résultant de cent ans de luttes sociales, et désormais dépeintes comme autant d’archaïsmes et d’obstacles au nouvel ordre naissant, mais aussi par des producteurs culturels (chercheurs, écrivains, artistes) et des militants de gauche qui, pour la grande majorité d’entre eux, se pensent toujours comme progressistes. // [...] [A]ujourd’hui nombre de topiques directement issus de confrontations intellectuelles liées aux particularités et aux particularismes de la société et des universités américaines se sont imposés, sous des dehors en apparence déshistoricisés, à l’ensemble de la planéte. // [...] C’est [...] un discours américain, bien qu’il se pense et se donne comme universel, en cela qu’il exprime les contradictions spécifiques de la situation d’universitaires qui, coupés de tout accès à la sphère publique et soumis à une forte différenciation dans leur milieu professionnel, n’ont d’autre terrain où investir leur libido politique que celui des querelles de campus déguisées en épopées conceptuelles4. Transcribiré a continuación una escueta frase: «Globalization is only another word for US domination»5. Debemos la memorable definición a una autoridad en la materia (aunque no precisamente en el campo cultural): Henry Kissinger. No siempre contamos con brutales confesiones semejantes. Vuelvo a mi canto llano y empiezo por la perspectiva española. En mi país, conmemoraremos el próximo la 132 rivista dell’ Arte año cuatro siglos de literatura cubana, pues se considera la primera obra literaria nuestra al poema épico Espejo de paciencia, escrito en 1608. Y al no haber sobrevivido areítos, ceremonias religiosas que incluían cantos y danzas de los aborígenes (ellos mismos fueron pronto exterminados), es indudable que la literatura cubana comienza como un desprendimiento de la española. Un desprendimiento, concretamente, de la literatura en lengua castellana, devenida lengua imperial, pues, a diferencia de España, no hay en la literatura cubana obras catalanas, ni gallegas, ni vascas. José Juan Arrom estudió «Las letras en Cuba antes de 1608»6. Letras, desde luego, de españoles. El primero, sin embargo, no lo era, pues se trató del mesiánico y pintoresco genovés Cristóbal Colón, quien pergeñó las páginas inaugurales en torno a nuestra Isla. Sobre la versión de su Diario de viaje que ha llegado a nosotros, y sobre otros textos más o menos emparentados con él, Beatriz Pastor escribió su excelente libro Discurso narrativo de la conquista: mitificación y emergencia7. Arrom escudriñó el inicio de las letras cubanas en obras de navegantes, cronistas y colonos que escribían en Cuba, trataban de ella o estaban íntimamente relacionadas con el desarrollo posterior de su cultura. Por descontado, dio un sentido bien lato a la literariedad. Al Diario de viaje de Colón lo consideró «la piedra angular de las letras de Cuba» (p. 18). José Lezama Lima, en su Antología de la poesía cubana8, diría luego que es «libro que debe estar en el umbral de nuestra poesía», (t. I, p. 7). Arrom se refirió luego a Fray Bartolomé de Las Casas, quien se dio a la tarea de defender, «en lenguaje vibrante y apasionado» (p. 18), el derecho del indígena a ser libre. Arrom afirmó que sería acto de justicia dar cabida en las letras cubanas a aquellos escritos de Las Casas que atañen directamente a la Isla. Los demás autores aludidos por el erudito ex profesor de Yale no tienen la relevancia del Almirante ni del gran dominico. Se ha añadido a Juan de Castellanos, quien en Elegías de Varones Ilustres de Indias incluye versos en los que se hace evidente que estuvo en Cuba. Y al republicarse en 2002, con un nuevo tomo, la Antología de la poesía cubana compilada por Lezama9, Álvaro Salvador y Ángel Esteban la hacen preceder, en «anexo», de «un canto de setenta y cuatro octavas reales que pertenecen a un conjunto de varios miles de versos dedicados a describir el periplo americano de Fray Alonso de Escobedo, franciscano andaluz» (t. I, p. xiv). Se trata de «Florida», alude a Baracoa y La Habana, lugares que el autor visitó, y se conjetura que fue escrito entre 1598 y 1600. Con criterios similares, el siglo XVI cubano puede ofrecer un muestrario, así sea magro, de cierta producción literaria. Se trata, sin duda, de una producción totalmente colonial, cuyos hacedores ni siquiera son cubanos. Y colonial seguirá siendo durante largo tiempo la literatura en Cuba. Los indígenas, como se sabe, no sobrevivieron al impacto con los europeos. Sobre esto, Las Casas dejó la 133 rivista dell’ Arte conocidas páginas lancinantes. La supervivencia de los aborígenes sólo ocurriría en palabras (las primeras americanas en penetrar en lenguas europeas), en especial en topónimos (el mismo nombre del país es prueba de ello, pues resistió a otros como Juana y Fernandina), en humildes viviendas, en alimentos, en costumbres como la del tabaco, al principio y al final tenido por diabólico. Fueron vencidos de verdad y para siempre, no como en los casos a que remiten los notables libros de Miguel León Portilla Visión de los vencidos (1959) y El reverso de la conquista (1964), ya que en buena parte de América hay millones de descendientes directos de los visionarios a que se refirió León Portilla. En consecuencia, no hay en Cuba, paralelamente a la de origen español, una literatura indígena, oral o amparada en ropaje español, como sí la hay, hasta nuestros días, en otros países americanos, según lo han señalado autores como Martin Lienhard y Gordon Brotherston10. Es curioso, sin embargo, que hace algo más de cuarenta años Lezama diera al protagonista de su novela Paradiso (1966) el nombre de José Cemí: cemí se llama una imagen indocubana de destino religioso y quizá una deidad. Caso bien distinto al del llamado «indio» es el del negro, «indígena “importado”», según lo llamó, en relación con zonas americanas más vastas, Alejandro Lipschütz11. Este otro «indígena» resultó factor esencial de lo que iba a ser lo cubano. Y al no arraigar en el país ninguno de los idiomas africanos traídos por los esclavos, el castellano acabó siendo su lingua franca: lo que, después de todo, les ocurrió también a los conquistadores y colonizadores venidos de España con el propio castellano, según he mencionado. El africano, llamado negro al margen de la variedad de sus orígenes étnicos, fue obligado a expresarse en castellano, aunque como lenguas rituales sobrevivieran varias, sobre todo el yorubá. Y en castellano dejaría ejemplos literarios como plegarias, cantos, leyendas, cuentos, refranes originalmente producidos en lenguas africanas (yorubá, ewe, bantú), que en el siglo XX iban a ser recogidos, en la estela de Fernando Ortiz, por autores como Ramón Guirao, Lydia Cabrera, Rómulo Lachatañeré12 e incluso Lezama, en su Antología de la poesía cubana13. Aquí es oportuno recordar que el de Cuba, en la clásica denominación de Darcy Ribeiro, no es un pueblo «testimonio» ni un pueblo «transplantado», sino un pueblo «nuevo», en que todos sus componentes han venido de fuera, y conocerían un proceso de fusión que en 1940 Ortiz llamó «transculturación», y no ha concluido. Este término, y otros más o menos cercanos a él, como mestizaje e hibridez, también están en discusión, según lo hizo ver, quizá como nadie, Antonio Cornejo Polar, pero no voy a detenerme ahora en dicha discusión, a la que contribuí con un comentario sobre un texto de Cornejo14. Un libro aparecido el año pasado sobre la literatura y el arte de Cuba lleva el significativo título la 134 rivista dell’ Arte Alma Cubana: Transculturación, Mestizaje e Hibridismo15. A mediados del siglo XVI, Cuba era una menguada factoría, en que el sistema monopolista que España impuso a sus colonias sólo era roto por la piratería internacional y el frecuente contrabando. Precisamente en relación con estos se produce la primera obra concientemente literaria producida en la Isla: el ya mencionado Espejo de paciencia, cuyas candorosas octavas reales, escritas en la villa de Puerto Príncipe, tratan de un encuentro no de españoles e indios, como en La araucana, de Alonso de Ercilla, sino de nativos y piratas. Su autor, Silvestre de Balboa Troya y Quesada, oriundo de las Islas Canarias, estaba radicado en Cuba, y casi seguramente había participado en la academia poética presidida en Las Palmas de Gran Canaria por Bartolomé Cairasco de Figueroa, quien, según Belén Castro, «influyó en la gestación del barroco español […], fue el inventor de la primera mitificación poética de su isla […], [y] trató temas muy afines a los de Espejo de paciencia: el de la piratería, que también amenazaba las costas de las Islas Canarias, y el de la defensa colectiva del patrimonio insular»16. Espejo de paciencia, pues, no es el resultado de una evolución literaria interna, de que entonces carecíamos aún, sino el trasplante de un producto canario adaptado a un tema y un ambiente del nuevo hogar del poeta. No se limitó a ello Balboa, sino que, a semejanza de lo que conoció en la mentada academia poética canaria, atrajo al cultivo de las letras a varios habitantes de la región, seis de los cuales le dedicaron sonetos laudatorios. Vale la pena subrayar que tanto en el texto como en uno de los sonetos que lo preceden aparece por primera vez en Cuba el vocablo «criollo». Aquí de nuevo debo citar a Arrom, cuya investigación «Criollo: definición y matices de un concepto»17 es el mejor estudio que conozco sobre el asunto. Según tal estudio, el vocablo había nacido en el portugués del Brasil, de donde se difundiría por otras lenguas, y antes de concluir el siglo XVI era de uso corriente en todo el Nuevo Mundo, donde implicaba haber nacido aquí, de ascendientes venidos del Viejo, sin importar, originalmente, el color de la piel, el estado político o la condición social. En efecto, en Espejo de paciencia un blanco «mancebo galán» es llamado «criollo de Bayamo», y un negro, «Salvador criollo, negro honrado»; mientras el Capitán Pedro de las Torres Sifontes ofrece a Balboa un «soneto criollo de la tierra», donde no deja duda sobre el significado del término: es «de la tierra». Se trata de un rasgo en que lo americano (en este caso lo cubano) empieza a diferenciarse paulatinamente de lo del Viejo Mundo. Recuérdese, de paso, que un importante personaje del jocundo Concierto barroco, de Alejo Carpentier, Filomeno, es presentado como «biznieto de un negro Salvador, que fue, un siglo atrás, protagonista de una tan sonada hazaña que un poeta del país, llamado Silvestre de Balboa, la cantó en una larga y bien rimada la 135 rivista dell’ Arte oda, titulada Espejo de paciencia»18. Es notable este deseo de dos autores tan relevantes del siglo XX cubano como Lezama y Carpentier, de entroncar con el pasado local en sus obras de ficción. No es necesario detenerse en el proceso multisecular de diferenciación de la literatura de Cuba con respecto a la de España. De ello se han ocupado varios panoramas de la literatura cubana, el primero de los cuales, debido a Aurelio Mitjans, apareció incompleto, póstumamente, en 1890, con el título Estudio sobre el movimiento científico y literario de Cuba19; y del más reciente, llamado Historia de la literatura cubana, obra colectiva preparada por el Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba, han aparecido en 2002 y 2003 los primeros tomos, y es inminente la publicación de un tercero y último. Baste decir que antes del siglo XIX la literatura de Cuba no contó con obras de la envergadura de las del Inca Garcilaso de la Vega o Sor Juana Inés de la Cruz; y que la diferenciación entre españoles y criollos blancos no avanzará mucho hasta el siglo XVIII. A finales de ese siglo empieza a abrirse la grieta que acabará por separar a españoles y criollos blancos, y hasta cierto punto a sus literaturas respectivas. Entre los varios acontecimientos importantes ocurridos entonces, ninguno fue más trascendente para Cuba que la guerra del Saint Domingue francés que hizo extinguir allí la esclavitud y acabó por independizar en 1804 al país, el cual asumió su nombre indígena de Haití. Bloqueado este por varias metrópolis, ve arruinada sus industrias, y Cuba pasa a ocupar su papel de colonia más rica del mundo, lo que implicará multiplicar sus plantaciones sobre todo de caña de azúcar e incrementar la mano de obra esclava. Precisamente este último hecho impidió que la oligarquía cubana se sumara a la onda independentista que sacudió a la América española continental a partir de 1810, pues tal oligarquía temía que sumarse a la lucha por la independencia desembocara en sucesos como los de Haití. A la contradicción metrópoli/colonia sobreponía la de esclavistas/esclavos. Tales contradicciones recorren el siglo XIX cubano, y se expresan también en su literatura, la cual en dicho siglo adquiere particular relieve. Sin querer forzar la mano, lo mejor de la valiosa literatura cubana de aquel siglo, con las excepciones de rigor, está recorrida por esas tensiones, y vocada a la independencia y la extinción de la esclavitud. Sus dos primeras grandes figuras literarias, el pensador y ensayista Félix Varela y el poeta José María Heredia, optan por la independencia, imposible entonces para la clase a que pertenecían, y mueren en el destierro. Los poetas Plácido y Juan Clemente Zenea serán fusilados por los colonialistas españoles. La cuestión de la esclavitud (que en Cuba sólo fue abolida oficialmente en 1886) se manifiesta en obras como las novelas Sab (1841), de Gertrudis Gómez de Avellaneda20, y Cecilia Valdés (1839 y 1862), de Cirilo Villaverde. Al ir a finalizar el siglo XIX, los escritores cubanos de primer orden muy poco, si algo, debían a la 136 rivista dell’ Arte la literatura española de la época, en plena decadencia. Sobre tal literatura dijeron dos autores de una reciente historia de España: «Sin pena ni gloria para las letras transcurre el siglo [XIX]»21, a pesar de Larra, Bécquer y Pérez Galdós. José Martí, cuya obra estuvo tan nutrida no sólo de literaturas extranjeras, sino de lo mejor de los clásicos de su idioma, había escrito que «los pueblos de habla española nada, que no sea manjar rehervido, reciben de España»22. Y Marcelino Menéndez y Pelayo apuntó que «el espíritu general de los literatos y de los hombres de ciencia en Cuba ha solido ser sistemáticamente hostil a España y manifestarse francamente como tal»23. No en vano Cuba mantuvo durante casi treinta años, entre 1868 y 1898, una guerra para independizarse de España (y en su última etapa también para frenar al entonces naciente imperialismo estadunidense), que al cabo perdieron ambos contendientes, pues en 1898 los Estados Unidos intervinieron pro domo sua en dicha guerra y se quedaron con Cuba, primero como tierra ocupada, y después, hasta 1958, convertida en protectorado o neocolonia. Cuba salió maltrecha de la contienda, lo que se puso de manifiesto en su pobre vida cultural en las primeras décadas del siglo XX. Pero en el caso de España, entre lo que se dio en llamar generación del 98 y la Guerra Civil el país vio un renacimiento cultural que influyó positivamente en Cuba. Pensadores y ensayistas como Unamuno y Ortega y Gasset, poetas como Juan Ramón Jiménez y los integrantes de la generación de 1927 alimentaron la creación literaria cubana, como se puso de manifiesto en autores que se nuclearon en torno a publicaciones como Revista de Avance (1927-1930), en la que no colaboraron ni Dulce María Loynaz ni Nicolás Guillén, y Orígenes (1944-1956). Pero tras el fin desdichado de aquella Guerra Civil, el régimen impuesto en España apagó esa relación, que incluso después de la muerte de Franco no ha vuelto a tener intensidad. Añadiré que no es indiferente el idioma empleado por los escritores cubanos. Cuando a principios del siglo XX, en España, gente mediocre le echó en cara a Rubén Darío que era un «meteco», el gran poeta nicaragüense que inició la nueva poesía en español replicó diciendo que era «ciudadano de la lengua»24. Eso somos los que urdimos fantasías y realidades otras en nuestro idioma, el cual hemos venido forjando en común, durante más de medio milenio, en ambas márgenes del Atlántico. Pero tampoco es cuestión de aceptar la reductio ad absurdum propuesta por Octavio Paz al decir: «No hay una literatura peruana, argentina o cubana; tampoco hay una literatura española, al menos desde el siglo XVI. No se clasifica a los 137 la rivista dell’ Arte escritores por su nacionalidad o su lugar de nacimiento, sino por su lenguaje»25. Al aportar esta cita, Claudio Guillén añadió: «La lengua dista mucho de ser suficiente en bastantes casos. Una pluralidad de literaturas pueden compartir perfectamente un mismo idioma y sin embargo considerarse a sí mismas como específicas y nacionales» (pp. 300-301). Quizá este sea buen momento para recordar que hoy de cada diez hablantes del español, nueve lo hacemos en América. Un fenómeno similar se da en cuanto al inglés y el portugués elaborados en tierras americanas. Por otra parte, algunos de los escritores cubanos que viven fuera del país se valen de otros idiomas, en particular el inglés. Queda por ver si seguirán siendo escritores cubanos o si se integrarán a otras literaturas, aun cuando los temas puedan ser cubanos. Sobre este y otros puntos, véase. el libro Memorias recobradas. Introducción al discurso literario de la diáspora. Selección, prólogo y notas de Ambrosio Fornet26. Hablaré ahora desde la perspectiva hispanoamericana. Sería de desear que este adjetivo hubiera sido asumido con el significado con que lo usó Pedro Henríquez Ureña, para quien, siendo Hispania, al igual que Iberia, el nombre de toda la península occidental de Europa (es decir, de España y Portugal), lo «hispanoamericano» abarcaba también al Brasil. Con ese criterio publicó en 1945 el libro fundador Literary Currents in Hispanic America27. Aunque sin conservar el sentido del sintagma propuesto por Henríquez Ureña, en general no aceptado, las literaturas americanas en español y en portugués (e incluso algo las caribeñas en francés e inglés) fueron estudiadas en la obra aparecida en Brasil, entre 1993 y 1995, América Latina: Palavra, Literatura e Cultura28, obra que, según su organizadora, Ana Pizarro, «comenzó proyectándose como una Historia de la Literatura Latinoamericana en el marco de la Asociación Internacional de Literatura Comparada», pero que «todas las dificultades con que se lleva a cabo la investigación de largo aliento en la cultura del continente» transformaron «en tres volúmenes de ensayos dispuestos en orden cronológico» (I, p. 13). Tales ensayos están en español unos y en portugués otros. En 2004, y en inglés, apareció la obra, también en tres tomos y con muchos colaboradores, editada por Mario J. Valdés y Djelal Kadir, Literary Cultures of Latin America. A Comparative History29, concebida, según Valdés, «[b]eyond Literary History» (I, p. XVII). En la introducción al primero de aquellos tomos, explicó Luisa Campuzano que esta historia incorpora la literatura del Brasil, las diferentes expresiones de las culturas amerindias y afrolatinoamericanas, la literatura de las comunidades hispánicas en el seno de los Estados Unidos, y las de otras minorías y culturas alternativas, como las obras de escritores judíos, mujeres, gays y lesbianas, pero no incluye explícitamente las culturas de lengua inglesa, francesa y holandesa del la 138 rivista dell’ Arte Caribe. A finales del siglo XVIII, Alejandro de Humboldt escribió: «Los criollos [término que a la sazón implicaba a los considerados blancos] prefieren que se les llame americanos, y desde la paz de Versalles, y especialmente después de 1789, se les oye decir muchas veces con orgullo: “Yo no soy español: soy americano”»30. La conciencia nacional acabaría por conducir, en los países continentales de la América española, a la violenta separación política de España a partir de 1810, mientras en la América portuguesa conocería un proceso evolutivo que también la llevaría a la independencia, en 1822. Según se ha repetido mucho, a la independencia política la acompañará la voluntad de independencia intelectual, que se ha visto encarnada en la silva de Andrés Bello «Alocución a la Poesía», aparecida, como una suerte de editorial, en el tomo primero de la Biblioteca Americana, publicado en Londres en 1823. Ese tomo, dedicado «Al Pueblo Americano» (es decir, de nuestra América), es rigurosamente coetáneo de la Doctrina Monroe. Tal poema programático ha sido comparado con el texto «The American Scholar», que Emerson dio a conocer en 183731. En 1824, la victoriosa batalla de Ayacucho sellará la secesión política de la América española continental. Ya se mencionó el caso singular de Cuba, que por las razones aludidas permanecerá como colonia española durante casi todo el siglo XIX. Pero se sentirá en muchos aspectos afín a la América independiente. Un valioso ejemplo de ello lo ofrecen las primeras antologías de la poesía de la América española, estudiadas por Rosalba Campra32. Si la inicial, América poética, que comienza con la silva de Bello, fue compilada por el argentino Juan María Gutiérrez e impresa entre 1846 y 1847 en Valparaíso, la segunda, con el mismo título, tuvo como uno de sus compiladores a Rafael María de Mendive (quien sería maestro de Martí), y sus dos tomos se publicaron en La Habana entre 1854 y 1856. En cuanto a los autores mismos, Heredia ha sido equiparado a Bello y Olmedo por quienes lo consideraron neoclásico, y tenido como iniciador del romanticismo americano por otros. Lo más cercano a la verdad parece ser que arrancó como neoclásico, y luego dio entrada en su poesía a elementos incuestionablemente románticos. En las últimas décadas del siglo XIX comenzó a manifestarse el modernismo hispanoamericano (representado en lo que respecta a Cuba por escritores como José Martí y Julián del Casal), cuya influencia vivificó la literatura de España En el siglo XX y lo que va del XXI, la literatura cubana es sin duda parte esencial de la compleja literatura hispanoamericana. Al producirse, a raíz del triunfo de la revolución cubana en 1959, la amplia recepción mundial de la narrativa hispanoamericana a la que varios han dado el lamentable nombre de boom, entre sus representantes o beneficiarios (al margen de los criterios de cada cual sobre el 139 la rivista dell’ Arte acontecimiento histórico que hizo volver los ojos del planeta sobre nuestra América) se hallarán cubanos como Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy, Reynaldo Arenas. La estrecha relación entre la literatura cubana y la del resto de Hispanoamérica es de interliterariedad, de acuerdo con el término propuesto por Dýonisz Durisin, «resultado», según Franca Sinopoli, «de la relación recíproca entre las comunidades interliterarias, por ejemplo las de las literaturas europeas o las de las literaturas latinoamericanas»33. ¿Cabe hablar de una literatura americana en conjunto? Por supuesto que es dable comparar, a menudo con provecho, obras de nuestra América con otras de los Estados Unidos y Canadá. Así procedieron, entre varios, José Ballón en Autonomía cultural de América: Emerson y Martí34, Bell Gale Chevigny y Gari Laguardia al editar el volumen colectivo Reinventing the Americas. Comparative Studies of Literature of the United States and Spanish America35, volumen en que hay contribuciones de los cubanos Pablo Armando Fernández y Edmundo Desnoes, y Vera Kutzinski en Against the American Grain: Myth and History in William Carlos Williams, Jay Wright, and Nicolás Guillén36. Pero tales libros no dan por sentado que traten obras de una misma literatura. En cambio, Gustavo Pérez Firmat se interroga desde el título de su compilación: Do the Americas Have a Common Literature?37 En la introducción, Pérez Firmat menciona que hemos dado una repuesta negativa a la pregunta el filósofo mexicano Edmundo O’Gorman y yo. Y añade: «Fernández Retamar is certainly correct in pointing to the huge historical and political differences between the United States and Spanish America […] even so, historical position is not always identical to cultural position, and the essays in this volume tend to demonstrate that even when the comparison involves authors and texts from the First and Third Worlds it is possible to find substantial common ground». Pero a continuación el agudo Pérez Firmat añade: «Having said this much, I should point out that the book’s title is not intended as a question to which its contents provide an answer. In fact, the essays themselves raise questions that suggest how difficult it would be to answer the title, both because of the scope of the question and because of the terms in which it is couched» (p. 5). No sé qué pensará ahora, diecisiete años después de publicadas, el autor de esas líneas. Por mi parte, me gustaría que a la pregunta de marras se la pudiera responder afirmativamente, pero de momento lo sigo viendo difícil. Y me parece interesante que de los trece ensayos incluidos en el volumen, seis tengan que ver con Cuba, donde nació Pérez Firmat. 140 la rivista dell’ Arte Aunque sin mencionar siquiera el libro editado por este, Earle E. Fitz parece hacerle eco, con un abanico más vasto, en Rediscovering the New World. Inter-American Literature in a Comparative Context38, en cuya introducción el autor afirma: «My purpose in writing this book was to show that, given the unique set of historical circumstances that governed the European discovery, conquest and settlement of the New World, one could approach English and French Canada, the United States, Spanish America, and Brazil as constituting a community of literary cultures related to each other by virtue of their origins, their sundry interrelationships, and their socio-political, artistic, and intellectual evolutions. Their very real differences notwithstanding, the nations of the New World share enough of a common history that they can legitimately be studied as a unit […]» (p. xi). ¿Es cierto que las naciones del Nuevo Mundo comparten lo bastante una historia común como para que legítimamente puedan ser estudiadas como una unidad? No estoy nada seguro de esto. Pero me llama la atención que en 1993 alguien tan confiable como Mary Louise Pratt haya publicado el ensayo «La liberación de los márgenes: literaturas canadiense y latinoamericana en el contexto de la dependencia»39. Para esta autora, «[e]l tema general que anima este ensayo ha sido obsesivo tanto en la crítica canadiense como en la latinoamericana desde los comienzos de ambas. Se trata, por una parte, del proyecto de formular los vínculos existentes entre esas literaturas, y entre sus historias, como sociedades dependientes coloniales y neocoloniales, por la otra» (p. 25). Pratt pasa luego a señalar semejanzas entre obras de las dos literaturas, en lo esencial glosando un trabajo de Jean Franco40, y menciona novelas de Carpentier y Lezama. Sin embargo, es evidente que hoy no se podría presentar la literatura de los Estados Unidos como propia de una sociedad dependiente colonial o neocolonial. Ignoro qué nuevos aportes se han hecho últimamente a esta cuestión sin duda relevante. Me ocuparé por último de la perspectiva caribeña. Ya hace décadas se ha reconocido la importancia en varios órdenes de la cuenca del Caribe, la región americana a la que llegó Colón por primera vez y donde comenzó la colonización española. Y en tal región, escasa en metales preciosos, pronto fue establecido el sistema de plantaciones, vinculado especialmente a la industria azucarera, sistema que implicó la esclavitud sobre todo de millones de criaturas descuajadas de África, y luego, con otras denominaciones, también de Asia. En esas empresas, modernas y terribles, participaron varias metrópolis europeas que provocarían la pluralidad del Caribe ostensible en lo idiomático y en distintas realidades políticas. El primer país del área en obtener su independencia fue el muy caribeño Haití, en 1804. Otros, en cambio, todavía son colonias, con un nombre u otro, de metrópolis como Francia, Holanda y los Estados Unidos, y el Caribe inglés 141 la rivista dell’ Arte empezó a obtener su independencia en 1962. En el caso de Cuba, el temor experimentado por su oligarquía de ver repetirse en la Isla los sucesos haitianos la sustrajo a las luchas libertadoras iniciadas en la América española continental a partir de 1810, como ya se mencionó, y ello hizo que en 1895, al iniciarse la segunda etapa de su demorada guerra de independencia contra España, las clases al frente de esa etapa fueran ya de extracción popular, y las metas desbordaran los fines anticolonialistas, para ser también antimperialistas y de justicias social, según el proyecto radical de José Martí. La intervención estadunidense en aquella guerra obligó a posponer la realización de tales metas, que al cabo se alcanzaron a partir de 1959, y llevarían al país, violentamente hostigado por los gobernantes estadunidenses, a iniciar la construcción del socialismo. El Caribe incluye, pues, junto a colonias de las viejas metrópolis y de una relativamente nueva, al primer país libre de nuestra América (y el primero en el mundo en abolir la esclavitud), y a su primer país socialista. En el Caribe se fusionan etnias y creencias de orígenes europeos, africanos y asiáticos, se hablan cuatro lenguas de origen europeo, varios creoles y probablemente lo que los lingüistas llaman un sabir: el papiamento. Pero más allá de las cuestiones que lo diferencian, se encuentran las que lo hacen una original unidad, con planteos desafiantes e intensa música, que más de uno ha considerado anuncio del porvenir humano. Se tardó en ver al Caribe como una unidad o subunidad. Quizá la primera vez que ello ocurrió fue en el libro ameno y superficial de Germán Arciniegas Biografía del Caribe, que vio la luz en 194541. Hubo que esperar a 1970 para que se ofrecieran serias visiones de conjunto, las cuales fueron hechura de dos importantes figuras de la región, quienes publicaron el mismo año sendas obras casi homónimas: Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial42; y Eric Williams, From Columbus to Castro. The History of the Caribbean 1492-196943. Siempre he creído que tales títulos comunes son deudores del epílogo a una segunda edición (la primera fue de 1938) del gran libro de C.L.R. James The Black Jacobins. Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution44. Tal epílogo se llama «From Toussaint L’Ouverture to Fidel Castro». Si hubo que esperar tanto para contar con aceptables historias del Caribe, no es extraño que hubiera que esperar todavía más para ver aparecer una historia conjunta de la literatura de la zona. Ella es A History of Ltterature in the Caribbean, cuyos tres volúmenes fueron publicados en inglés, entre 1994 y 199745, la 142 rivista dell’ Arte editados por A. James Arnold, como parte de A Comparative History of Literatures in European Languages que auspicia la Asociación Internacional de Literatura Comparada. En el primer tomo se estudian las literaturas de lenguas española (y por tanto la cubana) y francesa; en el segundo, las literaturas de lenguas inglesa y holandesa: en los tres últimos casos, con los correspondientes creoles; el tercer tomo se consagra a «Cross-Cultural Studies». En la Cuba del siglo XIX no se solía hablar aún del Caribe, sino de las Antillas. Ellas fueron preocupación cardinal de José. Martí, quien se sintió atraído, junto con los puertorriqueños Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos y el haitiano Antenor Firmin, por la idea de: una confederación antillana46. Entre los muchos ejemplos del interés que para Martí tuvieron las Antillas, a las que llamó «las islas dolorosas del mar»47, se encuentra la última carta suya a su fraterno amigo mexicano Manuel A. Mercado, que fue hecha la víspera de morir combatiendo y ha sido considerada su testamento político: «ya estoy todos los días», escribió allí, «en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber […] de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestra tierras de América»48. En el siglo XX cubano nos acercaron a preocupaciones del área muchos estudios de Fernando Ortiz, la obra de Ramiro Guerra Azúcar y población en las Antillas (1927), y en lo estrictamente literario el libro de poemas de Nicolás Guillén West Indies Ltd., de 1934. Diez años después de publicado este, Guillén estuvo entre los editores de la cubana Gaceta del Caribe. Revista Mensual de Cultura, en cuyo primer editorial se leía: «Si se nos pidiera justificar el título, diríamos que arrancando de lo hondo de esta isla nuestra, centro geográfico del mar de las Antillas, queremos dar el latido pleno del archipiélago dentro del ámbito continental, pero con una alerta conciencia de universalidad. Por otra parte, huelga declarar que no pretendemos imponer determinado “meridiano”, y que sólo nos guía el afán de servir a la cultura en esta parte del mapa con un limpio espíritu solidario hacia los pueblos con los que estamos hermanados en el Caribe.» En 1948, Guillén dio a conocer su Elegía a Jacques Roumain, en el cielo de Haití. Y en 1949 Alejo Carpentier, a partir de un viaje revelador a Haití, publicó El reino de este mundo, e inició así un ciclo de novelas cuyo centro temático es el Caribe. la 143 rivista dell’ Arte Aunque en 1960 yo conocía ya esas obras y me consideraba latinoamericano, mi amistad, anudada ese año en París, con el escritor martiniqueño Édouard Glissant empezó a hacerme conciente de mi condición, también, de caribeño. Ambos proyectamos entonces publicar en París una revista con textos latinoamericanos para la que solicité y obtuve el respaldo de Alejo Carpentier. Pero el proyecto, por diversas causas, no se hizo realidad. Cuando mucho después, en 1975, dediqué un número de la revista que dirigía y dirijo, Casa de las Américas, a Las Antillas de Lengua Inglesa49, objeté en un largo editorial el empleo de West Indies, consagración de un error geográfico, para nombrar al Caribe anglófono, y sugerí que bastaría el sintagma «América Latina», más allá de lo que originalmente significara, para abarcar todos nuestros países. Criterio similar mantuve cuando, en el VIII Congreso de la Asociación Internacional de Literatura Comparada, que se celebró en 1976 en Budapest, leí en francés la ponencia «La contribución de la literatura de la América Latina a la literatura universal en el siglo XX» 50 , cuyo tema y cuyo título me fueron sugeridos por los organizadores del Congreso. Ese año se incluiría en el Premio Literario Casa de las Américas la literatura caribeña anglófona, y en 1979 la literatura caribeña francófona, más sus correspondientes creoles. También ese año 1979 fue creado por la Casa de las Américas su Centro de Estudios del Caribe (que a partir de 1981 contaría con su publicación periódica, Anales del Caribe), y se realizó en Cuba, después de haberlo hecho en Guyana y Jamaica, el III Carifesta, el Festival de las Artes del Caribe, como parte del cual tuvo lugar en la Casa de las Américas un. simposio sobre la identidad cultural caribeña cuyos materiales fueron recogidos en la revista Casa de las Américas51. Que todavía no estaba en uso la expresión «América Latina y el Caribe» lo revela, además, que el útil Panorama histórico-literario de nuestra América (tomo I 1900-1943, tomo II 1944-1970), editado por la Casa de las Américas en 1982, llevara tal título, de clara raíz martiana, para dar a entender que el panorama englobaba a todas las regiones de nuestra América. Incluso este mismo año 2007 hemos contemplado el cambio de nombre de la más importante de las colecciones que publica la Casa, la Colección Literatura Latinoamericana, que ha pasado a ser Colección Literatura Latinoamericana y Caribeña al incluir Los placeres del exilio, de George Lamming, quien ya había visto publicada en dicha colección en 1979, cuando sólo se llamaba Literatura Latinoamericana, su primera novela, En el castillo de mi piel (1953). En aquel simposio celebrado en 1979 en la Casa de las Américas, dijo Victor Stafford Reid: «Nosotros, los del Caribe, somos hoy día el último conglomerado importante de cultura en llamar la atención»52. En efecto, en apreciable medida, estamos ante una literatura emergente. Al frente de The Oxford Book of Caribbean la 144 rivista dell’ Arte Verse, aparecido en 2005, se afirma: «A hundred years ago it would have been inconceivable that the Caribbean, for centuries the site of the worst atrocities of human history, would produce what is arguably the most life-affirming and spiritually uplifting body of poetry of the twentieth century»53. Pero los antologadores parecen tener insuficiente conocimiento de la poesía de lengua española. En todo caso, admiten que «the culture of, say, Cuba differs in fundamental ways from that of Haiti or Jamaica», y que «the “English language” poetry of the region forms the core of this collection» (p. xx). Por eso pueden decir: «Caribbean poetry has grown in both volume and stature through the twentieth century from something that hardly existed —at least as far as the literary mainstream was concerned— into a body of word-culture […] that is generally acknowledged to be among the richest, most accessible, and yet technically adventurous libraries of contemporary verse. […] // Indeed, West Indian poetry is essentially a twentieth-century phenomenon […]» [p. xvii]. No es dable aceptar que la poesía cubana sea creación del siglo XX. De los románticos José María Heredia y Gertrudis Gómez de Avellaneda a los modernistas José Martí y Julián del Casal, la suya ya era poesía auténtica y mayor en el siglo XIX. En cuanto al siglo XX, son graves las ausencias, en la antología de Oxford, de poetas como Dulce María Loynaz, Eugenio Florit, Emilio Ballagas, todos los integrantes del Grupo Orígenes y en particular Lezama, cuya filiación caribeña ya había sido puesta de relieve por David Huerta en una valiosa antología poética de 198854, donde Huerta lo acercó, al más alto nivel, a Saint-John Perse, Aimé Césaire y Derek Walcott. La de Cuba, debemos concluir, es una literatura caribeña sin dejar de ser hispanoamericana, así como es una literatura de lengua española cuando ya no es una literatura de España. De Edward Said son estas conocidas palabras: «I suggest that we look […] at what comparative literature was, in vision and in practice; ironically […], the study of “comparative literature” originated in the period of high European imperialism and is irrecusably linked to it»55. Parece difícil negarle validez a la observación anterior, de alguien a quien tanto debemos, y que fue, entre muchas cosas importantes, eminente profesor de literatura comparada. Pero Armando Gnisci, en «La literatura comparada como disciplina de descolonización»56, planteó que para muchos la literatura comparada es una disciplina en fase de extinción, si no ya extinta; y al preguntarse con qué se propone sustituirla, mencionó dos opciones: o que ella fuera absorbida por una teoría de la literatura concebida como la disciplina central y más potente del estudio literario, o que la literatura comparada fuera superada por los estudios sobre la traducción (Translation Studies), los estudios sobre la descolonización cultural (Post-colonial Theory), los estudios 145 la rivista dell’ Arte interculturales (Intercultural Studies) y los estudios feministas (Gender o Women’s Studies). A continuación, Gnisci rechaza la primera de esas opciones, la cual, según él, expresa una posición típicamente euronorteamericanocéntrica que propone una vez más la vieja concepción imperialista y jerárquica de la ciencia «occidental»; y añade que la segunda opción, articulada y plural, proviene, en cambio, de los desarrollos concretos del estudio literario con una perspectiva verdaderamente mundial, no sólo euroestadunidense. Además, los Translation Studies, la Post-colonial Theory, los Intercultural Studies y los Women’s Studies no se presentan como alternativos o indiferentes entre sí, sino que parecen marchar juntos en la misma dirección, siendo la literatura comparada la forma confederada de conocimiento y de enseñanza a través de la cual estos problemas y estos campos de indagación pueden ser considerados en conjunto, dentro de un coloquio verdaderamente «universal» y como imagen del futuro que toma en cuenta a todas las culturas. Si la literatura comparada, concluye, es un modo de comprender, estudiar y ejercer la descolonización cultural por los países que se han descolonizado del Occidente, para nosotros, estudiosos europeos [recuérdese que Gnisci es italiano], ella representa la forma de pensamiento, de autocrítica y de educación, en otras palabras: la disciplina para descolonizarnos de nosotros mismos. He dedicado estas páginas a intentar considerar, desde distintas perspectivas, el perfil de la literatura de un pequeño país, no necesariamente la pequeña literatura de un país, para no decir nada de «una literatura menor», en el sentido rebelde que a esta última expresión le dieron, al hablar de Kafka, Deleuze y Guattari57. Heráclito nos invitó hace milenios: «Entrad con confianza, porque aquí también los dioses están presentes». * Conferencia inaugural del XVIII Congreso de la Asociación Internacional de Literatura Comparada, que se realizó en Río de Janeiro entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2007. 1 Revista Brasileira de Literatura Comparada, 3, 1996. 2 GODZICH WLAD, Teoría literaria y crítica de la cultura, trad. de Josep-Vicent Gavaldá, Madrid, Frónesis, Cátedra, Universitat de València, 1998, p. 322. 3 Ponencia presentada en coloquio internacional realizado en 2002 en Valparaíso sobre Orientaciones de la crítica literaria y cultural. BARRERA ENDERLE VÍCTOR, Ensayos sobre literatura y cultura latinoamericanas, Santiago de Chile, Miscelánea Textual, 2002. 146 4 la rivista dell’ Arte BOURDIEU PIERRE y WACQUANT LOÏC, “La nouvelle vulgate planétaire”, Le Monde Diplomatique, mayo de 2000, pp. 67. 5 Cit. en GNISCI ARMANDO, “Una historia diferente”, Casa de las Américas, 219, abril-junio de 2002, p. 35. 6 En Estudios de literatura hispanoamericana, La Habana, Imprenta Úcar García, 1950. 7 La Habana, Casa de las Américas, 1983. 8 Tres tomos, La Habana, Consejo Nacional de Cultura, 1965. 9 Madrid, Verbum, 2002. 10 LIENHARD MARTIN, La voz y su huella. Escritura y conflicto étnico-social (1492-1988), La Habana, Casa de las Américas, 1990; BROTHERSTON GORDON, La América indígena en su literatura: los libros del cuarto mundo, trad. de Teresa Ortega Guerrero y Mónica Utrilla, palabras liminares de Miguel León Portilla, México, Fondo de Cultura Económica, 1997. 11 Perfil de Indoamérica de nuestro tiempo. Antología 1837-1962 (1968), La Habana, Ed. Ciencias Sociales, 1972, p. 9. 12 Cit. en RETAMAR ROBERTO FERNÁNDEZ, “Introducción a la literatura cubana”, Temas. Cultura Ideología Sociedad, 1617, octubre de 1998-junio de 1999. Número extraordinario. Nueva época, p. 221. 13 “Cantos negros anónimos”, en Antología, cit., III, pp.171-187. 14 Cf. CORNEJO POLAR ANTONIO, “Mestizaje, transculturación, heterogeneidad” y mi comentario a dicho texto en Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro de homenaje a Antonio Cornejo Polar. José Antonio Mazzotti y U. Juan Zevallos Aguilar, coordinadores, Ann Arbor, Asociación Internacional de Peruanistas, 1996, pp. 47-56. Cf. también, de CORNEJO POLAR ANTONIO, “Mestizaje e hibridez: Los riesgos de las metáforas”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 47, 1er. semestre de 1998. 15 REGAZZONI SUSSANA (ed.), Alma Cubana: Transculturación, Mestizaje e Hibridismo. The Cuban Spirit: Transculturation, Mestizaje and Hybridism, Madrid-Frankfurt am Mein, Iberoamericana-Vervuert, 2006. 16 CASTRO BELEN, “La Arcadia caribe de Espejo de paciencia: ninfas, sátiros y desculturación”, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 50, 2do. Semestre de 1999, p. 139. 17 En Certidumbre de América, 2a. ed. aumentada, Madrid, Gredos, 1971. 18 CARPENTIER ALEJO, Concierto barroco, México, Siglo XXI, 1974, p. 20. Carpentier insiste en Espejo de paciencia entre las pp. 20 y 26. 19 Prólogo de Rafael Montoro, La Habana, Imprenta de A. Álvarez, 1890. 20 Cf. ARAÚJO NARA, “Raza y género en Sab”, Casa de las Américas, 190, enero-marzo de 1993; y CAMPUZANO LUISA, “Sab: la novela y el prefacio”, Alma cubana…, cit.. 21 GARCÍA DE CORTÁZAR FERNANDO y GONZÁLEZ VESGAS JOSÉ MANUEL, Breve historia de España, Madrid, Alianza, 1994, p. 518. 22 MARTÍ JOSÉ, “Francisco Sellén”, Obras completas, 2a. ed., La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, t. 5, p. 189. 23 Cit. en RETAMAR ROBERTO FERNÁNDEZ, Introducción…, cit., pp. 226-227. 24 DARÍO RUBÉN, “Dilucidaciones”, en El canto errante (1907), Poesías, prólogo de Ángel Rama, edición de Ernesto Mejía Sánchez, cronología de Julio Valle-Castillo, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977, p. 301. 25 Cit. en GUILLÉN CLAUDIO, Múltiples moradas. Ensayo de Literatura Comparada, 2ª ed., Barcelona, Tusquets, 2007, p. 300. 26 Santa Clara, Cuba, Ediciones Capiro, 2000. 27 Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1945. 28 Sâo Paulo, Memorial; Campinas, UNICAMP, 1993-1995. 29 Nueva York, Oxford University Press, 2004. 30 Cit. en ARROM JOSÉ JUAN, Certidumbre de América, cit., p. 22. 31 UREÑA PEDRO HENRÍQUEZ, Op. cit., p. 100. 32 “Las antologías hispanoamericanas del siglo XIX. Proyecto literario y proyecto político”, Casa de las Américas, 162, mayojunio de 1987. 33 SINOPOLI FRANCA, “La historia comparada de la literatura”, en Introducción a la literatura comparada. Al cuidado de Armando Gnisci, trad. de Luigi Giuliani, Barcelona, Crítica, 2002, p. 271. 34 Madrid, Pliegos, 1986. 35 Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 36 Baltimore, John Hopkins University Press, 1987. 37 Durham y Londres, Duke University Press, 1990. 38 Iowa, Iowa University Press, 1991. 39 “La liberación de los márgenes: literaturas canadiense y latinoamericana en el contexto de la dependencia”, Casa de las Américas, 190, enero-marzo de 1993. 40 “La parodie, le grotesque et le carnavalesque: quelques conceptions du personnage dans le roman latino-américain”, en Idéologies, littérature et société en Amérique latine [...], Bruselas, Editions de l’Université de Bruxelles, 1975. 147 41 la rivista dell’ Arte Buenos Aires, Sudamericana, 1945. Madrid, Alfaguara, 1970. 43 Londres, André Deutsch Ltd., 1970. 44 2ª ed., revisada, Nueva York, Vintage Books, 1963. 45 Amsterdam, Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1994-1997. 46 Cf. FIRMIN ANTENOR, “Betances, Martí y el proyecto de Confederación Antillana”, Casa de las Américas, 233, octubrediciembre de 2003, pp. 89-91. 47 MARTÍ JOSÉ, “Nuestra América”, Obras completas, cit., t. 6, p. 23. 48 MARTÍ JOSÉ, Obras completas, cit., t. 20, p. 161. 49 Casa de las Américas, 91, julio-agosto de 1975. 50 Incluida en Para una teoría de la literatura hispanoamericana, primera edición completa, Santafé de Bogotá, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1995. 51 Casa de las Américas, 118, enero-febrero de 1980. 52 STAFFORD REID VICTOR, “Identidad cultural del Caribe”, Casa de las Américas, 118, cit., p. 48. 53 The Oxford Book of Caribbean Verse. Editado por Stewart Brown y Mark McWatt, Nueva York, Oxford University Press, 2005, p. xvii. 54 LEZAMA LIMA JOSÉ, Muerte de Narciso. Antología poética. Selección y prólogo de David Huerta, México, Era, 1988, p. 26. 55 SAID EDWARD, Culture and Imperialism, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1993, p. 43. 56 Casa de las Américas, 208, julio-septiembre de 1997. 57 DELEUZE GILLES [y] GUATTARI FÉLIX, Kafka. Por una literatura menor, trad. de Jorge Aguilar Mora, México, Era, 1978. 42 la 148 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Yue Daiyun - Peking University Development and Problems of Chinese Comparative Literature For the China Special Issue, Revue de Littérature Comparée* L'articolo propone un'analisi dello sviluppo degli studi cinesi di Letteratura Comparata. Dopo aver delineato una breve storia della disciplina in Cina, l'autrice discute una serie di nodi teorici fondamentali al fine di meglio individuare l'ampio campo d'azione della ricerca comparatistica. Secondo l'autrice, nel periodo di transizione senza precedenti che noi tutti stiamo vivendo, la Letteratura Comparata è chiamata a giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di un mondo ideale nel quale le diverse culture possano coesistere e arricchirsi dal reciproco scambio. Le singole culture nazionali, infatti, sono destinate inevitabilmente ad aprire i propri confini e a svilupparsi grazie all’incontro e all'interazione con le altre culture. Modern Chinese literature and Comparative Literature were both born in the early 20th century. Lu Xun, the founder of modern Chinese literature, said novel literature generates when «one priority is to examine oneself and meanwhile to know others; consciousness emerges from comprehensive comparison». It aims at «externally keeping up with the ideological trend of the world and inherently maintaining the intrinsic tradition; acquiring what belongs to today to restore ancient ways and establishing another new school» (Wenhua Pianzhi Lun, 1907). This marks the end of the closed state of Chinese literature, meaning that China's new literature began to consciously involve into its dialogue with World Literature along the direction of Comparative Literature. Comparative Literature was established in China as a formal university course between 1929 and 1932. At that time, I. A. Richards, Dean of the English Department in Cambridge University, opened two courses, “Comparative Literature” and “Literary Criticism” at Tsinghua University. These lectures were later compiled into a book, Comparative Literature, by his assistant P. D. Jemeson. Other courses opened at that time were “Chinese and Western Poetry Comparison”, “Renaissance Literature”, “Comparative Study on 149 la rivista dell’ Arte Various Texts of Buddhist Classics”, “Study on Indian Stories in Chinese Literature”, “Bibliography of Oriental Studies by Westerners”, “Buddhist Translated Literature”, etc. In 1985, co-sponsored by 36 universities, the Chinese Comparative Literature Association was founded in Shenzhen. In 1998, the State Board of Education approved “Comparative Literature and World Literature” as a secondary discipline under Chinese Linguistics and Literature. Since then, Comparative Literature has been greatly developed in China and has become a pervasive and regularly taught subject. Since China’s reform and opening up, Chinese Comparative Literature circles have discussed a number of major issues and arrived at generally consistent conclusions. For instance, we discussed the relationship between Comparative and World Literature. It was generally believed that once a point on the coordinate system, formed by the time-axis of ancient-contemporary literature and the space-axis of Chinese-foreign literature, was linked to a certain reader, part of World Literature was composed. No one can master all of World Literature and no one can be referred to as expert of World Literature. Comparative Literature is different, because it is a cross-cultural and interdisciplinary study of literature. In fact, the cultural context of discussants can not be detached from discussions of World Literature, since each moment of history sets out from a certain subject and precipitates the past, responds to the present and creates the future. The core of Comparative Literature lies on the study of intersubjectivity, interliterature, interculturality and interlanguage. Therefore, Comparative Literature provides theories and a horizon for World Literature studies, while World Literature offers resources and a foundation for Comparative Literature studies. There used to be disputes over whether interdisciplinary literary studies would turn the discipline of Comparative Literature into a boundless hunting ground. However, just as Prof. Yang Zhouhan writes in his preface for Interdisciplinary Comparative Literature Studies (1989), «We need an ‘interdisciplinary’ research horizon that oversteps not only the boundaries of nations and languages, but also the boundary of disciplines in order to study literature under a broader cultural background». In fact, China already has a strong tradition in this respect, where issues such as the isogenesis of poetry and painting, symbiosis of ritual, music and dance etc., have long served as topics. Today, when cultures inevitably encounter each other, we believe that this process of cultural encounters is neither persuasion, assimilation and fusion, nor conquest and merger, but rather a process of renewal through “generative dialogues”, mutual recognition, verification and complementation under various circumstances. This process is first founded when a culture realizes how it might benefit from other cultures, both in cognition and aesthetics, and makes choices at liberty. It results not in convergence, but in a joint upgrade, creating new qualities and differences, similar to two circles tangent at a certain point that 150 la rivista dell’ Arte still run on their own tracks. When the world entered the 21st century, in addition to having significant progress in conventional research of this discipline, such as in the relationship between Chinese and foreign literature, image studies, theme studies, genre studies, etc., Chinese Comparative Literature has also made major breakthroughs in the following areas. 1. New Progress in Comparative Poetics Comparative Poetics has changed radically in the post-modern world. The original philosophy system has been replaced with interdisciplinary and intercultural theories, which are features of Edward Said’s “traveling theory”. New Comparative Poetics highlights the theoretical and aesthetic features of commonality, universality and cosmopolitism, presented by original, country and national poetics. Meanwhile, in the features of commonality, universality and cosmopolitism, it pursues the differentiation, particularity and national characteristics of diverse poetics, realizes the hermeneutic fusion of horizons, and then creates poetic concepts that explain and circulate. Finally, it fits into the diversified and liquid trend of World Poetics. This is the “third poetics” that is emerging from the confluence and integration of Chinese and foreign poetics. Poetics of this kind have turned into cutting-edge theories and have converged local and international poetics. Inevitably mixed with elements of interfusion, misreading, confluence, and innovation, it is neither from one original foreign poetics nor from indigenous or traditional poetics, but instead is a type of multiplex new poetics built on the basis of inter-material, inter-aesthetics and interdisciplinary. This type of new poetics is generated from interaction, absorbing foreign poetics widely and maintaining local features as its mainstay. 2. New Horizon of Literary Anthropology and Comparative Study of Domestic Minority Literature Literary anthropology and comparative study of domestic minority literature have ripened into core aspects of current Chinese Comparative Literature. Comparatists engaged in this area are aware that Western academic-style literature education, which eclipses and constrains the growth of local knowledge, has brought about three abuses: text-centrism, Han chauvinism and Central Plains-centrism. They believe that more attention should be paid to living literature, interactive multi-ethnic literature and oral literature, whose cultural role of integrating stories, performances, faith, ritual, props, Thangka, images, medical treatment, aphelxia, carnivals, etiquette and customs, etc. deserves to be brought into full play. In this way, evolution from paradigm merely confined to internal research of literariness and literature to reductive 151 la rivista dell’ Arte study on the cultural context of literature can be accomplished step by step. Our knowledge of how diverse, rich and unique our local heritages are can thus be greatly expanded. The forthcoming book, Courses in Literary Anthropology (Wenxue Renleixue Jiaocheng), is based both on Chinese culture’s internal diversity and the fact that the shaping of Han nationality on the Central Plains cannot break away from the cultural migration, dissemination and amalgamation of surrounding minority groups. It is produced in the pursuit of breaking the stereotypes of binary opposition, such as majority and minority, mainstream and tributaries, orthodox and subsidiary, as well as dominant and complementary. This puts forward a view of Chinese literature that reconstructs literary anthropology, sparking a search for new approaches and new materials by proceeding from the construction of interaction among ethnic groups, beyond the history outlook of Central Plains Empire narration, to reenter the history of human and literature. They conclude that too little has been done to understand China as «a community of multinational coexistence and how many headstreams and shapes her tradition owns». Thus, special emphasis should be laid on the cross-cultural and interdisciplinary comparative study connected to the historical heritage of China as a multinational country. What’s more, the field analysis method, which anthropology employs, should be introduced into Comparative Literature because ethnic writing in modern Chinese and Western contacts should be emphasized and respecting the weak and marginalized groups deserves special acclaim. Strong national support has been given to this field. Following the publishing of History of the Relationship between Southern Minority Literature (2001) and Research on Literary Relations of Chinese Ethnic Groups (2004), large-scale projects, such as “Chinese Minority Literature Database” and Comparison of Literature in Multinational States, are now underway. 3. Research on Chinese Diaspora Literature Overseas Chinese Literature is the world’s largest writing group among immigrant and expatriate literatures. Since the late 1990s, Chinese comparatists have paid attention to such peculiar poetic discourse of Chinese Diaspora literature such as its search for cultural identity, collision and fusion of Chinese cultural awareness and the local, its marginality and cosmopolitism, etc. Since the beginning of the new century, hundreds of books and many academic papers have discussed a train of theoretical issues on its further exploration. For instance, research on its localization, Diaspora, modernity, cosmopolitanism, marginality and interculturality, questions on its cultural poetics and aesthetics, and comparative study on its works written in native and non-native languages. At present, in the field of Chinese Comparative Literature, it is studying the process of how Chinese literature, in different corners of the world and under 152 la rivista dell’ Arte historical contexts, clashes and fuses with the local culture and then derives and grows. In addition, it investigates Chinese culture and Chinese literature in the general background of human culture and world literature. 4. Restoration of Ideas of Literary Translation China has an almost 2000-year history of translation and has lead in the personnel of translators and amount of translations. Literary translation is not only the conversion of text symbols, but also transmission and remodeling of cultural values. Translated literature cannot exist without translators who commit to innovatively representing the message in the text, even to «create the possibility of communicating where communication is impossible», which means to develop his native language where two languages meet. Therefore, translated literature is not the same as foreign literature, and works translated into Chinese should be considered as a necessary and important component of Chinese literature. Since 2001, “Volume of Translated Literature ”, as well as “Volume of Novels” and “Volume of Essays”, etc., has been formally included in 21 Century Chinese Literature Series and its annual publication has accumulated to 7 volumes so far. Monographs like History of Modern Chinese Translated Literature and 20 Century History of Foreign Literature Translation in China have come off the press. Translation studies is gaining independence from conventional foreign language teaching discipline, with 15 institutions of higher learning having formally established it as a major for Master programs. 5. Interdisciplinary Studies of Literature and Religious Studies Interdisciplinary studies of literature and religious studies have also developed. In recent years, international seminars have been held annually in summer to discuss issues of “religious interpretation of literature and culture”, “the problem of publicity in cultural and theological studies”, “theological methods in literary and cultural studies”, “sinology, theology and cultural studies”, as well as “theology and poetics”. The Journal of Christian Culture has issued 19 volumes, including special issues like “theology and poetics”, “poetic and spirituality”, and so on. Multivolume academic journal series, such as Theological Aesthetics and Biblical Literature Studies, whose authors cover disciplines from religious studies, philosophy, historical research, to anthropology and sociology, have also been published and have become important vanguards of interdisciplinary studies. The Collection of 20 Century Chinese Literature Studies, which came out at the turn of the century, has consisted of monographs of the relationships between Chinese Literature and 153 la rivista dell’ Arte Buddhism, Christianity, and Islam. Overall, since the beginning of the 21st century, dramatic changes have taken place in Chinese Comparative Literature. As Comparative Literature advocates the process of equality-based dialogue, concepts and methods of mutual recognition, verification, complementation and bi-directional interpretation have widely replaced the one-way absorption, reference, critique or imitation in the past. This does not just occur in the scope of World Literature and Comparative Literature, but also permeates different fields of Classical Chinese Literature, Modern Literature, Literary Theory, Foreign National Literature studies and other humanities. However, in this transformation and development boom, there are many theoretical questions still left unanswered and many new problems emerging. We first had long discussions about the "relationship between universality and diversity ". After the collapse of the last century’s colonial system, people in some of the newly independent countries were anxious to build their own identities and highlight the differences between the cultures to resist the dominant culture’s attempts to cover cultures of other nations in the name of “universal values”; this is absolutely necessary. However, some nations put undue emphasis on absolute differences and the “incommensurability” between cultures. Since cultures share no common ground and “commensurability”, the potential to start a dialogue and have communication is then neglected. So, do the universal values of culture really exist?Or it is really incommensurable for different cultures? Secondly, we must examine the relationship between holding fast to traditional culture and accepting foreign influence. Will the “purity” of local culture be changed through accepting foreign influence? There is a popular saying in China, “the more national it is, the more international it becomes”. Nevertheless, being “national” is far from being “enclosed”, or even being immutable and frozen. A national culture is bound to develop in interaction with other cultures. Moreover, being “national” and being “international” is not something separated and unrelated; what we call “national” means to gain recognition and favor internationally. Cultures highlight their own prominent features, by also considering the horizon of expectations and acceptance screen of recipients. Then, does the fact that cultures inevitably permeate and absorb each other run contrary to the effort to maintain original features and distinctions? Will this kind of interflow lead to the gradual reduction of cultural diversity and even its disappearance? The next question is the “Self” and the “Other” in dialogue. The “Other” is what I am NOT; hence, its dissimilarity is what should be analysed first. Only when this dissimilarity of “face à face” is fully 154 la rivista dell’ Arte displayed, can the “Other” be the reference to review the Self. However, if we just focus on dissimilarity, the “Self” and the “Other” tend to fall into “complete irrelevance”, which deviates from our goal of understanding and communication. If we do it conversely, it is possible that both sides will lose their characteristics and end up assimilating. Then, how could we deal with such a paradox? Even more important is the question of discourse in the dialogue of cultures. Equality-based dialogue requires, a set of discourse understood and accepted by both sides to reach successful communication. At present, developing countries are facing an effective, widely recognized concept system formed over the years by the advanced world with strong political and economic support. This discourse, after hundreds of years of accumulation, brings together millions of reflections on various human problems, and enriches and develops local culture in its exchange with other cultures. Without this discourse life would be difficult to continue; however, if we employed only this set of discourse and the mode it is composed of to interpret and intercept local cultures, then numerous innovative live cultures with local characteristics would be excluded for their failure to comply with this mode. Should that be the case, the so-called dialogue would turn into a monologue of one culture, with some exotic materials added, and no true interactive dialogue would be formed. What should be done to construct a new, creative set of discourse that will benefit equality-based dialogue? In addition to these issues that have yet to be well addressed, there are many new problems emerging. Strong cultures “adopt” new independent cultures and the latter finally completely liberates from the spirit colonization; how to outline the intercultural, time and space transcending writing and reading history; the transversion of print culture and the rise of media culture, which China and other parts of the world are going through, and the interwoven, dynamic relation of these two, and so on. In the end, we are in an unprecedented transition period. In constructing an ideal world where global cultures coexist, literature-- Comparative Literature in particular-- plays an increasingly important role. Comparatists and literature researchers all over the world will walk side by side, devote themselves to the great cause of reconsidering the meaning of human existence and the way of life for a novel spirit world. *This article was completed in Langrun Yuan, Peiking University, in Aug. 11th, 2009. la 155 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Yue Daiyun - Peking University Pour un dialogue transculturel La licorne et le dragon* È forse possibile immaginare un dialogo tra un liocorno ed un dragone, allegorie rispettivamente del mondo Occidentale e di quello Orientale? Oggi, il Caos-mondo di cui parlava Édouard Glissant impone di trovare un unico, nuovo modo di comunicazione fra le diverse culture. In questa nuova prospettiva si inserisce anche Yue Daiyun in un articolo che, attraverso un’immagine “esopica”, propone nuove importanti direzioni per la comparatistica mondiale. Liocorni e dragoni altro non sono che elementi di questo CaosMondo, protagonisti assoluti della volontà e necessità dell’incontro e del dialogo fra culture diverse che oggi più che mai diventano imperativi urgenti per un nuovo, completo cammino della Letteratura Comparata mondiale. La licorne, animal mythique de l'Occident, ressemble à un cheval ou à une chèvre portant, du front, une superbe corne. Apparue pour la première fois en Mésopotamie, cette représentation est depuis devenue symbole de bonheur et de joie à l'Ouest. Le dragon, lui, est étroitement associé à la culture chinoise. Son image symbolise la puissance du grand Empire qui occupait le "centre du monde". La rencontre de ces deux animaux est emblématique des contacts transculturels organisés depuis quelques années à l'initiative commune de l'Institut de Littérature Comparée de l'Université de Pékin et de l'Institut Transcultura en Europe. 156 la rivista dell’ Arte L'une des questions-clés est celle des malentendus entre culture chinoise et culture occidentale dans leur quête d'universalité. Nous entendons par malentendus, les phénomènes survenant dès que deux personnes de cultures différentes entrent en contact. Chacune éprouve une réelle difficulté à se libérer de sa propre tradition culturelle et de ses modes de pensée, et ne peut voir l'autre que dans les termes de ses références familières. Une fable chinoise met en scène une grenouille qui tente de décrire à un poisson de ses amis, comment il en va sur la terre ferme. Le poisson interprète alors les oiseaux comme des poissons volants, et les charrettes comme des poissons géants avec quatre nageoires ventrales circulaires ; il ne comprend le monde que dans ses propres termes. Quand un être humain tente de comprendre une autre culture, il commence par opérer des sélections et des classements, puis les interpréter, selon sa forme de pensée usuelle. Ainsi, surgissent nécessairement les malentendus. Les attitudes à l'égard de ces contresens varient selon l'époque et le contexte. La première attitude consiste à voir en tous ceux qui appartiennent à une culture différente des païens, des êtres non-civilisés ou primitifs, à les appeler barbares, à les réduire à l'animalité. La seconde attitude est d'admettre l'existence des valeurs d'une culture différente, mais de ne la voir que comme un trésor exceptionnel, ou un précieux vestige historique. La troisième attitude est plus tolérante : à partir du relativisme culturel, elle reconnaît que toutes les cultures, aussi diverses puissent-elles être, ont toutes leurs éléments de rationalité et leurs valeurs existentielles. Mais nous devons aller plus loin et nous demander : y a-t-il quoi que ce soit d'universel ou de commun entre de lointaines cultures ? Existe-t-il un critère commun pour distinguer le bien du mal ? Au cours du vingt-et-unième siècle, les différences entre les cultures tendront-elles à s'atténuer ou à s'amplifier ? Apparaîtra-t-il des régularités, des éléments rationnels unificateurs dans l'hétéroglossie des cultures plurielles ? Est-il concevable que les hommes finissent par transcender leurs centralismes nationaux, leurs cultures et civilisations propres, pour atteindre une perfection plus élevée et former une "nouvelle humanité" ? Le développement d'une "société de l'information globale", les nouveaux besoins culturels et idéologiques résultant des rapides changements sociaux dans les pays d'Extrême-Orient, rendent ces questions aiguës et urgentes. 157 la rivista dell’ Arte Pour un nouveau médium Le projet de Dialogue transculturel touche aujourd'hui un lectorat considérable. Depuis plus d'une décennie, des chercheurs et penseurs chinois et européens ont eu l'occasion de se retrouver dans plusieurs rencontres. Ils partagent le refus d'une "assimilation mutuelle", d'une "intégration fusionnelle en un tout organique" sous couvert d'une idéologie de la globalisation qu'ils regardent plutôt comme une variante particulière d'égotisme. Ce n'est qu'en acceptant et en protégeant les différences culturelles, que chaque système culturel peut adopter les éléments forts des autres, afin de mieux se découvrir lui-même et de se développer au travers de cette référence mutuelle. Dans notre esprit, le système culturel occidental est à l'heure actuelle en quête d'une telle référence, d'une altérité qui lui permette de se réexaminer dans la perspective d'un décentrement et d'une extraversion, dépassant ainsi ses limitations internes et visant à un nouveau développement. Par ailleurs, débarrassé des scories de la colonisation, le Tiers monde a besoin de revivifier ses cultures traditionnelles tout autant que de les transformer dans un dialogue à égalité avec l'Occident. Le dialogue entre l'Est et l'Ouest est donc une exigence historique essentielle pour le développement des cultures modernes. Le dialogue direct est le moyen de contact le plus rapide et le plus adéquat entre les deux cultures, à condition que le discours utilisé comme support de communication, chacun puisse le comprendre, l'accepter. Cependant, fort de ses modes de pensée et modèles de comportement, le monde développé éprouve une réelle difficulté à comprendre l'étrange discours d'une autre culture. En même temps, le Tiers monde est confronté à tout un ensemble de systèmes conceptuels déjà construits de longue date par le monde développé, qui constituent autant de discours traversant les domaines politiques, économiques et culturels, dominants et utilisés de manière extensive. Accumulé au cours des siècles, cet ensemble constitué par les réflexions de millions d'esprits supérieurs, sur nombre d'enjeux concernant toute l'humanité, ne peut ni ne doit être rejeté. Mais il serait dangereux pour le Tiers monde de ne recourir qu'à cet ensemble de discours pour interpréter et transformer ses cultures originelles, car cela reviendrait à exclure nombre de cultures vivantes et innovatrices, en raison de leurs incompatibilités avec ces modèles. C'est pour cela que certains plaident pour la "découverte" d'un discours absolument natif et libre de toute pollution. Mais ils s'apercevront qu'un tel discours n'existe pas, tant il est vrai que toute culture se développe en interaction 158 la rivista dell’ Arte avec d'autres. Au demeurant, quand bien même existerait un tel discours aborigène, il ne serait pas intelligible aux autres et ne permettrait aucune communication. Ainsi, pour faciliter un dialogue authentique, un médium doit être trouvé, capable, non seulement d'exprimer les caractéristiques et les innovations de chaque côté, mais aussi de traverser les frontières des anciens systèmes, établissant une base de départ pour leur réexamen et fournissant les conditions de possibilité de leur réjuvénation. Un tel médium est sans doute le problème commun de l'humanité entière. Quelles que soient la complexité des systèmes culturels et les considérables différences entre les êtres humains, il existe des éléments communs permettant de donner un statut objectif au concept d'"humanité". Les humains vivent sur la même Terre et sont évidemment confrontés aux mêmes enjeux et aux mêmes intérêts, qu'il s'agisse de paix et de développement futur, d'écologie, d'utopie, ou du sens de la mort, de la fin de l'humanité, etc. Les différentes cultures apporteront leurs propres réponses à ces questions, en accord avec leurs diverses façons de vivre et de penser. En écho à la réverbération de longues traditions historiques, ces questions seront aussi acceptées, interprétées ou rejetées par les contemporains en fonction du contexte contemporain. Ce n'est que par de fréquents dialogues mutuels entre systèmes culturels différents qu'émergeront les réponses les plus satisfaisantes, qu'une perspective plus large sur ces questions pourra être explorée et que s'établira un dialogue mutuellement compréhensible. * L’articolo è stato pubblicato in Dialogue Transculturel, 41-42, 1999. la 159 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Miguel León-Portilla [Manuela Derosas&Armando Gnisci] Ihcuac tlahtolli ye miqui/Cuando muere una lengua/Quando muore una lingua Ihcuac tlahtolli ye miqui mochi in teoyotl, cicitlaltin, tonatiuh ihuan metztli, mochi in tlacayotl, neyolnonotzaliztli ihuan huelicamatiliztli, ayocmo neci inon tezcapan. Cuando muere una lengua las cosas divinas, estrellas, sol y luna; las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Ihcuac tlahtolli ye miqui, mochi tlamantli in cemanahuac, teoatl, atoyatl, yolcame, cuauhtin ihuan xihuitl ayocmo nemililoh, ayocmo tenehualoh, tlachializtica ihuan caquiliztica ayocmo nemih. Cuando muere una lengua todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan, ni pronuncian con atisbos y sonidos que no existen ya. Ihcuac tlahtolli ye miqui, cemihcac motzacuah nohuian altepepan in tlanexillotl, in quixohuayan, in ye tlamahuizolo occetica in mochi mani ihuan yoli in tlalticpac. Cuando muere una lengua entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Ihcuac tlahtolli ye miqui, itlazohticatlahtol, imehualizeltemiliztli ihuan tetlazoltlaliztli, ahzo huehueh cuicatl, Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, la 160 ahnozo tlahtolli, tlatlauhtiliztli, amaca, in yuh ocatcah, hueliz occepa quintequixtiz. Ihcuac tlahtolli ye miqui, occequintin ye omiqueh ihuan miec huel miquizqueh. Tezcatl mianiz puztequi, netzatzililiztli icehuallo cemihcac necahualoh: totlacayo motolinia. nadie, cual fueron, alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas: la humanidad se empobrece. rivista dell’ Arte la 161 Quando muore una lingua tutto ciò che c’è di divino, stelle, sole e luna; tutto ciò che c’è di umano pensare e sentire, non si riflette più in quello specchio. Quando muore una lingua tutto ciò che c’è nel mondo, mari e fiumi, animali e piante, non si può pensare, né pronunciare con segni e suoni che non esistono più. Quando muore una lingua in quell’istante si chiude per tutti i popoli del mondo una finestra, una porta, affacciarsi in modo diverso a ciò che è essere e vita sulla terra. Quando muore una lingua, le sue parole d’amore, le intonazioni di dolore e affetto, forse i vecchi canti, i racconti, i discorsi, le preghiere nessuno, quali furono, riuscirà a ripeterli. Quando muore una lingua, - e molte già sono morte e molte possono ancora morire gli specchi rotti per sempre e l’ombra delle voci per sempre ammutolite. Così l’umanità impoverisce. rivista dell’ Arte 162 la rivista dell’ Arte Questa poesia è una lapide, un tombeau, sul periglioso avvenire delle varie lingue della specie umana. È stata scritta dallo storico messicano Miguel León-Portilla in náhuatl e da lui stesso tradotta in spagnolo1, proponendola così già all’origine come un’operazione transculturale. Il náhuatl appartiene alla famiglia linguistica dello Yuto-nahua ed è una delle 68 lingue indigene presenti in Messico, secondo le fonti ufficiali2, è anche la più parlata (da circa 1.200.000 persone). Le lingue, come gli antichi saperi, i racconti, i proverbi, la poesia a memoria e per il cuore, come dicono i francesi, scompaiono ogni anno e il rischio di scomparire sembra ormai diventato un destino. Lo storico messicano, che ha imparato da adulto questa lingua ancestrale e lontanissima, ma ancora presente e viva, con questa sua azione mostra una formidabile testimonianza di "resistenza e custodia transculturale". È un messaggio forte quello di León-Portilla che ricorda Glissant quando afferma che «Non potremo salvare una lingua del mondo lasciando morire le altre». E quest’opera di difesa delle lingue indigene, così come dei diritti dei loro parlanti, è uno dei punti fermi dell’azione-pensiero politica dello storico messicano. Della sua ampia produzione in Italia è stato tradotto solamente il piccolo e prezioso Il rovescio della Conquista3, che insieme al più vasto Memoria del fuoco di Edoardo Galeano, compone un’alleanza perfetta per la loro "Nuestra América": un “nostra” che non appartiene alla separazione e all'esclusione ma che è un invito alla “nostranza” anche per noi europei, se lo vogliamo, e a ogni persona del mondo. Abbiamo deciso di affiancare alla nostra traduzione (un’azione di avvicinamento del testo di León-Portilla ai lettori italiani) sia il testo auto-tradotto dall’autore in spagnolo, sia l’originale náhuatl4 per ricordare una necessaria estraneità e il diritto all’opacità, (che qui è dovuto all’aura ancestrale dell’antenata lingua precolombiana), cioè la rinuncia a ricondurre l’ampiezza delle verità alla misura di una sola trasparenza (Glissant). Miguel, al contempo, risana i traumi delle ferite antiche e del passato che non può tornare nello scialle transculturale che ha gettato sulle nostre spalle, per poter stare tutti insieme nel suo calore fino a quando il freddo passerà. 1 Cfr. LEÓN-PORTILLA MIGUEL, “Cuando muere una lengua”, Revista de la Universidad de México, Nueva Época, 82, Diciembre 2010, http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/leon/82leon.html. 2 Cfr. http://www.inali.gob.mx/clin-inali/#agr. 3 LEÓN-PORTILLA MIGUEL, Il rovescio della Conquista. Testimonianze azteche, maya e inca, trad. di Giuliana Segre Giorgi e Gabriella Lapasini, Milano, Adelphi, 1974 [I ed.]. 4 In questo sito http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/8210/leon/82leon_v.html potrete anche ascoltare il testo recitato in quella prima lingua di scrittura, antica e scelta da adulto, ma presente-viva a tante persone. la 163 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Shirley de Souza Gomes Carreira - ABEU – Centro Universitário Imigrantes libaneses no Brasil: a representação literária do processo de aculturação Questo articolo esamina la rappresentazione letteraria degli immigrati libanesi all'interno della letteratura brasiliana. L'autrice mette in evidenza come la letteratura abbia giocato un ruolo fondamentale non solo nel testimoniare il processo di acculturazione, ma anche nel tramandare la memoria etnica. L'articolo ripercorre le molteplici fasi che gli immigrati libanesi hanno dovuto attraversare in vista di una completa integrazione e fornisce una vivida rappresentazione dell'interazione sociale e dell'iniziale scontro tra culture diverse. A cultura permite ao homem não somente adaptar-se ao seu meio, mas também adaptar esse meio ao próprio homem, a suas necessidades e seus projetos. (CUCHE, 1999, p. 10) 164 la rivista dell’ Arte Introdução A migração é um fenômeno tão antigo quanto a origem do homem e, conforme afirma Goldberg (1997, p.21), é uma condição natural da experiência humana. No entanto, o deslocamento implica a perda de referentes identitários, ou seja, do lugar antropológico (AUGÈ, 1994) e traz como consequência a necessidade de adaptação a uma outra cultura. Segundo o Memorandum on the study of acculturation, de 1936, «Acculturation comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different cultures come into continuous firsthand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups»1. No entanto, Berry (1997, p. 7) afirma que, na prática, a aculturação tende a induzir maior mudança em um dos grupos do que no outro e, embora seja a princípio uma mudança de ordem cultural, acaba por tornar-se uma mudança psicológica do indivíduo. A aculturação é, portanto, um processo que envolve tanto o grupo dominante quanto o grupo minoritário, tendo um impacto maior neste último. O contato cultural atinge dois aspectos básicos: o grau de envolvimento de um grupo com o outro e o grau de manutenção da cultura manifestada por cada grupo. Deste modo, um grupo pode assimilar o outro, ambos podem permanecer culturalmente distintos ou misturarem-se entre si. O processo de aculturação do imigrante implica etapas que refletem, em maior ou menor grau, a ansiedade resultante da desorientação experimentada ao se entrar em uma nova cultura, ou seja, do choque cultural. Este artigo consiste em uma análise da representação literária da aculturação de imigrantes libaneses na literatura brasileira, bem como uma reflexão sobre as variáveis sociais que afetam a integração social do imigrante. Para tanto, examinaremos três obras que contextualizam a imigração libanesa no Brasil: Amrik, de Ana Miranda, Nur na escuridão, de Salim Miguel, e Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum. Amrik é um romance histórico, fruto de minuciosa pesquisa da autora, que não apenas utilizou como matéria prima os relatos de imigrantes, denominados mahjar, como também dados extraídos da literatura árabe, bem como registros históricos relativos à imigração. A narradora é uma imigrante libanesa, que rememora a sua saga pessoal, desde a infância no Líbano, passando por uma frustrada experiência na América do Norte, até a sua chegada ao Brasil, onde, finalmente, se estabelece. Em Nur na escuridão, de Salim Miguel, um imigrante libanês nos leva a conhecer a sua saga familiar e as relações complexas dos estrangeiros com o país de adoção. Liderada pelo pai, Youssef, uma família percorre alguns lugares do Brasil à procura de um local onde possa se estabelecer e de uma oportunidade 165 la rivista dell’ Arte para recomeçar. Embora entrecortada pela autobiografia do pai, quem nos conta toda essa história, desde a chegada à Praça Mauá, no Rio de Janeiro, é Salim, o filho mais novo, que reflete sobre a formação da família e as muitas viagens, mesmo as involuntárias, que acabam fazendo. Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, constitui um mosaico de relatos de membros e amigos de uma família libanesa, ordenado pela narradora não nomeada na forma de uma carta enviada ao irmão, que está em Barcelona. O texto é resultado de múltiplas informações amealhadas durante a viagem de regresso a Manaus, sua terra natal, para rever a mãe de criação e matriarca da família, que, no entanto, falece antes do reencontro. Os três textos têm o deslocamento e a memória como molas propulsoras da narrativa e, em proporções diferentes, exploram a temática do choque entre culturas, bem como relatam a árdua experiência dos imigrantes na nova terra. 1. O imigrante libanês no Brasil A emigração libanesa para o Brasil iniciou-se oficialmente após a visita de D. Pedro II ao Líbano, muito embora haja registros históricos da presença de libaneses desde 1808. No século XIX, o governo brasileiro adotara uma política de branqueamento que levou, por sua vez, ao estímulo à emigração de europeus, cuja vinda para o Brasil era subsidiada. No entanto, o mesmo não aconteceu com emigrantes de outras regiões, como os japoneses, sírios e libaneses. Desvinculados da política de imigração oficial, que dirigia os imigrantes europeus às lavouras do interior paulista e dos estados do sul, os imigrantes libaneses tiveram que custear a viagem e a manutenção na nova terra, o que os levou a procurar apoio na rede de familiares já estabelecida no país, ligando-se aos ofícios urbanos e comerciais – sobretudo o de mascate, ocupação importante num país ainda essencialmente rural. Apesar da ausência de incentivos governamentais, o Brasil foi o país que recebeu o maior número de imigrantes libaneses. O sucesso dos pioneiros estimulou o processo migratório, pois aqueles que conseguiam se estabelecer convidavam seus parentes e amigos para que também viessem tentar a sorte no Brasil, formando uma corrente volumosa de imigrantes que se estendeu dos anos 1880 até o presente, com breves períodos de interrupção (especialmente durante as guerras mundiais). Vários foram os fatores que colaboraram para a emigração libanesa, dentre eles a violência no tratamento dado aos soldados cristãos durante o alistamento militar, que se tornou obrigatório em 1909; a pressão 166 la rivista dell’ Arte demográfica, pobreza do solo, doenças endêmicas, declínio das indústrias tradicionais e a falta de oportunidades econômicas. Roberto Khatlab (2007) afirma que foram três as ondas migratórias sírio-libanesas para o Brasil: de 1880 a 1900, 1900 a 1950 e de 1975 em diante. Os integrantes da primeira onda migratória tinham em mente fazer fortuna para poder retornar à terra natal, caracterizando uma imigração de ordem econômica. Sua atividade principal no país era o comércio e logo ficaram conhecidos como “mascates”. A experiência bem-sucedida de alguns pioneiros fez com que a emigração se tornasse uma verdadeira febre, estimulada cada vez mais pela crença de que alguns anos nas Américas seriam suficientes para garantir a aquisição de terras e a prosperidade dos membros da família que ficaram. O modelo de existência para esses primeiros imigrantes ainda era o da terra natal, para onde ambicionavam retornar. É difícil precisar o contingente de imigrantes nessa fase, pois não existem estatísticas sobre a distribuição de libaneses no Brasil do início do século 20. No entanto, conforme Truzzi (2005, p. 15) registra, “nos primeiros anos de 1900, havia três centros de atração principais no Brasil para essa etnia: a Amazônia, São Paulo e Rio de Janeiro”. Diferentemente de europeus e asiáticos, os árabes não se fixaram de maneira concentrada em um único lugar, mas se espalharam de Norte a Sul do Brasil, com alguma predominância no Norte. Os mascates tiraram proveito do surto de prosperidade da borracha que atraía grandes levas de brasileiros para a região do Amazonas. Com o tempo, a decadência da borracha determinou a transferência de muitos libaneses para São Paulo e para o Rio Janeiro, contribuindo para a eclosão de grandes artérias comerciais (KHATLAB, 2007). O espírito de clã, trazido por imigrantes que tinham na aldeia o horizonte máximo, beneficiou a comunidade. A rede de favorecimentos começava na acolhida aos recém-chegados e se estendia depois até as relações entre industriais e grandes comerciantes, com facilidades de crédito e de fornecimento. Os mascates, em geral, abasteciam-se com patrícios, comerciantes que já haviam passado pela fase da maleta debaixo do braço e conseguiram abrir uma lojinha. Muitos sírios e libaneses vieram para o Brasil enganados pelas companhias de navegação. Esses imigrantes eram levados para Santos ou Rio de Janeiro e só quando desembarcavam percebiam que não estavam na América do Norte. O Brasil também foi a opção para aqueles que não conseguiram visto de entrada para os Estados Unidos devido ao seu estado de saúde ou analfabetismo. A segunda fase de migração foi marcada pelas consequências das duas grandes guerras mundiais, quando o 167 la rivista dell’ Arte Líbano atravessou uma das mais sombrias páginas da sua história e conheceu a fome, as doenças contagiosas, as disputas político-religiosas e o bloqueio marítimo. Nessa época, os emigrados tiveram um papel importante na vida de seus familiares, a quem enviavam ajuda. O fluxo migratório sírio-libanês atingiu seu auge entre 1920 e 1930. Esse período assinala a mudança de objetivo dos que aqui chegaram. Decepcionados com o rumo que seu país tomou após o fim da dominação política e econômica, os imigrantes optaram por fixar residência no Brasil, iniciando uma “imigração de assentamento”. Diferentemente da primeira onda migratória, quando o imigrante não considerava definitiva sua vinda para o Brasil e o retorno ainda permanecia no pensamento da maioria; o libanês da segunda onda migratória não via a si mesmo como parte de um grupo de expatriados, mas como membro de uma coletividade de emigrados que desejavam ter um lugar que pudessem considerar como seu em terras brasileiras. A terceira e última onda migratória, que teve lugar após a guerra civil libanesa, deveu-se à falta de perspectivas para os jovens que viviam em regiões rurais. Mais recentemente, a partir de 1995, começou uma evasão, em grande parte, de cidadãos libaneses qualificados, devido à recessão econômica e ao desemprego. A fim de que possamos analisar a representação literária da imigração libanesa no Brasil, examinaremos, a seguir, as variáveis de ordem social que afetam a integração do imigrante e que são, de certa forma, igualmente representadas, já que estão associadas à questão do choque cultural. 2. Variáveis que afetam a integração social do imigrante A aculturação é bidirecional, afetando os dois grupos envolvidos, e exige certos requisitos como o contato, a influência recíproca e a mudança. Em uma situação intercultural, o imigrante depara-se com dois aspectos fundamentais: o envolvimento com a cultura receptora e a manutenção da própria cultura. A partir do posicionamento do individuo ante a sociedade que o recebe, foi possível detectar estratégias de aculturação, que, na realidade, implicam escolhas pessoais. Berry (1997) distingue quatro estratégias aculturativas: 1-Integração: em que há o interesse em manter a cultura original e, ao mesmo tempo, há interação com outros grupos culturais. Ela só é possível em sociedades multiculturais baseadas em valores de aceitação da diversidade cultural e com baixo nível de preconceitos. 2- Assimilação: em que os indivíduos adquirem totalmente os traços da cultura de inserção, abrindo mão de 168 la rivista dell’ Arte sua identidade cultural. 3- Separação: quando o grupo não-dominante tenta manter sua cultura original e evita interagir com o novo ambiente cultural, significando o mínimo de desprendimento cultural combinada com o mínimo de aprendizado da nova cultura. 4- Marginalização, quando há pouca possibilidade em manter a cultura de origem, bem como de entrar em contato com outros grupos culturais. Em outras palavras, há o máximo desprendimento cultural vinculado a um mínimo aprendizado cultural. No caso específico dos imigrantes no Brasil, dada a natureza do processo migratório, associado ao desenvolvimento econômico do país, houve uma integração, com intensas trocas culturais (LESSER, 1999, p. 22). O idioma é, via de regra, um dos obstáculos à adaptação do imigrante ao país de adoção. Oliveira (2001, pp. 12-13) define o idioma como a primeira grande barreira a ser enfrentada pelo imigrante: o bilinguismo ou a competição entre a língua de origem e a nova definem a construção da identidade do imigrante, ou seja, a identidade nova e híbrida, que surge das trocas culturais. A identidade cultural pode ser compreendida como um conjunto de tradições, histórias e valores morais, espirituais e éticos deixados por gerações passadas. No entanto, no contexto da migração, essa identidade é forjada tanto por esse conjunto de tradições quanto pela apreciação que a sociedade inclusiva faz do grupo, ou melhor, em reação às demandas e valorações, positivas ou negativas, que essa sociedade exerce sobre o grupo (TRUZZI, 2005, p. 51). Esse critério de valoração construiu uma imagem do imigrante libanês que gerou o estereótipo do “turco”, bastante difundido na literatura brasileira. 3. A representação do imigrante libanês na literatura brasileira: uma deambulação A visão estereotipada do imigrante libanês pode ser encontrada em obras da literatura brasileira, quase sempre associada à imagem de comerciante, como podemos observar na seguinte passagem de Gabriela cravo e canela, de Jorge Amado: Era comum tratarem-no de árabe, e mesmo turco, fazendo-se assim necessário de logo deixar completamente livre de qualquer dúvida a condição de brasileiro, nato e não-naturalizado, de Nacib. [...] De turco ele não gostava que o chamassem, repelia irritado o apodo, por vezes chegava a se aborrecer: – Turco é a mãe! (AMADO, 1975, pp. 43-45). 169 la rivista dell’ Arte Embora não focalize em particular a questão da imigração, o romance recupera um dado histórico, uma vez que a denominação deveu-se ao fato de que os sírio-libaneses viajavam com documentos emitidos pela Turquia. Segundo Knowlton (1961), todos os imigrantes do Oriente Médio foram denominados “turcos” até 1892, quando os sírios passaram a ser listados separadamente. Por essa época, os libaneses eram incluídos nessa lista, porque faziam parte da Grande Síria, que hoje compreende os estados da Síria e do Líbano. O rótulo funcionava como uma espécie de umbrella term, uma vez que eliminava distinções entre os grupos que agregava. Conforme Oswaldo Truzzi nos faz recordar: Embora a região territorialmente pertença ao chamado mundo árabe moderno, e seus habitantes efetivamente sejam falantes da língua árabe, os sírios e libaneses identificam-se, sobretudo, com a religião professada e com a região ou aldeia de origem, elementos fundadores de suas identidades, muito mais que com um estado-nação, inexistente para eles na época (TRUZZI, 2005, p. 2). Em Nur na escuridão, Salim Miguel relata a indignação de Youssef ao ser chamado de “turco”: E de repente, sem qualquer explicação, sem lógica visível, sem nenhum fato aparente que justificasse ou provocasse, a reclamação dos demais comerciantes [...] esse estrangeiro, esse turco, chegou ontem e nos tomou a clientela, sem se lembrarem que também eles eram imigrantes, ou filhos ou netos de, passaram a chamar o pai de turco e gringo. Deslembravam-se de que eram chamados de galegos (MIGUEL, 2008, p. 118). Como é possível observar, a ideia de uma identidade ou cultura árabe unitária, que ignore as características particulares advindas de situações geográficas e históricas específicas, nunca foi totalmente aceita. A palavra “turco” assumiu, assim, um sentido pejorativo, advindo, em grande parte, pelo incômodo causado pelo sucesso econômico dos imigrantes. Em Amrik. Ana Miranda narra a trajetória dos imigrantes libaneses no Brasil: suas aspirações, seus sonhos, bem como a luta para superar o choque entre culturas. O romance incorpora dados históricos, como, por exemplo, o desvio do rio para fazer a rua 25 de março, assim como registra as dificuldades de aceitação na nova terra: No começo, disse tio Naim, vinham os italianos e os alemães à porta ver despejar de mais árabes, riam de nossos modos, contavam histórias engraçadas sobre nós e não tinham medo [...] mas o mascates foram prosperando e de miseráveis ambulantes descalços que vendiam cigarros em bandejas dependuradas no pescoço ou quibe frito em tabuleirinhos passaram a mascates de santos de madeira e escapulários depois a mascates de tecidos botões linhas arre, assim os mascates se tornaram perigosos sujos traiçoeiros ambiciosos usurários [...] mas não somos o que eles 170 la rivista dell’ Arte pensam, libaneses são limpos, cultos, temos a Université dos jesuítas e a Universidade Americana, sabemos falar inglês grego francês, sabemos ler escrever, inventamos álgebra astronomia matemática, os algarismos arábicos o alfabeto, disse tio Naim, trouxemos para ocidentais a laranjeira o limoeiro o arroz, ensinamos ocidentais a melhor cultivar a alfarrobeira e a oliveira, a criar cavalos, a plantar uvas, figos e imensas maças, a regar, pintar as unhas, fazer hortas de verduras e talhões de legumes, mais de seiscentas palavras à língua dos lusis (MIRANDA, 1997, p. 52). O ofício de mascate também encontra a sua representação no romance de Ana Miranda. Chafic e Abrahão são representações de duas fases vivenciadas pelo imigrante de primeira geração. O primeiro representa o comércio itinerante, ocupação inicial dos imigrantes. O segundo aponta para uma tendência que se perpetuaria na segunda geração, comércio fixo, que não só viria a formar uma rede de conterrâneos a dar suporte uns aos outros, como permitiria aos seus descendentes o privilégio de dedicar-se aos estudos. Os imigrantes da segunda geração encontraram os primeiros aqui fixados, muitos deles atacadistas, podendo assim lhes fornecer mercadoria e ensinar a língua e os conhecimentos básicos para o exercício das transações comerciais: Abraão abriu a canastra mostrou como vendia renda, bordado, retrós sabonete meia dentifrício coisas pequenas pesam pouco, vendem fácil, preço bom, crédito, lágrimas no olhos, Logo aprendes a língua e se sabes umas poucas palavras podes trabalhar por tua conta, sais de manhã cedo mesmo que chova levas pão farinha pudim de palmito bocajuva vais de casa em casa nos bairros da Sé Santa Ifigênia, havia um mapa da capital da província de São Paulo, Abraão tinha lista de fregueses (MIRANDA, 1997, p. 176). Em Nur na escuridão, de Salim Miguel, pode-se observar a dificuldade enfrentada pelos libaneses recémchegados para se iniciarem na profissão de mascate: Não importa o que uma pessoa tenha sido ou queira ser [...] ao chegar ao Brasil, libaneses e sírios, árabes em geral, começam mascateando [...] Se estão se dando bem e o mascatear dá certo, vão deixar de ser trouxas, não demora adquirem um cavalo, uma carrocinha, depois podem ter uma vendola, um armazém, loja de tecidos, quem sabe uma fabriqueta (MIGUEL, 2008, p. 96). O processo de aprendizagem é quase sempre o mesmo: A primeira investida foi para Petrópolis, perto, acompanhado de um parente, que dominava os segredos da profissão, e não só dominava, gostava de mascatear, de conhecer novas gentes e novas regiões [...] explicou como o pai deveria agir. Cada país de origem pedia um modo, bom de perguntar logo a nacionalidade, indagar dos primeiros tempos deles ou dos antepassados, dos problemas de adaptação; ensinava, nunca dê o preço de uma mercadoria, para realizar a venda precisa pôr um preço sempre mais alto, depois ir cedendo, pechinchar se chama, faz parte de um jogo milenar (MIGUEL, 2008, p. 101). Essa atividade favorecia o enraizamento na nova terra, pois o mascate necessitava socializar-se e cativar a 171 la rivista dell’ Arte sua freguesia, muito embora não fosse essa a intenção inicial dos imigrantes, para quem aquela era uma condição passageira, a ser coroada com o retorno à terra natal. Com o passar do tempo, no entanto, este passava a ser algo cada vez mais distante, fazendo com que os imigrantes começassem a pensar em meios de melhorar a sua condição de vida. Assim é que Naim, tio da protagonista de Amrik, exorta os amigos libaneses à criação de estruturas sociais locais que lhes permitam ter uma vida próxima à da terra natal em solo brasileiro: «[...] um dia vão perceber que a vida passou, ficaram aqui fazendo fortuna e não voltaram nem ficaram ricos, só alguns, Entendam logo isso e façam os cemitérios clubes igrejas mâdrassas que nos dos outros não nos aceitam [...]» (MIRANDA, 1997, p. 64). O domínio do português foi, sem dúvida, a primeira grande barreira a transpor. Ao mesmo tempo em que necessitavam aprender o idioma para mascatear, os imigrantes libaneses buscavam manter vivo o idioma de seu país natal, mantendo contato com outros imigrantes da mesma origem. No entanto, aos poucos, assim como a terra natal, a interação apenas em árabe tornou-se algo distante. Em Amrik, a narradora relata essa tendência dos imigrantes a se agruparem com seus conterrâneos. O início do processo de intercâmbio cultural é também descrito no romance, bem como o desenvolvimento de uma interlíngua2, mistura de árabe e português: Tio Naim estudou na Université dos jesuítas Saint Joseph, escrevia para o ALK-Ahram e agora pediam para escrever sobre imigrantes, dinheiro, política, república, ele gostava de república porque trazia prosperidade, os escritos de tio Naim eram discutidos por libaneses nos mezzes as domingos, senhores de muitos espíritos contrários e dados a leis da imaginação, mais levados por seus sonhos do que pela realidade, cada qual vendo mais a distância que a proximidade, misturando árabe com português [...] (MIRANDA, 1997, p. 62). Néstor García Canclini, na introdução de seu Culturas híbridas, nos diz entender hibridização como os «processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas» (CANCLINI, 2003, p. XIX). A interlíngua é um idioma híbrido e uma das primeiras manifestações do hibridismo cultural. Quando Homi Bhabha (apud RUTHERFORD,1990, p. 211) desenvolveu o conceito de hibridismo, ele o definiu como o terceiro espaço, isto é, o lócus do surgimento de uma representação mútua e mutável da diferença cultural e produtor de uma nova configuração identitária, híbrida, porque não é fruto da assimilação nem da resistência à aculturação, mas fruto da tessitura de elementos provenientes de duas culturas diferentes. Em Relato de um certo Oriente, de Milton Hatoum, Hakim, filho de imigrantes libaneses, nascido em Manaus, é iniciado na língua árabe pela própria mãe, aprendendo sem nenhum método a língua e a cultura 172 la rivista dell’ Arte de seus ancestrais: As primeiras lições foram passeios para desvendar os recantos desabitados da Parisiense, os quartos e cubículos iluminados parcialmente por clarabóias: o corpo morto da arquitetura. Sentia medo de entrar naqueles lugares, e não entendia porque o contato inicial com um idioma inaugurava-se com a visita a espaços recônditos. Depois de abrir as portas e acender a luz de cada quarto, ela apontava para um objeto e soletrava uma palavra que parecia estalar no fundo de sua garganta; as sílabas, de início embaralhadas, logo eram lapidadas para que eu as repetisse várias vezes. Nenhum objeto escapava dessa perquirição nominativa que incluía mercadorias e objetos pessoais [...]. Ela ensinava sem qualquer método, ordem ou seqüência. Ao longo dessa aprendizagem abalroada eu ia vislumbrando, talvez intuitivamente, o halo do “alifebata”, até desvendar a espinha dorsal do novo idioma [...] (HATOUM, 2006, p. 51). Esse aprendizado inscreve em Hakim uma memória ligada à família imigrante, à tradição de uma cultura que não conhece em sua raiz, mas como legado familiar e forma de resistência a uma homogeneização do estrangeiro na terra do outro, gerando um conflito em relação à própria identidade. Hakim é um sujeito cindido, diante de uma dualidade identitária: Desde pequeno convivi com um idioma na escola e nas ruas da cidade, e com outro na Parisiense. E às vezes tinha a impressão de viver vidas distintas. Sabia que tinha sido eleito o interlocutor número um entre os filhos de Emilie: por ter vindo ao mundo antes que os outros? Por encontrar-me ainda muito próximo às suas lembranças, ao seu mundo ancestral onde tudo ou quase tudo girava ao redor de Trípoli, das montanhas, dos cedros, das figueiras e parreiras, dos carneiros, Junieh e Ebrin? (HATOUM, 2006, p. 52). A angústia experimentada pela personagem reflete o dilema dos filhos de imigrantes, obrigados a conciliar dois sistemas de valores diferenciados. No romance, a complexa coexistência de culturas distintas é definida por Hakim como “as águas de dois rios tempestuosos que se misturam para originar um terceiro”. Esse terceiro rio é o “terceiro espaço”, onde a identidade híbrida é forjada. Identidade “transcultural”, posto que resulta de trocas culturais: O termo ‘transculturação’ define um modo de integração cultural em que há transformação dos grupos envolvidos, gerando novas configurações identitárias. Esse termo é mais preciso do que “aculturação”, uma vez que traz implícita a noção de ultrapassagem da própria cultura e da cultura do outro (CARREIRA, 2009, p. 177). Os imigrantes de primeira geração buscavam modos de revisitar as próprias origens, como é possível observar na seguinte passagem de Nur na escuridão: «Precisa não renegar a raça a que pertence, precisa conhecer a história da sua terra (tão rica em acontecimentos), precisa participar das reuniões da colônia, precisa se integrar, precisa entrar para o Clube Monte Líbano, precisa» (MIGUEL, 2008, p. 23). Os valores e a tradição eram mantidos e transmitidos através do núcleo básico que era a família. Embora a 173 la rivista dell’ Arte maior parte dos descendentes de libaneses tenha perdido contato com o idioma de seus antepassados, a memória histórica era transmitida nos momentos de reuniões familiares; uma memória que era reconstruída, inclusive, através de hábitos alimentares (KEMMEL, 2000, pp. 14-15): A família reunida. Tradição dos finais de semana. Pode ser aos sábados ou num domingo. De preferência na casa do pai. Eventualmente na de um dos filhos. Enquanto a mãe vivia, costumava-se levar amigos, não dispensavam a comida árabe, quibe em especial [...] a comida continuava a mesma. Só que agora, na cozinha, as duas filhas, ajudadas pelas empregadas. Noras relutavam, repetindo: não sei preparar comida árabe, por melhor que faça vocês vão dizer, a da mamãe era melhor. E era. Pratos preferidos: quibe cru (ou de forno, ou frito, com e sem recheio), tabule, esfiha, labnia, malfufe (melhor com folha novinha de parreira, pode ser também de repolho), mjadra (lentilha com arroz, a que não pode faltar cebola frita cortada fininha), grão-de-bico amassado com óleo de gergelim, zatar com azeite de oliva, por vezes uns goles de arak, quase sempre cerveja, mais raro vinho (MIGUEL, 2008, p. 185). Às vezes, os costumes causavam estranheza em seus descendentes, fazendo, curiosamente, do território familiar um espaço exótico e estrangeiro: No centro de um pátio iluminado pelo sol equatorial, homens e mulheres repetiam o hábito gastronômico milenar de comer com as mãos o fígado cru de carneiro. Não era a um ritual bárbaro ou ao sacrifício de um animal que eu assistia do quarto dos pais, mas sim a uma novidade assombrosa, a uma festa exótica que tanto contrastava com o ritmo habitual da casa (HATOUM, 2002, p. 58). A tentativa de manutenção de valores influenciou também a escolha dos cônjuges e a questão do casamento entre brasileiros e libaneses também é representada na literatura: Uns homens daqui mandavam buscar mulheres nas suas aldeias no Líbano, mulheres da sua mesma religião maronita e de virgindade virgindade sempre virgindade, alguns mascates logo que ganhavam um dinheiro voltavam a suas aldeias para escolher uma mulher, traziam a mulher para o Brasil ou deixavam a mulher lá e voltavam sozinhos, outros casavam com uma brasileira e voltavam com ela para sua aldeia no Líbano, uma mascate casou com uma brasileira e levou a brasileira para Beirute, lá estava outra mulher e a brasileira não aceitou a bigamia, o marido deixou a brasileira na rua, ela ficou perdida nas ruas e ia virar mendiga ou prostituta de turcos, na sala de tio Naim eles discutiram o destino da perdida [...] decidiram trazer de volta a brasileira ai que sacrifício pagar passagem assim para brasileiro tanto libanês precisava trazer mãe ou pai ou irmão, não ia custar tão caro, mais caro é ter boa reputação [...] (MIRANDA, 1997, p. 67). O tipo de situação descrita no romance de Ana Miranda se reporta a uma fase da imigração em que os casamentos mistos ainda não eram comuns. Segundo Oswaldo Truzzi (2005, p. 33), «o padrão de buscar a noiva na terra de origem» era uma prática rotineira entre os pioneiros, mas muitos imigrantes conheceramse e casaram-se aqui no Brasil, como o casal de libaneses de Relato de um certo Oriente. Como observa Cecília Kemel (2000, p. 57), muitos foram os fatores que facilitaram o processo de 174 la rivista dell’ Arte aculturação do imigrante árabe; dentre eles a afinidade entre a prática religiosa dos árabes cristãos e o catolicismo praticado no Brasil. Os imigrantes muçulmanos, privados desse fator, tornaram-se menos acessíveis. Essa questão é bem delineada em Relato de um certo Oriente, principalmente, em relação à Emilie e seu marido. Emilie cultua seus santos com a liberdade de quem compartilha o lugar comum. Seu marido, no entanto, como afirma Dorner, o imigrante alemão que é amigo da família, «não era esquivo aos da terra, mas sempre foi imbuído de uma indiferença glacial para com todos»; era «um asceta mesmo cercado por pessoas». A negociação entre culturas, entretanto, nem sempre é bem-sucedida. Se a maioria dos imigrantes engendra uma estratégia de aculturação integrativa, ou mesmo de assimilação, alguns acabam optando pela marginalização. Em Relato de um certo Oriente, a falta de ancoragem e o sentimento de inadequação levam o irmão de Emilie, a matriarca da família libanesa, ao suicídio: Não, Emir não era como os outros imigrantes, não se embrenhava pelo interior enfrentando as feras e padecendo as febres, não se entregava ao vaivém incessante entre Manaus e a teia de rios, não havia nele a sanha e a determinação dos que desembarcam jovens e pobres para no fim de uma vida atormentada ostentarem um império (HATOUM, 2004, p. 62). Jeffrey Lesser (1999, p. 22) chama a atenção para o fato de que a assimilação, na qual a cultura prémigratória da pessoa desaparece por completo, bem como a marginalização, em que há a impossibilidade de manutenção da cultura de origem e a incapacidade de interação com o meio, foram casos raros no Brasil, dando lugar às trocas culturais. À guisa de conclusão A nossa deambulação pelas obras de Milton Hatoum, Salim Miguel e Ana Miranda, embora não exaustiva, revela não apenas o registro da presença dos imigrantes libaneses em solo brasileiro, mas também o choque entre culturas e as estratégias de aculturação. A par disso, é possível observar, também, o papel da obra literária na manutenção de uma memória étnica, pois, através dela, torna-se possível o conhecimento dos valores e práticas sociais dos imigrantes por um viés que vai além do registro histórico, uma vez que resulta de impressões, ainda que ficcionalizadas, de imigrantes e de seus descendentes, e de sua forma de lidar com o passado. Em Nur na escuridão, Salim Miguel deixa claro o teor autobiográfico de seu romance. Ainda que haja 175 la rivista dell’ Arte alguma variação nos fatos narrados (no romance, por exemplo, é o tio Hanna que atrapalha a ida para os Estados Unidos por conta de uma inflamação nos olhos, mas, na realidade, foi o seu pai quem a teve), são as reminiscências de sua própria história que constituem o arcabouço do romance. Milton Hatoum sempre procurou esclarecer em suas entrevistas que Relato de um certo Oriente não é um livro autobiográfico, mas não nega que a sua elaboração é um kilt de memórias, suas e de outros, entremeadas a tal ponto pela ficção que nenhum membro de sua família reconhecer-se-ia no romance. Ao contrário de Nur na escuridão, o romance de Hatoum situa-se em um momento histórico em que os imigrantes já ultrapassaram o choque cultural. Amrik, por sua vez, constitui o resultado de uma minuciosa pesquisa. Ana Miranda, ao fim do romance, fornece uma lista bastante detalhada de suas fontes, que vão de relatos de viagens e registros da imigração a livros de culinária, bem como um glossário de termos em árabe e nomes de personagens ficcionais ou históricos citados no livro, desvelando ante o leitor a materialidade da obra. Os romances examinados sugerem uma intenção subjacente dos autores de vencerem as barreiras do estereótipo, que marcou boa parte da representação do imigrante na literatura brasileira, buscando, através da ficção, construir, cada um a seu modo, uma visão da saga dos imigrantes libaneses no Brasil. Os olhares que lançam à história são fruto das formas diferenciadas de lidar com a memória. Ao dialogar com a cultura árabe, os romances demonstram como a interpenetração de culturas permite uma ressignificação dos elementos culturais, proporcionando versões do Oriente cujos escopos e feições são sempre múltiplos e em mutação. 176 la rivista dell’ Arte 1 Em 1936, foi criado, nos Estados Unidos, um comitê encarregado de organizar as pesquisas sobre aculturação. Esse comitê, composto por Robert Redfield, Ralph Linton e Melville Herskovits, organizou o Memorando sobre o estudo da aculturação, que se tornou o primeiro referencial teórico sobre o assunto. REDFIELD ROBERT, LINTON RALPH, HERSKOVITS MELVILLE J. (1936), “Memorandum on the study of acculturation”, American Anthropologist, 38, 1, pp. 149-152. 2 Interlíngua é o sistema de transição criado pelo aprendiz, ao longo de seu processo de assimilação de uma língua estrangeira. É a linguagem produzida por um falante não nativo a partir do início do aprendizado, caracterizada pela interferência da língua materna, até o aprendiz ter alcançado seu teto na língua estrangeira, ou seja, seu potencial máximo de aprendizado. Referências bibliográficas AMADO JORGE, Gabriela cravo e canela, São Paulo, Círculo do Livro, 1975. AUGÉ MARC, Não- lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade, Rio de Janeiro, Bertrand Editora, 1994. BERKSON ISAAC BAER [1920], Theories of acculturation: A critical study, New York, Arno Press, 1969. BERRY JOHN W., “Conceptual approaches to acculturation”, in CHUN KEVIN M., ORGANISTA PAMELA BALLS, MARÍN GERARDO (Eds.), Acculturation: Advances in theory, measurement and applied research, Washington, D.C., American Psychological Association, 2003, pp. 17-37. BERRY JOHN W., “Immigration, acculturation, and adaptation”, Applied Psychology: An International Review, 46, 1, 1997, pp. 5-34. CARREIRA SHIRLEY DE SOUZA GOMES, “Imigrantes: a representação da identidade cultural em Relato de um certo Oriente e Amrik”, in EADEM et all, Protocolos críticos, São Paulo, Iluminuras, Itaú Cultural, 2008, pp. 177-191. COHEN ROBIN, Global Diasporas: An Introduction, London, UCL Press, 1999. CUCHE DENIS, A noção de cultura nas ciências sociais, Bauru, SP, EDUSC, 1999. FELDMAN-BIANCO BELA, CAPINHA GRAÇA (orgs.), Identidades. Estudos de Cultura e Poder, São Paulo, Hucitec, 2000. GOLDBERG DAVID THEO, “Introduction: Multicultural conditions”, in IDEM, Multiculturalism: a critical reader, Oxford, Blackwell,1997. HATOUM MILTON, Relato de um certo Oriente, São Paulo, Companhia das Letras, 1994. KEMEL CECÍLIA, Sírios e libaneses: aspectos da identidade árabe no sul do Brasil, Santa Cruz do Sul, SC, Edunisc, 2000. KNOWLTON CLARK S., Sírios e Libaneses. Mobilidade social e espacial, São Paulo, Anhambi, 1960. LESSER JEFFREY, A negociação da identidade nacional. Imigrantes, minorias e a luta pela etnicidade no Brasil, São Paulo, EDUSP, 1999. MIGUEL SALIM, Nur na escuridão, Rio de Janeiro, Record, 2008. MIRANDA ANA, Amrik, São Paulo, Companhia das letras, 1997. OLIVEIRA LÚCIA LIPPI, O Brasil dos imigrantes, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. RUDMIN FLOYD WEBSTER, “Critical history of the acculturation psychology of assimilation, separation, integration, and marginalization”, Review of General Psychology, 7, 2003, pp. 3-37. REDFIELD ROBERT, LINTON RALPH, HERSKOVITS MELVILLE J. (1936), “Memorandum on the study of acculturation”, American Anthropologist, 38, 1, pp. 149-152. 177 la rivista dell’ Arte RUTHERFORD JONATHAN, The Third Space: Interview with Homi Bhabha. Identity, Community, Culture, Difference, London, Lawrence and Wishart, 1990, pp. 207-221. SAYAD ABDELMALEK, A imigração ou os paradoxos da alteridade, São Paulo, EDUSP, 1998. TRUZZI OSWALDO, Imigrantes no Brasil: sírios e libaneses, São Paulo, CEN, 2005. TRUZZI OSWALDO, “Presença árabe na América do Sul”, História UNISINOS, 11, 3, Set./Dez. 2007, pp. 359-366. la 178 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Hussein Mahmoud - Università di Helwan (Il Cairo) L'integrazione alla rovescia: la scelta del dialetto nella poesia migrante egiziana in Italia Introduzione Sono poeti arabi perciò producono poesia in arabo: tutto è normale; tutto in regola. Solo un elemento bizzarro rende questa affermazione irregolare: i poeti di cui parliamo non vivono più nel mondo arabofono, ma vivono in Mahjar, cioè nella destinazione della loro avventura migratoria, che è in questo caso l'Italia. Questo nuovo elemento pone subito diverse domande: sono ancora arabi, malgrado alcuni di loro abbiano acquisito anche la cittadinanza italiana? La loro produzione fa parte della storia della letteratura araba, o per motivi di soggiorno questa loro produzione letteraria si aggiunge alla storia della letteratura italiana? Se la letteratura araba è quella scritta in lingua araba, così come la letteratura italiana è quella scritta in italiano, queste poesie prodotte in arabo, ma in Italia, devono avere delle peculiarità diverse dalla poesia araba prodotta nel mondo arabo? O sono peculiarità di una poetica trans-culturale che va al di là delle due letterature nazionali locali? Ci sono caratteristiche, linguistiche o tematiche, che distinguono questa produzione letteraria, sia da quella italiana che da quella araba? Queste sono le questioni che vogliamo discutere in questo testo, attraverso la produzione di tre poeti egiziani che vivono a Roma, che hanno già un soggiorno durevole alle loro spalle – tutti loro hanno superato 20 anni di soggiorno continuo nella capitale italiana – e che hanno pubblicato di recente in Egitto le loro opere in lingua araba, con una scelta precisa del dialetto. 179 la rivista dell’ Arte È una scelta, quella del dialetto, significativa, come vedremo, per una peculiarità del dialetto egiziano in particolare, che va inquadrata nella storia del mondo arabo, perché è stata per lungo tempo la lingua del cinema e della tv araba che, grazie alla massiccia produzione cinematografica e televisiva egiziana, ha diffuso questa lingua vulgata chiamata dialetto, con le sue diverse sfumature, in tutto il mondo arabo. Il rapporto arabo classico/dialetto nel mondo arabo è diverso dal rapporto latino/volgare, o italiano/dialetto locale, perché l’arabo classico, come lingua sacra, quella del Corano, è stata sempre usata e conservata viva. I dialetti, specialmente quelli vicini al centro del mondo arabo, il cosiddetto Medio Oriente, sono vicinissimi al classico. I dialetti arabi, finora, sono stati orali, si usano nella comunicazione quotidiana, ma non si scrivono. È la solo poesia dialettale che ha ottenuto il privilegio di essere detta e anche scritta. I poeti dei quali parliamo sono: Magdi Sarhan, Hesham Fayadh e Mohamed Yosef, autori di tre raccolte di poesia in dialetto egiziano. Prima diamo una conoscenza biografica di ognuno di loro. 1. Magdi Sarhan: il contadino emigrante Magdi Abdel Halim Sarhan, nasce in uno dei villaggi del fertile delta del Nilo, Hazeq, nel centro urbano di Biela, Kafr El Sheikh, in una delle province del nord-est dell'Egitto, che produce il 40% del riso egiziano, ma che ha anche una storia antichissima, come la capitale faraonica del Regno del Nord, e una storia moderna come parte del grande progetto della modernizzazione dell'Egitto, sognato e verificato da Mahamed Ali che regnava in Egitto nei primi Ottocento. La famiglia del nostro poeta era tra quelle agiate del villaggio, per la proprietà di terre coltivabili, ma il padre, un impiegato bancario, è morto sul suo motorino, in un incidente stradale quando aveva ancora 43 anni, lasciando quattro bambini con la loro madre illetterata, che disegnava a stento il suo nome. Una tra moltissime madri egiziane che, perdendo il marito si dedica completamente, quasi da suora, ai figli. Il figlio maggiore, secondo un'altra usanza egiziana, lascia la scuola per arruolarsi nell’esercito: così alleggerisce gli oneri sul bilancio economico famigliare, contribuendo nello stesso tempo a sostenere la famiglia. Ma la vita difficile ha spinto il giovane Magdi ad accontentarsi del diploma della scuola superiore di commercio mentre suo fratello minore raggiunge una tappa di istruzione più alta, una specie di laurea minore, così come l'unica sorella che lavora come impiegata di Stato. Magdi era un tipo allegro, più attivo degli altri maschi della famiglia, lavorava nelle vacanze estive nelle province vicine, guadagnava e si divertiva. Ricorda ancora le avventure del suo lavoro precario come assistente sul trattore che tirava un serbatoio d'acqua per spruzzarla sulla strada prima 180 la rivista dell’ Arte di asfaltarla: si tratta della strada asfaltata che conduce al suo villaggio, un lavoro che gli rendeva una somma mensile che aiutava, oltre alle sovvenzioni che arrivavano dalla famiglia della madre. Anche lei era di una famiglia agiata di Mansuora, e riuscì a sostenere la famiglia dopo la morte del marito. La fine dello studio del nostro giovane poeta segnava, però, l'inizio delle sue difficoltà. Cercare e trovare un lavoro. Una difficile impresa, quasi impossibile, in un paese di alta percentuale di disoccupazione e di una corruzione in cui prevalgono il nepotismo e il favoritismo. In tanti si presentavano ai concorsi per avere un posto di lavoro, ma solo lui, ed i suoi simili che non sono parenti di nessuno, non ottenne nessun risultato positivo. Ma c'era una speranza che gli arrivò dall'altra sponda del mare. Dall'Italia. Da un cugino, borsista che studiava in una delle università del bel paese. Bastava una telefonata per preparare il terreno all'avvio di una nuova esperienza: la migrazione. Per un contadino egiziano l'evento dell'emigrazione è straordinario. Per tutta la storia egiziana l'emigrazione non è mai stata una delle caratteristiche dei contadini egiziani, legati per millenni alle loro terre nella valle del Nilo. Per Magdi, emigrare significava trovare un lavoro che garantisse qualche futuro. In Italia ha trovato questo futuro, tramite un altro migrante più veterano che gli ha proposto un lavoro in un'agenzia di automobili, come custode notturno per 11 anni. Un lavoro dietro l'altro, da custode a facchino, da operaio in una fabbrica di cuoio ad assistente di un centro statistico che lavora anche per la Rai. Un culmine della sua vita è raggiunto quando un giorno gli è conferita la cittadinanza italiana. Venti anni di lavoro e di vita in Italia, una vita, una famiglia, moglie laureata in economia domestica, due figli che studiano in scuole italiane che parlano l'italiano da madre lingua e conoscono la cultura italiana di prima mano, in contatto continuo e costante coi genitori arabofoni: a volte i figli riescono ad imporre i loro valori a tutta la famiglia. Magdi ha la sua formazione culturale basata sulla letteratura popolare con le sue prevalenti fonti orali. Ha letto pochi libri, ma è entusiasta lettore dei giornali. La poesia la pronunciava solo per scherzo, per divertimento con gli amici, una specie di passatempo efficace. Ma l'esperienza della migrazione ha raffinato la sua poetica, grazie ad un concetto molto importante che ha il suo peso per tutti i migranti egiziani. Lasciare la propria terra per un contadino egiziano si considera ghorba. La ghorba si svela in tante forme, tra cui la nostalgia, l'amore della patria, la memoria viva di ogni singolo dettaglio vissuto nel passato nel proprio paese ecc. Per il contadino-poeta sensibile Magdi Sarhan, vivere in Italia significa fare paragoni tra la vita qui e la vita lì, riuscire a risolvere i problemi quotidiani, guadagnare il pane, migliorare il benessere, acquisire una nuova cultura e nuove conoscenze tecniche, trovare nuove amicizie, riconoscere l'altro e 181 la rivista dell’ Arte rispettarlo, e soprattutto accorgersi dell'importanza della libertà di espressione. Mettere in confronto i sistemi sociali delle due nazioni: sanitario, educativo, igienico ecc. Da questa materia umana nascono le poesie di Magdi: sono poesie di critica sociale del proprio paese, di amore per la patria, di commento della cronaca dei giornali egiziani, ecc. Magdi ha pubblicato due libri di poesia: Zucchero rocca, Il Cairo 2008; Ti ricordi o hai dimenticato? Il Cairo 2009. Si tratta di piccole raccolte di poesia scritte in un dialetto quasi contadino della campagna nordegiziana. Ha inoltre partecipato a un festival di poesia in Italia dove le sue poesie tradotte hanno avuto un riconoscimento italiano. 2. Mohamed Yosef: l'élite migrante Per Mohamed Ysef Ismail l'esperienza è molto diversa. Non è il contadino legato alla sua terra coltivata, ma cittadino, abituato da bambino alla ghorba. Con la sua famiglia ha passato dieci anni della sua infanzia in Libia, poco dopo la sua nascita al Cairo nel 1967, in un quartiere popolare, popolatissimo, Rodh el Farag, al nord del Cairo, dove vivono almeno 6 milioni di abitanti. In questo quartiere è cresciuto il nostro poeta il più possibile vicino allo spirito della classe popolare, acquisendo la capacità di parlare la sua lingua e di capirne le esigenze espressive. Vivendo al Cairo, si avvicinava tranquillamente all'élite, agli intellettuali del suo tempo, entrando in dibattiti ardenti con loro. Da qui l'opera di Yosef prendeva un doppio volto, quello di esprimere il popolo più povero con tutti i problemi di cui soffre, malattie e ignoranza in primo luogo, ma nello stesso tempo valori umani veri. Dall'altra parte presenta al suo pubblico le sofisticate ideologie con parole semplici. Dopo il trasferimento della sua famiglia in Libia per motivi di lavoro ritornò in Egitto e partecipò all’attività culturale e politica della vita universitaria, come studente di chimica nell'università di Ain Shams, dove si laureò. Ma abbandonò subito la chimica per dedicarsi al giornalismo. Pochi mesi da giornalista furono sufficienti per convincere il giovane a cercare altre soluzioni di vita lontano dalla patria, optando per Roma. A Roma il giovane laureato è riuscito a trovare lavoro come insegnante di chimica nella scuola libica, un lavoro che gli permette di approfondire le sue conoscenze, di impadronirsi della lingua italiana, di conoscere fin in fondo la cultura e lo stile di vita europeo. Dopo 12 anni di lavoro da maestro di scuola ha deciso di dedicarsi completamente al giornalismo: corrispondente di diversi canali televisivi arabi, egiziani, kuwaitiani e sauditi. Ha partecipato a diverse attività poetiche nell'Istituto Egiziano di Cultura a Roma, e ha vinto un premio nel Festival della Poesia del Mediterraneo. 182 la rivista dell’ Arte L'ambiente popolare in cui è cresciuto gli ha insegnato a parlare in modo molto semplice di questioni complicate che l'élite in generale non riesce a comprendere. Perciò anche lui ha scelto il dialetto cairota per esprimersi in poesia. Tra le sue ultime pubblicazioni il libro Insegnami il nuoto ti prego Ahmed, il Cairo 2008. 3. Hesham Fayadh: la crisi esistenziale Per Hesham Fayadh la poesia era un progetto di vita. Prima della sua esperienza migratoria scriveva in arabo classico dando un giudizio molto negativo della poesia dialettale accusata da lui di incapacità espressiva, particolarmente quando affronta questioni difficili, in particolare quelle che si riferiscono alle problematiche esistenziali. Lasciamo a lui descrivere la sua vita in una specie di autobiografia che ha scritto proprio per questo saggio. "Oggi inizia la primavera. Una brezza leggera sospesa negli strati d'aria non priva di freschezza. La casa in uno stato di confusione chiara. Il medico è stato chiamato, ma la madre aveva già partorito senza assistenza di nessuno. Il medico ha solo staccato la corda dall'ombelico per finire una fase di comunicazione fisica e per dare inizio ad una comunicazione spirituale che è durata fino alla morte di mia madre. Quel neonato ero io e il parto aveva luogo nel primo giorno della primavera dell’anno sessanta dello scorso secolo. Sono arrivato al mondo senza preavvisi, infatti mia madre non aveva avuto travaglio. Niente dolori, niente strilli. La nascita era così facile: avverrà altrettanto facile la morte? In quel tempo mio padre, un giovane ingegnere, aveva un maschio e due femmine. La nostra casa dava sul mare della città di Rosetta dalla quale sono stato sempre affascinato, come sono affascinato oggi da Roma. Avevamo una vita serena e quieta, con madre pietosa e padre austero ma affettuoso, che ci voleva bene e voleva per noi che fossimo figli sani, forti e importanti. I primi passi cominciarono con i pochi amici di mio padre: Maestro Don Ismail Sherbini, che aveva un'officina di mobili ed arredamenti, Maestro Don Farghaly, un pescatore che possedeva una piccola barca. Sono i due amici che maggiormente ebbero l'effetto più marcato sulla mia maturità intellettuale allargando gli orizzonti verso nuovi mondi. Maestro Ismail era appassionato della lettura dei quotidiani ad alta voce, anche per far favorire il Maestro Farghaly, illetterato, ma che aveva sapienza della vita e della realtà. Le discussioni tra i due maestri affrontavano i temi della politica, letteratura, sport e arte. Mi sono arrivati all'orecchio tante parole e nomi che non conoscevo, ma l'unica cosa che mi è rimasta in mente da questo frastuono di informazioni aveva come fonte i giornali quotidiani, fogli di carta grandi che portano notizie e idee diverse, ma anche annunci 183 la rivista dell’ Arte funebri sui quali sempre il maestro Farghaly faceva lunghi commenti, sostenendo che erano pieni di informazioni e notizie interessanti. Infatti in questi annunci venivano menzionati tutti i parenti del defunto, che Farghaly riconosceva per poi estrarre storie dai rapporti di parentela, ma anche riflessioni politiche: “Questo morto era nel vicino passato facchino nel porto, ora è diventato uno dei giganti del porto. Dio gli ha dato molto!”, disse Farghaly commentando uno di questi annunci. Da questi incontri, che erano per me delle occasioni da non perdere, sono riuscito a crearmi una base di informazioni disorganizzate che raccoglievano temi stravaganti ed enigmatici, che mi hanno fatto conoscere una ricchezza linguistica imparagonabile, che io mettevo a frutto, e grazie alla quale prendevo i massimi voti nei temi a scuola. Un giorno mio padre decise di trasferirsi da Rosetta, a Zaqaziq, la sua città natale, perché non poteva abbandonare la sua anziana madre, che oltre a non potere, non voleva lasciare la sua terra per congiungersi al figlio dove lui abitava. Il trasferimento è riuscito, ma non a Zaqaziq, bensì in un villaggio adiacente, divenuto poco dopo un centro urbano, Qanayat. In campagna ho imparato un linguaggio nuovo, una quotidianità molto interessante e diversa: la lampada a gas, la lanterna, il canone (un forno locale composto da due mattoni tra cui si mettono alcuni tipi di combustibili come il legno, o delle pastiglie particolari fatte impastando le merde degli animali e il fieno), camminare con piedi nudi, raccogliere lo sterco degli animali per farne da secco le pastiglie di "Ghella" che si usa come commestibile alternativo al legno secco. Ero meravigliato a vedere e sentire i tamburi battenti per annunciare la morte di qualcuno o per comunicare alla gente del villaggio di aggregarsi in un certo punto per cominciare il funerale. Sono gli stessi tamburi che battevano al mattino per annunciare, in un ritmo triste e cupo, la morte e che battevano la sera per accompagnare una sposa alla sua nuova casa con gioia ed allegria. Uno dei piaceri maggiori della vita in campagna era quello di vagabondare nelle strade del villaggio. Il tragitto breve da scuola a casa, cinque minuti a piedi, prendeva due ore: mi soffermavo per osservare, sentire, vedere tutto, anche quando si trattava di una rissa in cui i contadini usavano bastoni pesanti o anche armi bianche, seguivo tutto l'evento con molta attenzione. Quando mi chiedevano poi di raccontare, da testimone, quello che avevo visto, raccontavo e ricostruivo tutto a modo mio, a volte mettevo un finale diverso dalla rissa, a volte la facevo finire prima che accadesse la fine vera. A casa mi aspettava il solito castigo dai genitori: privarmi di veder una o due puntate del telefilm di successo in quei giorni, La vittima. Il periodo della scuola elementare fu molto incisivo su di me. Nella scuola non c'era biblioteca, ma c’erano 184 la rivista dell’ Arte lezioni di lettura, usate dalla maestra per esercitare un gioco beffardo in cui ci diceva "luna" e noi dovevamo chiudere gli occhi e chinare le nostre teste sui banchi; questo finiva quando lei diceva "sole", aprivamo gli occhi e ritornavamo diritti sui banchi. La maestra approfittava del tempo tra l'alba ed il tramonto, tra la luna e il sole, per fare le cose sue, come per esempio preparare i legumi per non perdere tempo in cucina al ritorno a casa, mentre noi approfittavamo a dormire un po': tante volte dormivamo profondamente e non sentivamo "il sole" della maestra che parlava e in crescendo ma mai arrivando ai destinatari dormienti. Ero uno studente dai talenti multipli: dipingevo e scrivevo racconti che leggevo al mio amico Ibrahim e provavo un piacere enorme a recitarli ad alta voce, come ora, ancora. La mia primissima poesia l'ho scritta per caso. Era una festa – della vittoria nella guerra di Suez 1956, nonostante la sconfitta subita poi nel 1967 – e la poesia attirò molta attenzione, in particolare da parte di un famoso poeta lirico, Morsi Gamil Aziz (Zaqaziq 1921- Il Cairo 1980), che era nostro parente. L'incoraggiamento del grande poeta mi ha stimolato a rivolgermi alla lirica, così ho scritto tante canzoni ma non sono riuscito mai ad incontrare il nostro parente-poeta e le canzoni sono rimaste nel mio cassetto. Completata la scuola primaria, il mio rapporto con i libri era limitato solo al libro di testo, e poi sono passato alla scuola media. La portineria posteriore, dedicata solo all'entrata degli insegnanti, era proprio davanti alla porta della casa nostra, perciò usavo solo questa entrata privilegiata rafforzando il mio rapporto con il portinaio che ogni volta mi lasciava passare sollecitandomi a passare veloce prima che se ne accorgesse qualcuno, e come se stessi entrando allo stadio internazionale del Cairo o al palazzo presidenziale. Ho aderito subito agli Amici della Biblioteca, con un bibliotecario, signor Hanafi, che era una persona elegante e bella che assomigliava a un grande attore egiziano di quel tempo, e nonostante i quaranta anni d'età era ancora scapolo. Con il signor Hanafi c’è stato un rapporto molto forte: egli mi permetteva di prendere tutti i libri che volevo leggere senza limitarsi al numero di libri permessi. Un giorno il professor Hanafi mi ha chiesto di venire a scuola dopo la preghiera del venerdì per aiutarlo a mettere in ordine i libri della biblioteca: in quel giorno è cominciata una nuova fase della mia vita con la scoperta che tanti libri della biblioteca non erano registrati, e tanti di questi mi furono donati dal professor Hanafi. Ci volle un'ora intera per trasportare i libri dalla scuola a casa mia che era molto vicina. Il nucleo di questa piccola biblioteca a casa conteneva più di centocinquanta libri che coprivano conoscenze varie. In quel momento mi sentivo un intellettuale importante, ma si trattava di un'illusione. Ero, in verità "un asino che trasporta libri", come dice il motto arabo. Ero fiero di possedere tutti quei libri, anche senza 185 la rivista dell’ Arte leggerli. Ogni volta che ci visitava qualche ragazzo della famiglia o del paese ero molto attento a farlo entrare nella camera mia per fargli vedere l'armadio degli argenti che era miracolosamente trasformato in libreria. Questa situazione è durata più di un mese: io pulivo e mettevo in ordine i libri, senza dar nemmeno un'occhiata al contenuto. Un giorno il Professor Hanafi mi ha chiesto: "Cosa hai letto finora? Voglio che tu scriva un riassunto di ogni libro che leggi…". Uscii dalla biblioteca senza pronunciare una sola parola. Ritornando a casa mi sono messo subito a leggere come un pazzo, e quindi a scrivere quello che avevo capito, per ritornare dal professor Hanafi, che mi incoraggiava e mi dava i libri che cadevano sotto le sue mani, con quello che avevo scritto. Da qui è cominciato la mia passione per la lettura in tutti i campi della conoscenza, in letteratura, politica, arte e religione. Ho letto le opere di Al Accad, Taha Hussein, Hassanein Heikal e Zaki Naguib. Nel frattempo la poesia era esplosa dentro di me, ma mi limitavo a descrivere i sentimenti romantici, le esperienze personali ed in particolare le esperienze emotive. Le mie prime poesie erano scritte in arabo classico. Di politica e di affari sociali non ne sapevo nulla, e non scrivevo nulla. Solo una volta, emozionato del massacro di Sabra e Shatila, ho scritto una poesia. Ma era una caso di anomalia. La mie attività poetiche erano limitate durante l'università. Si trattava di concorsi di poesia organizzati dall'università e della pubblicazione di alcune poesie nella rivista della facoltà, che vedeva luce una volta all'anno, o nelle riviste murali di tipo culturale. Si trattava di giornali redatti dagli studenti ed affissi ad un muro della scuola o dell’università. Appena ho finito il servizio militare ho deciso di emigrare per motivi vari che non trovo conveniente menzionare. La mia destinazione era l’Italia: se tutte le strade conducono a Roma, Roma conduce a tutte le strade del cuore. Roma per me era affascinante: la più bella delle belle. In Italia i primi tempi furono molto difficili: era un periodo di scelte e di autodeterminazione: dovevo stabilire tutto, il lavoro, la casa, la famiglia. Questo primo momento fu proprio lungo: dieci anni, in cui ho scritto niente. Ma ho constatato che la causa della mia patria mi preoccupava di più. Seguivo con ansia tutte le notizie dell'Egitto. Forse è la lontananza che ci rende più sensibili per la patria, o rende la patria più dolce e più cara. La situazione continua così senza lettura né scrittura, fino alla prima Intifada e l'assedio di Yasser Arafat, il 186 la rivista dell’ Arte martirio della bambina Iman Hijo, autobomba di una ragazza palestinese, il martirio del bambino palestinese Mohamed el Dorra fucilato mentre cercava rifugio tra le braccia del suo povero padre che non ha potuto garantire al figlio nessun senso di sicurezza. Le mie poesie sono rinate in quel contesto, spontaneamente come se fossero esplosioni vulcaniche. Di scatto si sono scatenate dentro di me le poesie, ma questa volta in dialetto: la lontananza è ancora lì a farmi dimenticare il classico o di dover scrivere in classico. In quel periodo ho scritto più di cinquanta poesie finora inedite. Era buona la ricezione di queste poesie da parte degli amici, dimostranti in tende da loro costruite davanti alla sede delle Nazioni Unite (FAO) a Roma per più di due settimane. Così ho cominciato a rileggere i poeti dialettali egiziani: Da Badie Khairy, Beiram el Tunsi, Salah Gahin, Fuoad Haddad fino al Abnodi e Ahmad Fuoad Negm. Perché il dialetto? Mi sono accorto che la poesia dialettale è la produzione locale artigianale; è come un piatto di felafel e fave cotte, che fa resistenza alla fame per lungo tempo. Ho considerato il dialetto la lingua ufficiale del popolo egiziano: nei dialetti c'è il calore e la promessa mantenuta delle parole, le parole dialettali sono più dolci e pietose. È una lingua che ha mille mani, una che asciuga le lacrime e una che ti accarezza, una combatte la malvagità e una va contro la corruzione. C’è una mano che ha mille dita che puntano la mira sui nostri vizi e sui nostri difetti. Anche se sono stato in Europa per più di 25 anni non sono stato influenzato molto dalla cultura occidentale, ma sono consapevole della mia profonda ammirazione per questa civiltà: mi sono trovato bene sotto il suo ombrello e essa ha approfondito la mia conoscenza di cosa si intende con i termini: civiltà, libertà, diritti umani e valore umano. In Italia ho avuto la voglia di vedere l'Egitto, e tutti i paesi arabi, come anche l’Italia; ho sperato che l'Egitto e tutti i paesi arabi avessero il diritto di espressione, di cura sanitaria, di istruzione, e quanto avrei voluto che la polizia avesse servito il popolo e non che il popolo e la polizia fossero al servizio dello Stato, quanto avrei voluto che ogni cittadino fosse trattato come un valore aggiunto alla sua nazione, quanto avrei voluto che la corruzione fosse diminuita ovunque e che la giustizia e l’uguaglianza fossero prevalse sempre. Per la mia esistenza fuori dei confini della patria sono stato in grado di vedere tutti i difetti e le carenze di ogni tipo di cui soffre l'Egitto e di cui ho scritto nel mio primo libro: Maschio, musulmano… in transito pubblicato verso la fine dell'anno scorso. Ora sto preparando la pubblicazione del mio secondo libro di poesie che si intitola Stagioni di lacrime; sto anche finendo la stesura di un romanzo intitolato La morte cammina a piedi che sarà tradotto in italiano e 187 la rivista dell’ Arte che parla delle condizioni degli egiziani e degli arabi nella diaspora”. La scelta del dialetto La scelta linguistica dei tre poeti è decisamente il dialetto egiziano: malgrado qualche sfumatura nordica, il dialetto cairota prevale. Le poesie, dalla prospettiva linguistica, sono più vicine a quelle di F. Haddad o A.H. Negm, ma non al linguaggio caratteristico del Sud, quello di Abnoudi. Qualche novità linguistica, però, c'è in questa poesia. Uso nuovo delle parole. Più libertà nell’avvalersi del lessico. A volte anche uso di formule, o addirittura frasi intere, in italiano, scritte in lettere arabe, come vedremo. Il titolo del libro di Hesham Fayadh è un esempio dell'uso linguistico particolare: Maschio, musulmano… in transito. Queste sono le parole che un emigrante partendo dall'Egitto, per l'Italia, tramite un altro paese di transito (in questo caso uno dei paesi dell'Est dell’Europa che offrono biglietti d'aereo molto scontati) deve recitare a memoria davanti agli sportelli dei visti. Ma nello stesso tempo rappresentano le diverse componenti dell'identità dell'autore. È maschio: la maschilità indica certe condizioni di vita in società, quella d'origine, fortemente definita come società maschilistica. Una definizione mai rispettata in Occidente, ma fortemente condannata dallo stesso poeta. È musulmano, un altro fattore controverso in Occidente. Ma lui si trova qui, in Mahjar, solo di transito. Non vi permane sempre. Ritornerà un giorno. È il sogno del ritorno che impedisce all’emigrante egiziano di integrarsi facilmente in Occidente. È lo stesso sogno che lo rende più pacifico non considerando il Mahjar il suo campo vero di battaglia e di lotta politica e sociale. La metafora nel titolo è un uso normale nella poesia, ma unire tre parole che non hanno un chiaro legame e che sono legatissime al livello dell'esistenza, si considera un uso inconsueto nella poesia dialettale araba. D'altro lato troviamo inserite, per esempio nelle poesie di Mohamed Yusef Ismail, parole "oscene" secondo il modello tradizionale della letteratura locale in Egitto, che considera le "parolacce" come un registro linguistico molto basso. È vero che ci sono tante poesie in dialetto egiziano che usano con libertà delle parolacce, ma sono per lo più o non pubblicate o in qualche modo clandestine. Ma qui il poeta ha trovato il coraggio di pubblicare poesie in cui vengono usate parole tipo "scopare" o "frocio", come nella poesia di Yosef intitolata "America": paese che insegna la libertà 188 la rivista dell’ Arte combatte il socialismo insegna l'arretramento religioso sviluppa l'arte della "frocia"… e in un'altra poesia dice: mi faccio "scopare" da Berlusconi… e ancora: vorrei diventare omosessuale… e laico Lo stesso poeta, che meglio porta queste innovazioni linguistiche degli altri due, usa ancora delle frasi italiane scritte in lettere arabe, delle quali si può indovinare il significato, o almeno stimola l'ascoltatore o il lettore a volerne conoscere il significato. In una poesia intitolata "Roma" il poeta usa un ritornello che dice " "ا او اche vuol dire "aspettatemi ogni sera". Questa tendenza linguistica riflette però un riavvicinamento verso la realtà egiziana. È lo stesso atteggiamento di tutti i migranti del mondo: allontanandosi fisicamente dalla Patria, se ne sentono più vicini spiritualmente. L'egizianità non si sente affatto se non fuori dell'Egitto, così come l'italianità. Nelle poesie dei tre poeti ci ritroviamo subito davanti a questo sentimento forte di patriottismo. In una poesia di Magdi Sarhan, scritta per festeggiare la cittadinanza italiana, il poeta insisteva sul fatto che non dimenticherà mai che è egiziano di origine: mi hanno detto: ora sei italiano! Ma come? Sono egiziano Amo la mia fede e le mie origini La mia civiltà è quella dei faraoni […] Evviva patria mia Senza la quale non sarei mai stato Il poeta che scrive per ogni egiziano… M. Yosef presenta una definizione del Termine Patria in una poesia che si intitola così: 189 la rivista dell’ Arte cosa vuol dire la parola: patria? Terra, cielo e quartieri Acqua, alberi e fogliame Senza la quale la nostra vita sarebbe stata umiliazione e sottomissione amore proibito tristezza e lacrime prigione illegale voce muta via senza uscita questo è il senso il significato della parola: patria La patria di Hesham Fayadh è espressa in modo diverso: lui parla del "mal d'Egitto", in una poesia intitolata "ti amo, Egitto" dice: canto per te, mio paese, Egitto sono un ragazzo che ha bevuto il tuo vino si è lavato nel tuo Nilo sotto il tuo cielo ha messo il suo letto e si è addormito coperto dalla tua notte sono l'innamorato che canta il suo amore… In un'altra poesia intitolata "La mia egizianità" dice Fayadh: mi fa male la mia egizianità o Samra, come se fosse un ferita infettata, piena di rancore come se fosse un pasto mal digerito… Nella poesia dialettale locale egiziana, cioè prodotta in patria, si parla anche dell'Egitto e dell'amor di patria, ma qui la differenza consiste nel fatto che i poeti locali cantano il bel paese, la patria forte e grande, al contrario degli espatriati che la vedono debole e bisognosa di sostegno. I poeti locali non seguono per esempio la cronaca locale, le catastrofi, le calamità, naturali e non, per commentarle nella loro poesia, al 190 la rivista dell’ Arte contrario dei migranti che a volte vedono le normali quotidianità con occhio catastrofico. Questo vuol dire che il motto famoso di colui che vede meglio dal momento che vede da fuori non è preciso, perché la poesia migrante egiziana manifesta che chi vede da fuori sente più forte la propria patria, e ciò forse avviene perché non vede bene, o non vede affatto. È più disposto a stereotipare e ad amplificare gli eventi. Così troviamo nelle tre raccolte tante poesie che criticano severamente la situazione politica, economica e sociale del paese d'origine. Mohamed Yosef in particolare si immedesima con l'Egitto nel suo libro Insegnami come si nuota Ahmad, è il suo portavoce, quasi tutte le poesie narrate con l'io femminile si riferiscono all'Egitto. L'autore stesso avverte il lettore all'inizio della sua raccolta affermando che non bisogna capire le sue parole alla lettera, ma bisogna meditare per interpretare il codice con cui scrive le poesie. Secondo questo codice la patria si personifica in caratteri, nella maggiore parte femminile. Così fa anche, a volte, Fayadh, mentre Magdi preferisce essere diretto e semplice. Una delle caratteristiche delle poesie di questi tre poeti egiziani che riguarda i temi trattati è l'attenzione speciale alle questioni della politica estera ed internazionale. Fayadh parla dei rapporti arabi-arabi nella poesia "Gli anni" in cui si rammarica di vedere i paesi arabi separati da confini artificiali che non riconoscono la loro unità linguistica e culturale. Lo stesso autore parla dell'Intifada palestinese: La questione.. e la verità Sulla mappa e sulla tavola Tutti firmano Tutti tacciono La metamorfosi la verità La mappa si frantuma in pietre e si impasta Col sangue del ragazzo Che fa parlare le pietre frantumate Quando cadono sulle teste dei soldati Lo stesso autore parla anche del Gatt (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio) e il suo effetto sulle economie nazionali, come una forma nuova del colonialismo, questa volta economico. Magdi Sarhan comincia la sua raccolta con una poesia intitolata "Il mondo" in cui dice: Il mondo attorno a noi 191 la rivista dell’ Arte Un'epopea inspiegabile In cui ci sono mostri feroci È trasformato in una casa dell'orco George Bush, con inaccettabile politica Ha bruciato terre Rubato campi di petrolio Venduto merci marcite La libertà a modo suo … I cretini, figli di cretini Lo hanno considerato come un protettore… Lo stesso autore parla anche dell'Afganistan, del Sudan, e naturalmente della causa palestinese, come fanno tutti i poeti nelle raccolte che presentiamo in questo saggio. Dal suo canto M. Yosef sembra occupato dell'immagine internazionale dell'Egitto che ha visto indebolire il suo ruolo regionale. In una poesia intitolata: "La notte afgana" dice: bambini muoiono di notte affamati escursioni per bombardare la Libia un razzo colpisce un aereo dell'Egitto da tempo in tempo colpi duri in Sudan ed in Iraq politica sporca puttana insulta Maometto e Kaaba Dio e fede Tutto il mondo risponde in coro: Amen E noi Siamo solo donne incapaci Un mondo di penne Di fumo Abbiamo paura di essere crocifissi Chiniamo la testa a Sharon Agli americani Le lacrime soffocate mi dicono Non sono uomo 192 la rivista dell’ Arte Yosef dedica una poesia al primo ministro italiano, Berlusconi e parla di Roma, usa parole italiane nelle sue poesie, così sembra l'unico tra i tre poeti più vicino alla cultura in cui sta vivendo, che però non sembra, per lui e per gli altri due, essenziale nel suo mondo poetico. A che serve allora la cultura del paese di destinazione? Per questi poeti la destinazione italiana era solo una patria adottiva, ma non la sua cultura. La poesia loro è dedicata esclusivamente agli egiziani, pertanto è scritta in egiziano e pubblicata in Egitto. Ma la cultura occidentale, italiana in questo caso, serve da riferimento. Essa certamente ha avuto un ruolo cruciale a costruire la visione critica del poeta. Ma serve anche a criticare secondo valori, canoni nuovi che appartengono ad una cultura diversa. Due poesie di Magdi Sarhan Fratello Gesù Il tessuto è sempre unico Ha un colore vivace in ogni filo Chi vuol tagliarlo Deve essere un ingrato, un folle o un malato. Terrorista superbo che pensa di essere martire se si scoppia abbracciando Marco o Shalit; non sa che fine avrà... un inferno eccessivamente bruciante, quel terrestre che lo decide un uomo savio e coraggioso ascoltate da me queste parole utili: i giorni di Maria e Gesù sono con noi condivisi li abbiamo sentiti in chiesa che parlavano d’amore… non di odio giuro su Maria e il bambino che gli assassini hanno tradito tutti i santi ed hanno tradito anche la moschea dei musulmani ditemi chi siete 193 giuro su Dio che nessuna fede avete siete invece una spina nel dorso della nazione che da anni spruzza veleno siete traditori assassini maledetti da ogni fede e religione potete anche sedurre i diavoli ripeto e ribadisco queste due parole in nome mio, in qualità di musulmano vi dico: non dimenticate che Gesù, ha condiviso con noi la sua vita e che l’abbiamo sentito in chiesa che la sua è una religione di amore senza odio Amante di Roma Dopo anni di dispatrio ritorno Mi addormento e nel sonno vedo Roma, assai bella che si affaccia fresca Che mi corteggia, tramite guance di fanciulle e tramite occhi Mi dico: scambio ogni tanto me le concedo e me le lascio Vedo un fiore di color rosa sulla fronte Dico: colgo il fiore o meglio annaffiarlo O mi do, con la mia mano, l’amarezza dell’abbandono Ho vissuto incantato dal tuo amore eri sogno che si trasforma in speranza dico: sei Roma, come sei sempre Con te ho vissuto la mia vita, ed eri al mio fianco Con tutto l’amore temo che ti perdo Tu sei il ricordo fantastico disegnato dal cervello A te l’amore, l’affetto da tutto il cuore Amore, Roma, continua ad essere come eri la rivista dell’ Arte la 194 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Laila Wadia Ironia La prima parola che ho scelto per il vocabolario di Fahrenheit è ironia1. L’ho scelta perché è una delle mie strategie di comunicazione letteraria. La parola ironia deriva dal greco eiro, ovvero “dico e esprimo il contrario di quello che penso e quello che le parole significano”. Nella mia madrelingua, l’inglese (sono figlia della colonizzazione britannica), si traduce in irony, che mi piace scomporre in un suffisso iron (ferro), qualcosa di solido, fermo, irremovibile, con la coda leggera della lettera epsilon. Mi sembra così di avvolgere una considerazione ferma e forte in un involucro diafano per rendere il messaggio più fruibile, ma non per questo più superficiale. In hindi, una delle lingue sorelle della mia India natia, si distingue tra l’ironia raffinata detta vyajstuti (trascrizione fonetica) – in cui forse si sente un richiamo fonetico alla parola italiana “astuzia”, e l’ironia più scherzosa, chiamata “boli-tholi”, quasi onomatopeico della burla. L’ironia è un’arte che ho imparato ad apprezzare da grande dai grandi pensatori – da Socrate a Gandhi. Il Mahatma, infatti, sosteneva che senza l’ironia e l’autoironia, lui si sarebbe suicidato. L’ironia è un’arma di denuncia formidabile. Gandhi la usò spesso come metodo di opposizione nonviolenta. Ad esempio, durante la lotta per l’indipendenza dell’India, un giornalista inglese chiese al Mahatma Gandhi cosa ne pensasse della civiltà inglese. “Cosa ne penso della civiltà inglese?” rispose 195 la rivista dell’ Arte Gandhi sorridendo. “Penso che sarebbe un’ottima idea!”. Da piccola, come tanti bambini indiani, ho conosciuto l’arte dell’ironia dalle leggende di Akbar e Birbal. Akbar era un imperatore mogul del XVI secolo (spesso definito come l’architetto dell’India moderna) e Birbal era il suo ironico primo ministro indù. Queste leggende sulla giustizia eseguita per risolvere sia le questioni di stato sia i problemi della gente comune usando l’astuzia e la saggezza sono dei classici della lettura dell’infanzia in India. L’ironia è un grido di dolore mascherato da un sorriso di chi ama profondamente. Di chi presta molta attenzione sia al senso sia al significato delle parole. È anche uno strumento di partecipazione dato che per poter ridere insieme, bisogna condividere certi valori. Infine, mi piace pensare all’ironia come un’arma di istruzione di massa. 1 Cfr. la puntata di Radio tre - Fahrenheit del 22 novembre 2010, disponibile online all’indirizzo: http://www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/. la 196 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Francesco Armato Sui prati, ora in cenere, d’Omero Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo e la fuga di Ulisse dal Mediterraneo Negli ultimi decenni, le riscritture del mito di Ulisse hanno preso forma dalla penna di scrittori di tutto il mondo, dal brasiliano Haroldo de Campos al libanese Khalil Hawi, dal premio Nobel nigeriano Wole Soyinka a un altro Nobel, il caraibico Derek Walcott. Anche due italiani, Vincenzo Consolo e Luigi Malerba, hanno apposto la propria firma nell’inesauribile epopea contemporanea dell’eroe di Itaca1. Ma nel panorama mondiale delle riscritture moderne dell’Odissea, una delle operazioni più clamorose è il romanzo Horcynus Orca (1975) di Stefano D’Arrigo che merita un discorso a parte: l’opera darrighiana chiude, infatti, il ciclo “tragico” delle odissee novecentesche2. L’Odissea di ’Ndrja Cambrìa, protagonista del romanzo, è concentrata tutta in pochi giorni, a cavallo tra il settembre e l’ottobre del 1943, dunque immediatamente dopo l’armistizio seguito al “proclama Badoglio” dell’8 settembre3. La stesura del romanzo costò a D’Arrigo diciannove anni della sua esistenza, dal 1956 circa al 1975, tutti praticamente donati all’altare di Horcynus Orca. Un’odissea anche questa, un’avventura della mente nel magma della scrittura, che il genio darrighiano ha plasmato e riplasmato dando vita a un 197 la rivista dell’ Arte oceano di immaginifica realtà. Horcynus Orca si presta come pochi altri romanzi italiani del secondo Novecento a un’indagine comparatistica. Ridiscutere questo componimento narrativo ponendolo al centro di una rete di dibattiti non più esclusivamente a carattere nazionale ma a livello europeo e perché no? mondiale, consentirebbe, infatti, l’elaborazione di un discorso nuovo e più aperto transculturalmente che verserebbe nuova linfa tra le ingiallite pagine del libro novecentesco, oltre a concedere finalmente l’occasione all’opus darrighiano di diffondersi e cercare altra fortuna aggirando gli ingorghi dell’affollata strada del mercato editoriale italiano e le insidie di una pausa, potenzialmente interminabile, nel vicolo cieco dei libri in attesa del “giudizio universale”. Dunque, è giunto il momento di compiere un salto, di agire su un altro versante inaugurando, per quanto concerne Horcynus Orca s’intende, un modo diverso di fare critica che guardi al capolavoro dello scrittore siciliano nelle significative relazioni che lo legano ad una letteratura più mondiale che mediterranea. Nel romanzo di D’Arrigo il tema dominante è il ritorno ad Itaca, il nostos del protagonista che gradualmente si risolve in un nostos-rimandato. La relazione più immediata è al contempo la più valida che si possa stabilire: quella con l’Odissea. Del mancato, o forse sarebbe più appropriato dire “impossibile”, incontro con il mito parla D’Arrigo nel suo racconto, nel quale un giovane ulisside sopravvissuto a una terribile guerra, torna a casa per poi scomparire improvvisamente (o se vogliamo, per poi scegliere di scomparire), tra le onde del suo mare. Un modo per cancellarsi, per non contaminarsi come la Storia pretenderebbe. In Horcynus Orca il Mediterraneo diviene l’urna funeraria del mito. E quindi, aiutiamo anche noi l’Orca a valicare le colonne d’Ercole per accedere ad un altro mare, l’Oceano di Atlante, il nec plus ultra della cultura antica – greca-romana e cristiana insieme, e il plus ultra degli europei moderni. Il secondo motto latino, infatti, è quello dell’imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V. In fin dei conti, insomma, l’alto mare atlantico è l’habitat ultra, “naturale”, forse, del poema di Ulisse. Le odissee come riscritture La letteratura comparata ormai da decenni si propone come importante strumento epistemologico, oltre che metodologico per stabilire una prospettiva mondializzata della letteratura tra il secolo novecentesco e il 198 la rivista dell’ Arte nuovo secolo. L’apparato critico della comparatistica presuppone una capacità d’analisi che sia il più possibile aperta e dinamica e inoltre si avvale spesso di apporti multidisciplinari. In tale direzione si muove, per esempio, la pioneristica prova di Nora Moll4 che ha svolto un’appassionante ricerca con il fine, tra le altre cose, di introdurre Horcynus Orca nel mare delle riscritture novecentesche dell’Odissea. Come giustamente sostiene Piero Boitani fu proprio Omero ad aprire la strada alle future semiotizzazioni di Odisseo e dell’intera Odissea, «perché egli è creatore di segni capaci di accogliere un significato ogni volta che esso incontra un significante e infatti, età successive ‘riconosceranno’ se stesse in quel segno, attribuendogli il significato del proprio momento storico opportuno – del loro kairos – e del proprio sistema di valori»5. Ogni riscrittura si stacca dalla radice per intraprendere un tragitto proprio, il grado di fedeltà al testo originale varia, come è ovvio, da caso a caso. Nello specifico di Horcynus Orca, la radice madre è certamente l’Odissea ma sono innumerevoli i rimandi ad opere del passato amate dall’autore siciliano. Una maestosa operazione di omogeneizzazione della scrittura e della trama del racconto ha consentito però a D’Arrigo di mimetizzarsi dietro le parole e di far apparire tali riferimenti consustanziali alla natura unitaria del testo. La straripante scrittura dello scrittore diventa così lo strumento stilistico originale che permette di mascherare questi omaggi. In Horcynus Orca il teatro dei Pupi e l’intero ciclo carolingio, Melville e Joyce, Vittorini e Verga sono quindi “fantasmi” più che fonti d’ispirazione. Il citazionismo è comunque lampante; tuttavia, i riferimenti non sfociano in vacua imitazione e pertanto non danno mai luogo a deliberati pastiche. La consapevolezza di non poter mai comprendere la complessità del reale in un unico discorso conoscitivo6 e la critica alla società capitalistica basata sul trionfo della merce sono invece argomentazioni assimilabili a gran parte della letteratura occidentale dopo la seconda guerra mondiale. Ma al di là del lecito o illecito (opportuno o inutile?) inquadramento critico-letterario del romanzo, resta il fatto che non furono – e a dire il vero non sono ancora oggi – molti coloro i quali hanno studiato la riscrittura di D’Arrigo nei rapporti intertestuali con l’Odissea; le ragioni potrebbero essere almeno un paio. La prima spiegazione può apparire come un’arrogante provocazione, ma nel caso di Horcynus Orca bisogna assumersi il rischio di mettere in dubbio l’etica professionale di alcuni critici perché, come dice Walter Pedullà, «tutti hanno il diritto di non apprezzarlo, ma sarebbe onesto che tutti lo leggessero. I più acerrimi nemici del romanzo sono quelli che non l’hanno sfogliato e che vorrebbero sentirsi dire che non vale la pena perderci tempo sopra»7. Questo argomento polemico non vuole attivare un gratuito attacco ai detrattori del racconto darrighiano, bensì una chiave interpretativa di sviste-omissioni e assurde considerazioni che non troverebbero, altrimenti, la 199 rivista dell’ Arte giustificazione critica. Horcynus Orca vive della sua indispensabile totalità, è un’opera indivisibile «piena come un uovo, dove è nutriente anche il bianco»8, e chi non ha la voglia, la forza o il coraggio di leggerlo da cima a fondo, dovrebbe astenersi dal giudizio. In secondo luogo, si ha la sensazione che alcuni critici abbiano considerato elementare e banale leggere il libro di D’Arrigo come una riscrittura odissaica; troppo facile, deve esser sembrato loro, accogliere e rielaborare gli impulsi dell’autore (il tema centrale del nostos rimandato, i nomi di luoghi e personaggi, la riproposizione di alcune situazioni e la parodia di certe azioni già narrate da Omero) in un’ottica intertestuale imposta dal richiamo dell’Odissea. Ad ogni modo, che in Horcynus Orca vi siano abbondanti riferimenti a Joyce, Vittorini e Melville nessuno lo nega e a tal proposito molte letture critiche hanno fornito esiti interpretativi davvero apprezzabili e di notevole spessore. Gli elementi che fanno pensare a un ammiccamento di D’Arrigo rivolto all’opera dello scrittore americano sono stati studiati per esempio da Marco Trainito che, oltre ciò, ha brillantemente rilevato il simbolismo segreto di Horcynus Orca. Nel suo saggio9, scopriamo alcuni possibili nessi e rimandi del testo darrighiano: partendo dall’Orca si arriva al Leviatano biblico attraverso la storia di Giona nella pancia del grande pesce, e a Giobbe XL, 22-35 e XLI, 1-26 (descrizione del Leviatano-coccodrillo). Secondo Trainito i legami di D’Arrigo con Melville sono strettissimi e si rivelano in molti episodi, come quello in cui Ferdinando Currò, il valoroso “pellesquadra”, ardisce l’impresa impossibile di “lanzare”10 l’animalone come il più imprudente melvilliano capitano Achab. Ma la più sorprendente corrispondenza tra Horcynus Orca e Moby Dick sta nella riproposizione dei temi dell’unicità, dell’onnipresenza e soprattutto dell’immortalità affibbiati all’Orca orcinusa e che già avevano accompagnato la leggendaria balena di Melville. Detto questo, per conoscere i significati simbolico-allegorici dell’Orca, basterebbe leggere Northrop Frye11: il grande critico canadese, nella sua opera, scritta nel 1957, elabora teorie sui simboli e sui miti della letteratura. Così ogni mostro marino diventa il Leviatano biblico, fonte di sterilità sociale che compare nei momenti di crisi, dopo catastrofi e carestie, proprio come accade nella piccola comunità cariddota12 falcidiata dalla guerra. Inoltre, come in ogni romance, l’eroe darrighiano è un individuo “superiore per grado” agli altri uomini che gli stanno intorno. Dunque, l’estesa miopia critica nei confronti di un’opera così smisurata e ricca di “sostanza letteraria” non ha colpito indistintamente tutti; pochi ma autorevoli critici hanno speso parole importanti per D’Arrigo e l’Orca. C’è chi, come Trainito, ha interpretato i rimandi simbolici disseminati nelle 1257 pagine del 200 la rivista dell’ Arte romanzo e chi come Walter Pedullà ha declinato ogni “quadro” presente in Horcynus Orca secondo lo schema omerico del nostos a tappe: l’ultimo viaggio dell’eroe in cerca della redenzione prima del definitivo ritorno a casa. Pedullà è stato il primo a vedere nel percorso di ’Ndrja lo spessore tragico di una oscura odissea contemporanea: «Itaca è un’isola infetta in cui si può solo morire. ’Ndrja obbedisce all’imperativo assoluto che ha dato alla sua vita»13. Rifacendosi ancora a Northrop Frye e ad alcune delle sue teorie applicabili al testo darrighiano, Pedullà s’interroga sui significati non manifesti del racconto: perché, ad esempio, è il mare a dominare costantemente l’orizzonte del protagonista? «L’acqua appartiene tradizionalmente a un regno d’esistenza inferiore alla vita umana, cioè allo stato di caos o di dissoluzione che segue alla morte naturale o alla riduzione all’inorganico»14. Troneggia sopra ogni cosa il mare, «omphalos dove tutto inizia e finisce»15. Il caos, la guerra, la morte. Tutto, in definitiva, è riconducibile al mare, dove la vita ha inizio e dove, prima o poi, termina. Pedullà non è stato il solo a leggere il grande romanzo di D’Arrigo come una tragica odissea del XX secolo. Claudio Magris, infatti, con parole semplici e incisive ha espresso un’opinione simile, avallando quanto affermato in precedenza in merito alla corrispondenza Odissea-Horcynus Orca: Con Horcynus Orca Stefano D’Arrigo ha scritto uno straordinario libro di mare, eccessivo e smisurato come quest’ultimo: un’odissea contemporanea nella quale l’orizzonte marino diviene, come in Melville o in Conrad, il paesaggio dell’avventura umana, del viaggio nella pienezza e nel caos dell’esistenza16. Per Giorgio Bàrberi Squarotti, invece, Horcynus Orca è sì un tentativo ben riuscito di “manipolazione” e reinterpretazione dell’Odissea, ma le attinenze principali intercorrono con Moby Dick e con l’Ulysses di Joyce: […] l’epica moderna non può assolutamente risolversi nel verosimile e nel realistico, neppure per un istante; e allora ecco la necessità di inventare anzitutto la lingua della nuova epica […]. Melville e Joyce sono, anche in questa prospettiva, i punti di riferimento opportuni17. Attualizzazione del mito e nuova epica. D’Arrigo, nel suo libro è perfettamente cosciente della crisi morale della civiltà occidentale postbellica; questa degenerazione ha colpito anche le umili popolazioni che abitano la 201 rivista dell’ Arte lo Stretto di Messina, piccola porzione dell’antico bacino Mediterraneo. L’autore descrive un’odissea da leggersi come malinconico e accorato lamento di chi è convinto – lo scrittore marsigliese e quindi mediterraneo anche lui, Jean-Claude Izzo, ne sa qualcosa – che «il nostro paese, le nostre radici, la nostra cultura, è tutta su questo mare, in questo mare»18. La traccia è la stessa ed è la nostra storia a parlare: ovunque la vita ci porterà, noi individui mediterranei, alla fine dei nostri giorni punteremo dritti in una sola direzione per tornare, un’ultima volta, dinnanzi al nostro mare. Qui, dove m’assomiglio, in patria, sui prati, ora in cenere, d’Omero, io da una guerra reduce, e da quante un gran figlio mi ricorda mia madre, perduto con lo scudo o sullo scudo, desidero tornare spalla a spalla coi miei amici marinai che vanno sempre più dentro nei versi, nel mare19. E proprio da questo mare – epicentro esistenziale – non può che sopraggiungere l’apocalisse, frutto della guerra, che cancella la memoria e rende l’uomo misero e inconsapevole della propria storia. L’incontro dissacrante del mito con la storia provoca, in Horcynus Orca, un regresso verso la morte. La constatazione disillusa della fine del mito antico e longevo è espressa prima nella parabola terrena del protagonista e poi si incarna nella figura dell’Orca, mostro sconvolgente e riflesso marino del disastro terreno. La conoscenza darrighiana si traduce nella semplice e amara certificazione della fine. Di un’epoca, di una storia e di una vita. E quindi se al mare tutto torna, anche l’Ulisse siciliano ’Ndrja non può sottrarsi al suo destino: anch’egli, infatti, viene riassorbito nell’ultima pagina del libro. Il mito nato nel Mar Mediterraneo è adesso senza alcuna dimora possibile. L’opera di D’Arrigo si candida a essere l’ultima vera odissea mediterranea. Questo significa anche che il Mediterraneo non è più la conca del mito che ci 202 la rivista dell’ Arte riguarda. Quel mito è diventato mondiale, dopo la vera prima guerra mondiale, e, allo stesso tempo, è diventato fisso e fossile per noialtri. Dopo la guerra devastante degli anni 40, il destino del mare e del nostro sguardo indigeno è stato scoprire che esso, semmai, è diventato l’urna funeraria di migliaia di “dannati della terra” che vengono a morire nel “mare color del vino”, da tutti gli angoli del Mondo, qui dove noialtri siamo nati. Del resto, Ulisse, al suo tempo, aveva già intrapreso un percorso che non prevedeva alcun ritorno. Ma quale è stato il “suo” tempo, quello fissato nella fonte archetipica del mito omerico o quello fluido e progressivo della longevità del mito in Europa? Scrive Giovanni Saverio Santangelo: […] dopo aver navigato attraverso un secolo che non ha certamente lesinato guerre, massacri e violenze, non poteva restare immune dalle angosce che hanno pervaso l’animo collettivo, sempre più fiaccato nelle sue speranzose pulsioni e nelle sue pur generose utopie. Anche l’immortale Ulisse, ormai, non può più soddisfare nella tradizionale e abusata versione dantesca. Non più, dopo la guerra nel fango delle trincee, dopo Auschwitz, dopo Hiroshima, dopo i massacri in terra d’Algeria, dopo le interminabili ed orrende carneficine perpetrate nei paesi balcanici. Dopo, dopo…20 Dall’orca all’arca: la fuga di Ulisse Se da un lato le odissee del Novecento certificano la morte del mito, come in Horcynus Orca, dall’altro lasciano comunque aperto un varco, una speranza che significa ancora possibilità di conoscenza. La missione è sempre la stessa: scoprire i lati più oscuri della specie umana e della sua mente. Nel 1968 esce nelle sale cinematografiche un’altra criptica odissea, quella di Stanley Kubrick. L’iconografia fantascientifica di 2001: Odissea nello spazio è particolarmente suggestiva; il grande regista americano tenta di rappresentare un’esperienza visiva e narrativa – basata sul romanzo di Arthur C. Clarke, che collaborò ampiamente alla stesura della sceneggiatura – che aggiri la comprensione per penetrare, con il suo contenuto emotivo, ad agganciare la patria dell'inconscio. Il simbolismo e le allegorie del romanzo di D’Arrigo sono pensate negli stessi anni in cui Kubrick gira la più celebre delle odissee cinematografiche21. E in letteratura? Nel lunghissimo viaggio letterario intorno al mito di Ulisse, un momento di discontinuità che imprime nuovo vigore al racconto dell’epopea omerica, è rappresentato dal romanzo di Alejo Carpentier, Los pasos perdidos (1953). Una tappa fondamentale antecedente il romanzo horcynuso. Nella riscrittura odissaica la 203 rivista dell’ Arte dello scrittore cubano, cambiano le prospettive e si ragiona su un’ipotesi affascinante. Forse il mito non si sta gradualmente spegnendo, come molti pensano, perché è ormai definito come finito nella cultura europea, superfluo e inattuale, ma è la cultura mediterranea da cui ha avuto origine a non essere più in grado di riconoscersi, a non essere più nella condizione di rigenerarsi: essa è divenuta sterile. Una possibile soluzione esiste ed è la rotta suggerita proprio da Carpentier che con la sua scrittura-riscrittura porta Ulisse lontano, dove mai nessuno aveva immaginato potesse giungere, in un “mondo nuovo”, oltre l’Oceano Atlantico, nel Mar dei Caraibi. Oggi, l’immenso bacino tropicale è più predisposto rispetto al decadente Mar Mediterraneo ad accogliere e ritemprare lo spossato Odisseo. Il viaggio di Ulisse cambia così cornice e l’intervento-trapianto del mythos nel nuovo mare Mediterraneo aperto, il mar dei Caraibi, nel romanzo di Carpentier pare compiersi senza crisi di rigetto. Nora Moll approfondisce e riflette sull’operazione carpentierana: «Una nuova cultura sincretica che porta i segni della contemporaneità spazio-temporale attraverso la quale viene indicata una possibile via d’uscita dagli empasse della storia occidentale»22. In maniera differente, l’argentino Jorge Luis Borges introduce Omero e l’Odissea all’interno della sua produzione. Sia in poesia, Odissea Libro XXIII in L’altro, lo stesso (1964), ma prima ancora in prosa, come nel racconto L’Immortale, il primo della raccolta L’Aleph (1949), l’ingegnoso scrittore argentino svuota di sacralità l’antico mito omerico costruendo su esso nuovi racconti e sviluppando personali riflessioni, costringendo così il lettore a interpretare gli intrecci e le connessioni tra i molteplici livelli di lettura23. In Centro-Sudamerica, il discorso avviato da Borges nel 1949 e portato avanti da Carpentier nel 1953 con Los pasos perdidos, prosegue anche nei decenni successivi, come dimostra ad esempio La Odilea di Francisco Chofre (1968) che, a differenza della “riscrittura seria” di Alejo Carpentier composta quindici anni prima, si presenta come “riscrittura parodica” del racconto omerico24. Lo scrittore, cubano d’adozione, prende di mira la superficialità e l’insulsaggine dell’uomo occidentale e l’improbabile Odisseo di Chofre, ribattezzato Odileo, con la sua mediocrità ne diventa l’emblema. Il fatto che numerosi scrittori latino-americani abbiano scritto o riscritto su (e dei) miti occidentali come quello di Odisseo, certifica l’inadeguatezza definitiva del Mare nostrum nell’affrontare la sfida, o meglio nel cogliere l’opportunità che arriva dal nostro passato, dal mythos sbocciato nella civiltà mediterranea. Da questo mancato accoglimento per esaurimento del genere letterario ma non della fonte mitica attuale, quella tragica, potrebbe e dovrebbe scaturire un esame di coscienza fermamente critico che motivi l’incapacità del mondo occidentale – manifesta soprattutto nell’aggressiva imperizia dei paesi europei mediterranei – di 204 la rivista dell’ Arte mettersi in discussione per riuscire a presentarsi alla pari con l’immaginario del mondo di oggi. Questi racconti lontani nel tempo si presterebbero, oggi più che mai nell’Occidente del terzo millennio, a una re-interpretazione a una discussione e a un confronto proficuo che tenti di arginare il disfacimento di una cultura agonizzante, offrendo possibili rimedi ai problemi posti in essere da questo presente così saturo di ignoranza e arroganza, ma anche di dolore di popoli e persone che vengono a morire nella diga-muro invisibile gettata nello stretto tra Europa e Africa. Non una ma più voci servirebbero per gettare le basi di un nuovo concreto percorso di crescita – specialmente sotto il profilo transculturale – della nostra società, che renda quantomeno testimonianza critica, se non delazione, di ciò che sta accadendo. In pochi, finora, l’hanno capito. Il sentiero indicato da Alejo Carpentier può davvero resuscitare altrove il mito trapiantandolo in «nicchie in cui la temporalità lineare propria della civiltà occidentale viene abolita a favore di una ciclicità mitica»25? Quell’urna del mythos, ma anche del nuovo mediterraneo che è divenuto Mare dei popoli morti nel tentativo della speranza, potrà quindi trarre vantaggio da questa momentanea assenza, da questa dislocazione di Ulisse al di là dell’oceano? Vale la pena crederci, perché per vivere l’eroe omerico ha bisogno di essere raccontato, in qualsiasi modo, in qualsiasi luogo: In effetti l’Odissea non ha mai smesso di essere raccontata, da una taverna all’altra, di bar in bar… E Ulisse è sempre fra noi. La sua eterna giovinezza è nelle storie che continuiamo a raccontarci anche oggi. Se abbiamo ancora un avvenire nel Mediterraneo è di sicuro lì26. 1 Per trovare notizie più dettagliate sugli autori citati si vedano BOITANI PIERO, Esodi e Odissee, Napoli, Liguori, 2004 e MOLL tra due mari, Isernia, Cosmo Iannone, 2006. 2 Esiste un cospicuo numero di riscritture novecentesche del mito di Ulisse ma non tutte possono essere classificate in una stessa categoria. Nora Moll, studiosa e critica letteraria, nella sua ricerca intitolata Ulisse tra due mari, cit., ha ben definito il sostanziale scarto tra le riscritture “serie” e le riscritture “parodiche” del racconto omerico presenti nella letteratura europea ed extra europea: Horcynus Orca appartiene alle riscritture “serie” e, per essere ancora più precisi, al filone tragico di questo ramo. La Moll ha dunque revisionato il mito di Ulisse scoprendo la fuga dell’eroe: dal mar Mediterraneo verso il nuovo “mediterraneo”, il mar dei Caraibi. Anche Piero Boitani, tra i maggiori studiosi di questo genere letterario, ha a più riprese analizzato le tante riscritture dell’Odissea, dal mondo antico al Novecento, tracciando un percorso storico-critico di notevole importanza. 3 L’8 settembre 1943 rappresenta una data fatidica per l'Italia. Quel giorno viene dato l'annuncio dell'armistizio con gli Alleati e NORA, Ulisse 205 la rivista dell’ Arte quindi la fine dell'alleanza militare con la Germania; questa data sancisce altresì la dissoluzione dell'esercito italiano. Da qui in avanti si inaugura una fase di instabilità che vede la cattura di centinaia di migliaia di militari, a causa della mancanza di precise disposizioni da parte dei comandi militari. 4 MOLL NORA, Ulisse tra due mari, cit.. 5 BOITANI PIERO, L’ombra di Ulisse, Bologna, il Mulino, 1992, p. 33. Per una ricostruzione completa della storia del mito di Ulisse si vedano anche ANDREAE BERNARD, L’immagine di Ulisse. Mito e archeologia, Torino, Einaudi, 1983; FERRUCCI FRANCO, L’assedio e il ritorno. Omero e gli archetipi della narrazione, Milano, Mondadori, 1991; STANFORD WILLIAM BEDELL, The Ulysses Theme, Ann Arbor, Michigan UP, 1968. 6 Mi riferisco a tutti gli interrogativi e alle speculazioni letterarie (quasi poetiche) e filosofiche ricorrenti nel racconto. Per esempio, il professore che cerca vanamente per tutta la vita l’origine delle uova di anguilla che rappresentano la cellula prima dell’esistenza; o il sogno di ’Ndrja che cerca di svelare il mistero della morte delle fere trentenarie; o, infine, il più grande enigma del romanzo: l’immortalità vera o presunta di un essere vivente, l’essere degli abissi e delle tenebre, l’Orca Orcinusa. 7 PEDULLÀ WALTER, “Il caso è chiuso”, l’Illuminista, IX, 25-26, Ponte Sisto, 2009, p. 13. 8 Ivi, p. 19. 9 TRAINITO MARCO, Il mare immane del male, Gela, Cerro, 2004. 10 I “pellisquadra” sono i vecchi pescatori dello Stretto di Messina, chiamati così perché posseggono una pelle e un carattere ruvido come la cartavetrata. Caratteristiche simili a quelle dello “squadro”, che sarebbe il verdone ovverosia il pescecane. “Lanzare”, nel linguaggio dei pellisquadra, significa colpire con la fiocina, fiocinare. 11 FRYE NORTHROP, Anatomia della critica, Torino, Einaudi, 2000. Come fa notare Giancarlo Alfano, dopo un’analisi delle teorie di Frye, nel suo Gli effetti della guerra. Su Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, Roma, Sossella, 2000, p. 94, è facile avvicinare l’opera darrighiana al genere del romance e quindi rilevare la presenza di tratti non-romanzeschi. Questo spiega il perché numerosi critici si siano richiamati proprio al lavoro dello studioso canadese e ad apparati concettuali derivanti da Jung e Bachelard per studiare Horcynus Orca. 12 Cariddi, il mostro marino della mitologia greca posto da un lato dello Stretto di Messina di fronte all’altro mostro, Scilla, è menzionato anche nel XII canto dell’Odissea. Il paesino immaginario del protagonista di Horcynus Orca, prende il nome proprio dal mostro mitologico Cariddi. 13 PEDULLÀ WALTER, Per esempio il Novecento. Dal futurismo ai giorni nostri, Milano, Rizzoli, 2008, p. 402. 14 Ivi, p. 405. 15 MOLL NORA, Ulisse tra due mari, cit., p. 97. 16 MAGRIS CLAUDIO, “Horcynus Orca”, Corriere della sera, 3 agosto 1994. 17 BÀRBERI SQUAROTTI GIORGIO, “Un grande romanzo”, in IDEM (a cura di), Storia della civiltà letteraria italiana, II, 5, Torino, UTET, 1996. 18 IZZO JEAN-CLAUDE, Marinai perduti, Roma, edizioni e/o, 2008, p. 233. 19 D’ARRIGO STEFANO, ultimi versi della poesia “Sui prati, ora in cenere, d’Omero” contenuta in Codice siciliano, Milano, Scheiwiller, 1957. 20 SANTANGELO GIOVANNI SAVERIO, “Elpénor di Jean Giraudoux”, in NICOSIA SALVATORE (a cura di), Ulisse nel tempo. La metafora infinita, Venezia, Marsilio, 2003, p. 372. 21 Piero Boitani nel suo Esodi e Odissee, cit., p. 15, accenna ad un’altra odissea cinematografica d’autore: Le regard d’Ulysse di Theo Angelopoulos e Tonino Guerra, che racconta un ritorno ai Balcani insanguinati dei nostri giorni alla ricerca di tre bobine cinematografiche. Film reso famoso anche dalla tragica morte dell’attore Gian Maria Volontè durante le riprese. 22 MOLL NORA, Ulisse tra due mari, cit., pp. 171-172. Un’intera sezione di questo volume è dedicata all’operazione di Alejo Carpetier e alla “teoria dei due Mediterranei”, pp. 135-190; niente a che vedere ovviamente con “i due Mediterranei” di cui parla Fernand Braudel nell’opera recentemente ristampata, Il Mediterraneo, Milano, Bompiani, 2008, pp. 79-81; in questo caso il Mediterraneo non subisce alcun “trasloco”. 23 Cfr. BOITANI PIERO, L’ombra di Ulisse, cit., pp. 208-212. 24 Questi concetti sono discussi nel testo di MOLL NORA, Ulisse tra due mari, cit., pp. 26-33. 25 Ivi, 184. 26 IZZO JEAN-CLAUDE, Marinai perduti, cit., p. 238. la 206 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Manuela Derosas La letteratura portoricana: luogo di resistenza al dominio coloniale Mi chiedo quale sia l’idea di Porto Rico che esiste in Italia. Con un’intenzione volutamente provocatoria provo a fare una rapida ricognizione su internet alla ricerca delle informazioni che si possono trovare nei siti delle agenzie di viaggio e mi imbatto in immagini riduttive, che deformano la realtà, pervase da quel gusto per l’esotico che null’altro rivela se non un’avvilente stereotipizzazione. D’altra parte, le agenzie di viaggio devono sopravvivere e pare non importare se, per farlo, vendono un’immagine irreale. Dagli esperti della pubblicità turistica viene chiamata la Isla del Encanto: Porto Rico, la più piccola delle Grandi Antille, è un arcipelago che comprende, oltre all’isola omonima, che i suoi abitanti chiamano La Isla, anche le isole Vieques, Culebra e Mona. Borikén (Terra dell’altezzoso signore) era il nome che le diedero i Taino, provenienti dall’America del Sud, il popolo che viveva nell’isola quando vi giunse Colombo, che si affrettò a ribattezzarla San Juan de Puerto Rico. Conquistata dagli spagnoli nel 1508, dopo 400 anni di dominio cambiò di padrone nel 1898, diventando bottino di guerra USA durante la guerra ispano-americana. Dal 1959 la sua denominazione ufficiale è Estado Libre Asociado (in inglese, Commonwealth) de Puerto Rico. “Associato”, ovviamente, agli Stati Uniti. Una denominazione-farsa che significa: nel 2011, essendosi ormai conclusa la denominata dall’ONU “seconda decade dello sradicamento del colonialismo”, il colonialismo esiste ancora (e non solo a Porto Rico), riducendo i popoli all’assenza di libertà e all’impossibilità di autodeterminarsi. Certo, a differenza di altri latinoamericani, i portoricani, come cittadini statunitensi (cittadinanza concessa loro con la legge Jones-Shafroth del 1917), non vivono 207 la rivista dell’ Arte nell’illegalità come la maggioranza dei latinos alla ricerca del “sogno americano”. Pochi sanno però che la maggioranza di loro vive in ghetti, che molti di loro sono quei giovani che ingrossano le fila dell’esercito statunitense, diventando carne da macello nelle imprese militari, “umanitarie” neocoloniali dello statopadrone. Come poco si sa della povertà che attanaglia la maggioranza della popolazione portoricana che resta nella Isla e delle centinaia di giovani distrutti dalle droghe, uccisi in scontri di bande narcotrafficanti rivali. Lourdes Vázquez, autrice portoricana, denuncia nelle sue poesie che le agenzie di pompe funebri sono un’attività assai redditizia oggi giorno a Puerto Rico. Luis López Nieves, autore e accademico portoricano, ricorda che durante il “Primer Congreso de la Lengua Española”, tenutosi nel 1997 in Messico, si rese conto che un «allarmante numero di ispanoparlanti non era molto sicuro di quale lingua si parlasse a Puerto Rico»1. Racconta che quando Puerto Rico divenne bottino di guerra USA durante la Guerra Ispano-americana, l’inglese venne imposto come lingua ufficiale della nuova colonia. L’inglese si insegnava in tutti i gradi di tutte le scuole, ma in realtà gli insegnanti davano lezione in spagnolo, passando all’inglese, con la complicità degli studenti, solo quando si affacciassero in aula i supervisori yankees. Nel 1948 gli USA concedono l’ufficializzazione dello spagnolo e il ritorno, quindi, alla scolarità in spagnolo. Alla fine degli anni ’80 Rafael Hernández Colón, governatore autonomista dell’isola, elimina l’inglese come lingua co-ufficiale: l’unica lingua è lo spagnolo, mentre l’inglese verrà insegnato nelle scuole come lingua straniera. Ma nel ’92 con la presa di potere del governatore annessionista Pedro Rosselló, l’inglese, ancora una volta, viene designato lingua co-ufficiale. La storia linguistica di questa piccola isola diventa sintomo della resistenza al dominio coloniale degli Stati Uniti: proprio la relazione asimmetrica con questi ha fatto sì che nell’isola si sviluppasse una forte coscienza linguistica e una lotta constante per la conservazione dello spagnolo. Il popolo portoricano ottenne nel 1991 il prestigioso premio spagnolo per la letteratura Príncipe de Asturias «per la difesa dello spagnolo che si realizza nel paese». Possiamo pensare che il popolo portoricano, quindi, abbia fatto della difesa linguistica una forma di resistenza culturale al dominio nordamericano. La letteratura diviene qui, innanzitutto, strumento per «il risorgere di un’autostima collettiva, offesa da 5 secoli di assoggettamento coloniale» - dice Mercedes López-Baralt e continua - «La letteratura registra la storia, la anticipa, la contesta […]. E ci salva da essa…», soprattutto a Puerto Rico, un paese in cui la letteratura ha dovuto spesso prendere il posto di «una storia falsificata dai silenzi della versione ufficiale»2. López-Baralt dichiara i motivi principali per i quali la letteratura della sua Isla risalta nel panorama delle lettere latinoamericane: innanzitutto, riprendendo Juan Gelpí, ricorda che è sostenuta da una contraddizione apparente, il fatto cioè che sia nata una letteratura “nazionale” in una terra che non si è ancora costituita 208 la rivista dell’ Arte come nazione indipendente; in secondo luogo, citando le parole dello scrittore e giornalista José Luis González, sottolinea che nessun paese, che per dimensioni, storia politica e popolazione si avvicini a Puerto Rico, possiede una produzione letteraria e culturale in generale comparabile alla sua3. Ci troviamo, infatti, dinanzi a un’intensissima produzione4; fra gli autori, forse più noti al pubblico italiano, si possono ricordare Mayra Santos Febres, Rafael Acevedo, Zoé Jiménez Corretjer, José Santos, Rosario Ferré, Yolanda Arroyo Pizarro, Luis Rafael Sánchez, Etnais Rivera, Luis López Nieves, Magali García Ramis. Parlare di letteratura portoricana vuol dire parlare di autori e autrici che scrivono nell’isola, e vuol dire includere anche quegli autori non portoricani che dell’isola hanno fatto la loro patria letteraria (come Kalman Barsy, ungherese, cresciuto in Argentina, stabilitosi a Puerto Rico dal 1974, come la galega Matilde Albert Robatto, il dominicano Carlos Roberto Gómez Bera o la cubana Mayra Montero). Vuol dire, infine, includere gli autori che vivono tra gli States e la Isla e, ancora, quelli che scrivono fuori dell’isola, i cosiddetti “autori della diaspora”. Bisogna inoltre riflettere sulla lingua che scelgono di usare: lo spagnolo, l’inglese, entrambe, lo spanglish? Si pensi, per esempio, ai cosiddetti autori nuyorican5. Non si tratta solo di una fiorente produzione letteraria, qualitativamente molto interessante, spesso poco conosciuta in Europa e in Italia, ma anche di scritture che invitano a interrogarci su concetti come quelli di “identità”, “nazione”, “canone”, “letteratura nazionale”. Una letteratura ricca di manifestazioni, che esplora e ibrida i generi, che affronta tutti i temi dell’umano, percorsa dall’intensa ricerca critica, esplicitata in forma diretta o metaforica, di un’identità da secoli negata dal dominio coloniale, intrisa di un nazionalismo che López-Baralt definisce di “resistenza” in opposizione a quello “di aggressione” imposto dagli imperi coloniali che si sono avvicendati nei secoli6. La conoscenza di questa letteratura diventerà ora più facilmente accessibile in Italia, grazie alla realizzazione da parte dell’associazione culturale letteraria EDIBOM della collana “La Isla”7, coordinata da Andrea Gallo, che ha deciso di sostenere la letteratura portoricana, di tradurla per il pubblico italiano, diffondendo autori contemporanei dell’isola. L’intenzione è inoltre quella di contribuire a generare anche nel nostro paese un percorso critico-interpretativo di conoscenza e di simpatia per una realtà civile assurda del nostro mondo globale: una nazione letteraria forte e complessa nelle scelte linguistiche, ma inesistente politicamente. Esperienze e proposte come queste non possono che essere salutate con profonda ammirazione perché contribuiscono alla diffusione di quella «letteratura dei mondi» che Armando Gnisci definisce come «rete planetaria di conoscenze e di ri-conoscimenti, di traduzioni e di reciprocità multiple. Questa letteratura dei mondi della quale parlo propone di opporsi alla globalizzazione della cultura di massa e del mercato unico euro-nordamericano: è alternativa e utopica. Essa intende diventare la zona mobile e 209 la rivista dell’ Arte incontrollabile, imprevedibile direbbe Édouard Glissant, del colloquio dei mondi e il soggetto espressivo ed evolutivo della comunicazione “di senso” e della parificazione mutua e non violenta delle culture»8. 1 Cfr. “¿Qué idioma se habla en Puerto Rico?, por Luis López Nieves”, in La Torre de Babel, 24 maggio 2010, http://latorredebabel.wordpress.com/2010/05/24/qu-idioma-se-habla-en-puerto-rico-por-luis-lpez-nieves. 2 LÓPEZ-BARALT MERCEDES, Literatura puertorriqueña del siglo XX. Antología, Puerto Rico, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2004, p. XX. 3 Cfr. LÓPEZ-BARALT MERCEDES, Literatura puertorriqueña del siglo XX. Antología, cit., p. XIX. 4 Basti pensare che nel Diccionario de autores puertorriqueños contemporáneos (2009) Víctor Federico Torres individua, nelle ultime quattro decadi del XX secolo 92 autori, selezionati fra quelli più attivi e più “riconosciuti”. Nella presentazione che della sua opera viene fatta a Puerto Rico nell’aprile 2009 dichiara che il Diccionario dovrà essere evidentemente ampliato includendo questa prima decade del secolo XXI, compito arduo per la quantità di nuovi scrittori. 5 Il significativo sviluppo della letteratura portoricana negli Stati Uniti interroga gli autori che scrivono a Puerto Rico sul concetto di canone letterario “nazionale” di una nazione che non esiste. Uno dei pionieri della critica letteraria portoricana, Efraín Barradas (1998, citato in López-Baralt, pp. XXV-XXVI), sottolinea che la produzione boricua (altro aggettivo con cui si denominano i portoricani, derivato dal nome dell’isola in epoca precoloniale, Borinkén) negli Stati Uniti costituisce parte integrante della cultura portoricana e che la tradizionale divisione fra la Isla e la diaspora non abbia più senso: sostiene infatti che gli scrittori nuyoricans sono portoricani nel momento in cui assumono pienamente la loro origine “nazionale” indipendentemente dalla lingua in cui scelgano di scrivere. 6 Cfr. LÓPEZ-BARALT MERCEDES, Literatura puertorriqueña del siglo XX. Antología, cit., p. XLVI. 7 Cfr. http://www.edibom.com/le-collane/isla.html. 8 GNISCI ARMANDO, “Letteratura globale e letteratura dei mondi”, in SINOPOLI FRANCA (a cura di), La letteratura europea vista dagli altri, Roma, Meltemi, 2003, pp. 108-109. la 210 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Questo scritto che il poeta albanese in esilio da molti anni in Italia, ha donato a Kuma&Transculturazione, presenta alcune sue “Opere patriarche” che stanno per uscire in italiano nel 2012 per la casa editrice Besa. Dobbiamo pensare a Gëzim Hajdari non solo come migrante linguistico, ma anche come uno spirito forte che vive tra noi in esilio politico. Gli italiani che lo leggono e lo apprezzano devono guardarlo come una generazione fa in Italia si guardava Rafael Alberti, il grande poeta spagnolo antifranchista in esilio da noi. Ma chi si ricorda di lui è morto. Intendo per “opere patriarche” i testi in onore della memoria delle cose vicine e di quelle lontane della storia albanese che Gëzim va studiando e traducendo in questi anni. Il poeta in esilio, in questo caso, propone al mondo e alla sua patria-nazione ancora non libera i punti memorabili della storia antica e nascosta e quella del periodo che abbiamo alle spalle della vicinissima e inesplorata, e feroce dittatura di Enver Hoxha. Il poeta in esilio, solo e con le sue mani, da sé e senza nessuno che l’aspetti o lo commissioni, costruisce monumenti di marmo e di fogli per riesumare con ardore e compassione la storia quasi morta ma giù muta dell’Albania. Lui, che è un esule politico e vive in povertà si fa storico del suo paese che non conosce ancora la propria storia. Gëzim sembra un poeta antico, in un’epoca e in una terra decadente in cui i poeti sono tanti ma minimi, dopo che Sanguineti e Zanzotto non scrivono più, e i non-poetici sono buffoni e criminali, riccastri e irresponsabili. E l’Italia non è più un paese per esuli, anche se qualche volta lo è stata. [a.g.] Gëzim Hajdari I CANTI DEI NIZÀM / KËNGËT E NIZAMËVE La storia dell’Albania, incisa sui drammi sociali, è stata un terreno fertile per la lirica orale. Il cantore popolare albanese ha donato al fondo europeo creazioni affascinanti e suggestive, ricche di elementi originali in cui confluiscono e s’armonizzano gli spiriti di tre religioni e quello di una confraternita mistica, i bektashi. Ciò che rende ancora più interessante la tradizione orale albanese è l’interazione con le tradizioni dei paesi confinanti e non solo. È per questo che il panorama della lirica popolare è singolare e allo stesso tempo molteplice. L’Albania – essendo un crocevia che collega l’Oriente con l’Occidente – ha fatto da tramite tra le culture del mare nostrum. Tale tradizione affonda le radici nei secoli remoti, in una cultura contadina patriarcale dove si viveva di pastorizia. la 211 rivista dell’ Arte Erano tempi in cui l’Albania subiva la repressione dell’impero più feroce dell’epoca, quello degli Ottomani, dove la lingua albanese fu severamente proibita per più di quattrocento anni. L’organizzazione della civiltà contadina si basava sulla besa, la parola data, la promessa. La lirica popolare albanese – appartenente ad una cultura prealfabetica – è riuscita a conservare fino ad oggi i valori etici e morali del passato, tramandandoli da una generazione all’altra attraverso bardi e rapsodi. Essi rispecchiano l’anima, lo spirito e gli ideali del popolo albanese, dentro e fuori dai suoi territori geografici. Sono stati proprio i canti popolari che hanno mantenuto viva la memoria collettiva della nazione nei momenti bui e tragici della storia, arricchendo così la tradizione culturale e l’identità stessa degli shqipëtar. Per la prima volta si propone al lettore italiano il ciclo dei canti lirici popolari dei nizàm (così venivano chiamati in turco i soldati albanesi che combattevano per conto della Grande Porta di Istanbul) e poi in un secondo volume quelli dei kurbèt (canti dei migranti). Questi due cicli fanno parte del patrimonio culturale del paese delle aquile, finora sconosciuti al di fuori dei confini nazionali. Sono di una bellezza rara ed unica. Vengono cantati dagli uomini nelle cerimonie e nei matrimoni e tramandati di padre in figlio. Sia i canti dei nizàm che quelli dei kurbèt rappresentano due fenomeni del passato della società albanese. Si distinguono tra di loro dalle condizioni storiche in cui sono stati creati, dalle peculiarità artistiche di ciascun ciclo, dal contenuto e dal linguaggio. Ciò che fa unire i canti dei nizàm a quelli dei kurbet fuori della patria è la nostalgia, le sofferenze, le disgrazie della loro vita e la ribellione. Nel primo volume si riportano i canti dei nizàm e nel secondo quelli dei kurbèt. Il primo volume si arricchisce anche di canti della vita militare prima delle riforme dell’amministrazione ottomana, mentre nel secondo sono inclusi anche quelli degli arbërèsh (albanesi d’Italia) che narrano della separazione forzata 212 la rivista dell’ Arte dalla terra degli avi, della fuga per il mare, della lontananza e della nostalgia per la patria perduta. I canti dei nizam si dividono in tre cicli: la “partenza”, “la vita fuori della patria” e il “ritorno”. Non c’è una separazione netta tra questi cicli, a volte gli stessi motivi migrano da un canto all’altro. L’originalità si trova negli elementi nuovi che porta ogni cantore e nella maniera in cui viene interpretato ogni canto. I canti dei nizam appartengono a un periodo storico particolare; sono legati alla situazione in cui si era venuta a trovare l’Albania dopo le riforme varate dalla Grande Porta di Istanbul nel 1839, per organizzare lo stato turco secondo i modelli europei. Una di queste riforme – conosciuta nella storia della Turchia con il nome di Riforme di Tanzimat era l’organizzazione dell’esercito. Per legge, i cittadini dell’Impero Ottomano dovevano essere per 5 anni nizàm e per 7 redìf (i soldati di riserva). I nizam albanesi venivano allontanati dall’Albania giacché nel paese si respirava un clima di ribellione contro l’amministrazione turca e venivano spediti nelle guarnigioni più lontane, fino in Anatolia. Lì affrontavano anni pieni di sofferenze, pericoli e tragedie. Le Riforme di Tanzimat scatenarono odio e scontri armati tra il popolo albanese e le autorità turche. È proprio da queste terribili condizioni che nascono i canti dei nizam, in cui si esprime dolore, angoscia e protesta contro l’invasore straniero. La pressione della Grande Porta di Istanbul si rivolgeva principalmente contro il popolo albanese, perché le altre nazioni balcaniche quali la Serbia, la Grecia e la Romania avevano già proclamato l’indipendenza dalla Turchia. I canti dei nizam sono un patrimonio inestimabile della cultura albanese. Il timbro di questi canti cambia da una regione all’altra. Nel sud del paese, dove le Riforme di Tanzimat furono applicate per prime, l’eco fu immediato. Mentre nel nord, la Grande Porta di Istanbul non riuscì a toccare i diritti tradizionali che si basavano sul Kanùn (Codice Giuridico orale degli albanesi). Quindi l’eco di queste vicende si sentì più tardi e più limitatamente. Nelle Alpi, questi canti vengono accompagnati dalla çiftelìa1 e dalla sharkìa2, a volte anche dalla lahùta3, rispettando lo stile narrativo di queste regioni di grandi tradizioni epiche. Mentre nel sud vengono interpretati dai gruppi polifonici. I canti dei nizam descrivono in pochi versi destini, drammi e tragedie epocali. Sono commoventi le scene 213 la rivista dell’ Arte della partenza dei soldati che lasciano i loro villaggi nativi e i loro affetti. I versi sono stracolmi di rabbia per la dura vita militare, fatta di marce, pesanti addestramenti sotto la neve e la pioggia. Con un linguaggio semplice, ma drammatico e struggente vengono descritte le vicende di questi giovani combattenti, spediti negli immensi territori dell’Impero Ottomano, sui monti ghiacciati dei Balcani, nei deserti dell’Anatolia e nei paesi arabi. Con una forza espressiva inaudita, il cantore maledice il destino dei giovani shqipëtar, le leggi turche e l’invasore. La vita del nizam è un dramma continuo nelle terre straniere, la sua mente non smette di pensare alla patria e ai propri cari. Egli si preoccupa giorno e notte del destino dei figli affamati, della madre anziana e malata, della moglie addolorata e della patria che soffre. Inoltre, del primo ciclo fanno parte anche alcuni canti più antichi ancora di quelli dei nizam, caratterizzati da elementi tragici in cui l’eroe rimane sul campo di battaglia come nel canto epopea “Mbeçë, more shokë, mbeçë, përtej urës së Qabesë” (Che tu possa rimanere ovunque, amico mio, ma non oltre il Ponte di Qabè). Sono canti che appartengono al feudalesimo militare ottomano. Il tema principale è quello della miseria del popolo albanese sotto l’occupazione turca. I canti dei nizàm e quelli dei kurbèt conservano la forma tradizionale della composizione, caratterizzata dai toni elegiaci. Spesso prendono la forma del dialogo e del monologo, ma non manca anche la ballata. Rimangono un documento storico di grande valore culturale, una testimonianza della straordinaria capacità creativa del popolo albanese. 1 Cifteli: strumento a monocorda. Sharki: strumento di solito a cinque corde. 3 Lahuta: liuto. 2 la 214 I CANTI DEI NIZÀM SORGE UNA NAVE DAL MARE Sorge una nave dal mare, nera, immensa come la notte, fa tremare monti e case, i nostri figli nizàm1 chiede il re. Lascia stare o re, i nostri figli, sono teneri come fiori, perché portarli nei deserti? 1. Nizàm: soldato in turco. Dal 1479 al 1912, l’Albania era sotto l’impero Ottomano. CHIAMA L’IMBONITORE DEL VIZIR1 Chiama l’imbonitore del Vizir: - O giovani fior dei fiori2, il re vi vuole nizàm. Ahimè i figli degli shqipëtar3, in Anatolia andarono a finire e al sultano mandarono a dire: rivista dell’ Arte la 215 - Sentiamo la nostalgia per la patria, lì abbiamo padre e madre, vedove le mogli abbiam lasciate. 1. Vizir: ministro, in turco. 2. Il ritornello che si ripete dopo ogni verso. 3. Shqiptar: albanesi. AHIMÈ, DOVE ANDREMO Giunge l’imbonitore da Istanbul, ahimè!1 - Non obbedisce al re lo Yemen! Gegë2 e toskë3, tutti in fila partono per la Turchia. Da Saranda4 a Valona5, ogni giorno una caravella, novantadue battaglioni. Miseri noi dove andremo? Oh, Yemen, maledetto Yemen, fai tornare i nostri giovani le madri sole, senza figli! 1. Ritornello. 2. Gegë, 3. Toskë: sono i due dialetti albanesi. 4. Saranda: città albanese. rivista dell’ Arte la 216 5. Valona (Vlorë), città albanese. VEDI O ISTANBUL Vedi, o Istanbul, l’arrivar dei nostri figli incurvati come montoni, come i montoni del sacrificio, belano le mandrie in montagna, piangono le mogli nelle cascine, fiumi di lacrime negli occhi. Non piangete madri e sorelle, alle nostre donne fate coraggio perché non andiamo in kurbèt1, ma nizàm per sette vjet2. 1 Kurbèt: migrazione,in turco. 2. Vjet: anni, in albanese. CHE TU POSSA BRUCIARE O ISTANBUL Che tu possa bruciare o Istanbul, hai portato via i nostri uomini, rivista dell’ Arte la 217 alcuni redìf 1, altri nizàm, tutti sotto i proiettili finirono: un annuncio funebre ogni giorno. Sulla vetta scruto il villaggio, di casa in casa piangono. Tutti chiedono: perché tardano a tornare i figli dallo Yemen? Piangete o madri, non smettete, il sangue dei figli che avete è versato in vano sulle pietre! Ahimè, o padri, ahimè, badate ai prossimi figli, questi son spenti per gli altri! 1. Redìf: soldati di riserva, in turco. PERCHE’ PIANGI MIO CUORE Perché piangi mio cuore, mi portò via il figlio l’invasore! rivista dell’ Arte la 218 Dieci anni asqèr nello Yemen, non si sa se tornerà. Si scuoterà dalla sabbia, scorderà la via verso casa. Lì, bollono sabbia e pietra, bolle l’acqua e la testa. Stringo al petto i suoi vestiti, la spada e le armi dorate, maledetti invasori! MISIR1, O MALEDETTO MISIR Misir, maledetto Misir, dai deserti né lettere, né haber2 Misir, maledetto Misir, fai tornare il mio fiore. Che tu possa morire Arabistan3, il mio uomo lo tieni lontano! Vullak4, maledetto Vullak, perché non diventi polvere e cenere?! Cosa ti hanno fatto le spose che lasci sole le sere? Ogni giorno un lutto, bruciano le donne come cera. Tante case hai distrutto, rivista dell’ Arte la 219 rivista dell’ Arte che tu solo morte possa avere. 1.Misir: l’Egitto per gli albanesi. 2. Haber: notizie. 3. Arabistan: i paesi arabi. 4.Vullak: quartiere del Cairo, dove abitavano molti albanesi emigrati durante l’occupazione turca. MIA COLOMBA DALLA BOCCA DI ROSA Mia colomba dalla bocca di rosa, partirò nizam con la luna piena. - Buon viaggio giovane soldato, tu la strada non la sai! Sentieri e strade li troverai, misera me, dove mi lascerai? - Ti lascerò a casa mia, insieme a mia madre gentil donna. Mia colomba dalla bocca di rosa, partirò nizam con la luna piena. - Buon viaggio giovane soldato, Tu la strada non la sai! Sentieri e strade li troverai, misera me, dove mi lascerai? - Ti lascerò a casa mia, insieme a tua suocera tanto buona. Mio uomo non ti capisco, la 220 senza di te non posso più vivere, non mi va di mangiare, senza di te non posso dormire, come fare senza di te mio cigno?! MALEDETTO, O NIZAM Misera me, come farò, appena sposata, sei partito a buon ora senza una parola, con la figlia tra le mani, come una suora, non so dove ti trovi nelle terre negre: Vestita a lutto, ogni giorno ti piango, chiede da mangiare la piccola non so cosa darle. Passano gli anni, le rughe aumentano, i capelli incanutiti, il cuore intristito. Mi sto consumando come la cera, rivista dell’ Arte la 221 la mia angoscia insieme non godemmo. CHE POSSA BRUCIARE IL TUO SEME Che possa bruciare il tuo seme, Peloponneso che tieni le nostre vite. Quante madri hai accecato, tanti padri hai ammalato, quanti fratelli rimasti soli tante sorelle senza fratelli tante donne senza mariti. Una lettera scriveremo nel paese la invieremo, gli hoxhallarët1 la leggeranno, le donne l’ascolteranno! Se chiede la madre: – Cosa c’è a poco prezzo? La testa del gatto una lira. Se domanda: Come facciamo? La carne di cavallo mangiamo. Se chiede: Cosa mettiamo per dormire? Come cuscino, abbaiamo la pietra. Quando sentiamo nostalgia della madre, guardiamo in cielo la luna, quando sentiamo nostalgia del padre, rivista dell’ Arte la 222 seguiamo l’acqua del ruscello, quando sentiamo nostalgia della sorella, sediamo davanti al focolaio, quando sentiamo nostalgia dei figli, guardiamo nel buio. 1. Hoxhallarë: sacerdote musulmano. AHIMÈ, AMICI MIEI Che tu possa rimanere ovunque amico mio, ma non oltre il Ponte di Qabé1, nelle montagne di Grebené2, ai confini del Moré3. Tanti saluti a mia madre, dì a lei di vendere i buoi per sfamare mia moglie, il cavallo nero per crescere mio figlio, di vendere il mulo per crescere mia figlia. Se ti chiede di me: dì a lei che mi sono sposato; se ti domanda dei miei paraninfi, falchi e corvi mi hanno divorato rivista dell’ Arte la 223 e se ti chiede della mia sposa: dille che ho dieci spade nel petto; se vuole sapere dove sono salito: lì, dove sale la salma dell’ignoto e se insiste in quale casa mi sono fermato: lì, nella stanza senza finestre, senza porte, dove non piove, né tira vento. 1.Ponte di Qabè: templio della Mecca in Arabia Saudita. 2. Moré: città in Thesalì (Grecia). 3. Moré: Pelloponeso. DOVE CANTA IL CORVO NERO? Dove canta questo corvo nero? Sulla tomba di un giovane soldato. Buon viaggio, amici miei, portate le mie armi in patria. Non dite nulla ai miei genitori, sono vecchi, perderanno il vedere degli occhi, non dite nulla alla povera sorella, è giovane, non voglio che viva nel lutto, non raccontate nulla a mia moglie, ho paura che esca fuori di senno. Se mia madre vi chiede di me: rivista dell’ Arte la 224 ditele che mi sono sposato con tre proiettili nel petto; se vi chiede cosa ho mangiato: i cani e i gatti che ho trovato; se vi domanda cosa ho bevuto: la pioggia nelle orme del cavallo; se vi chiede dove ho dormito: per terra e sulle pietre. Dimmi mio fratello: - Quanti giorni sarai in lutto per me? - Finché sarà sciolta la pietra nell’acqua, i giorni che merita un fratello scomparso. - Dimmi sorella mia: quanti giorni sarai in lutto per me? - Finché sarà bagnata la quercia seccata, i giorni che merita un fratello. - Dimmi madre mia: - Quanti giorni sarai in lutto per me? - Finché si fermerà il mio cuore. - Giunge l’estate nei campi verdi, - germogliano i fiori nei prati, - inizia il cuculo a cantare, - continua la madre a piangere. Dimmi tu, moglie mia, - Quanti giorni sarai in lutto per me? - Finché non arriva la primavera, - e non germoglia la montagna, - finché non arriva l’autunno - e non belano le pecore, - finché non inizia l’uva a gocciolare, - e non mi reco a prendere l’acqua, - tornata a casa, ti ho già dimenticato. rivista dell’ Arte la 225 rivista dell’ Arte SLOGAN DELL’ALBANIA DI ENVER HOXHA /PARRULLA ENVERISTE Questi slogan, proposti per la prima volta al lettore occidentale, appartengono al regime stalinista di Enver Hoxha, una delle dittature comuniste più spietate del XX secolo. Oltre alle persecuzioni, alle condanne, alle prigionie, alle torture, ai lager, alle fucilazioni, alle impiccagioni, ai lavori forzati, gli slogan enveristi hanno esercitato, per mezzo secolo, un terrore psicologico sulla mente dei cittadini albanesi, un lavaggio del cervello, facendo impazzire uomini e donne, giovani e anziani. Erano ripetuti a memoria fino all’ossessione, giorno e notte, non soltanto dai cittadini liberi, ma anche dai detenuti, che spesso venivano costretti a recitare ad alta voce la retorica comunista. Furono molti coloro che finirono dietro le sbarre per non aver accettato di lanciare slogan pro regime, durante le manifestazioni organizzate dal Partito e dal dittatore; lo stesso destino ebbero anche coloro che espressero rabbia e odio contro i versetti della “liturgia rossa”. Alcuni di questi slogan sono tratti dai testi dei poeti del realismo socialista assoldati al regime. Tutto questo faceva parte del Terrore di Stato, dell’assurdità, della patologia criminale contro l’umanità del regime totalitario di Tirana durante gli anni 1941 – 1990. Gli slogan enveristi inneggiavano al Partito, alla dittatura del proletariato e al dittatore Enver Hoxha, trasmettendo alle masse la coscienza rivoluzionaria e il fervore ideologico, come nella Cina maoista. Ma lo scopo principale degli slogan era quello di poter diffondere le massime e le direttive del tiranno e quello di tenere viva la famigerata lotta di classe. Essi apparivano ovunque: ai margini delle strade, in cima alle montagne, nelle piazze, sui muri delle case, all’entrata delle fabbriche e delle miniere, negli stadi, negli uffici, negli asili, nelle scuole, nelle università, nei libri, negli ospedali, lungo il confine, nei porti, sulle spiagge, negli stadi, nei parchi, nelle camere da letto, nelle ninnenanne, nei manicomi, persino nei cessi pubblici. Erano gli anni della pianificazione della nuova estetica di Stato e dell’affermazione dell’“uomo nuovo” del socialismo, plasmato dal Partito e temprato sotto l’incudine della classe operaia: “l’uomo muscoloso e stakanovista”, che vigilava giorno e notte per difendere le vittorie e la patria dai nemici. Ancora oggi, alcuni di questi slogan, scritti con la vernice rossa, si intravedono sbiaditi sui muri. Se gli slogan del “Libretto Rosso” di Mao Tse-Tung erano 286, quelli di Enver Hoxha erano quasi 800. Il dittatore albanese, per la 226 rivista dell’ Arte aumentare l’influenza ideologica, aveva creato le sue “Guardie Rosse” sparse in ogni angolo del Paese, che diffondevano i comandamenti comunisti e denunciavano i nemici del suo “Libretto Rosso”. Dopo “Epicedio albanese”, in cui racconto il massacro contro poeti e scrittori albanesi dal 1920 al 1989, “Slogan dell’Albania di Enver Hoxha” è un altro frammento della memoria collettiva del mio Paese. Ho deciso di pubblicare questo “libretto” per confrontarmi con la verità storica del passato e per non dimenticare, affinché il Parlamento di Tirana condanni i crimini commessi contro l’umanità durante il comunismo. Slogan dell’Albania di Enver Hoxha Evviva il Partito Comunista Albanese con il compagno Enver Hoxha, la nostra guida! Evviva la dittatura del proletariato! Innestare cervelli e cuori nel tronco socialista! Amarsi da comunisti! Evviva la lotta di classe! Evviva il canto del gallo nel villaggio comunista! Evviva la sposa comunista! Evviva lo sposo comunista! Evviva padre Stalin! 227 la rivista dell’ Arte All’Albania finalmente è nato un figlio: il compagno Enver Hoxha! Il cervello del compagno Enver è anche il nostro! L’opera più preziosa del Partito: la creazione dell’uomo nuovo! Abbasso la donna borghese! Ciò che dice il Partito, fa il popolo, ciò che dice il popolo, fa il Partito! L’opera del padre Stalin: grande esempio per il Partito e il compagno Enver! Alla forca i nemici del Partito! Per il Partito e il compagno Enver, daremo la nostra vita! Gli scrittori: leve del Partito per l’educazione comunista della gente! Siamo soldati fedeli al Partito-padre! Gli scrittori e gli artisti sono grati al Partito e al compagno Enver! All’epicentro di ogni opera letteraria ed artistica ci deve essere l’eroe positivo comunista! Interiorizziamo gli isegnamenti preziosi del compagno Stalin sulla letteratura e le arti! Prima di tutto, l’amore per il Partito e il compagno Enver! Donare al Partito il nostro sangue! 228 la rivista dell’ Arte Dedicare al Partito e al compagno Enver la propria vita! Abbasso gli scrittori cattolici reazionari! Abbasso gli scrittori mistici musulmani! Il nostro eroe positivo deve essere comunista ogni momento: nella vita quotidiana, in famiglia, in amore, nelle preoccupazioni, nella gioia e nel sangue! Il giorno in cui è nato il Partito, è nato il nostro sole! La teoria di Freud: disgrazia per la letteratura del realismo socialista! Abbasso i poeti e gli scrittori sentimentali e mistici, seguaci di Nietzsche e di Freud! La letteratura del realismo socialista: letteratura della classe operaia! Le opere del compagno Enver e quelle dei classici del marxismo-leninismo sono l’unica arma contro l’arte decadente e revisionista! Guerra contro le influenze straniere e le teorie reazionarie di Freud! L’opera di J. V. Stalin: sempre attuale! Abbasso gli scrittori traditori sovietici, cechi, bulgari, francesi, irlandesi e americani! Abbasso i servi della degenerata società occidentale come Kafka, Joyce, Sartre, Kamy, Roger Garaudy, Natalie Sarraute, Rob Grijene, Mishel Bytorit, Klod Simon, Solgenitsin, A. Kuznecov A. Demetjev, la 229 rivista dell’ Arte Tvardovskij, Xhon Hers e L. Andrejev! Evviva la letteratura e le Arti sotto la luce del Partito! Freud è la causa di un’epidemia mai vista nella cultura mondiale! La sua teoria sta divenendo sempre più pericolosa e sta contagiando, una dopo l’altra, le letterature e le generazioni di scrittori e di artisti! Evviva gli insegnamenti del compagno Mao Tse Tung per i problemi della Letteratura e delle Arti! Noi poeti e artisti siamo legati più che mai al Partito e al marxismo-leninismo! L’arte comunista è l’arte della sublimazione della Rivoluzione! EPICEDIO ALBANESE Dedico Epicedio albanese ai poeti e agli scrittori del mio Paese, vittime innocenti del Terrore comunista. I primi oppositori della banda sanguinaria di Enver Hoxha furono proprio i poeti. Essi combatterono eroicamente con i propri versi e sacrificando la loro vita contro il Terrore rosso. Il dittatore temeva molto le voci dei cantori, perciò decise di usare il pugno di ferro aizzando contro di loro il Sigurimi (la polizia segreta di Hoxha). Spesso venivano condannati non solo i poeti e gli scrittori, ma anche le loro opere, e venivano profanate le loro tombe. Ho iniziato a scrivere questo libro in Darsìa, regione dove sono nato, per continuare poi in Italia durante l’esilio ciociaro. Sono stati anni di ricerca, di studi, di letture, di approfondimenti, di riflessioni, di incontri, sia con gli amici sia con i familiari delle vittime. Anni intensi, drammatici, pieni di incubi e di orrore, che 230 la rivista dell’ Arte hanno segnato per sempre la mia esistenza. Non è stato facile dare nome, volto, corpo e voce ai poeti shqiptar perseguitati, imprigionati, torturati, uccisi o morti di stenti nei lager e nei campi di internamento durante la feroce dittatura di Enver Hoxha. Dopo aver scritto l’ultima pagina di questo poema funebre mi sono sentito come schiacciato dal peso atroce di quella che rappresenta forse la parte più agghiacciante dell’intera Storia del mio Paese. Le difficoltà dell’impresa sono state enormi poiché i responsabili di questo massacro ricoprono oggi alte cariche politiche nell’Albania postcomunista e fanno di tutto per seppellire la memoria di quanto è successo. Essi non vogliono che la verità storica venga resa pubblica, né in Albania né all’estero. Coloro che tentano di far luce sugli efferati crimini commessi, è il caso di chi scrive, vengono considerati dei nemici e condannati quindi al silenzio. Il Terrore era un sistema, il principio su cui si basava la dittatura stalinista. Finché il nuovo Parlamento di Tirana non dichiarerà il Terrore di Stato un crimine contro l’umanità, in Albania non ci sarà pace nelle coscienze e vera democrazia. Il 25 gennaio 2006 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato la risoluzione 1481 “Sulla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi del totalitarismo comunista” in cui condanna le violazioni di massa dei diritti umani commesse dai regimi totalitari comunisti. Stigmatizza, inoltre, che gli autori di questi crimini non sono stati portati in giudizio dalla comunità internazionale e, di conseguenza, c’è una scarsa presa di coscienza pubblica sui crimini del totalitarismo comunista. Sono trascorsi più di vent’anni dalla fine della dittatura, ma il Parlamento albanese, nonostante questa risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, fino ad oggi non ne ha mai tenuto conto. Il Passato si identifica solo con le vittime e si dimenticano i commissari che progettarono tale carneficina. Fino ad ora la tragedia del genocidio albanese non ha avuto nessun responsabile; non c’è stata nemmeno una condanna, almeno morale. I governi post-comunisti attendono che scompaia la generazione dei perseguitati e, insieme a loro, ogni testimone oculare, ogni testimonianza, ogni ricordo vivente della tragedia storica. I familiari delle vittime attendono la verità su ciò che è accaduto nelle stanze del Sigurimi e sperano che il Parlamento di Tirana condanni finalmente le atrocità perpetrate durante l’epoca comunista. Essi non sanno che fine abbiano fatto i corpi martoriati e le opere manoscritte dei loro cari, mentre i boia e gli ideatori del Terrore di Stato vengono premiati dai governanti “democratici” di Tirana per aver servito con devozione la 231 la rivista dell’ Arte patria comunista di ieri! L’Albania si è trasformata in un cimitero sepolto e rivelato: ogni giorno viene scoperta una fossa comune con resti di uomini, donne e bambini considerati nemici della dittatura del proletariato. In questo Gjëmë (Epicedio) ho cercato di evitare qualsiasi polemica ideologica, poiché volevo dar voce a coloro che sono scomparsi e ai superstiti che hanno potuto testimoniare della tragedia, della follia, della perversa banalità della dittatura. Ho raccontato la loro vita e quella dei loro compagni sacrificatisi in nome dei diritti umani e della libertà di Parola. Le interviste e le testimonianze riportate nel testo si basano tutte su fonti documentate. Ringrazio l’editore Mësonjëtorja di Tirana per aver avuto il coraggio di pubblicare, in esclusiva mondiale nel luglio del 2010, “Epicedio”. Gëzim Hajdari è nato nel 1957, ad Hajdaraj (Lushnje), Albania, in una famiglia di ex proprietari terrieri, i cui beni sono stati confiscati durante la dittatura comunista di Enver Hoxha. Nel paese natale ha terminato le elementari, mentre ha frequentato le medie, il ginnasio e l’istituto superiore per ragionieri nella città di Lushnje. Si è laureato in Lettere Albanesi all’Università “A. Xhuvani”di Elbasan e in Lettere Moderne a "La Sapienza" di Roma. In Albania ha svolto vari mestieri lavorando come operaio, guardia di campagna, magazziniere, ragioniere, operaio di bonifica, due anni di militare con gli ex detenuti, insegnante di letteratura alle superiori dopo gli anni ’90; mentre in Italia ha lavorato come pulitore di stalle, zappatore, manovale, aiuto tipografo. Attualmente vive di conferenze e lezioni presso l’università in Italia e all’estero dove si studia la sua opera. Nell’inverno del 1991, Hajdari è tra i fondatori del Partito democratico e del Partito repubblicano della città di Lushnje, partiti d’opposizione, e viene eletto segretario provinciale per i repubblicani della suddetta città. Nello stesso anno, insieme ad un suo amico: poeta e scrittore Shpend Sallaku, fondano il settimanale di opposizione Ora e Fjalës, nel quale svolge la mansione di vice direttore. Nello stesso tempo scrive sul quotidiano nazionale Republika. Più tardi, nelle lezioni politiche del 1992, si presenta come candidato al parlamento nelle liste dei repubblicani. Nel corso della sua intensa attività di esponente politico e di giornalista d’opposizione, ha denunciato pubblicamente e ripetutamente i crimini, gli abusi e le speculazioni della vecchia nomenclatura di Hoxha e dei 232 la rivista dell’ Arte recenti regimi mascherati post-comunisti. Anche per queste ragioni, a seguito di ripetute minacce subite, è stato costretto, nell’aprile del 1992, a fuggire dal proprio paese. La sua attività letteraria si svolge all’insegna del bilinguismo, in albanese e in italiano. Ha tradotto vari autori. La sua poesia è stata tradotta in diverse lingue. È stato invitato a leggere la sua opera in vari paesi del mondo, ma non in Albania. La sua opera è stata ignorata cinicamente in Albania, dalla mafia politica e culturale di Tirana perché egli non ha mai cantato ai partiti e ai tiranni. È presidente del Centro Internazionale Eugenio Montale e cittadino onorario per meriti letterari della città di Frosinone. Considerato tra i maggiori poeti viventi, ha vinto numerosi premi letterari. Dal 1992, vive come esule in Italia. Ha pubblicato in Albania: Poesia Antologia e shiut, Tiranë, Naim Frashëri, 1990. Trup i pranishëm / Corpo presente, Tiranë, I edizione Botimet Dritëro, 1999 (con testo albanese a fronte). Saggistica Gjëmë: Genocidi i poezisë shqipe, Tiranë, Mësonjëtorja, 2010. Ha pubblicato in Italia in bilingue: Ombra di cane/Hije qeni, Frosinone, Dismisuratesti, 1993. Sassi controvento/Gurë kundërerës, Milano, Laboratorio delle Arti,1995. Antologia della pioggia/ Antologjia e shiut, Santarcangelo di Romagna, Fara, 2000. Erbamara/ Barihidhur, Santarcangelo di Romagna, Fara, 2001. Stigmate – Vragë, Nardò, Besa, 2002, II edizione 2006. Spine Nere/ Gjëmba të zinj, Nardò, Besa, 2004, II edizione 2005. Maldiluna-Dhimbjehëne, Nardò, Besa, 2005, II edizione 2007. Poema dell'esilio/Poema e mërgimit, Santarcangelo di Romagna, Fara, 2005, II edizione 2007. Peligòrga/Peligorga, Nardò, Besa, 2007. Poesie scelte 1990 – 2007, Nardò, Controluce, marzo 2008, II edizione 2009. Poezi të zgjedhura 1990 – 2007 (edizione albanese di Poesie scelte), Nardò, Besa, 2008. 233 la rivista dell’ Arte Corpo presente/ Trup i pranishëm, Nardò, II edizione Besa, 2011. Libri reportage di viaggio: San Pedro Cutud. Viaggio nell’inferno del tropico, Santarcangelo di Romagna, Fara, 2004. Muzungu. Diario in nero, Nardò, Besa, 2006. Premi letterari: EkseTra (Rimini 1996) Montale (Roma 1997) Fratellanza nel mondo (Potenza 1999) Trieste Etniepoesie (2000) Scritture di Frontiera - Umberto Saba (Trieste 2000) Dario Bellezza ( Roma 2000) Grotteria (Reggio Calabria 2000) Ciociaria (Fiuggi 2003) Popoli in cammino (Milano 2005) Multietnicità, (Roma 2006) Piccola Editoria di Qualità. (Chiari 2007) Vittorio Bodini (Minervino Lecce 2011) Libri sull’opera di Hajdari: GAZZONI ANDREA (a cura di), Poesia dell’esilio. Saggi su Gëzim Hajdari, Isernia, Cosmo Iannone, 2010. Ha tradotto in albanese: MANZI LUIGI, Il muschio e la pietra (con testo italiano a fronte), Nardò, Besa, 2004. Curatela di Antologie Ha curato insieme a I. Mehadheb e S. Mugno l’antologia I canti della vita del poeta tunisino Abū’l-Qāsim AshShābb, Trapani, Di Girolamo, 2008. 234 la rivista dell’ Arte Ha curato insieme con Amoà Fattiva l’antologia Dove le parole non si spezzano (con testo inglese a fronte) del poeta filippino Gémino H. Abad, Avellino, De Angelis, 2011. Libri in uscita 2011: Epicedio albanese (un saggio di 400 pagine che racconta del “genocidio” della poesia albanese 1920 – 1989), Nardò, Besa, 2012. Traduzione dall’albanese in italiano I canti dei nizam/ Këngët e nizamit (canti lirici popolari albanesi, con testo albanese a fronte), Nardò, Besa, 2012. la 235 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Rosa Di Violante Novità dalla collana “Kumacreola” Dopo due anni di pausa torna nell’orizzonte dell’editoria italiana “Kumacreola”, collana diretta da Armando Gnisci e fondata nel 2004 per l’editore Cosmo Iannone di Isernia. Giunta alla diciannovesima pubblicazione nel 2010 con Luoghi incerti della scrittrice, traduttrice e germanista Stefanie Golisch, “Kumacreola” può vantare nel suo catalogo opere di scrittori e poeti della migrazione in lingua italiana, sia immigrati da noi che emigrati dall’Italia, oltre che importanti studi critici sull’argomento. Per il 2012 la collana si rinnova aprendosi ad un approccio mondialistico e transculturale più forte. Ad inaugurare questa nuova “Kumacreola” sarà La melodia del piano, racconto autobiografico di uno scrittore e intellettuale egiziano che vive in Italia da ormai trent’anni, Abou El Maati Ahmad Abdel Rahman Abou Shareb, noto con il nome di Abou Shareb. L’opera di Abou Shareb – della quale si offrono in lettura in questo primo numero di Kuma&Transculturazione i due estratti critici che accompagnano il testo nella pubblicazione – è apparsa in Egitto nel 2006 ed è stata accolta calorosamente dai lettori e dai critici egiziani. Adesso La melodia del piano si offre anche al pubblico italiano, nella traduzione di Marianna Massa e Hussein Mahmoud con una mia nota finale, come un testo che afferma la sua qualità transculturale di racconto egiziano e insieme italiano, tradotto da una italiana e da un egiziano. Il libro di Abou uscirà nella primavera del 2012, nuovi volumi in preparazione lo seguiranno: dai racconti di Božidar Stanišić alla Premiata Compagnia delle Poete di Francesco Armato, al nuovo romanzo di Yousef Wakkas e da altri ancora. la 236 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Hussein Mahmoud Postfazione a La Melodia del piano di Abou Shareb La migrazione è un fenomeno diffuso nel Mediterraneo – nelle sue componenti di immigrazione ed emigrazione – come in e dall’Italia, e come nel mondo arabo, sia verso l’Europa e le Americhe che verso altre nazioni arabe o africane. Nel campo letterario, basti pensare a scrittori italiani del Novecento come Ungaretti, Cialente e Marinetti. Partendo da questa considerazione, nel campo della letteratura della migrazione nel Mediterraneo, possono essere rintracciate delle linee discriminanti utili al fine di comprendere divergenze e punti di contatto fra la odierna letteratura italiana della migrazione e la adab almahg˘ar o “letteratura dell’emigrazione”. Scrive Isabella Camera D’Afflitto, nel suo importante volume Letteratura araba contemporanea. Dalla nahdah1 a oggi: Con il termine adab al-mahg˘ar (letteratura dell’emigrazione) si intende, nel mondo arabofono, a partire dal 1870 fino alla prima metà del Novecento, un momento storico caratterizzato da un forte colonialismo non-arabo che sfruttava tutte le risorse economiche dei paesi del Sud e dell’Est del Mediterraneo, spingendo gli autoctoni ad emigrare mossi da una “speranza” di vivere meglio altrove. La produzione letteraria dei “mahg˘ariyyu-n”, come furono chiamati gli scrittori e i poeti che, senza mai perdere il contatto con la madrepatria e soprattutto con gli intellettuali innovatori egiziani, contribuirono a un marcato rinnovamento della produzione letteraria araba, sia in prosa, sia in poesia2. Gli effetti di questo fenomeno, che ha rappresentato una frattura e un trauma determinante per l’identità storica e culturale posteriore, che vanno dall’assimilazione completa nel tessuto sociale di arrivo, al rifiuto delle proprie origini, fino alla perdita – totale o parziale – della propria identità, possono essere rintracciati 237 la rivista dell’ Arte nelle opere scritte dagli emigranti arabi in modo astratto. Come abbiamo chiarito qui sopra le condizioni di quei paesi troppo sfruttati dalle forze coloniali europei, oltre l’oppressione sotto il dominio ottomano e il bisogno delle economie del Nuovo Mondo di mano d’opera, sono stati i motivi che hanno spinto migliaia di giovani arabi ad immigrare oltre oceano, nel primo momento da Palestina, Siria e Libano, poi anche dall’Egitto. Le generazioni posteriori di questi primi avventurieri che si trovano oggigiorno nelle due Americhe sono decine di milioni. La critica araba ha riconosciuto e studiato la produzione narrativa e poetica dei migranti, confluita nella cosiddetta “scuola del Mahg˘ar”, formata da due gruppi essenziali: il Nord americano, “El Qalam” (la penna), il cui scrittore più famoso è Gibran, e il Sud latino, “El Osba Al Andalusía” (La Lega Andalusa), il cui autore più famoso è M’aluf3. Di questa scuola è sempre stato sottolineato il contributo allo sviluppo letterario e culturale delle varie nazioni di origine degli autori. Per rendere l’idea dell’importanza di tale scuola ritorniamo a segnalare sia Khalil Gibran, la cui produzione ha avuto un influsso, ormai indiscutibile, non solo sulla letteratura araba, ma sulla letteratura mondiale: Il profeta è ancora oggi una delle opere più lette in Europa come negli Stati Uniti. Accanto a Gibran, vi sono numerosi altri scrittori dell’emigrazione non meno importanti, come Mikhael Naima, Ilia Abu Madhi. D’altra parte, oggigiorno, si è diffuso l’interesse per la letteratura migrante in Italia, introdotta e seguita attentamente negli studi italiani da Armando Gnisci e dai suoi discepoli. Per Armando Gnisci […] i destini degli scrittori migranti e dei loro figli si dividono e si incontrano. Gli scrittori migranti sono quelli che hanno viaggiato, quelli che hanno imparato la lingua italiana lungo e a partire dalla strada, poi hanno letto Manzoni e Calvino. Gli scrittori “creoli” sono quelli che Manzoni e Calvino li hanno letti a scuola mentre imparavano l’italiano, e che poi hanno scritto in italiano4. Molti sono gli scrittori arabi migranti, che hanno pubblicato in italiano negli ultimi vent’anni, incoraggiati da studiosi e critici che si sono interessati di questo fenomeno. Basta consultare la Banca dati sugli Scrittori Immigrati in Lingua Italiana, BASILI, che elenca, nel 2010, circa 500 scrittori provenienti da più di 90 nazionalità. Una banca dei dati statistici, chiaramente, non può includere tutti gli scrittori migranti egiziani in Italia, ignorati, nel senso di essere invisibili, tanto dalla madrepatria critica letteraria quanto dai critici italiani. 238 la rivista dell’ Arte Alcuni di loro, infatti, sono arabofoni, a differenza degli scrittori italofoni che scrivendo in italiano sono meglio conosciuti. Alcuni di loro, all’inizio degli anni Novanta, furono affiancati nella scrittura da un “partner” letterario italiano, in grado di rendere più gradevoli le loro opere. Per questo, la traduzione delle opere degli scrittori egiziani che hanno scritto in Italia ma in lingua araba, e che sono stati pubblicati in Egitto, acquista una particolare importanza: queste opere anche se non parlano italiano, parlano dell’Italia e degli italiani/e. Il fenomeno migratorio ha cominciato a interessare e a preoccupare le società europee a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, con la prima grande ondata proveniente da diverse zone del sud e dell’est del mondo. L’Italia assume in tale contesto un ruolo del tutto peculiare: per la sua collocazione geografica al centro del Mediterraneo, infatti, è uno dei paesi europei maggiormente coinvolto nell’accoglienza ai migranti. Allo stesso tempo, l’Italia ha l’esperienza della sua lunga e ancora recente storia di emigrazione massiccia, soprattutto verso le Americhe, e oggi si trova a subire questo fenomeno, come una specie di rovescio del gioco, prendendo in prestito il titolo del primo saggio di critica letteraria di Armando Gnisci sul fenomeno della letteratura della migrazione in Italia, pubblicato nel 1992. Armando Gnisci è stato il primo studioso a monitorare l’emergere della letteratura italiana della migrazione, e a seguirne le vicende, muovendosi come compagno di strada degli scrittori migranti e mettendo a punto una vera e propria poetica, critica e mondialista, nella quale centrale è il ruolo innovativo delle scritture nate dall’incontro di mondi e di lingue diverse. Altrettanto fondamentale, però, è il ruolo degli scrittori migranti nel favorire il processo di «decolonizzazione e di mondializzazione della mente europea»5. Dunque, la critica letteraria transculturale, così come è stata impostata dal comparatista italiano, e la scuola che intorno a lui si è sviluppata, pare convergere e dialogare con quella araba sulla letteratura del mahg˘ar. Occorre precisare come Armando Gnisci riconosca alla letteratura della migrazione in Europa tra XX e XXI secolo una funzione attiva e critica nella presa di coscienza e dunque nel compito di decostruire la volontà di dominio e di conquista dell’Europa moderna, in campo letterario come in ogni altro. Ad Armando Gnisci si deve inoltre l’impiego del termine “migrante” per definire il campo letterario che ci apprestiamo a indagare. Oltre che riconoscere a lui certamente il merito di aver superato fin dall’inizio il dibattito intrapreso dagli studiosi per sottrarre tale letteratura alla connotazione negativa legata al “problema politico dell’immigrazione” dei vari governi degli ultimi vent’anni, ci sembra inoltre che il suo uso converga efficacemente con la poetica del mahg˘ar. A tale proposito occorre però sottolineare l’esistenza di una netta differenza tra la letteratura migrante araba e quella europea: la seconda non è legata alla colonizzazione come invece accade per la prima. Quando gli arabi colonizzavano una parte più estesa del 239 la rivista dell’ Arte mondo (dal VI secolo fino al Rinascimento europeo circa), il fenomeno migratorio era praticamente ignoto; mentre nella fase di “debolezza”, in particolare sotto l’impero Ottomano, dal XV fino al XX secolo, la migrazione è diventata effettivamente un modo di ricercare altrove i lumi per rischiarare il buio culturale del proprio mondo. Un ultimo ma fondamentale accenno si deve alla questione della lingua: se per Armando Gnisci gli scrittori migranti sono «quelli che cambiano vita e lingua, che girano il mondo e lo spazio, che trapassano i mondi e accrescono la presenza del letterato nel mondo e creolizzano le contrade dove si fermano»6, da parte nostra ci sembra opportuno anticipare come alcuni degli scrittori egiziani migranti non abbiano cambiato lingua, nonostante che buona parte della letteratura dei migranti arabi sia legata alle “storie di immigrazione”, e si sia dunque dedicata in parte alle condizioni dell’ambiente di origine e molto alle esperienze del protagonista fuori del suo paese: ne è esempio proprio il nostro scrittore che presentiamo qui con la sua opera tradotta in italiano, cioè Abou El Maati Abou Shareb, che vive a Firenze e che ha scritto e pubblicato in arabo, una “storia famigliare italiana”. Riassumiamo brevemente la sua biografia: il suo nome completo è Abou El Maati Ahmad Abdel Rahman Abou Shareb, noto con il nome di Abou Shareb. Egli nasce il 3 marzo 1952 a Ismailia d’Egitto, città che prende il nome dal Khedivé Ismail, re egiziano al quale si deve la costruzione del Canale di Suez nel 1869, ma anche la fondazione delle città che, sulle rive del Mar Rosso, ospitavano il multiculturale e multietnico cantiere di operai impiegati nell’escavazione del canale e poi di funzionari della Compagnia multinazionale del Canale. Anche dopo la nazionalizzazione della grande opera, nel 1956 a opera di Nasser, l’impronta cosmopolita delle varie città del Canale non scompare, anzi esse conservano la natura peculiare ai porti marini: quella di essere un punto d’incontro e incrocio fra i diversi mondi “gettati dal mare”. Le tante guerre subite hanno acuito nel giovane Abou Shareb la tendenza a chiudersi nel proprio ambiente, fra i propri connazionali, ai quali soltanto manifestare una totale e condivisa solidarietà. Una tendenza esistenziale che è ancora evidente nello scrittore, dedito per la maggior parte del proprio tempo a risolvere i problemi “umani” dei connazionali a Firenze, avvalendosi della propria esperienza da “veterano” migrante e considerato, da parte dei nuovi arrivati, un “grande fratello”. L’anno in cui Abou Shareb nasce, Nasser, con la sua rivoluzione sociale, mette fine alla monarchia fondata da Mohamed Ali, dando inizio ad un regime di impronta socialista il quale, benché in conflitto con lo spirito liberale delle città del canale, trova un grande sostegno presso le loro popolazioni, per lungo tempo vissute sotto il governo dispotico della straniera Compagnia del Canale. Liberati dai colonizzatori, ai quali era 240 la rivista dell’ Arte riservato ogni privilegio, mentre gli autoctoni si ritrovavano in una condizione di estraneità alla propria terra, gli ismailiti cominciarono a sviluppare una cultura molto ricca, che alla solida base della tradizione popolare egiziana sommava i frutti della convivenza con altre culture. Abou Shareb durante l’infanzia, quando vede nascere la prima repubblica egiziana, frequenta la scuola coranica che gli fornisce le basi per imparare la lingua araba classica. Il primo amore per le lettere nasce nel corso della scuola primaria, quando ogni fine settimana gli veniva assegnato da svolgere un tema sulle bellezze della sua città, che lo porta a esplorare e osservare tutto con occhi curiosi, ma anche a dedicarsi alla scrittura e alla lettura, a frequentare lungamente la biblioteca pubblica, dove ha la possibilità di leggere gli autori classici e contemporanei, i capolavori della letteratura mondiale e quelli del grande conterraneo Naghib Mahfuz, e di scoprire altri mondi. A undici anni scrive la prima poesia, pubblicata sulla rivista Al-Nasr (La vittoria), grazie alla quale riceve in premio sei Lire egiziane (corrispondente a quel tempo a 10 dollari, quasi lo stipendio di un impiegato medio di allora). Questo premio, oltre all’esperienza nella biblioteca, che egli stesso descrive come una vera e propria scoperta di un tesoro, lo stimola a scrivere ancora poesie e racconti brevi. La composizione del primo racconto, Il ritorno del mio babbo con il sorriso della libertà, risale agli anni delle scuole superiori, dove partecipa ai festival della poesia, in uno dei quali, accompagnato dal pianoforte recitò I patrioti del nostro Paese, un testo di incoraggiamento da lui composto per i soldati: sono gli anni della “guerra dei sei giorni” contro Israele. Anche questo componimento riceve un premio, una somma di danaro, ma raddoppiata, come raddoppiato era anche il suo entusiasmo per la letteratura. Finita la scuola superiore, si iscrive all’Accademia di cinema e teatro del Cairo, settore della scenografia. Ma il sogno dura poco: la guerra diventa sempre più violenta, i bombardamenti sulle città distruggono scuole, fabbriche e abitazioni civili e il giovane Abou Shareb è costretto ad abbandonare l’Accademia per prendere parte, insieme ad un gruppo di amici coetanei, al conflitto. Si arruola nel 1973, dopo l’addestramento diventa tiratore scelto e viene trasferito nel campo speciale nella zona delle piramidi al Cairo. Nello stesso anno scoppia la guerra e Abou Shareb viene mandato al fronte, a Suez, dove rimane fino al 1975. In questi anni scrive Diario di un cacciatore egiziano in guerra. Congedato dal servizio militare a fine guerra, viene assunto presso il tribunale di Ismailia, dove svolge un lavoro di responsabilità, e contemporaneamente scrive pezzi di cronaca sul settimanale Il Canale. Fonda anche, insieme ad alcuni giornalisti, scrittori e poeti, un Club culturale in cerca di giovani talenti letterari da far conoscere al pubblico proprio attraverso la rivista Il Canale. Eletto rappresentante dei giovani del partito Al Tajmu’, un partito di sinistra, nel 1976, si interessa dei 241 la rivista dell’ Arte problemi dei suoi giovani concittadini ritornati dalla guerra. Riprende gli studi con interesse, ma dopo alcuni mesi, oppresso dai problemi familiari, decide di abbandonare tutto: lavoro, politica, interessi culturali, amici e parenti e nel 1977 lascia l’Egitto. Privo di una meta, viaggia molto, visitando i paesi del Medio Oriente e scoprendo nuove realtà, opere, persone e bellezze naturali. Nell’aprile del 1980 ritorna in Egitto, ma a dicembre riparte per raggiungere l’Italia. Visita Roma, Napoli, Firenze. A Firenze decide di fermarsi e di cercare un lavoro che gli permetta di potervi rimanere. Conosce una giovane donna italiana con la quale stringe amicizia e dalla quale viene guidato nei primi rudimenti della lingua italiana. L’amicizia si rivela ben presto un sentimento più profondo, che porta Abou Shareb a sposarsi e a stabilirsi definitivamente a Firenze, dove inizia a svolgere lavori di vario genere. Si iscrive all’istituto Dante Alighieri per migliorare la conoscenza della lingua. E nel 1986 nasce l’unica figlia, alla quale trasmette, oltre alla ricca eredità di una vita avventurosa, la propria passione per il giornalismo. Abou Shareb, infatti, continua a scrivere articoli per alcune testate egiziane: per il settimanale vicino a Sadat October, per Il Canale, Al Ahram (edizione internazionale), e Ahram di Sera. Inoltre l’autore è tra i più citati dai siti sociali dell’internet di lingua araba, che gli chiedono la traduzione di articoli scritti in italiano per poterli diffondere anche in rete. L’autore prosegue anche nella stesura in lingua araba di romanzi, racconti e opere teatrali, ma per far fronte alle insormontabili difficoltà di pubblicazione, nel 2006 decide di pubblicare a sue spese tre delle opere che otterranno successo in Egitto: la raccolta di Racconti sul viale dell’Ovest, il romanzo La melodia del piano, le commedie Il parlamento dei topi, Viva l’Egitto e Da quale parte stiamo, Ministro degli Esteri?. In corso di stampa attualmente è un nuovo libro dal titolo 30 giorni con il figlio del sindaco e anche Il diario di un cacciatore egiziano, scritto nel 1975. Dal 2007 trova lavoro nell’ufficio culturale egiziano a Roma, dove non si limita al dovere degli incarichi quotidiani, ma svolge un’attività culturale tramite la quale quell’istituto, immerso nel bosco buio del Colle Oppio, è trasformato in un luogo pieno di vita e di attività di ogni genere. Questa attività finisce bruscamente, e il luogo da lui animato ritorna ancora una volta al buio di prima. Durante questo periodo, e fino ad oggi, l’autore ha contributo a diverse testate in lingua araba, e in italiano, come capo della redazione della rivista El Masria (l’Egiziana), un numero unico che si interessava degli affari della comunità egiziana a Roma, in cui ha pubblicato diversi articoli, usando pseudonimi per non ripetere la sua firma. Inoltre ha contribuito al mensile torinese Popoli, una rivista con un taglio da giornale, pluriliguista e pluriculturale, ove pubblica diversi articoli nei quali mette in risalto le attività culturali che riguardano gli immigranti arabi e segue e commenta gli eventi della madrepatria. L’autore dirige anche un la 242 rivista dell’ Arte giornale elettronico bilingue, in arabo e in italiano, Il mondo arabo (www.ilmondoarabo.net), seguito da un grande pubblico, non solo immigrato in Europa, ma anche nel mondo arabo. In questo giornale elettronico egli non parla solo di cultura, ma anche di politica, società ed altro. Attualmente Abou Shareb prosegue le sue attività di scrittore e giornalista, per le quali trae spunto dagli accadimenti quotidiani che più lo colpiscono, ma anche dalla esistenza privata e quotidiana fatta di gioie, dolori, lotte, conquiste. La melodia del piano, il testo che presentiamo ora nell’edizione italiana, tradotto da me in collaborazione con Marianna Massa, è un romanzo autobiografico e una cronaca di famiglia. Abou Shareb, tuttavia, e a differenza degli scrittori arabi che fanno sempre iniziare le loro opere autobiografiche dall’infanzia, vi narra solo gli anni fiorentini. E quindi, l’età dell’esilio volontario in Italia. Il tema centrale della narrazione è la sacralità della famiglia, un valore che l’autore sente profondamente legato alla propria cultura di origine e che lo accompagna costantemente nella nuova vita di immigrato. Il narratore racconta i disperati tentativi di proteggere la propria famiglia – quella “italiana” come quella “egiziana” – dalle avversità del destino: la malattia che colpisce l’amata moglie italiana, l’intervento chirurgico subito da sua figlia e ancora la malattia della madre. Nello stesso tempo, la scrittura letteraria mostra tacitamente la protezione che la famiglia fornisce al suo “portavoce”. Lo stile è scorrevole, quasi a imitazione della tecnica impiegata dai cantastorie egiziani, in grado di tenere il pubblico in ascolto delle epopee degli eroi per tutta la notte; ma, al contempo, il ritmo della narrazione si affanna e diventa spezzato, quasi che il lettore inseguisse il protagonista nella sua lotta contro la morte, contro le distanze e le sventure che trattengono sua moglie in ospedale, sua figlia a casa, in Italia, e i suoi genitori in Egitto. Si possono riassumere i dati essenziali de La melodia del piano secondo il modello suggerito da Tetz Rooke7. Data di pubblicazione: 2006 Patto autobiografico: Esplicito Genere autobiografico: Maturità Lo stato: Continuo Il narrante: L’io narrante Genere narrativo: Romanzo Il tempo: 1998-2000 la 243 rivista dell’ Arte L’autore: A.E.M, Abou Shareb Il paese: Italia; Egitto Lo sfondo sociale: Classe media L’età dell’autore al tempo della pubblicazione dell’opera: 55 anni L’opera nasce dalla reale esperienza dell’autore-narrante della ghorba, una parola-concetto-tema che spiegheremo tra poco. I motivi che hanno spinto l’autore a scrivere il romanzo, oltre al bisogno di trovare uno sfogo esistenziale e auto-curativo, o di alleggerire il peso dell’“estraniarsi”– potremmo dire “del farsi straniero in un mondo straniero” – vanno cercati nelle necessità creative che inducono ogni scrittore a riportare, e a trasformare, sulla carta gli avvenimenti della propria vita, per cercare il senso dietro gli eventi, un senso che altrimenti non sarebbe né visibile né spiegabile. È sempre stato molto forte nell’essere umano il desiderio di lasciare ai posteri testimonianza scritta della propria esperienza vitale, sia di un periodo breve e/o circostanziato, sia dell’arco di una intera vita. Senza andare a scavare nel profondo della psiche umana per capire perché si senta il bisogno di parlare di sé, è innegabile il fatto che in ogni cultura, sotto ogni parallelo e meridiano, l’uomo, o la donna, vuoi per vanità, o narcisismo, vuoi per un senso del dovere storico e morale, in una sorta di servizio da rendere all’umanità, scrivendo di sé e della sua famiglia riordina le memorie della sua vita e ne mostra il senso condivisibile con il lettore. Abou Shareb si cimenta nella scrittura con la voglia di comunicare le proprie esperienze, al pubblico dei lettori suoi connazionali e a tutti coloro i quali hanno sperimentato le dure e dolorose condizioni di vita dell’immigrazione, il primo impatto con la cultura occidentale, che nello stesso momento abbraccia e respinge. Ma immediatamente, occorre sottolinearlo, superando tale situazione, Abou Shareb ci offre nel romanzo un esempio di “condotta virtuosa” dei tanti attuali migranti in Europa che non si lasciano schiacciare dal peso dei problemi, e che reagiscono positivamente al trauma della migrazione. L’unico vero problema esistenziale ed emotivo che l’essere immigrato comporta per il nostro autore è la lontananza dal contesto “naturale” della propria terra natale. Neppure la forte nostalgia, però, lo spinge al pensiero di voler ritornare al suo paese. La nostalgia serve forse soltanto a richiamare la forma familiare della cultura di origine, alla quale più si sente legato ogni qual volta ne sente bisogno. E nella “situazione estraniante” la nostalgia non è solo dolore ma presidio della temperanza, della pazienza, della saggezza, forse, che non si impara nei libri ma, meglio che altrove, nella richiesta di un senso condiviso, nella famiglia, per vivere 244 la rivista dell’ Arte insieme custoditi dalla speranza, dalla dignità e dalla rettitudine. La nostalgia-ghorba è un sentimento traumatizzante ma potente. Ghorba è una parola che nasce da un’esperienza di esilio rispetto al luogo originario che si riconosce come proprio. Con tale termine si indica la tristezza dell’abbandono, la nostalgia acuta (quella chiamata in inglese home sickness), si evoca la fragilità dello straniero, la solidarietà fra connazionali che si incontrano altrove. Inoltre, secondo la tradizione letteraria egiziana, la ghorba più severa e crudele è quella che si sente in patria, quando lo straniamento diventa sinonimo di emarginazione e, come sottolinea Ibrahim Farouk8, la sua esperienza influenzerebbe non solo chi si è «estraniato» altrove, ma anche i suoi famigliari rimasti nella terra natale. Il tema della ghorba è da tempo divenuto uno dei temi più interessanti della letteratura araba. È anche un termine che si incontra in quasi tutte le opere degli scrittori migranti egiziani come una sorta di lamentazione che si leva non solo per la lontananza dalla terra natale, ma persino per trasferimenti da un quartiere all’altro nella stessa città: il distacco da quanto si percepisce come connaturato alla propria esistenza crea evidentemente per l’egiziano gravi problemi, di natura emotiva, ma il concetto di ghorba, con tutte le sue sfumature, letterarie e linguistiche o psicologiche e sociologiche, meriterebbe uno studio più profondo e dettagliato. Abou Shareb, come scrive un critico egiziano, ha «trasferito» una parte della sua cultura nel libro: si tratta del valore «sintetico» della «pazienza», così come appare nella tradizione egiziana, anche religiosa, utilizzato dall’autore come la chiave per combattere le calamità della vita e il loro potere distruttivo, della speranza e della dignità. L’autore rende noto questo concetto forte rivolgendosi ai suoi connazionali come «un ambasciatore senza valigia» della cultura egiziana in Italia9. E quindi, come un tramite transculturale mediante la narrazione di un’avventura umana alla luce della translazione, presentandosi come «un uomo tradotto», a translated man, come ha scritto Salman Rushdie. Un uomo tradotto nel mondo una seconda volta. Discordi sono state le ipotesi critiche sulla natura del romanzo proposte in Egitto da giornalisti e studiosi. Quasi tutti i critici sottolineano la spontaneità dell’autore, la sincerità nel rendere i sentimenti e la semplicità dello stile che non soffre certo di accademismi10 malgrado alcune imperfezioni linguistiche nell’arabo – come la punteggiatura che a volte rende confuse alcune parti del testo – ormai lontano e inconsueto per la mente di un uomo che vive “in un’altra lingua” da più di trent’anni. Ali Shinawi11 osserva come l’opera di Abou Shareb – a suo avviso un lungo monologo interiore che narra la trasformazione in eroi di persone incontratesi in condizioni eccezionali – parta da esigenze emozionali, cercando nella scrittura tanto il piacere di esprimersi quanto la fuga dal logorio che comporta la «quotidiana sopravvivenza nella diaspora». 245 la rivista dell’ Arte Diversa è l’idea di un critico rimasto anonimo. In una lunga analisi-recensione questi considera il romanzo un prototipo delle esperienze che si ripetono largamente fra i migranti, fra coloro i quali hanno deciso di espatriare e di tuffarsi in una realtà nuova, spesso sconcertante e difficile, della quale poco sappiamo sia per mancanza di una efficace informazione mediatica, sia per ignoranza della stessa letteratura migrante. L’importanza del romanzo di Abou Shareb risiederebbe perciò nella sua natura testimoniale, in grado di descrivere le difficoltà materiali, psicologiche, culturali che la migrazione comporta, esaltando allo stesso tempo i valori coranici della pazienza, della speranza e dell’amore12. Da parte sua, un poeta e critico egiziano di rilievo, Faruq Shusha13, analizza il romanzo indicando una caratteristica culturale e mistica molto legata all’autore/narratore, cioè il sufismo, pieno di fede e ottimismo che lo rende puro, lo stimola a vivere e convivere con serenità e amore, convinto che il domani porti una nuova speranza. Shusha, considerato l’emiro dei poeti arabi, aggiunge un’altra caratteristica dello stile, affermando che l’autore prende in prestito alcuni stratagemmi dal cinema. Gli avvenimenti del romanzo sono, secondo lui, messi insieme come se fosse una sceneggiatura di un film internazionale che avrà un lieto fine. Secondo lo stesso poeta/critico, il romanzo è una fotografia, o meglio un autoritratto del suo autore, con la sua sensibilità e l’emozione ardita dei sentimenti. Shusa afferma che il romanzo mette in scena […] una battaglia da eroe, combattuta da Abou Shareb – l’uomo, l’artista, il creatore, lo scrittore, il saggio, il sufi – con tutto il coraggio, la forza e volontà, senza disperazione e senza esitazione… La melodia del piano di sua figlia gli ha restituito la vita, e l’ha fatto ritornare a noi, suoi amici vicini, più sereno, più sorridente, più altruista14. Non tenendo in considerazione, però, che la musica che la figlia suona al pianoforte è quella europea. E così il sufismo, uno stile spirituale e materiale di mistica della saggezza, diventa un “traslato transculturale”. La memoria biografica dell’autore, oltre ad essere, in prima istanza, uno sfogo personale, diventa quindi una “guida” e un monito per i nuovi migranti avventurieri, che si apprestano a lasciare la loro patria per sfidare l’ignoto. Ma quel che contraddistingue La melodia del piano rispetto alle opere che si fermano al racconto delle traversie della migrazione, risiede nella scelta da parte dell’autore di indagare i legami d’amore che uniscono fra loro i diversi membri della famiglia, la quale diviene in tal modo il maggiore ambito espressivo del romanzo e la sua custodia, in uno “stile mesto” che non è solo nostalgia e non è mai disperazione. Potremmo dire che si tratti di uno “stile spirituale”. I protagonisti sono tre, fermamente ancorati al proprio ruolo famigliare: l’autore-narrante, marito e padre, sua moglie – maestra di professione, madre e sostenitrice della famiglia, gravemente malata e dunque in pericolo di vita – e la figlia, alla quale si riferisce il titolo: suonando «la melodia del piano» ella afferma il 246 la rivista dell’ Arte trionfo della vita sulla morte e rappresenta la speranza e il futuro. Il romanzo quando è stato pubblicato in Egitto ha suscitato molto interesse tra il pubblico e la critica, nelle due ristampe finora uscite. Oltre a recensioni in diversi quotidiani e riviste, da parte di giornalisti e critici di rilievo, ha avuto riconoscimenti da studiosi che considerano questo romanzo “non romanzesco”, in senso europeo, un tentativo verista di analizzare e narrare il mondo migratorio, senza deviare i lettori nei labirinti della sociologia, o nella banalità dei massa media. Il romanzo di Abou Shareb si svolge in diciotto capitoli, la maggior parte di essi è ambientata in Italia, mentre solo i capitoli ottavo, decimo e undicesimo si svolgono in Egitto. Alla luce di quanto abbiamo sostenuto prima, va sottolineato come nel testo una sola volta si constati esplicitamente il dolore per la lontananza dalla terra d’origine, quando cioè il narratore non riesce a tornare in Egitto in tempo per vedere il padre morente; e come vi si trovi un’unica allusione a problemi di lavoro. La narrazione si concentra, invece, su quattro principali avvenimenti intorno al protagonista-narratore: l’infermità della figlia che deve suonare in un concerto; la travagliata malattia della moglie; la morte del padre e la malattia della madre nel paese d’origine. Interessante sembra anche portare alla luce gli aspetti imagologici del romanzo: in primo luogo quale sia l’immagine dell’Italia che l’autore offre al lettore arabo, ma anche – tramite la presente traduzione e pubblicazione – ai lettori italiani, e quale il volto dell’Egitto presentato. I personaggi “simbolo” della società italiana sono senza dubbio positivi: vi troviamo bontà (i parenti della moglie), cultura e sapere (i professori e i medici che curano la moglie e la figlia), compassione (la nipote del conte), simpatia (il medico della terapia chimica, il medico di famiglia e persino l’impiegata dell’agenzia turistica). Al contrario, l’autore non si esime dal criticare alcuni aspetti negativi della società egiziana rappresentata da figure come gli agenti dell’aeroporto, l’autista e il venditore di ricariche telefoniche. Lo scrittore sembra voler esaltare e ringraziare l’ambiente italiano-fiorentino e criticare quello egiziano: la novità è data dal fatto che Abou Shareb ha scritto il libro in arabo e che il suo successo è stato decretato in Egitto. Questo fatto “curioso” e imprevedibile per un lettore italiano, potrebbe discendere direttamente proprio dallo spirito sufico della scrittura narrativa del nostro autore. Infine, forse ai lettori italiani l’opera sarà sembrata pervasa da una atmosfera totale e continua di dignitosa mestizia, quasi una innaturale, o estremamente virtuosa, modestia. Invece, essa discende da una visione profondamente religiosa dello scrittore, di una religione che però gli europei non sono abituati a riconoscere attraverso la loro visione della religione islamica. Tutto accade nel romanzo come se la “mestizia” sia una virtù che aiuta a difendere gli individui dalle disgrazie in terra straniera e che vive nella cinta della famiglia, dove l’individuo non teme mai di rimanere solo. Essa, quindi, 247 la rivista dell’ Arte serve per poter resistere meglio e giustamente alla devastazione emozionale della ghorba. E, al contempo, essa si rivela come una superiore accettazione della condizione umana, quasi eroica – di un eroismo che è vicino, però, più alla figura di Giobbe che a quella degli eroi omerici Achille o Ulisse – e un ringraziamento pacato e sottile, un dono di risposta alle persone straniere dalle quali siamo ospitati, per la loro attenzione e benevolenza. Nel testo di Abou Shareb un gruppo famigliare egiziano e i cittadini di Firenze si scambiano una gioia discreta e condivisa nel modo di affrontare con semplicità e umanità piena le vicende della gioia e del dolore. La difesa dalla potenza devastante della ghorba e il ringraziamento amichevole dei semplici verso gli ospiti stranieri nella città straniera sembrano dare forma alle due forze che individuano lo stile della narrazione, una musica bassa e continua che accompagna la vita attraverso lo spirito della pazienza vitale del sufismo. Abou Shareb riesce a disegnare un quadro dettagliato della vita quotidiana soprattutto attraverso i dialoghi, ininterrotti dalla prima all’ultima pagina, che presentano uno spaccato della vita con la sua semplicità e la sua complessità, insieme, e che in definitiva danno a La melodia del piano l’impronta di un romanzo moderno, dal nostro punto di vista misto, egiziano e italiano. 1 Il Rinascimento arabo. CAMERA D’AFFLITTO ISABELLA, Letteratura araba contemporanea. Dalla nahdah a oggi, Roma, Carocci, 2007, p. 95. 3 La famiglia M’aluf, scritta anche Maalouf, a cui appartiene anche Amin M’aluf, membro dell’Accademia Francese, è una delle famiglie libanesi note per essere al centro del fenomeno migratorio dai primi anni del Novecento. Si ricordano almeno tre di questa famiglia che hanno aderito alla Lega Andalusa, quali Shafiq, Fawzi e Michel M’aluf. 4 Citato da LAMRI TAHAR, “Pillole di letteratura migrante in Italia”, minima&moralia, 12 maggio 2010, http://www.minimaetmoralia.it. Ripreso da GNISCI ARMANDO, Il rovescio del gioco, Roma, Carucci, 1992. 5 Cfr. GNISCI ARMANDO, Creolizzare l’Europa. Letteratura e migrazione, Roma, Meltemi, 2003. 6 GNISCI ARMANDO, MOLL NORA (a cura di), Diaspore europee e lettere migranti, Roma, Edizioni Interculturali, 2002, p. 194. 7 ROOKE TETZ, “In My Childhood. A Study of Arabic Autobiography”, Stockholm Oriental Series, 15, Aug. 1997. Rooke, studioso di letteratura araba a Stoccolma, ha pubblicato questo saggio nel 1997. Si tratta di una rielaborazione in forma breve della sua tesi di dottorato, in cui viene studiato il genere autobiografico nella letteratura araba. Il libro è stato tradotto in arabo nel 2002 (l’unica versione integrale del lavoro di Rooke) ed ha avuto un’importanza straordinaria per lo studio di questo genere letterario nell’area araba. 8 Scrittore e giornalista egiziano. Cfr. FAROUK IBRAHIM, “L’esperienza di vita di Abou Shareb nel suo libro Racconti sul viale dell’Ovest”, Al Ahram Internazionale, 43548, 28.2.2006. 9 Cfr. FAHMI ABD EL MONEIM, “Introduzione”, in SHAREB ABOU, La melodia del piano, Il Cairo, 2006. 10 Cfr. EL SALAB MOHAMED HELMI, “Uno spazio per il dialogo”, Al Ahram el Arabi, 10.6.2006. 11 Critico letterario egiziano. Cfr. SHINAWI ALI, “La melodia del piano”, Ahram di Sera, Il Cairo, 13.4.2006. 12 Cfr. la recensione anonima nel quotidiano Ahram Internazionale, “Il romanzo di Abou Shareb, una storia egiziana narrata all’italiana. La melodia del piano suona la speranza derivata dalle malinconie della ghorba”, 43751, 10.9.2006. 13 Citato in FAHMI ABD EL MONEIM, “Introduzione”, in SHAREB ABOU, La melodia del piano, cit.. 14 Ivi, p. 7. 2 248 la rivista dell’ Arte la 249 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Rosa Di Violante Nota a proposito della redazione transculturale de La Melodia del piano di Abou Shareb Questa nota nasce, nella mente di chi l’ha ideata e poi commissionata all’interno di una Libera Scuola di Transculturazione, come una “certificazione” del lavoro di collaborazione fra scrittori, traduttori e redattori che operano nel campo della Letteratura Italiana della Migrazione [LIM] per la collana “Kumacreola”, presso l’editore Cosmo Iannone di Isernia, fondata e diretta da Armando Gnisci. “Kumacreola” ha iniziato a produrre libri dal 2004 con Terra mobile di Yousef Wakkas, scrittore siriano. La redazione del testo di Abou Shareb segue la poetica che il fondatore-direttore ha pensato tempo fa per le opere della LIM, ma che può trovare una felice applicazione anche nel lavoro su un testo scritto e pubblicato in arabo e ora qui tradotto in italiano da un translator egiziano e da una italiana. Si tratta della poetica-pratica della redazione come forma di ‘doppiaggio’ della voce. Il testo ‘toccato’ dal lavoro redazionale non va mai riformulato, sostiene Gnisci, «quanto piuttosto assecondato: sulla riga, per il verso, appena aggiustato, riflesso, a seguire»1. È un intervento che, nel caso di autori non di madrelingua italiana, sfiora la «pelle» del testo, con «sensibilità» e «accortezza» e lo educa alla lingua che l’autore ha scelto di affrontare e adottare letterariamente. Il mio intervento si pone entro queste coordinate di 250 la rivista dell’ Arte riferimento, teso a conservare e a valorizzare quella “mestizia silenziosa” di significati e di valori e del cursus della scrittura de La melodia del piano, che hanno trovato un commentatore esemplare in Hussein Mahmoud, nella sua postfazione che completa criticamente il suo lavoro di traduttore e di ermeneuta. Il narratore Abou Shareb, a sua volta, è un traduttore dal silenzio. Il suo piano è rovesciare tutto – il dolore così come lo “stare un po’ meglio” – nel cursus del narrare, traducendo costantemente in mestizia l’invisibile e il non-detto, che sono consustanziali al dettato e alla scrittura. Questo lavoro ha richiesto un equilibrio costante fra la volontà di conservare la pratica dell’opera nel suo “passaggio” linguistico e culturale all’italiano e la proposta di un “doppiaggio” creativo che ne potesse valorizzare stili e contenuti, senza togliere né aggiungere. In un solo caso abbiamo scelto di operare un’aggiunta-dettaglio al testo, piccola ma significativa, volta a potenziare semanticamente alcuni momenti della narrazione che si pongono al lettore come ideale contrappunto alla musicalità e alla leggerezza della scrittura di Abou Shareb. Non la esterno perché essa è minima e sfuggente e deve rimanere come un piccolo segreto nel testo. In questo caso letterario, possiamo così definire la redazione non solo un passaggio di nettezza linguistica obbligatorio nella proposta di un testo “corretto” al lettore e al mercato editoriale, ma anche un “pezzo” ultimo, ma mai definitivo, di quella collaborazione transculturale che un racconto lungo come La melodia del piano è stato capace di mettere in moto. Una collaborazione “complicata” dalla “qualità” culturale e linguistica degli “attori” in gioco: uno scrittore egiziano che vive in Italia ma scrive in arabo (Abou Shareb); un traduttore egiziano italofono che lavora in Egitto insegnando italiano all’università Elwan del Cairo (Hussein Mahmoud); una traduttrice italiana “dislocata” al Cairo (Marianna Massa). Una traduttrice-redattrice italiana che non conosce l’arabo, me, e che quindi viene anch’essa da una forma del silenzio. L’opera di custodia del testo e di azione su di esso nel mio lavoro editoriale ha richiesto una un’accortezza poetica e pratica, basata su un’idea di un sapere-fare “aperto”, che nasce dalla relazione e dal “fare insieme”, frutto della collaborazione transculturale tra le persone, oltre che tra le culture, tra le generazioni e tra i generi. La sua via è quella suggerita dagli scrittori della migrazione mondiale, italiani e non solo: la decolonizzazione dalle nostre prospettive eurocentriche, l’esposizione benefica e imprevedibile alla creolizzazione e la mondializzazione delle nostre menti2. La letteratura traduce e illumina questo cammino, perché essa è maestra di finesse umana, come ha scritto Iosif Brodskij. 251 la rivista dell’ Arte È importante, infine, ricordare alcuni aspetti della ricezione del testo, esposti nella postfazione di Hussein Mahmoud. La melodia del piano, infatti, è un pezzo di vita raccontata seguendo la strada dell’autobiografia da un migrante egiziano in Italia, destinato originariamente ad un pubblico apparentemente lontano, ovvero quello della madrepatria egiziana, che ora viene proposto in traduzione-pubblicazione anche ai lettori italiani. Due viaggi testuali e “due prime volte” linguistiche si incrociano, ora. Anche questo incrocio transculturale, assieme ai meriti dell’opera e al gioco delle sue traduzioni “tra le lingue”, concorre a definire il senso acutamente cooperativo che ha lavorato in questa “seconda” e “prima” Melodia del piano. Il miglior fine, in fondo, lo raggiunge il lettore che compie propriamente l’opera e la lascia aperta nella sua memoria. 1 2 GNISCI ARMANDO, “editing (doppiaggio)”, Kúmá. Creolizzare l’Europa, 4, 4 aprile 2002. Cfr. GNISCI ARMANDO, Manifesto Transculturale, 16 maggio 2011, pubblicato in questo primo numero di Kuma&Transculturazione. Il Manifesto è stato tradotto in spagnolo, galego, francese, portoghese, inglese, arabo e cinese. la 252 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Christiana de Caldas Brito 500 Temporali in Brasile Sono appena tornata dal Brasile, dove è stato presentato, prima a São Paulo e poi a Rio de Janeiro, il mio romanzo 500 Temporali, edito nel 2006 da Cosmo Iannone, nella collana Kumacreola di scritture migranti creata da Armando Gnisci. A tradurre il libro in portoghese è stata Roberta Barni, professoressa di lingua e letteratura italiana all’Universidade de São Paulo (USP). La Barni vive in Brasile sin da piccola. La casa editrice è Mar de Ideias. 253 la rivista dell’ Arte Come ebbe inizio questo evento prolungato di transculturazione in cui una brasiliana migrante pubblica in Italia un romanzo ambientato nelle favelas di Rio de Janeiro scritto in italiano, e questo romanzo viene tradotto in portoghese, la sua lingua, da un’italiana che vive in Brasile? Tutto iniziò con una mia amica dai tempi dell’adolescenza, Martha Pires Ferreira, che aveva trovato difficoltà nel leggere 500 Temporali in italiano. Martha spesso mi diceva di dispiacersi che i miei libri non potessero essere letti dai miei connazionali. Ella organizzò un mio incontro con Daniella Riet, la direttrice della casa editrice Mar de Ideias. All’incontro era presente il consulente legale della casa editrice, Cristiano Miranda. In quell’occasione, a Rio, consegnai loro il mio romanzo. Mesi dopo, ci siamo rivisti a Roma. Daniella e Cristiano avevano chiesto a Leonardo Boff (sì, uno dei protagonisti della Teologia della Liberazione) che conosce bene la lingua italiana, di leggere il mio libro e di dare il suo parere per un’eventuale traduzione e pubblicazione. Il parere di Boff fu favorevole. Il libro, fra l’altro, arrivava in un momento opportuno, date le molte discussioni sulle favelas a Rio, motivate anche da due recenti film di grande impatto sul pubblico: Tropa de elite, dal regista José Padilha, considerato il miglior film al Festival di Berlino del 2008. «Non è usuale tradurre in portoghese il romanzo di un’autrice carioca, una brasiliana che divide cuore e cultura tra due paesi con grandi affinità. Nella stessa forma in cui Christiana si trova divisa, Brasile e Italia sono uniti dall’origine dei nostri ascendenti, dalle nostre lingue, dai nostri nomi, dai sapori e dai colori. Noi, dell’editrice MAR DE IDEIAS siamo grati per la collaborazione della casa editrice Cosmo Iannone e in modo particolare ad Armando Gnisci che ha facilitato lo scambio culturale tra le due case editrici. Grazie a questa collaborazione è stato possibile pubblicare 500 TEMPORALI in Brasile. Ringraziamo l’autrice, Christiana de Caldas Brito per la fiducia concessaci. Il ringraziamento si estende anche alle numerose persone che hanno dato prestigio alla presentazione del libro a São Paulo e a Rio de Janeiro». Queste parole di Daniella Riet sono state tratte dal sito della casa editrice: http://www.mardeideias.com.br. 500 Temporali è stato presentato il 17 novembre a São Paulo, nella “Livraria da Vila”. C’è una catena di queste eleganti librerie in varie zone della città di São Paulo. Quella dove è stato presentato il mio libro ha tre piani e si trova nell’Alameda Lorena, al centro della città, non molto distante dall’Avenida Paulista. Nel primo piano, in fondo, su un grande tavolo di legno circondato da confortevoli poltrone, avevano messo il romanzo sopra un leggio, sotto uno spot luminoso. La luce risaltava l’eccellente veste tipografica del libro. 254 la rivista dell’ Arte Cominciarono ad arrivare gli amici e gli amici degli amici e delle persone curiose che si avvicinavano. L’ambiente era informale, in mezzo ai libri che coprivano le pareti dall’ingresso della libreria fino al salotto letterario dove ci trovavamo. Si era creata, intorno al tavolo, un’allegra conversazione che durò dalle ore 17 fino alle 22. Presentare un romanzo in Italia è un evento soprattutto intellettuale, oltre che di mercato. Si parla del momento storico in cui il romanzo sorge, si enfatizza il suo significato. L’autrice o l’autore spiega le sue motivazioni alla scrittura di quel testo e, in un certo senso, a volte, sembra quasi giustificarsi. Presentare un libro in Brasile è una festa. Viene privilegiato più il lato affettivo dell’evento. Avevo invitato i miei parenti e i miei amici. Aspettavo i miei invitati e loro si sono presentati già con il libro in mano per ricevere una dedica. Poi, tutti si sono seduti a far conversazione. Chi non ha trovato una poltrona o una sedia ha chiacchierato in piedi, mentre io scrivevo le dediche. La libreria si era magicamente trasformata in una casa in festa. Un cameriere offriva salatini e dolcetti insieme a delle bibite. A Rio de Janeiro, la presentazione era parte dell’evento Primavera dos livros. Potrei comparare questa “Primavera dei libri” di Rio alla Fiera della piccola e media editoria di Roma, anche se alla fiera di Roma partecipano molte più case editrici. A Rio, erano 75 le case editrici presenti. La fiera carioca, che è alla sua undicesima edizione, è nata nel 2001 con lo scopo di dare spazio alle case editrici indipendenti dalle grandi società industriali, e sono quelle che offrono un prodotto culturale diverso dai best seller nordamericani. Per quattro giorni (quest’anno, da giovedì 24 novembre alla domenica 27) vengono esposti e messi in vendita libri di case editrici che appartengono alla Liga Brasileira de Editores (LIBRE), gruppo che ha organizzato il primo evento con un grande successo che da allora ogni anno viene ripetuto. La primavera dos livros offre anche cinema, tavole rotonde, giochi e storie raccontate a voce per i bambini, dibattiti, gruppi musicali e danze. Questa primavera letteraria è ospitata nel suggestivo ex palazzo del presidente della Repubblica, quando Rio de Janeiro era la capitale del Brasile. Oggi il Palazzo del Catete si è trasformato nel Museo della Repubblica. In un parco tropicale, con altissimi alberi centenari e un gazebo ottocentesco, le case editrici presenti formano, sotto tende bianche, vere strade di libri in mezzo al verde del giardino. C’è pure un “pipoqueiro” (il venditore di popcorn della mia infanzia), un venditore di gelati e delle signore con dei dolcetti fatti in casa. Nel giardino, alla colonna sonora pensano gli uccellini. La fiera rimane aperta dalle 10 del mattino fino alle 18, escluso l’ultimo giorno in cui non potrebbe mancare 255 la rivista dell’ Arte - siamo in Brasile! - un incontro musicale, con canti e danze. L’entrata alla manifestazione è gratuita. Primavera dos livros, inizialmente organizzata dalla Liga Brasileira de Editores, oggi conta la sponsorizzazione della Prefettura e della Segreteria Municipale dell’Educazione di Rio de Janeiro. Il suo obiettivo è formare nuovi lettori, offrire uno stimolo alla lettura e dare uno sguardo a quello che viene creato nella periferia delle città brasiliane. Uno speciale riguardo va alle tradizioni culturali del Brasile. Mi domandano spesso se scrivere in italiano e raccontare il mio paese in una lingua diversa dalla lingua natale mi faccia sentire in colpa verso la mia cultura. Non senti di tradire le tue origini? Non ti crea dei conflitti? No, assolutamente no. Mi sono sentita a mio agio nell’aver scritto un romanzo in italiano. Vivere in Italia significa anche vivere in italiano. Scrivo nella lingua italiana perché voglio essere letta e capita dove vivo. 500 Temporali è stato scritto per gli italiani. Ogni tanto ho lasciato dei termini in portoghese, certi modi tipici del parlare carioca che aiutavano a caratterizzare personaggi e situazioni del romanzo. Quando andiamo in un paese sconosciuto, la cui lingua non parliamo, ci vengono incontro delle parole il cui significato ci è oscuro. Tali parole comunicano un senso di estraneità e presentano anche sonoramente il nuovo paese. Lo stesso succede con le parole lasciate in portoghese nel mio testo italiano. Naturalmente questo senso di estraneità si è perso con la traduzione in portoghese. La lingua è la veste che diamo ai nostri pensieri. Più lingue usiamo, più profondamente conosciamo la realtà del mondo, non solo di uno o di due paesi. Al di là della soddisfazione di essere letta dove sono nata, la traduzione di 500 Temporali ha avuto per me il significato di vedere le mie idee rinnovate perché riconosciute e vestite diversamente. A Rio, 500 Temporais è stato presentato la domenica 27 novembre dalle ore 17 alle ore 18:30. Il giorno prima, ero andata a visitare la fiera, per curiosare nei vari stand sparsi in giardino. Ho sfogliato tanti libri, ho chiacchierato con le persone che li vendevano. Sono rimasta colpita soprattutto dalla originalità e dalla qualità grafica dei libri infantili. Per un attimo, tra le meraviglie dei libri, sono tornata bambina, curiosa e capace di stupore. Grazie alla magia dei miei temporali, ero tornata in Brasile e avevo di nuovo una casa a Rio, in mezzo ai libri. la 256 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Ricciarda Ricorda Archivio delle Scritture e Scrittrici migranti Università Ca’ Foscari Venezia L’Archivio è nato dall’intenzione di partecipare a quelle «pratiche critiche di azione transculturale tra i saperi contemporanei», a cui invitano le prime righe del Manifesto transculturale proposto da Armando Gnisci: ci è sembrato che, a Ca’ Foscari, fosse riconosciuta una centralità tale alle lingue e alle letterature straniere (se ne possono studiare ben quaranta, numero davvero straordinario), da richiedere un’attività in questo campo, che per altro ci appariva in piena sintonia con la vocazione di Venezia agli “incroci di civiltà”, alla funzione di crocevia dei saperi. Perché le scrittrici, perché l’ottica di genere? Un primo motivo a ispirare la scelta è stato di ordine pratico: il progetto dell’Archivio è stato pensato e fortemente voluto dal Comitato delle Pari Opportunità, nella persona delle colleghe che lo hanno presieduto negli ultimi anni, Susanna Regazzoni e Giuliana Giusti, e che hanno pensato di dedicare una parte del modesto finanziamento del CPO a un centro di studi sulle scritture migranti, con l’intenzione di lavorare sui due versanti dell’immigrazione e dell’emigrazione, anche degli italiani in uscita. Un secondo, ma anche più sostanziale motivo, ci ha spinto a privilegiare le scritture femminili: la loro abbondanza e fecondità; nel quadro delle scritture migranti si riscontra infatti una crescente presenza femminile, attualmente predominante: secondo dati recenti (inizio del 2010) si attesta infatti al 56,7%. Accanto al dato statistico, va ricordata anche la crescente maturità critica delle scrittrici, il valore di eccellenza raggiunto da alcune di esse; d’altra parte, riteniamo che la scrittura delle donne debba essere seguita con un’attenzione particolare, perché possa avere tutto lo spazio che merita. Abbiamo inaugurato l’Archivio nel marzo di quest’anno, in una giornata importante per noi, sia perché ha significato l’avvio di un progetto cui lavoravamo da tempo, sia per l’interesse che ha suscitato, sia per la 257 la rivista dell’ Arte gradita partecipazione di ospiti come la scrittrice Laila Wadia, che è stata intervistata da Silvia Camilotti. L’Archivio è collocato presso la Biblioteca del Servizio didattico alle Zattere (Dorsoduro 1392), scelta sia perché l’allora direttore Alessandro Bertoni ci ha accolto con grande generosità, sia perché è la biblioteca del nostro Ateneo con l’orario più esteso (anche la sera e la domenica) e più aperta alla città. Al momento, stiamo incrementando il fondo librario e intendiamo farlo crescere il più possibile, arricchendolo anche di materiali diversi – documentari, materiali multimediali, ecc.; abbiamo partecipato, in questi primi mesi, a varie iniziative: un incontro con scrittrici e studiose migranti dell’area balcanica (Melita Richter, Azra Nuhefendic), una Giornata Internazionale di Studi “America Latina: la violenza e il racconto”, l’interessante esperienza del Centro Donna della città di Venezia, il progetto di Digital Story Telling for Transformation, dedicato a racconti di donne Migranti. Stiamo progettando un sito web, legato alla pagina di Ca’ Foscari, dove inseriremo notizie, materiali, recensioni, ecc.; vorremmo riuscire a organizzare un seminario annuale di riflessione e di raccolta di informazioni e di dati, che ci consenta di confrontarci con altre esperienze e di approfondire le nostre competenze: saremo molto contente di ricevere suggerimenti, idee, proposte da parte di chiunque ce ne possa fornire e speriamo di riuscire a far crescere l’Archivio e di renderlo un servizio il più utile possibile. Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può scrivere a Ricciarda Ricorda o a Monica Giachino all’indirizzo email: [email protected]. la 258 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione Care amiche e cari amici, siamo lieti di informarvi che è possibile consultare online, in via provvisoria, all’indirizzo http://sbcr.comperio.it/ il catalogo del Fondo Armando Gnisci (FAG), donato al Consorzio delle Biblioteche comunali dei Castelli Romani, presso la Biblioteca di Lanuvio. Il FAG è frutto, in progress, di una cospicua donazione di volumi, riviste e documenti che riguardano la Letteratura Italiana della Migrazione (LIM) e la storia della Letteratura Comparata in Italia (LCI). Al momento risultano schedati 400 volumi, e presto sarà disponibile online anche il corpus delle riviste. Per visualizzare i documenti è necessario collegarsi all’Opac del Sistema bibliotecario dei Castelli Romani, selezionare la Biblioteca di Lanuvio e cliccare sul Fondo Armando Gnisci il link: “Vedi tutti”. Ogni documento può essere trovato attraverso i comuni criteri di ricerca in Opac (titolo, autore, soggetto etc.). Il FAG ospita anche un primo contributo ad un “Archivio delle carte” degli Scrittori Migranti in Italia, che si propone di raccogliere e conservare l’importante materiale documentale (carteggi, autografi, carte d’autore etc.) degli scrittori migranti e della transculturazione, particolarmente importante ai fini della ricerca filologica e storica sulla LIM. Gli/Le scrittrici – al femminile, perché la banca dei dati BASILI negli ultimi anni ha accertato il sorpasso e la prevalenza numerica delle autrici sugli autori – che volessero contribuire ad accrescere l’Archivio tramite donazioni personali, o a farci proposte e consigli, può scrivere direttamente ad [email protected]. Invitiamo, infine, gli editori italiani, e non, che pubblichino opere di e/o su scrittori migranti di inviare notizie e volumi ad Armando Gnisci, Via delle Costellazioni, 183 // 00144 Roma. Così come gli editori ed autori della e/o sulla Comparatistica italiana. Le opere della LIM e della LCI hanno ora una piccola casa sui Colli Albani accanto al tempio del VI secolo prima dell’Era Volgare della Grande Dea dei Latini. Armando Gnisci la 259 rivista dell’ Arte Kuma&Transculturazione BASILI BASILI nasce nel 1997 presso l'Università La Sapienza di Roma grazie ad un finanziamento iniziale del CNR e a seguito di una ricerca pluriennale sulla nuova letteratura prodotta dagli scrittori immigrati in Italia condotta da Armando Gnisci, docente di Letterature comparate presso l'ateneo romano sino al 2010. È la prima e l’unica banca dati on line degli scrittori immigrati in Italia che scrivono e pubblicano le loro opere in lingua italiana. Basili è un work in progress che raccoglie i dati bibliografici delle opere degli scrittori, degli studi ad esse dedicati e delle tesi di laurea elaborate sulla letteratura della migrazione in Italia (le tesi di laurea prodotte presso altre università vengono segnalate su Basili solo a seguito dell'acquisizione del materiale inviato dal tesista). Affianca la Banca dati un bollettino di sintesi periodico e un "trend dati" di crescita della banca dati, scaricabili dalla homepage, entrambi realizzati da Maria Senette. BASILI è annoverata tra le Worldwide resources per gli Italian Studies dell'Università di Berkeley, al sito seguente: http://italian.berkeley.edu/resources/worldwide.shtml. La banca dati è stata affiancata sin dalla sua fondazione da una biblioteca cartacea di gran parte dei volumi schedati, ora reperibile nel fondo FAG-Fondo Armando Gnisci della Biblioteca di Lanuvio (RM) e consultabile dal sito: http://sbcr.comperio.it/, l'elenco dei volumi del fondo FAG è al link: http://sbcr.comperio.it/index.php?page=View.ShelfDetail&id=158. Recapito Internet della banca dati: www.disp.let.uniroma1.it/basili2001/. Sede attuale: Dipartimento di Studi greco-latini, italiani e scenico-musicali - Sapienza Università di Roma. Fondatore della Banca dati e responsabile scientifico dal 1997 a novembre 2010: Prof. Armando Gnisci. 260 la rivista dell’ Arte Attuale responsabile scientifico: Dr. Franca Sinopoli (Sapienza Università di Roma, ricercatore di Critica letteraria e Letterature comparate). Database Consultant & Editor: Dr. Maria Cristina Mauceri (The University of Sydney, Department of Italian Studies). Recapito postale per l'invio di libri e riviste: Dr. Franca Sinopoli, Dipartimento di Studi greco-latini, italiani e scenico-musicali, Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma. Fax: +39.06.491609 E-mail del responsabile scientifico: [email protected] 261 la rivista dell’ Arte CHE COSA NE FACCIAMO DELL’ARTE Questa sezione non è una vera propria sezione autonoma ma un’area di riflessione ancor più evidentemente interdisciplinare delle altre aree della nostra rivista. È più che ovvio quanto sia necessario un luogo specifico, viste le stanze di interesse, nel quale far bollire la pentola in cui si cuoce la questione sempre aperta di che cosa si intende quando usiamo questa parola dalle numerosissime accezioni, “arte”. E quindi anche dell’uso che facciamo di questo pensiero, perché tutto quello che ci riguarda è sicuramente un utensile che può essere usato, a seconda dei nostri interessi, per qualunque scopo, dal più nobile al più vergognoso. Del resto, nella nostra storia è evidente come l’arte possa aver liberato qualcuno come anche ingannato qualcun altro. Il fatto è che il ventaglio delle possibilità faste e nefaste si allarga sempre più quando si ha a che fare con una parola così frequentemente sulla bocca, negli occhi, nelle orecchie, nell’intestino, nel fegato, nel pancreas, nelle surrenali e sulla pelle di tutti noi. Chi non incontra questo concetto almeno una dozzina di volte al giorno? Se non altro alla televisione o sui giornali o sul web. E la cosa più interessante è che nessuno chiede “Cosa voleva dire quello lì?” “Che cosa intendevi dire tu?” Invece per niente, se non raramente tutti siamo d’accordo, tutti ci siamo capiti al volo anche se sembra assai difficile che poi lo si sia sul serio, tutti d’accordo. Ci viene adesso in mente che la stessa cosa succede per la parola “Dio”. Facciamoci caso. Anche quello di Dio è un concetto che mette ipocritamente tutti d’accordo. “Ma com’è fatto il tuo Dio?” “Ha la barba e i baffi?” “Tuona o ci carezza?” ”Vede, sente, giudica e punisce proprio tutto tutto oppure se lo faccio con discrezione magari chiude un occhio?” Possibile che quello che invocava Maria Teresa di Calcutta sia lo stesso a cui George W. Bush obbligava tutti i suoi ministri a rivolgersi per chiedere consiglio all’inizio di ogni riunione di gabinetto? Tanto è che queste due parole, arte e Dio, anzi come spesso si usa, Arte maiuscolo come Dio, sono a volte tra i più efficaci passepartout per le nebbie del pensiero, proprio come “amore”, “bellezza”, “il bene” e “il male”, queste ultimi entrambi rigorosamente con l’articolo. La similitudine tra Arte e Dio è comunque meno peregrina di quanto parrebbe. Soprattutto dal ‘700 in poi da quando credere in Dio ha cominciato a diventare sempre più rocambolesco per le nostre circonvoluzioni cerebrali, gli Artisti e l’Arte (maiuscoli!) sono diventati una possibile risposta a quel vuoto. È nel mondo delle Arti che è nato del resto il concetto di “divismo”, ovvero di divinità senza religione stabilita e quindi particolarmente dinamica ma a seconda delle mode momentanee. Leggendo certi entusiastici testi di estetica se si sostituisse “Arte” con “Dio” molte delle frasi suonerebbero lo stesso. Dagli anni ’70 del ‘900 questa 262 la rivista dell’ Arte identità si è stabilita poi anche con “inconscio”, anzi, scusateci, “Inconscio”. Il vero senso della vita dell’uomo è solo in Dio, il vero senso della vita dell’uomo è solo nell’Arte, Il vero senso della vita dell’uomo è solo nell’Inconscio. I lettori possono sorteggiare la frase in cui credere, tanto l’effetto non cambia, la nebbia del pensiero è garantita in ogni caso. Questo primo contributo non ha la struttura del saggio ma più della novella, del racconto o se vogliamo dell’apologo. La logica del resto è quella di tutta questa nostra rivista, cercare forme comunicative che sappiano far convivere il piacere della lettura, la facilità di comprensione e il rigore della riflessione, sottotraccia forse ma almeno nelle nostre intenzioni comunque rigorosa. la 263 rivista dell’ Arte Alessandro Tamino OMAGGIO AD UNA SORELLA Qualche anno fa, in un piovoso pomeriggio di domenica me ne andavo bel bello a vedere una mostra in quel di Rovigo. Non ricordo perfettamente il titolo, comunque era qualcosa che riguardava le popolazioni autoctone ed il loro incontro prima con i Romani e poi con i Barbari. Ci arrivo dopo vari cambi di treno, via via dal superveloce al localissimo, trasbordi comunque molto gradevoli che aumentano la distanza percepita ed arricchiscono l’immaginario. Alla stazione nessun mezzo per arrivare al museo che non era proprio lì dietro l’angolo. Non che non mi piaccia di camminare ma oltre i bagagli con cui ero partito ero pieno di buste di libri e cataloghi di qualche altra mostra vista quella mattina, se non ricordo male a Padova e quindi la lunga passeggiata a piedi in un giorno grigio e piovigginoso non era gradevolissima. Fuori asse per i pesi non facili da distribuire e con le plastichette dei manici dei sacchetti del bookshop che mi entrano nelle dita e poi il sudore che non posso evitare perché il giaccone pesante lo devo portare addosso, sottobraccio sarebbe un problema rimpinzato com’è di blocchetti per gli appunti e per fare qualche schizzo, i pastelli e il resto della solita mezza cartoleria che mi porto sempre dietro. Magari non la uso ma se qualcosa mi colpisce e non posso appuntarlo o disegnarlo mi sento perso. Comunque, tanto è che arrivo al museo. Avevo il tempo e me la volevo gustare la mostra, chiedo se c’è la possibilità di una visita guidata o di un’audioguida ma nisba. Entro quindi, e m’immergo nella fantasia che quegli oggetti mi nutrono. 264 la rivista dell’ Arte Nella prima sala ci sono dei plastici e delle ricostruzioni di ambienti interni delle case, i monili, addirittura dei giocattoli per bambini e poi dolcissime statuette votive. Come sempre dopo una breve fase idilliaca quando incontro quella che chiamano arte, penso almeno per un attimo a come sia possibile che gli stessi esseri umani che l’hanno realizzata ed apprezzata riescano poi a fare cose tanto terribili ad altri loro simili. Ci sono cresciuto con questa questione di quello che siamo capaci di fare nonostante la bellezza dell’arte. Mio padre mi ha nutrito con due tipi di latte durante quelle bellissime passeggiate che hanno contribuito a fare di me una persona, credo, attenta a molte delle cose del mondo. Mi ha nutrito prima di tutto, di amore per qualunque forma d’arte, da quella “alta” a quella delle cosi dette culture subalterne e poi non mancava mai, forse anche per evitare che il volo pindarico mi portasse in luoghi troppo illusori, di nutrirmi con qualche aneddoto sulla vita degli artisti che li ridimensionassero o eventi storici che mi facessero percepire quello che tutti siamo veramente, oppure, quando mio padre dentro era più triste del solito, con qualche racconto di quando era stato in guerra e soprattutto di quando era un deportato in un campo di concentramento tedesco. Mio padre, di etnia prevalentemente italiana (quasi nessuno di noi è monoetnico nei Balcani come del resto anche in Italia e come probabilmente in buona parte del mondo) era nato a Zara in Dalmazia quando era ancora sotto l’impero asburgico e quindi fu costretto al bilinguismo perché a casa si poteva anche parlare italiano, anzi veneto per la precisione, ma a scuola e negli uffici il tedesco era obbligatorio. Mia nonna mi raccontava di quando Zara tornò finalmente italiana, alla fine della prima guerra mondiale, dei giorni di festa e di commozione a sventolare i tricolori cuciti di nascosto nei giorni precedenti. Ma non per questo i miei avevano mai nutrito sentimenti di particolare ostilità verso la cultura tedesca. Leggere Goethe nella sua lingua madre era per mio padre una delle cose belle della vita e per tutta la sua, di vita, in fondo, non credo abbia mai mandato giù o sia mai riuscito a comprendere del tutto come sia stato possibile che quei nobili, biondi guerrieri siano stati capaci di fare con tanta nonchalance quelle cose alle quali dovette assistere al campo di concentramento di Wietzendorf, e poi magari, la sera, leggere anche loro Goethe commuovendosi come lui. Ma che strano, mentre scrivo queste cose metto a fuoco per la prima volta che mio padre pur avendomi stimolato a studiare qualunque cosa e qualunque lingua non mi ha mai, neanche una volta, stimolato a studiare il tedesco, e nemmeno cercato di insegnarmi qualche frase in quella lingua, proprio lui che ci teneva tanto a che io imparassi di tutto ed il più possibile, lui che era quasi perfettamente bilingue. 265 la rivista dell’ Arte Mentre penso a queste cose sento una giovanile, familiare parlata veneta che ad alta voce introduce i temi della mostra. Perché anche io sono bilingue, veneto e romanaccio doc del popolarissimo, ai tempi di mio padre e me, quartiere della Garbatella. Mentre mio padre era involontario ospite del Terzo Reich, il resto della mia famiglia, tra cui mia madre ed una sorellina appena nata, dovette scappare da Zara per salvarsi dalla pulizia etnica che i Croati misero in atto, con la complicità dei bombardamenti di civili inermi da parte dell’aviazione Inglese, verso gli Italiani che abitavano da secoli quella cittadina. Pertanto i miei dovettero fuggire dall’incubo delle foibe e giungere profughi, letteralmente stranieri in patria, e dopo varie peripezie a Roma. E qui mio padre li poté raggiungere solo dopo la guerra senza aver mai più avuto modo di rivedere la casa dove era nato e cresciuto e la sua terra, perse per sempre. Sono quindi nato romano ma mentre a scuola mi dovevo esibire in “daje” e “mortaccitua” per mimetizzare la mia estraneità - pensate che in quegli anni a Roma ancora si diceva “a profugooo” per indicare che uno era un po’ tardo di mente - a casa sembrava di stare in una commedia di Goldoni. Insomma, come può non commuovermi la dolce parlata veneta di una graziosetta guida in quel di Rovigo biondina e con gli occhioni azzurri come mia madre, le mie zie e le mie sorelle? No, non può non intenerirmi. A occhio e croce si tratta di una visita guidata di gruppo di un centro anziani. Lo si capisce dall’età media e soprattutto perché si vede benissimo che, anche se ce la mettono tutta per apprezzare quello che vedono, la mostra è solo la scusa per quel pranzone alla faccia del colesterolo e della glicemia che si sono concessi perché uno strappo in gita culturale si può anche fare. Quasi barcollano ancora tramortiti dalle sei portate bevande a parte. Alle mostre non so mai se trovo più interessante ciò che è esposto o la gente che le popola. Su questo argomento tornerò tante altre volte, siatene certi. È straordinario vedere le dinamiche che si attivano: ad esempio, molti si vergognano di far trapelare che quello che vedono non gli dice proprio un bel niente ed eccoli allora costretti a simulare multiorgasmi estatici. Questi del gruppo anziani a Rovigo non sono neanche tipi da simulazione, i più seguono buoni buoni la guida con lo stesso spirito con cui hanno lavorato per una vita in fabbrica o coltivato i campi, se siamo qui per fare una cosa la si fa e zitti. 266 la rivista dell’ Arte Etica del lavoro austroungarica direbbe qualcuno. Se qui si produce e non c’è la mafia molti pensano che è sopratutto perché loro hanno avuto la fortuna di essere stati inquadrati da una novantina d’anni di franceschigiuseppe. Mentre al sud, che si può fare, solo fannulloni come gli spagnoli ci sono andati, cosa vuoi che gli abbiano insegnato? La qualità di un popolo dipenderebbe quindi da quale popolo si è fatto colonizzare. Un signore fa una domanda dalla risposta scontata per il piacere di sentirsi dire dalla guida, che è una ragazzina proprio giovane giovane, che ha capito bene l’introduzione, si vede che si emoziona per il complimento, è incredibile come nei contesti di gruppo la regressione possa trasformarci, quel signore in quel momento è in prima elementare, né più né meno, proprio tenera la cosa. Non c’è nessuna ressa, la mostra non è affollata e gli anziani seguono la guida alla spicciolata e non sono nemmeno tanti, gli spazi sono ampi e piano piano mi accodo al gruppo. A questo punto devo però aprire una parentesi sull’etica dell’ascolto a scrocco di una visita guidata. In generale non mi piace viaggiare senza biglietto, è faticoso non essere in regola e quindi, quando posso, le pago le visite guidate. Ma restano alcuni aspetti di cui discutere. Quando il gruppo dispone di radioline con auricolare che li tengano collegati con la guida la questione non si pone. Sente solo chi ha la radiolina a meno che lo scroccone per sentire non si metta in braccio alla guida. E la guida, grazie all’amplificazione, può permettersi di non parlare a voce alta e non corre il rischio né di farsi derubare da qualcuno dei suoi saperi ma nemmeno di disturbare chi vuole fare la sua visita senza subire alcun travaso indesiderato degli stessi saperi di cui sopra. Diversa è la situazione quando non vi è l’amplificazione e soprattutto quando la mostra è affollatissima ed il gruppo assai numeroso. Ricordo una scena assai sgradevole cui assistetti tempo fa alla Galleria Borghese. Anzi, una scena sgradevole alla quale, per essere preciso, diedi anche il mio non richiesto contributo. Per chi non avesse dimestichezza con i musei romani, va detto che la Galleria Borghese è uno degli spazi espositivi più visitati del mondo e quindi tra i più affollati. Pensate che si entra solo per prenotazione e non si può stare a vedersi il Bernini o il Caravaggio in santa pace per quanto si vuole, no, ci sono dei turni mi sembra di un’ora e mezzo o giù di lì alla fine dei quali si viene letteralmente buttati fuori dal museo che va svuotato per accogliere altri visitatori. 267 la rivista dell’ Arte Durante una mostra in quella sempre affollatissima Galleria assistetti ad un violentissimo battibecco tra una guida ed un visitatore che si era intrufolato nel suo gruppo. Da una parte “disonesto”, dall’altra “ho pagato il biglietto del museo e qui dentro sto dove mi pare”. Intervenni com’è purtroppo mio costume nella diatriba, anche perché quella stessa guida poco prima mi aveva disturbato parlando ad alta voce mentre mi stavo concentrando su non ricordo quale opera. Perché esiste, come accennavo prima, anche questo aspetto della questione, se è vero che qualcuno scrocca è anche vero che in molti casi le guide e i loro codazzi disturbano. Comunque, tornando alla discussione alla Galleria Borghese, in quel caso sostenni la parte del presunto scroccone, affermando con gran prosopopea che la voce altro non fosse che “res nullius” ovvero una cosa di nessuno che può essere raccolta gratuitamente da chi passa, come le foglie secche in un bosco d’autunno e nel mio concionar non mancai di dire che nel contratto sottinteso stipulato acquistando il biglietto del museo non vi fosse alcuna limitazione riguardante il dove stare negli spazi espositivi e, turni a parte, il quando starci. Quello che aveva fatto esplodere la tensione in quel caso era sicuramente dovuto al grande affollamento e all’esiguità dello spazio, infatti la diatriba era esplosa in una saletta già piccola di suo ed ulteriormente ristretta dai totem illustrativi ed in effetti il ladro di spiegazioni o presunto tale si era messo letteralmente in mezzo, tra la guida e i suoi guidati, limitando evidentemente la possibilità di ascolto e partecipazione di chi invece era in regola con il pagamento della quota guida. Ma qui, alla mostra di Rovigo, la situazione era assai diversa. Prima di tutto questa è una visita guidata che in ogni caso, pur volendo, non avrei potuto pagare perché non era una guida del museo, avevo infatti chiesto se ve ne fossero e mi avevano detto di no. Questa è una guida esterna il cui servizio fa parte di un pacchetto gita acquistato dagli anziani al di fuori del museo e che sicuramente comprende anche altre cose non essendo quegli anziani, mi sembrava di cogliere dal loro dialetto, dei veneti Rovigotti. Quindi, ripeto, in ogni caso non mi sarebbe stato possibile pagare. E poi, francamente, non mi sembra di disturbare proprio nessuno e nemmeno di rubare niente a nessuno, li seguo con discrezione, mai in prima fila, entro nelle stanze e mi fermo ad ascoltare solo quando sono già tutti entrati ed hanno preso posizione. Non faccio nemmeno domande anche perché la guida, sarà stata pure una graziosa e giovane veneta ma non sembrava una cima. 268 la rivista dell’ Arte E poi è brava gente, ad alcuni mi viene spontaneo di sorridere mentre ascoltiamo le spiegazioni, e mi rispondono sorridendo anche loro. Non è così ovvio rispondere al sorriso in quella maniera, il giorno prima alle terme di Abano quando sorridevo incrociando qualcuno in fila per la pedicure mica tutti rispondevano. Altra cultura, penso, questi sono ancora contadini abituati a condividere, quelli borghesotti arroccati nei loro privilegi, chi ti sorride sotto sotto ti vuole fregare, ne sono convinti. Sento quasi che mi sto affezionando a questi anziani in gita a Rovigo. Si fa notare una matura culona a cui va di fare un po’ la capocordata. Si capisce che non gliene frega niente della mostra ed infatti, senza seguire molto le spiegazioni si muove da un sottogruppo all’altro come per controllare che tutto vada bene. Abbastanza alta e robusta, ha un maglioncino blu elettrico molto peloso e assai aderente, direi anzi stretto che per gli ondeggiamenti della panza a tratti tende a scivolare verso l’alto scoprendo una camicetta rosa e acquisendo quindi la configurazione di un bolerino. Pantaloni neri a zampa d’elefante immagino per sfinare la gambotta e soprattutto un grosso culone portato in giro quasi con fierezza. Ogni tanto comunque si sente in dovere di stare a sentire o meglio, soprattutto di far vedere che sta a sentire, facendo oscillare la sua testa tinta e cotonata stile primissimi anni ’60, seguendo la prosodia della descrizione della guida. Ma subito si stufa ed allora deve manifestarsi al mondo con un commento del tipo “che maraviglia sti giojei, i par moderni” oppure “che bei, come i me staria ben sti orecini”, e gli anziani nei pressi a ridere o almeno ad annuire forzatamente come sempre si fa in questi casi per necessaria inerzia adattativa di gruppo. Dopo questo successo di pubblico e di critica la culona torna a spostarsi nella stanza e ad avvicinarsi ad un altro sottogruppo. Non riesco a sorriderle perché non incrocia mai lo sguardo con me, che strano. Ci spostiamo in uno spazio molto grande e saliamo su un ballatoio che percorre tutto il quadrilatero del salone, a metà altezza tra pavimento e soffitto. È molto ampio e non ci sono altri visitatori, per cui ci si dispone lungo il perimetro alla spicciolata, tutti in prima fila appoggiati alla balaustra con la guida che aspetta che tutti prendano posizione, praticamente a semicerchio. 269 la rivista dell’ Arte Entro per ultimo, di proposito, per non prendere spazio ad altri ma non c’è problema, gli anziani non saranno più di una ventina ed il ballatoio è così ampio che più o meno ci si riesce a distribuire a non meno di un metro l’uno dall’altro. La guida sta per iniziare ad illustrare la ricostruzione di un carro da battaglia che sta in basso, al centro della sala e che tutti stiamo già fissando sporgendoci dal ballatoio ma ecco che viene avvicinata dalla culona che gli parla all’orecchio proteggendo quel segreto con una mano dalle dita così tese da apparire arcuate e agitando, si percepisce irritata o scandalizzata, le chiappone che gonfiano quei pantaloni neri. La guida annuisce in continuazione per tutta la durata di quel breve contatto mentre i suoi occhioni azzurri scannerizzano la sala percorrendo il bordo del ballatoio o meglio scannerizzando quasi tutta la sala, perché lo sguardo nel suo movimento oscillante e continuo ha un’extrasistole quando dovrebbe inquadrarmi e salta quindi la mia casella, sarà per questo che faccio una fantasia persecutoria autoreferenziale sulla natura di quel bisbiglio indignato, ma no, non essere paranoico, mi dico un microsecondo dopo. Il bolerino blu elettrico si scosta dalla guida, ha terminato il suo discorso e si percepisce la soddisfazione, la fierezza, con il senno di poi potrei dire che giustizia è fatta, congratulazioni. La guida biondina interrompe la flessuosa scannerizzazione e si irrigidisce fissando un punto, credo una decorazione della parete di fronte a lei, ad un metro circa al di sopra di chiunque di noi, il meccanismo è chiaro quanto faticoso per la fanciulla perché presuppone un certo sforzo per evitare che lo sguardo oscilli liberamente e possa cadere dove evidentemente si vergogna o almeno la imbarazza guardare ma dove comunque avrebbe anche tanta voglia di guardare. C’è poco da fare, solo la vendetta è spontanea, a volte anche liberatrice ma la giustizia non può che essere innaturale e quindi faticosa per tutti, rei, giudici, testimoni e carnefici. Le parole della guida questa volta sono ben scandite con una forza diversa da quella con cui ha descritto il tepore di quelle antiche case e l’abilità di quegli artigiani, si vede che ha dovuto prendere una rincorsa per riuscire a fare quello che sta facendo ma che andrà fino in fondo e senza dubbi e per questa sentenza non usa il dolce veneto, parla in un italiano che solo nella prosodia riecheggia vagamente il dialetto: “Devo fare una comunicazione importante, questa è una visita guidata privata, quelli che vi partecipano hanno pagato e nessun altro ha diritto di parteciparvi, chi pertanto non appartenesse al gruppo è pregato di allontanarsi immediatamente perché non ha nessun diritto di seguire questa visita guidata.” Non potendo fucilarmi, le dita della manina destra della biondina giustiziera disposte ad ok ed il suo braccino semiflesso seguono il ritmo calmo e implacabile delle frustate che meriterei. Resto paralizzato per qualche secondo indeciso sul da farsi. 270 la rivista dell’ Arte Mi guardo attorno e nessuno mi fissa, si sono irrigiditi come la guida che immediatamente è passata alla descrizione del carro da guerra, fingono indifferenza, anzi stupore per l’evento, “chissà ela di chi la stava parlando?”, sembrano dirsi facendo i semivergini. Non se ne rendono conto ma hanno paura della guida e di essere buttati fuori anche loro. Perché i poveracci da generazioni quando qualcuno viene escluso dalla distribuzione della polenta, prima di tutti vivono un momento di ansia, “ostia, podeva capitar anca a mi!” Il fatto è che si sentono solo a stento sopportati dal mondo, dalle guide e dai musei, sono sempre in bilico e vivono sempre nel timore di essere espulsi anche loro, da un momento all’altro. La culona esce dalla stanza e la intravedo dalla porta a parlare con entusiasmo con un sottogruppo che si era attardato. Di solito in queste situazioni reagisco assai vivacemente. Argomenti ne ho e tutto sommato ho un’indole reattiva, almeno credo, ma purtroppo non quando la faccenda mi prende di sorpresa e soprattutto mi proviene da chi non me lo aspetto, da chi come in questo caso non percepivo come ostile e verso il quale provavo persino un embrione di tenerezza. La paura di strafare mi blocca e, come in questo caso, preferisco abbandonare il campo in silenzio, in definitiva mi fa meno male anche perché sento il bisogno di accudirmi per una ferita che potrà anche sembrare sproporzionata ma sanguina, non mi ucciderà e non mi porterà nemmeno ad una notte insonne, ma un quarto d’ora di vergogna lo vivo, eccome, di umiliazione, di fastidio che quasi me ne voglio andare via dalla mostra e comunque me li ha fatti evitare per il resto della visita, quegli anziani. Per buoni altri cinque minuti, nella sala accanto, da solo, cerco di comprendere ma mi rendo conto che è uno sforzo del tutto inutile, bla bla, tutte cose ovvie, la psicologia dei gruppi e della territorialità la insegno alla Scuola di Arti Terapie e a volte ai miei pazienti, ma qui alla mostra, a caldo, la lezioncina è ridicola, se continuo così, per lenire il mio disagio, finisco per assolverli tutti, ‘sti stronzi che per un puntiglio mi hanno negato qualche briciola, gli inutili per loro avanzi di un pasto. Hanno preferito buttarli nella spazzatura piuttosto che darli ad uno che aveva fame. Ma poi ecco che arriva, in punta di piedi, benefica, sorella narrazione. Invece che essermi solo successa questa brutta cosa, me la sto anche raccontando questa cosa. E quel nucleo sgradevole comincia ad ammorbidirsi e mi ritrovo con piacere, con un filino di esaltazione direi, a pensare come la metterò in scena quella storia, alle varie versioni, alla voce della biondina e della culona che magari imiterò facendo ridere gli amici ad una cena oppure, care signore e cari signori, scrivendoci una novella. 271 la rivista dell’ Arte COLLOQUI DELL’ARTE È una rubrica per conversare insieme, noi della rivista con voi lettori, per i quali noi facciamo la rivista. Al modo e al fine di diventare una comunità, quella di “noi tutti insieme” nel colloquio. Il grande poeta germanico, Friedrich Hölderlin – vissuto tra Settecento e Ottocento e che passò i trentasei ultimi anni della sua vita recluso in una torre essendo stato dichiarato pazzo – scrive: “...da quando siamo un colloquio / e possiamo ascoltarci l’un l’altro”. Questa sentenza poetica vede e impianta il colloquio come sorgente e cammino, ma al tempo stesso come valore, metodo e mèta dell’andare insieme nel mondo. Colloquio è anche un luogo in comune dove stare a parlare in una “cittadina conversazione”, come scrive Leopardi. E significa anche pensare e dire: - sai? parlando con te mi sono chiarito un pensiero che era ancora 272 la rivista dell’ Arte opaco e informe dentro di me. È l’opposto dei non-luoghi di cui tanto si parla oggi. Ed è l’opposto della chiacchiera e della confusione internettiana. Colloquio ambisce di essere un luogo calmo e ricreativo. Invitiamo i lettori di arte a esprimere un loro argomento, un tema da discutere, anche in contraddittorio con la nostra po-etica. Lo discuteremo insieme in questa rubrica. Come si fa in una polis o in una repubblica. Inoltre, alcuni gruppi di ricerca-azione di artiterapie, diretti da Alessandro Tamino e Maria Pompa, a Roma, discuteranno alcune parti dei testi proposti dalla Rivista dell’Arte e sintetizzeranno il loro lavoro in un breve scritto che sarà postato nella Rubrica dei “Colloqui” nel numero successivo della rivista. Nella rubrica, oltre i “colloqui”, troverete anche delle nostre segnalazioni, recensioni di libri e di film, a volte, ed altro. 273 Contatti Vincenzo Bellia email: [email protected] Rita Campolo email: [email protected] Armando Gnisci email: [email protected] Marino Midena email: [email protected] Maria Pompa email: [email protected] Alessandro Tamino email: [email protected] la rivista dell’ Arte
Scarica