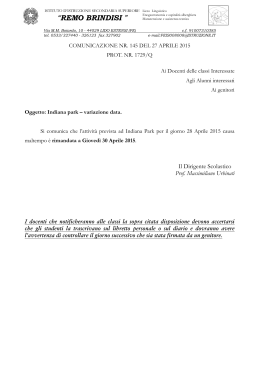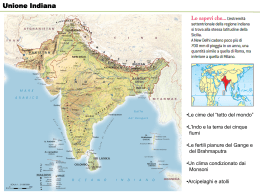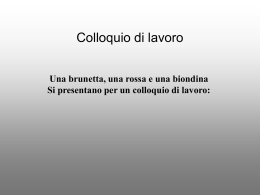Ruggiero Romano Introduzione a America indiana Introduzione Mi sia lecito dire subito che ho paura delle reazioni del lettore - di tutti i lettori - dinanzi al titolo di quest’antologia. Ho paura d’esser mal compreso; in ogni modo ed in ogni caso, mal compreso. «America indiana»? Che cos’è? Ah! sí, ho capito: gli Inca, gli Aztechi, delle sculture interessanti, del folklore. Queste sarebbero le reazioni del lettore «bon enfant»... Ma ve ne possono essere di peggiori, più sottilmente maligne: s’insiste sull’«America indiana», per dire che l’« America latina» è poca cosa al confronto... Vorrei dire che questa raccolta di studi, che ho l’onore di presentare, non Torino, Einaudi, 1972 risponde a nessuna di queste preoccupazioni. Rispetto troppo gli indiani d’America per ridurli a folklore e, d’altro canto, mi sento troppo ‘latino’ per distruggere d’un colpo quel che può essere il patrimoRuggiero Romano è stato un grande nio (in ogni senso) che la civiltà alla quale appartengo ha, bene o storico. Dopo gli esordi a Napoli male, accumulato in quel continente. Presentando questi saggi, dove conobbe Benedetto Croce, agli io non voglio negare l’esistenza dell’America latina. Solo, mi inizi degli anni ’50 abbandonò l’università sembra che quest’espressione vada precisata, corretta, initaliana e giunse a Parigi dove lavorò dal tegrata. Non si dispone di nessun lavoro serio che possa 1947 sino al 1989 nel Centre National de indicarci con precisione dove e quando l’America «latiRecherche Scientifique (del quale fu direttore na» sia stata inventata. Sappiamo solo che si tratta, apdal 1962) e nell’École Pratique des Hautes punto, di un’«invenzione»... La ‘latinità’ dell’AmeÉtudes (in seguito École des Hautes Études en rica nasce come etichetta per coprire la politica di Napoleone III: essa doveva costituire una sorta Sciences Sociales), dove collaborò con i fondatori di preparazione propagandistica per l’operazione degli Annales che diverranno anche i suoi Maestri, messicana. Combattuta da Madrid (in nome della Lucien Febvre e Fernand Braudel. Hispanidad) e, inizialmente (ma solo inizialmenGrande studioso del Rinascimento e dell’America te), dagli Usa (in nome del panamericanismo), la Meridionale è autore di un numero sterminato di definizione ha avuto in seguito un successo totalibri e di antologie. La sua opera più importante le. Nata or è quasi un secolo, come espressione è stata certamente la “Storia d’Italia” (Einaudi), di precisi interessi politici ed economici, essa ha “Enciclopedia” e “Annali” della stessa casa editrice. poi assolto anche un’altra funzione e cioè quella di Ripubblichiamo l’introduzione a una raccolta di mantenere in una certa orbita culturale le repubblisaggi sull’America indiana: nonostante molti dati che centro e sudamericane. siano invecchiati (il testo venne scritto nel 1965), Ma veramente vi sono restate? Veramente vi sono l’approccio metodologico è tuttora rivoluzionario, mai state? Che delle classi dirigenti siano state affacome se fosse stato scritto ieri. scinate dagli aspetti più appariscenti (e per ciò stesso Ma, certo, non è questa epoca di banalità più falsi) della cultura francese è incontestabile; che giornalistiche in grado di competere con lo altri gruppi (i più retrogradi) abbiano creduto veramenspessore e la cultura di persone come Romano. te di poter stabilire le proprie radici nel Don Quijote era un atto di gratuita fedeltà ad un’immaginaria comunanza spirituale del passato. In realtà, quei paesi si venivano faE’ scomparso il 5 gennaio 2002. cendo lentamente, maturando nella sofferenza, al di fuori d’ogni mirifica ‘latinità’: vi contribuivano contadini italiaViaggi di Cultura, 3 ni (più spesso vicini al mondo etrusco o magno-greco che a quello latino), Polacchi dei campi e dei ghetti, Tedeschi delle miniere, Francesi delle vigne della Gironda. Restava, certo, sempre la dipendenza a schemi culturali. Pablo Neruda, uno degli alti testimoni più vigili del nostro tempo, l’ha notato con fine intuito: parlando dello stato degli spiriti in quei paesi intorno agli anni ’20 del nostro secolo, dice: «nos llenabamos la cabeza con lo ultimo de los transatlanticos» (ci riempivamo la testa con le ultime novità apportateci dai transatlantici). Questa era certo l’America ‘latina’. Ma poi, per definire il loro paese, per definire se stessi, quegli americani (almeno i migliori) hanno sempre meno atteso navi (ed aerei), con i loro carichi di libri, riviste, concetti europei. Certo negli intellettuali (e nei politici) meno provveduti questo rifiuto ha dato origine a forme assurde di provincialismo, di «criollismo»; ma si è trattato, in realtà, di fenomeno minore, da considerare come il prezzo che si doveva necessariamente pagare per ottenere la libertà, il privilegio, d’essere americani e soltanto americani. In ogni modo, a quel provincialismo s’è ormai reagito, e così l’America del Centro e del Sud diventa progressivamente «americana», ciò che non significa rifiuto delle idee degli altri continenti, ma semplicemente adattamento di quelle idee a situazioni tipicamente americane. In questo processo, che conta ormai una trentina d’anni (e tanto peggio per quanti, in America e fuori d’America, non se ne sono resi conto), è evidente che l’aggettivo ‘latino’ ha acquisito delle nuove dimensioni, un nuovo senso. Non solo, ma v’è da aggiungere che, parallelamente, s’affermava con forza un nuovo fenomeno: la tendenza «indigenista». Questa ha avuto incontestabilmente il difetto, a volte, di presentarsi con un tono un po’ piagnucoloso, contraddittorio, con degli accenti d’intolleranza, di superiorità e, perfino, di razzismo, ciò che non poteva condurre a gran che di positivo. Ma è del pari incontestabile che questa tendenza ha avuto il merito d’attirare l’attenzione sul fatto che una parte della popolazione americana era indiana: la sua cultura, la sua lingua, la sua etnìa, la sua volontà di vita erano indiane. Così, mentre, per mille segni, l’America centro-meridionale afferma sempre più la sua volontà d’essere ‘americana’; mentre, per conseguenza, il vecchio aggettivo ‘latina’ si carica di sensi nuovi e, soprattutto, si limita nella sua portata, l’aspetto ‘indiano’ dell’America prende tutto il Viaggi di Cultura, 4 suo rilievo. Siamo, certo, agli inizi del fenomeno; ma, proprio per ciò, bisogna subito prenderne coscienza, senza arrestarsi alla superficie. Che l’intelligencija di Buenos Aires ascolti nelle sue serate musica (in parte falsa) indiana non rappresenta il fenomeno, ma è purtuttavia un segno; che il governo di tale o tal altro paese irrobustisca la legislazione per impedire l’uscita di opere d’arte del mondo precolombiano, anche ciò non rappresenta il fenomeno nella sua complessità, ma ci si trova dinanzi ad un altro segno. Ma v’è altro ancora. Tuttavia, prima di proseguire, mi sembra necessario tracciare, sia pur brevemente, le linee del processo storico che, dagli inizi del XVI secolo, ha condotto alla situazione di oggi. Gli europei, nel corso della loro progressiva scoperta e conquista dell’America, si sono incontrati con due grosse forme statali rigidamente strutturate: da un canto, l’impero inca (Nord e parte del Centro del Cile attuale, piccola parte dell’Argentina settentrionale, Bolivia, Perù, Ecuador), dall’altro, la «federazione» mexica (corrispondente, grosso modo, al Messico attuale). Vi sarebbe, certo, da parlare anche del mondo maya, ma questo, fiorentissimo nel X-XI secolo, è, ormai all’arrivo degli Spagnoli -, in pieno disfacimento, lacerato da lotte interne, oggetto, forse, più che soggetto di storia. Al di fuori di queste compatte unità, non v’erano essenzialmente altro che tribù, popoli sparsi, dalla consistenza socio-politica poco determinata, poco compatta: in breve, delle società segmentate. Ma, all’interno di queste popolazioni ‘sparse’, v’è pur da stabilire una differenza: che, fra di loro, vi erano quelle che avevano opposto resistenza alle strutture imperiali. Esemplari, tra queste, gli Araucani (abitanti il Centro-Sud del Cile attuale) che si erano sempre ferocemente e vittoriosamente opposti ad ogni tentativo d’occupazione del loro territorio da parte dell’impero inca. Questi habitués della resistenza seppero sbarrare il passo, con eguale valore, all’espansione spagnola e, se conservarono la loro indipendenza per lunghissimi periodi (a volte per secoli, come appunto nel caso degli Araucanos), ne pagarono il prezzo con la successiva loro distruzione pressoché totale: indios Pampas, Charruas, Araucanos e tanti altri ancora scompariranno quasi completamente nel corso del secolo XIX. Per contro là dove, a lato d’una insufficiente strutturazione socio-politica, non v’era neppure una tradizione di resistenza, per esempio nei Caraibi, queste popoViaggi di Cultura, 5 lazioni si spensero rapidamente dinanzi all’impeto della conquista bianca. Lì dove gli Spagnoli incontrarono delle forme statali strutturate, fu loro facile sostituire la loro autorità a quella dei precedenti governanti. Questa facilità si tradusse, sul piano etnico e demografico, in una possibilità di sopravvivenza per le popolazioni locali. È certo sorprendente il constatare che, oggi, grossi gruppi etnici indiani sopravvivono esattamente, con una precisione straordinaria, solo all’interno delle antiche formazioni inca, mexica, maya; altrove, è l’America bianca (Argentina, Uruguay), o meticcia (per incrocio con indiani: il Paraguay, il Cile..., o per incrocio con negri: Brasile, Caraibi, America centrale). Non penso ci si debba lasciar attirare dalla violenza della conquista: morti, stragi, assassinii, furti, formazione di veri e propri harem. Tutto ciò è indiscutibile e solo in nome d’una pretesa scientificità (che serve a nascondere cattiva fede, spirito piccolo-borghese e mal addormentati sogni d’impero) si può passare sotto silenzio per mettere in luce gli aspetti positivi (sic) della conquista: la «diffusione della civiltà» - almeno così la chiamano -. Personalmente, sarei più propenso a lasciar perdere la leggenda nera con la sua coorte di violenze e ad attribuire il potere più profondo di distruzione, di destrutturazione, di violenza inferta all’uomo proprio a quella «diffusione della civiltà». Certo, insegnare agli indiani che esiste la ruota significa diffondere civiltà; ma, una ruota cosa è al di fuori di tutto un contesto? Che civiltà della ruota è mai quella in cui l’uomo è aggiogato, in funzione del colore della sua pelle, alla ruota stessa? È lì che la conquista europea dell’America ha originato vere stragi. Nel diffondere un certo senso dell’autorità, un tipo d’economia, una religione, certi ritmi di lavoro, una certa nozione della proprietà, senza creare le condizioni socio-politiche che consentissero l’introduzione di quella religione, di quell’autorità, di quel tipo di proprietà, e così via. Personalmente, ammiro al di là d’ogni immaginazione le grandi pagine d’Alphonse Dupront sull’«acculturation», ma confesso che, a proposito dell’America iberica, non vedo quali ne siano le possibilità d’applicazione concreta. Ché - ripeto - in quel continente, là dove non fu apportata morte violenta alle popolazioni indigene, fu imposto un sistema di destrutturazione della coscienza, della storia, della volontà di grandi masse d’uomini senza nulla apportare in cambio. Nulla significa Viaggi di Cultura, 6 nulla: sfumare, precisare, chiarire significherebbe, in questo caso, tradire i concetti. L’operazione, del resto, fu talmente violenta, imperiosa, brutale che essa non riuscì che parzialmente, formalmente, materialmente. In profondità, le vecchie strutture rimasero: oggi assistiamo con stupore a tutta una serie di risorgenze del passato indiano: lì, sono degli indiani che s’oppongono alla rimozione d’un monumento religioso azteco, al quale sono, nel loro fondo, legati; altrove, sono gli stessi indiani che mostrano il loro attaccamento alle vecchie forme di proprietà comunitaria delle terre; altrove ancora, voci si levano a rivendicare non più una generica dignità d’uomo, ma una specifica dignità d’indiano. Certo non sono mancate, anche nel corso della vita coloniale, energiche riaffermazioni dei valori del mondo indiano. Come non ricordare, tra tante, la grande rivolta capitanata da Tupac Amaru nel 1780-81? Ma oggi, anche se non si è (lungi da ciò) allo stadio della rivolta, comincia ad apparire una più netta coscienza del passato, un voler affondare le proprie radici in un patrimonio culturale che, per essere lontano, non è meno vivo. Il risveglio totale non è per domani; ma l’alba è prossima. Da questo rapido, rapidissimo scorcio del passato del processo storico del passato è facile passare all’esame del presente, che, credo, deve essere visto da un doppio angolo. Cosa è di fatto, oggi l’America indiana? Cosa può rappresentare potenzialmente, per domani questa stessa America indiana? Una risposta iniziale al primo punto può venire dall’esame di situazioni quantitative. Quanti sono questi indiani? Nel 1950, pel Messico, le Antille e l’America centrale, gli indiani rappresentavano il 15,39 per cento della popolazione totale; i meticci il 39; per l’America del Sud, rispettivamente, il 7,40 ed il 20,58 per cento. Non sembrano grandi cifre; ma, se si escludono taluni paesi, per i quali gli aborigeni rappresentano lo 0,07 per cento, ci si trova dinanzi a percentuali di popolazione indiana del 55 (Bolivia), 40 (Ecuador), 40 (Perù), 55 (Guatemala), 20 per cento (Messico) ed in questi stessi paesi le percentuali di meticci sono, rispettivamente, del 30,00, 30,00, 32,00, 30,00, 60,00 per cento.... Se si pensa che, come dice la saggezza popolare, «un indiano benestante è meticcio; un meticcio benestante è bianco», è da credere che una parte della po- polazione meticcia vada tranquillamente riversata al totale degli indiani. Queste cifre di popolazione trovano conferma nella situazione linguistica di queste masse di indiani. In Perù, sui 2.626.865 indiani di più di cinque anni esistenti nel 1942, 1.626.156 parlano solo quichua; 184.743 parlano solo aymara; 816.966 parlano anche spagnolo. Per altri paesi, le statistiche possono rivelare dati ancora più forti di monolinguismo indigeno. Queste poche considerazioni d’ordine numerico costituiscono, mi sembra, una utile introduzione per cogliere l’importanza del fenomeno, allorquando lo si isola dal contesto delle medie continentali per reintrodurlo nelle situazioni nazionali. Ma, al di là delle situazioni numeriche, vi sono da prendere in esame anche le condizioni di fatto di queste masse indiane. Quest’esame mostra che le condizioni dell’indiano sono, oggi, per molti aspetti, immutate rispetto al passato coloniale e, per molti altri, addirittura peggiorate. Immutate: può parlarsi di cambio reale, allorquando si considerano le condizioni di lavoro? Che le forme giuridicamente costrittive del lavoro siano scomparse da codici, costituzioni, statuti, come negarlo? Ma, nella realtà, come non ricordare che i servizi personali obbligatori sussistono ancor oggi? Come dimenticare che, ancora nel 1951, in Bolivia, nella regione d’Oruro il funzionamento di una rete di distribuzione postale, per un totale di 104.728 chilometri, era assicurato mediante il servizio obbligatorio (postillonaje) degli indigeni? In Colombia, i servizi domandati dalla municipalità agli indigeni non sono retribuiti; in ogni modo, mai in danaro; al massimo, con un pugno di foglie di coca. In Messico, il tequio (corvée) per la riparazione di strade, di pubblici edifici, ecc., è ancora vivo in talune regioni. Quelle, che abbiamo qui indicate, sono forme di lavoro obbligatorio che possono trovare una loro (retorica) giustificazione nel fatto che si tratta di servizi resi, in genere, alla pubblica amministrazione, alla collettività. Ma forme di lavoro obbligatorio esistono anche nei riguardi dei privati: grandi proprietari, capi politici possono esigere, e di fatto esigono, prestazioni obbligatorie di lavoro da parte dei loro colonos e dei membri delle loro famiglie (moglie e figli, anche adolescenti), al di fuori di quelle previste dal normale rapporto di lavoro e senza alcuna retribuzione. E, oltre queste forme costrittive, sono le vecchie forme di rapporto di lavoro che permangono, soprattutto nelle campagne: Viaggi di Cultura, 7 locazione non già della forza di lavoro, ma della persona tutta intera (così nel caso dell’huataruna boliviano, che, per la durata d’un anno, si mette interamente, completamente, a disposizione del proprietario); sistema di bassi salari (per esempio nel caso dello huasipunguero equadoriano, il quale « lavora in una grande proprietà contro una remunerazione che riceve parzialmente in danaro, a titolo di salario, ed in parte sotto forma d’un diritto di coltivazione d’una parcella di terra che il datore di lavoro mette a sua disposizione»). Quel che il codice del lavoro non dice è che quel salario è assolutamente insufficiente ed è assorbito dai debiti che l’indigeno è obbligato a contrarre col datore di lavoro; ma, in merito, avremo da tornare. Ora si dovrà insistere sul fatto che, malgrado il codice prescriva che le giornate di lavoro sulle terre padronali non possano eccedere il numero di quattro, esse sono generalmente cinque e giungono talvolta a sei... Il mozo guatemalteco, per avere il diritto di coltivare una parcella di terra, dà la sua opera al servizio del proprietario «senza salario, o per pochi centavos al giorno durante 150 giorni all’anno». A tutto ciò - per cui sarebbe possibile portare ancora una moltitudine d’esempi - si sovrappone, dappertutto, con monotonia esasperante, il fenomeno dell’indebitamento. È possibile mostrarne migliaia di casi, variati, tutti egualmente tragici. Vorrei indicarne uno solo, relativo all’Ecuador. Un foglio di contabilità d’un’impresa agricola degli anni ‘50 del nostro secolo, nella zona di Riobamba, si presenta nel modo seguente: MARIANA YAMBAY Debito del padre, deceduto 23 febbraio: acconto in denaro 28 febbraio : acconto in merce ( 1 quintale d’orzo) 5 maggio: acconto in denaro 16 luglio: acconto in merce (1 botte di oche) 8 dicembre: acconto in denaro 22 dicembre: acconto in denaro Totale del debito 108 sucres 23 40 5 25 10 80 291 Il guadagno non è stato che di 144 sucres; in tal modo il debito iniziale passa da 108 a 147 sucres... inizio d’un ciclo infernale, che nulla può conchiudere. Di contro a questo documento, possiamo contrapporne un altro, assolutamente identico, del secolo XVIII. Esso è molto lungo ed il lettore mi consentirà di riassumerlo. Nel Viaggi di Cultura, 8 1756, il 13 settembre, si «ajusta», si bilancia, il conto di un «indio», Bernardo Guaman Reserbado, che aveva prestato il suo lavoro durante due anni, due mesi ed undici giorni, al salario di 18 pesos annuali. Dovrebbe dunque ricevere 39 pesos e 5 reales, ma il suo debito ascende a 60 pesos e ½ real, di modo che inizia il nuovo ciclo di lavoro con un debito di 28 pesos e 3 reales ½, che immediatamente aumenta di 4 reales, poiché egli chiede 4 reales «para pan» (per il pane). Il debito, in tal modo, cresce di mese in mese: una volta è una pecora, altra volta l’orzo, altra volta ancora denaro corrente (ma poche volte ed in piccole quantità). Passano così i giorni del 1756, poi del 1757, 1758, ’59, ’60... Fra il ’60 ed il ’63, la contabilità non dà nessuna notizia sul nostro Bernardo Guaman Reserbado, ma in quest’ultimo anno riappare con un «ajuste», che lo mostra debitore di 22 pesos e 5 reales; subito ricominciano nuovi debiti. Poi la contabilità si chiude - per quel che lo riguarda - con una sola parola: «muerto». Il tipo di documenti, sul quale ho lavorato, non consente di stabilire con precisione quale doveva essere esattamente il debito al momento del suo decesso, ma credo si possa affermare tranquillamente ch’esso doveva oscillare entro i 20 ed i 30 pesos. La partita si chiude per lui, ma si riapre di certo per i suoi eredi. Quel che dicevo poco prima sulla continuità delle condizioni della popolazione indiana per quel che riguarda taluni aspetti della sua vita (in particolare per quel che riguarda il mondo del lavoro) mi sembra in tal modo clamorosamente confermato da questo paragone (a proposito del quale tengo a dire ch’esso potrebbe molto facilmente essere moltiplicato per un numero straordinario, ma non è questa la sede). Già l’ho detto: non si assiste solo ad una continuità delle condizioni; in altri settori è possibile assistere ad un loro progressivo deterioramento. Per esempio, per quel che riguarda l’alimentazione. Gioverà partire dalla notazione seguente: per tutta l’America latina la media della produzione agricola era, avanti la seconda guerra mondiale, di 109; per quel che riguarda i prodotti alimentari nel loro assieme, era di 104. Ora le stesse medie, per gli anni 1958-59 e 1960-61, sono scese, rispettivamente, a 105 e 102. È lecito supporre che quelli che hanno sopportato in modo più disastroso le restrizioni siano stati pro- prio gli strati indigeni della popolazione. Si aggiungano a ciò la diffusione di malattie da carenze alimentari; l’alto tasso di mortalità infantile; la durata estremamente limitata della vita media: sono tutti fenomeni che ritrovano la loro genesi, se non esclusivamente, almeno in buona parte, proprio nell’insufficiente (qualitativamente e quantitativamente) alimentazione. Ma lasciamo da canto le supposizioni (anche se a queste si può tranquillamente attribuire un carattere di quasi assoluta certezza), per presentare qualche elemento di dettaglio, che sia sufficientemente esplicito. Allorquando si esaminano dappresso i regimi dietetici delle popolazioni indigene delle distinte regioni dell’America centro-meridionale, si resta colpiti dalle carenze particolarmente gravi di proteine, di vitamine A e C e del complesso, in particolare, tiamina e riboflavina. In Messico, tra gli indiani Otomf della valle del Mezquital, la razione alimentare si distribuisce nel modo seguente: 34,70 per cento di pulque (bevanda fermentata estratta dall’agave), 22,47 di mais, 5,11 di pimento, 4,02 di quelites (sorta di bietole), 6,32 per cento di latte e carne. Il restante 27,83 per cento è costituito da pomodori, fagioli, riso, zucchero, caffè, acquavite. Altrove il quadro non muta molto: possono variare i generi, ma la predominanza dell’alcool nell’alimentazione resta impressionante. Né, del resto, potrebbe essere differentemente: il salario medio percepito dalla maggioranza degli indiani d’America, in rapporto a quella che è la composizione media della famiglia indiana, non può assicurare al livello corrente dei prezzi un minimo alimentare decente. Situazione grave, dunque. Ma, quel che conta, situazione che si aggrava in questi ultimi tempi e che, in ogni modo, è nettamente peggiorata in rapporto a quella che era nel secolo XVIII. Certo, non disponiamo di tabelle dietetiche per quel tempo; ma è pur significativo che tutti i viaggiatori, i funzionari, gli osservatori del secolo XVIII, nel denunciare le gravi condizioni dell’indiano (in particolare sul piano delle condizioni di lavoro e del suo status d’uomo), si tacciono completamente per quel che riguarda il problema del cibo: a scorrere libri e documenti del tempo, si ha l’impressione che questo aspetto non costituiva problema. Oggi, esso salta agli occhi di studiosi, di giornalisti, inviati speciali, cineasti, romanzieri: la sottoalimentazione Viaggi di Cultura, 9 dell’America indiana non ha bisogno di molte parole per essere dimostrata. A considerazioni non troppo differenti si presta anche il problema dell’abbigliamento e dell’igiene sanitaria. Ma il deterioramento più grande delle condizioni della massa indiana, a mio avviso, va segnalato in un altro settore. Oggi questa massa umana è, malgrado le apparenze, molto più isolata dal contesto nazionale di quanto essa fosse nel passato. Quest’asserzione, ovviamente, non va presa in senso assoluto, ma solo relativo. In un mondo - ivi compresi i paesi dell’America centro-meridionale -, i cui abitanti s’integrano sempre di più nelle unità nazionali, costituendo delle masse sempre più compatte, è pur impressionante vedere che le masse indiane d’America fanno sempre più «banda a parte». Nel periodo coloniale ed ancora fino a pochi decenni fa, in sistemi di vita più semplici, più elementari, i cui segni massimi d’integrazione erano per tutti a tutti i livelli sociali costituiti, non so, dalla messa domenicale, dalla conversazione sulla piazza del villaggio, dalla ricorrenza della festa del santo, dalla visita del ‘cacique’ politico, l’integrazione anche se relativa esisteva: formale, se si vuole, ma tale da consentire almeno delle speranze. Oggi da ventitrenta anni a questa parte la situazione è completamente cambiata: il discorso della radio è di gran lunga più incomprensibile oggi, per un indiano, di quanto fosse un secolo fa la predica già estranea e lontana del curato. Radio, auto, macchine, urbanizzazione, tutto quel che dappertutto costituisce elemento di coesione di gruppi anche molto differenti rappresenta, nei paesi dell’America indiana, un fattore di divisione, di separazione. Mai, forse, come oggi l’indiano è stato estraneo alla vita del paese (non parliamo in rapporto al mondo!): la sua opera, il suo lavoro, il suo stesso esistere non ha senso in rapporto all’unità del paese. Essa acquista un suo significato - quanto piccolo! - solo al livello della famiglia, del villaggio, della comunità indiana al massimo. Di ciò si potrebbero fornire molteplici esempi. Mostrare come gli indiani d’Otavalo, in Ecuador, pur raggiungendo notevole prosperità economica per mezzo della fabbricazione e della distribuzione commerciale dei loro splendidi tessuti, restano isolati; si potrebbe segnalare fino a qual punto, all’interno stesso d’una grandissima città come Mexico, malgrado contatti deViaggi di Cultura, 10 terminati dalla scuola, dal lavoro, dalla curiosità, degli uomini e delle donne possano restare isolati nel loro nucleo familiare o, al massimo, nel gruppo d’inquilini d’un immobile: è quanto Oscar Lewis ha mostrato. Ma preferisco citare un altro esempio, un altro caso, molto più significativo perché d’un indio araucano, d’un indio, cioè, che vive in un paese - il Cile - in cui la presenza degli indiani (dei pochi che sopravvivono dopo gli stermini del secolo XIX) non è per nulla avvertita come un problema. Si tratta d’un giovane indiano che, giunto dal Sud del paese a Santiago, lavora e studia: egli ha ‘confessato’ tutta la sua biografia e molte considerazioni sulla sua visione del mondo ad un sociologo, Carlos Munizaga, che ne ha pubblicato larghi estratti con sagaci commentari. Molto di quanto è raccontato dallo studente L. A. non presenta caratteristiche distintive molto forti in rapporto a quanto potrebbe raccontare qualsiasi contadino - indiano e non - inurbato, in America o in Europa: è la vecchia, fondamentale incomprensione tra città e campagna che traspare in molti punti. Ma, al di là di questa, appaiono molteplici aspetti che, appunto, sono nuovi, originali, strani, differenti: per l’appunto, sono ‘indiani’, in opposizione ad una società, rispetto alla quale si sente estraneo. Perché estraneo? Perché, come dice egli stesso, egli non ha idea - la sua società d’origine non gli ha dato idea - d’amicizia tra sconosciuti: l’amicizia è un rapporto che può stabilirsi, per lui, solo «con un certo grado di parentela». La scuola gli fa comprendere che l’amicizia è un fatto «fundamental», che consiste in «due persone che associano idee ed in quella arrivano a comprendersi in profondità». Questa è una conquista, è un’integrazione: è una nuova categoria di pensiero, che il nostro giovane indiano si forgia. Ma non tutto procede così bene. Interrogato sui suoi progetti sentimentali, risponde che ambisce sposarsi «con una donna della sua classe». Richiesto di precisare cosa significa classe, indica: «ossia: della mia razza, che abbia una cultura, che possegga qualche bene materiale (della terra) e che sia di famiglia onorabile». La richiesta di bene materiale e di qualità culturali può rispondere al desiderio d’un uomo qualsiasi, a prescindere dalla sua appartenenza ad una comunità etnico-culturale. Ma, per quel che riguarda l’esigenza dell’appartenenza etnica e l’ascenViaggi di Cultura, 11 denza onorabile, il problema cambia completamente: non varrà la pena di spendere troppe parole per l’esigenza razziale; più importante mi sembra invece l’esigenza della ‘onorabilità’ della famiglia. Infatti, non s’ha da intendere quella parola in senso generico, di rispettabilità, onestà e reputazione. In realtà, onorevole ripete ancora una volta il concetto di gruppo etnico: è onorevole chi è araucano. Mi sento confortato in questa mia interpretazione dal fatto che lo studente L. A., per precisare il suo pensiero, cita il caso d’un suo amico, fidanzato con una «mestiza francesa» molto carina; tutto era pronto per il matrimonio, ma, il giorno della cerimonia, la promessa sposa scompare. Con ciò, egli sembra voler dire che, se ella fosse stata d’una famiglia ‘onorevole’ (capace, cioè, di far rispettare l’impegno preso alla ragazza, come solo una famiglia araucana, dalla solida struttura gerarchica, avrebbe potuto fare), quel «tropiezo», quell’inconveniente, non avrebbe avuto luogo. Ecco, dunque, che su d’un punto fondamentale la non integrazione appare manifesta. Da questo stupendo libretto sarebbe possibile trarre ancora molti esempi capaci di confortare la mia tesi. Ma vorrei soprattutto citare le ultime pagine, in cui il giovane studente racconta un mito. Un mito di formazione recente, degli anni ’20 del nostro secolo, in cui è riferito che un giovane araucano, Manquián, si trasforma, per volontà del Mostro del Mare, in roccia, che sprofonda progressivamente nel mare. Prima di scomparire, le sue ultime parole sono: «la nostra razza risorgerà sempre, anche se altri uomini hanno rubato la nostra terra! Ma non disanimatevi per ciò, vigliacchi! Seguite l’esempio di Caupolicán, Lautaro, Galvarino e altri eroi che lottarono fino alla morte». La frase prende tutto il suo senso se si sa che Caupolicán, Lautaro, Galvarino sono i nomi dei grandi capi araucani, che si erano opposti, secoli fa, all’occupazione spagnola... Questo di L. A. è un caso limite, d’un indiano giunto all’insegnamento superiore, in un paese - ripeto - come il Cile, più aperto d’altri d’America alla sua minoranza indiana. Altrove, ed in strati sociali e culturali meno alti di quelli di L. A. (e che rappresentano la stragrande maggioranza), la situazione è ovviamente peggiore. Certo non è che manchino, qui e là, segni ‘positivi’: in un paese si possono segnalare emissioni radio nella lingua parViaggi di Cultura, 12 lata dalla comunità indiana (ma ciò pone dei grossi problemi: nelle zone più intensamente abitate dagli indiani manca l’elettricità; la radio ha dunque possibilità di penetrazione solo per mezzo di apparecchi a transistor, che marcino su pile; ma le pile, bisogna comprarle... a meno che radio e pile non siano regalate da missioni religiose - ma in tal caso, la radio non può ricevere altro programma che quello emesso dalla missione che ha donato l’apparecchio...); in un altro, delle campagne d’alfabetizzazione; altrove ancora, l’azione di sindacati e di partiti politici offre l’occasione alle masse indiane di partecipare più intensamente - attraverso la tutela dei propri interessi - alla vita della comunità nazionale. Né, del resto, voglio affermare che, per tutta l’America centro-meridionale, la condizione umana e sociale dell’indiano sia la stessa. Le differenze vi sono, ed anche grandi: tra il Messico e la Bolivia, tra il Cile ed il Guatemala, le situazioni non sono identiche: basti dire che, se Lima ospita ed onora una statua equestre di Francisco Pizarro, Mexico ha rifiutato di rendere simile onore a Cortes. È purtuttavia vero che l’impressione generale, che si può ricavare, è quella d’un immenso isolamento della popolazione indiana, anche lì dove - come in Messico - l‘«integrazione» (quella, cioè, che costituisce la massima ambizione dei programmi politici formulati nelle repubbliche americane nei riguardi degli indiani) s’è almeno in parte compiuta. Sarà che, personalmente, considero queste «integrazioni» - in America ed altrove - come una violenza portata alla dignità dell’uomo, ma l’idea che conservo è che, per molti aspetti, essa introduce una falsificazione dei dati. Veramente l’indiano diventa messicano (o peruviano o altro che sia), perché gli si insegna a leggere e scrivere in spagnolo, perché lo si veste di abiti all’europea, lo si mette, casco in testa e torcia elettrica al collo, a lavorare in una miniera? Magari, tutto ciò potrà servire a migliorare la sua sorte materiale (e fino ad un certo punto), ma non sembra si possa dire che, in quanto uomo, egli si sia affermato nella sua specifica individualità. Ma, in merito, v’è da fare un più ampio discorso, che servirà anche a rispondere alla seconda domanda, che ci eravamo posti più sopra. Cosa può rappresentare, potenzialmente, per domani queViaggi di Cultura, 13 st’America indiana? Ecco quel che ci siamo chiesti prima. In Brasile, corre una storiellina: durante un ricevimento, uno straniero giunto da poco chiede ad un amico brasiliano: «chi è quel negro laggiù? Oh, quello non è un negro; è un generale!» Prodigi dell’«integrazione», si può dire, che poi fanno facilmente parlare di ‘quasi-fraternità delle razze’. Certo, anche in Messico o in Perù, vi sono indiani che non sono più tali, per essere generali o direttori di stabilimenti industriali o professori universitari. Diremo allora che la vera soluzione «integrazionista» è quella di fare di tutti gli indiani dei generali, degli ingegneri e dei rettori? Perché la semplice urbanizzazione non basta: si pensi che gli indiani Peruviani inurbati nella periferia di Lima dove costituiscono uno dei mondi sottoproletari più infernali che si possa immaginare - perdono i loro vestiti, i loro sandali, per acquisire stracci e scarpe sfondate all’europea; perdono anche il loro nome di indios, ma non diventano altro che cholos (parola ambigua, che essenzialmente vuol indicare un meticciato culturale). Ma il cholo è veramente «integrato», o almeno sulla via dell’«integrazione»? Mi sembra alquanto difficile sostenerlo. E poi, siamo veramente certi che la soluzione ideale sia proprio quella dell’integrazione? In fondo - ragioniamo - questo fatto dell’integrazione delle masse indiane dovrebbe aver luogo in paesi sottosviluppati. La loro integrazione, dunque, dovrebbe inserirsi nello sviluppo di quei paesi. È qui, credo, che il denunciare con forza l’esistenza d’un’America indiana prende tutto il suo vero senso, che non è solo storico, umano, culturale, ma anche - e forse soprattutto - politico ed economico. È veramente possibile avviare un discorso concreto, esatto, scientificamente impostato, senza tener conto del fatto della specificità «indiana» di milioni d’uomini, che si dice voler inserire in un processo di sviluppo, che deve interessare non solo quelle masse, ma anche i paesi, nei quali esse vivono? È veramente possibile, per esempio, parlare di «riforma agraria» in termini generali, dimenticando che gli ‘oggetti-soggetti’ di questa riforma sono, sì, contadini, ma contadini-indiani? Il problema dell’America indiana qui si allarga, per giungere a dimensioni molto più vaste: a quello generale del sottosviluppo e dello sviluppo. Si Viaggi di Cultura, 14 dimentica troppo spesso, mi sembra, che ‘sottosviluppo’, ‘sviluppo’, ‘rivoluzione industriale’, ‘industrializzazione’, ‘urbanizzazione’ ed altri ancora son tutti concetti europei, nati in rapporto ad una cultura, ad una generale matrice, a situazioni socio-economiche europee (integrate da esperienze nordamericane). L’esportazione, l’emigrazione di questi concetti non può essere compiuta così, sic et simpliciter, in questi paesi sottosviluppati di oggi. Non va mai dimenticato che, nel costo globale dello sviluppo economico europeo, una parte assai importante (anche se spesso trascurata da economisti) è rappresentata dai traumi sopportati dalle masse contadine nel corso della loro trasformazione in operai. Questo prezzo è stato pagato, per compiere una mutazione all’interno d’una società che, pur divenendo industriale, conservava tutta una parte del suo vecchio patrimonio di civiltà contadina: malgrado ciò, ripeto, lo scotto è stato fortissimo. Quello stesso prezzo dovrebbe essere moltiplicato per 10, 100, 1000, n volte, in società differenti da quelle europee... Ma, se è facile scrivere 10, 100, 1000, n, non è egualmente facile, nella realtà, pagare questi altissimi prezzi. E v’è ancor più: ammesso pure che si giunga a ‘pagare’, i risultati sarebbero falsi, artificiali: delle coscienze sarebbero violentate, degli abiti distrutti, delle tradizioni sopraffatte, per creare un mondo da giardino zoologico. Eliminiamo subito un equivoco: non sono tanto ingenuo da auspicare (come pur si è fatto con candore mirabile) di restaurare una società inca o azteca, con culti del sole e della luna, abiti precolombiani, sistema duale di potere e non so che altro. Si giungerebbe a qualcosa di simile a quelle mostruose riserve di indiani dell’America del Nord, linde, pinte, nelle quali visi-rossi impiumati si mostrano a visi-pallidi in vacanza, con camicie a quadroni. Il problema è tutt’altro. Il vero problema insomma, che è alla base dello sviluppo dei paesi nei quali l’America indiana costituisce una forza preponderante, è prima quello di recuperare un passato, una coscienza del passato, della tradizione. Né si creda che queste son generiche parole: non si può immaginare che degli uomini, i quali costituiscono la maggioranza della popolazione del loro paese e che continuano ad essere degli stranieri in patria, possano parteci- pare ad un’opera di costruzione, d’edificazione del mondo di domani. E ciò è possibile nell’America indiana alla sola condizione che domani sia recuperata la storia, la vera storia. Una canzone equatoriana dice: Io voglio essere seppellito come i miei antenati nel ventre oscuro e fresco di un vaso di creta. Bisogna che, domani, queste popolazioni possano avere un nuovo canto che dica semplicemente: Io voglio vivere come i miei antenati col viso rivolto al sole. da uomini liberi, con una loro dignità, con un loro passato. Ma, si dirà, queste considerazioni non riguardano che pochi dei paesi americani: Perù, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Messico. Tutti gli altri, quelli che costituiscono l’America bianca, dall’Argentina all’Uruguay, dal Cile al Venezuela o al Brasile o al Paraguay, non sono interessati. Lasciamo da canto il problema che quell’America bianca è meno bianca di quanto molto spesso si creda; lasciamo pur da canto il fatto che il problema d’un’America nera potrebbe essere posto e ricondotto a quello dell’America indiana. Ma anche quei paesi dell’America ‘bianca’ hanno una loro specificità, che più accuratamente che altrove respingono, attratti come sono da un desiderio di mimetismo con l’Europa. È certo che, il giorno in cui l’America indiana saprà mostrare d’aver trovato il suo proprio cammino, ebbene quel giorno anche gli altri paesi dell’America ‘bianca’ sapranno rinunciare a deludenti imitazioni, ritrovare la propria storia, il proprio passato, che anche per loro non può essere altro che americano (e non già europeo) e, di conseguenza, l’indicazione del cammino da percorrere. Ho parlato di ‘storia’, ‘passato’, dell’America bianca. Ma non sono essenzialmente europei? ci si chiederà. Molto meno di quel che si possa credere a prima vista. Quei Viaggi di Cultura, 15 paesi sono in buona parte dei paesi di meticci. Che quel meticciato sia nascosto come una vergogna da parte di milioni di uomini, che ci si sforzi disperatamente di essere di sembrare, in realtà - bianchi non significa che il passato sia europeo... Al contrario: quel rifiuto, quella vergogna d’una parte - la più valida e quella che può essere la più vitale - di se stessi sono dettati solo dal fatto che le categorie, i valori imperanti sono quelli bianchi. Si cambino, come possono essere cambiati, i valori, gli standard, ed il rifiuto non avrà più luogo. Tanto avevano capito con precisione i governanti spagnoli i quali, dopo aver represso nel sangue, nel 1781, la rivolta di Tupac Amaru, proibirono la circolazione in America dei Comentarios Reales dell’inca Garcilaso de la Vega. Cosa erano, in profondità, quei Comentarios Reales? L’inca Garcilaso de la Vega, figlio d’un soldato spagnolo e d’una principessa indiana, condotto giovanissimo in Spagna, uomo dalla più straordinaria sensibilità che si possa immaginare, di formazione culturale essenzialmente europea, umanistica, aveva espresso in quel libro tutta la sua «difficulté d’être» (per servirci d’un’espressione moderna): mestizo, sentiva che, malgrado i suoi successi mondani, culturali, sociali, in profondità egli restava estraneo al mondo spagnolo: le sue radici erano laggiù, nel lontano Perù, e di quel paese, dei suoi abitanti, dei loro costumi preispanici aveva compiuto un ritratto, fortemente critico a tratti, ma sempre animato da simpatia, passione, nostalgia. Quel che nel XVI secolo, nei Comentarios Reales, era solo dramma individuale d’un uomo, nel secolo XVIII coinvolgeva invece un numero assai grande d’uomini: era normale, in un’ottica di «police» di governo quale quella spagnola del tempo, di proibirne la circolazione... Queste risorgenze, dunque, sono possibili e, oso sperare, inevitabili; ma occorre che sia l’America indiana a dare il la. Una vecchia frase (ormai fatta e rifatta) diceva che l’«America è il paese dell’avvenire». Vorrei poter dire che è il «paese della speranza»; ma la speranza non ha molte possibilità di realizzarsi, se non solidamente ancorata al passato. Dovere scegliere nell’immensa letteratura, che esiste sull’argomento, - mi creda il lettore - non è impresa facile. Viaggi di Cultura, 16 La selezione da me compiuta è di certo arbitraria e non penso certo di trovar giustificazioni più o meno assurde e che, tutte, giungerebbero alla conclusione che quel che qui si presenta è il meglio. Che significa mai il meglio? Avrei potuto presentare testi di A. M. Garibay, Jesus Lara, Arguedas e tanti altri ancora, ed avrei egualmente presentato il meglio. I testi, che ho qui riuniti, rispondono, in fondo, alle numerose domande, alle quali io stesso ho cercato di rispondere nelle pagine che precedono: solo le risposte, che il lettore avrà, saranno più compiute, più esaurienti e più convincenti. Saranno, penso, chiari al lettore tutti i problemi, che tormentano questo enorme continente, le sue contraddizioni, gli ostacoli interni al suo sviluppo. Raccolta ‘politica’? Sí, se politica vuol dire prendere coscienza d’un problema. Pel resto, i saggi qui presentati sono assolutamente liberi. Mi auguro che essi possano render servigio per una presa di coscienza d’un così grave problema: riformatori e rivoluzionari, ‘guerrilleros’ dell’altipiano boliviano o della foresta guatemalteca e funzionari degli enti di riforma agricola, lettori europei o lettori americani debbono pur giungere presto alla conoscenza di questa enorme realtà fortemente specifica che è l’esistenza dell’America indiana, al di fuori d’ogni folklore, d’ogni paternalismo, d’ogni vago spirito missionario. Quell’esistenza va, semplicemente, riconosciuta e rispettata.
Scarica